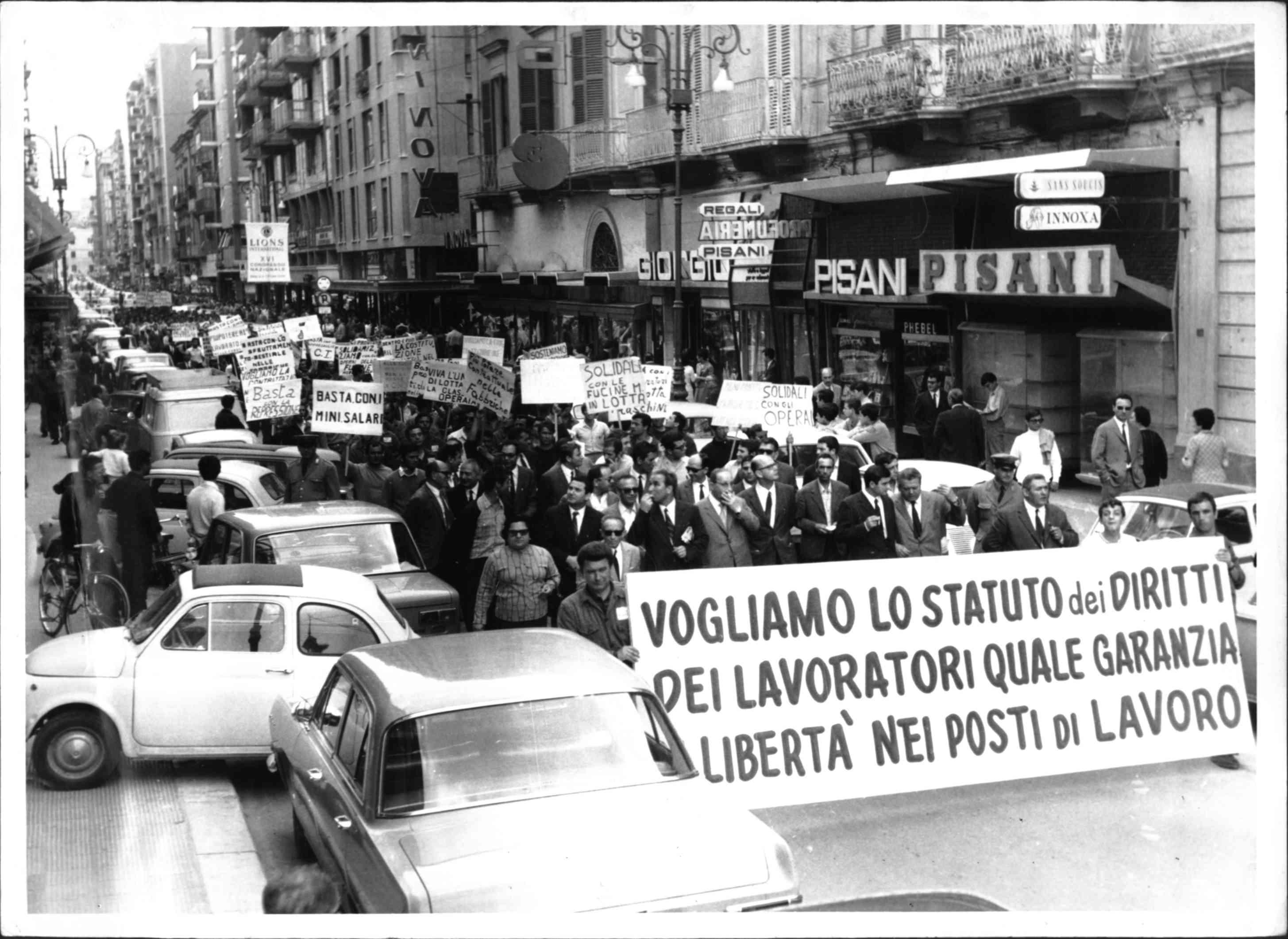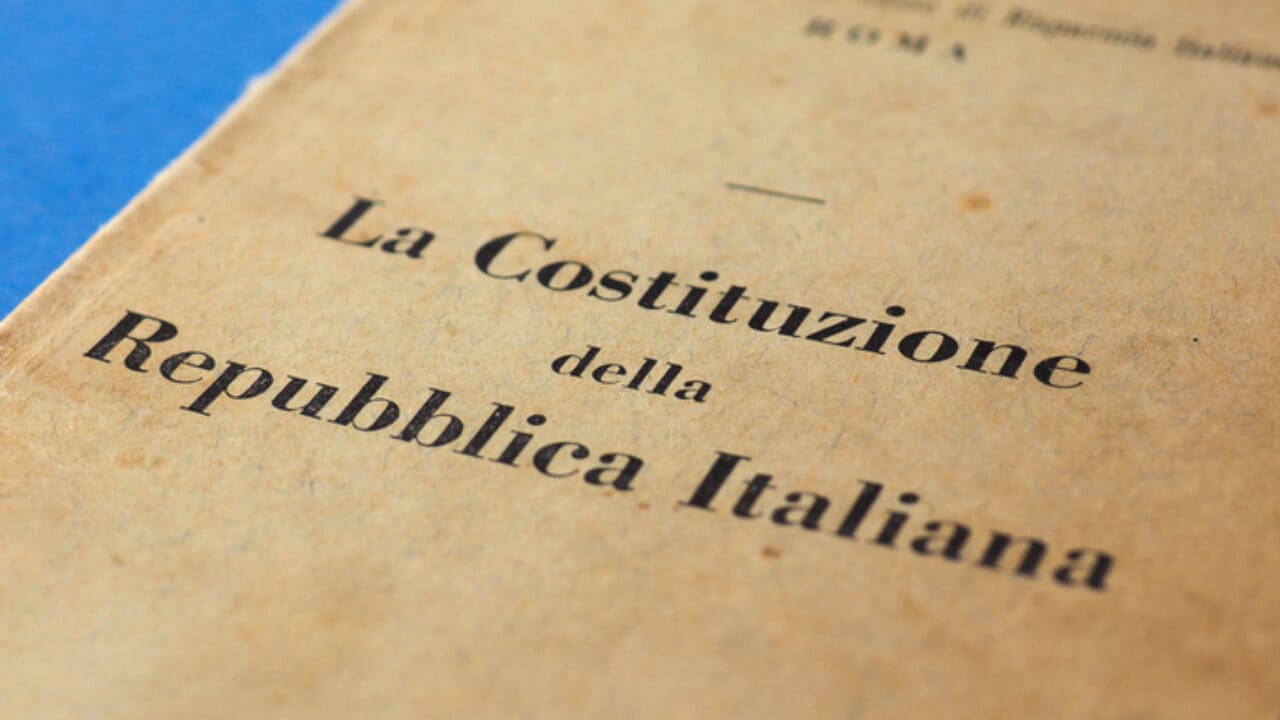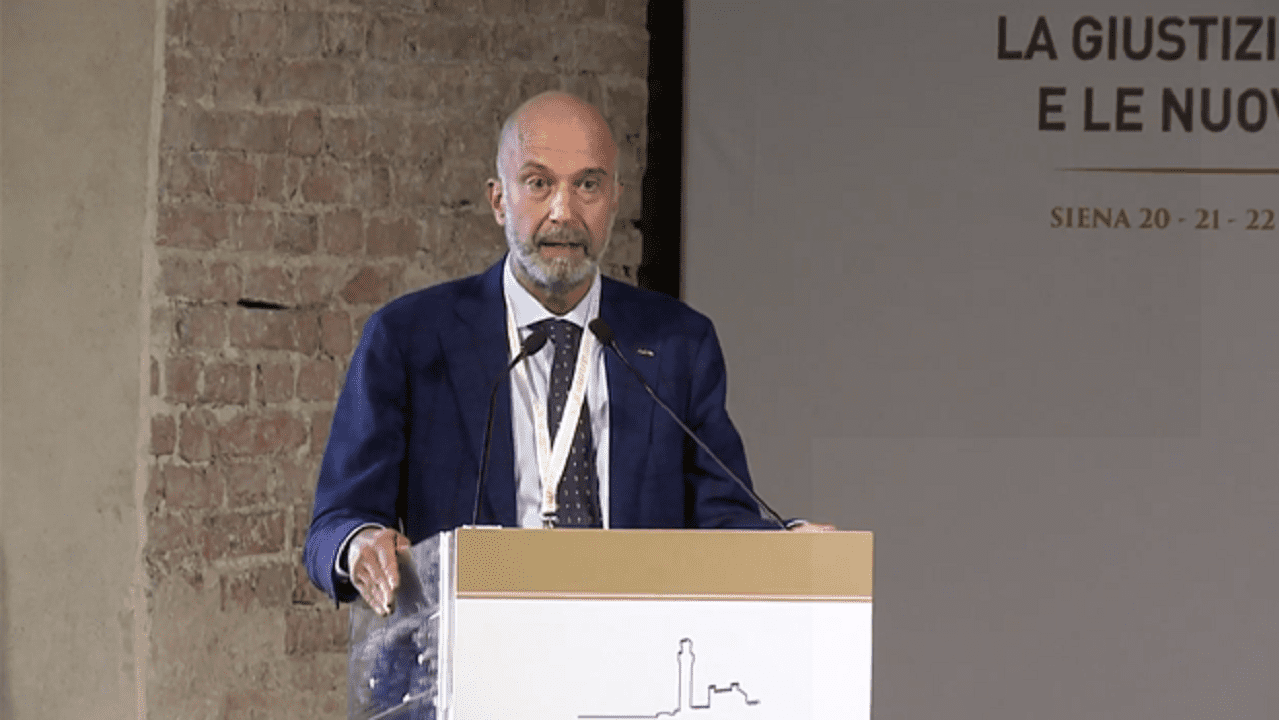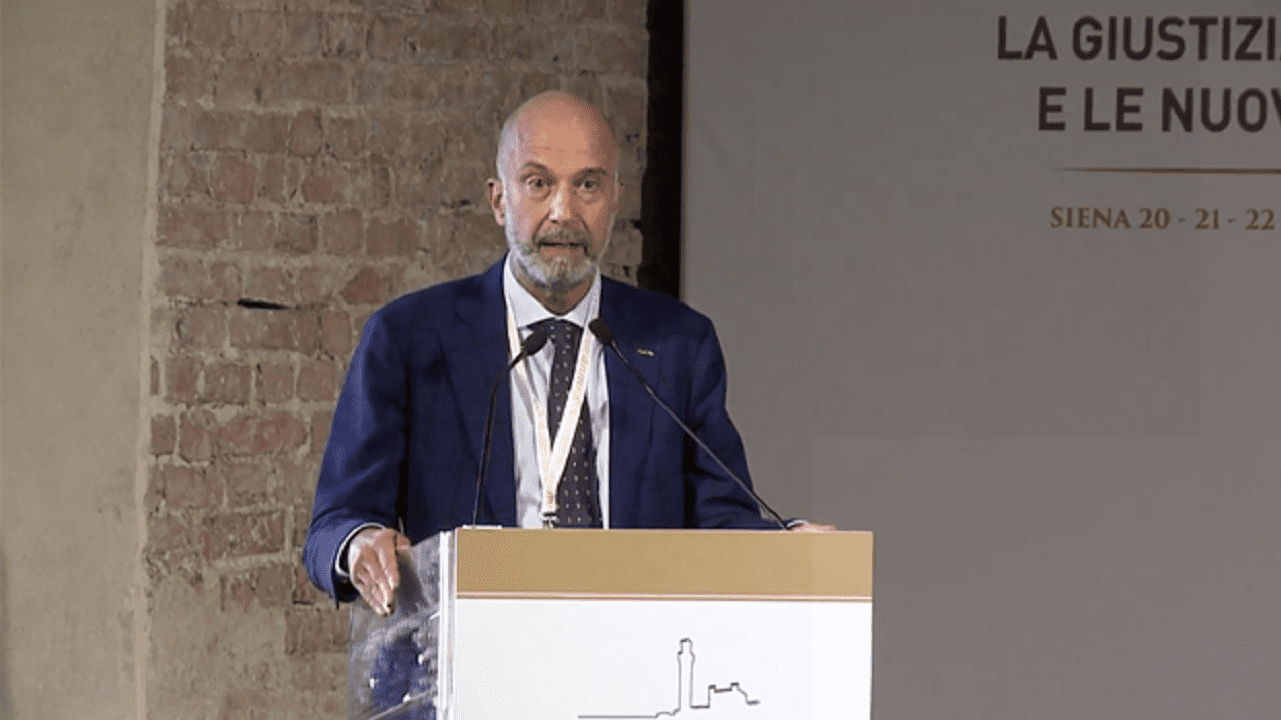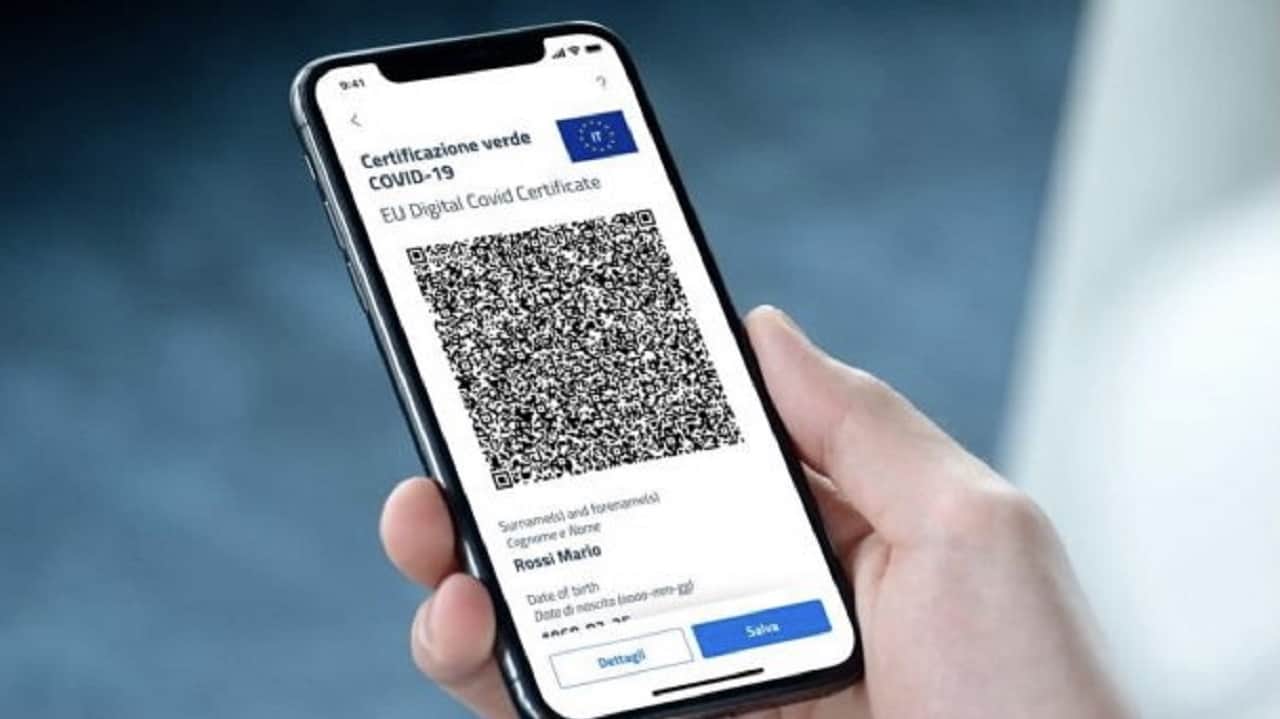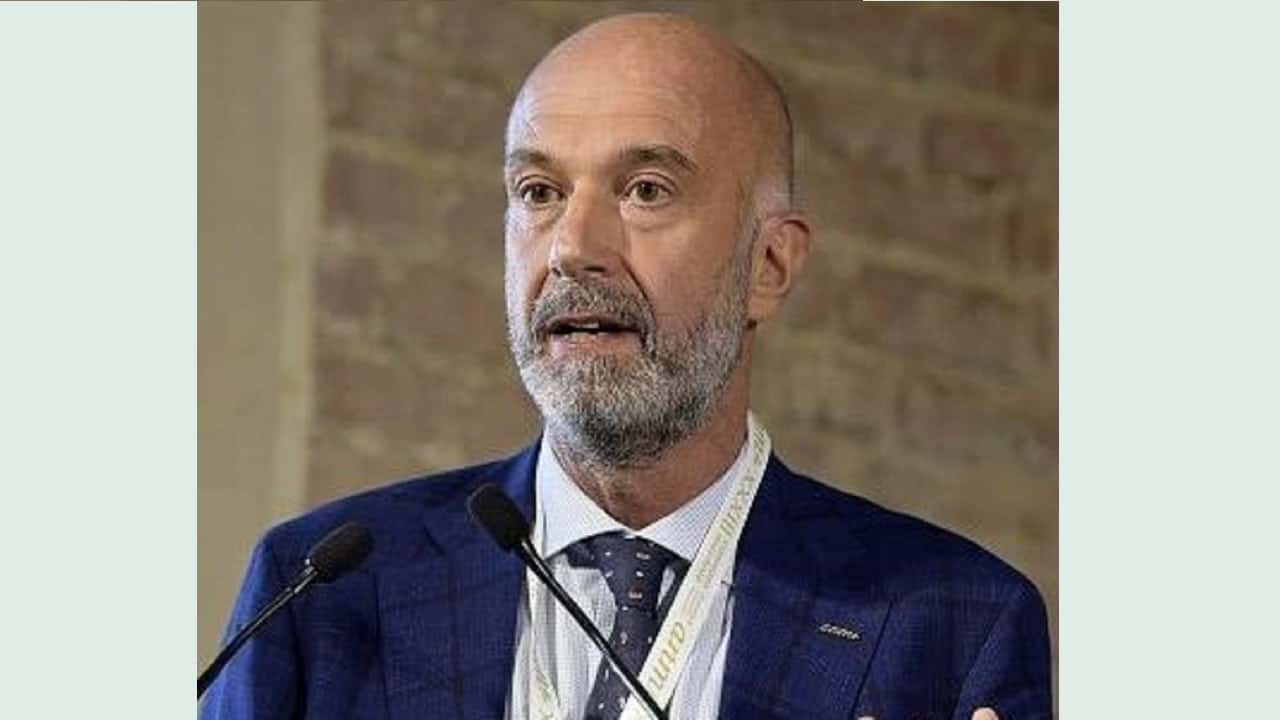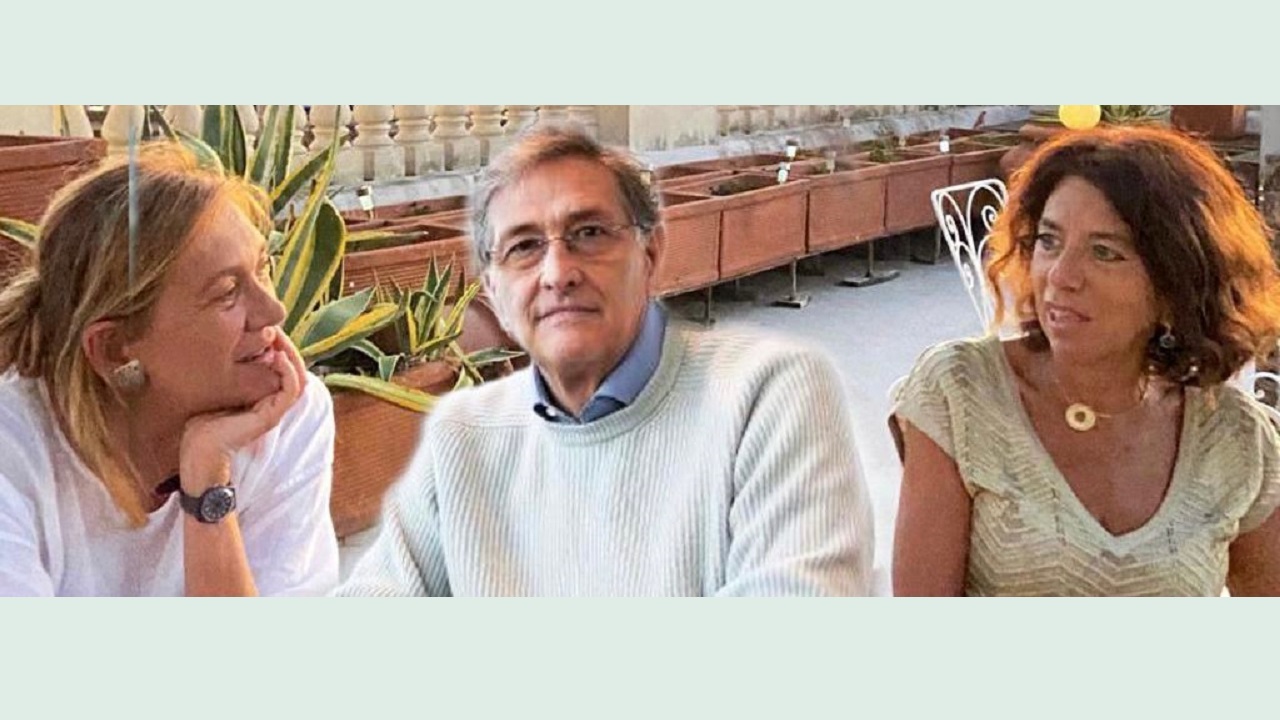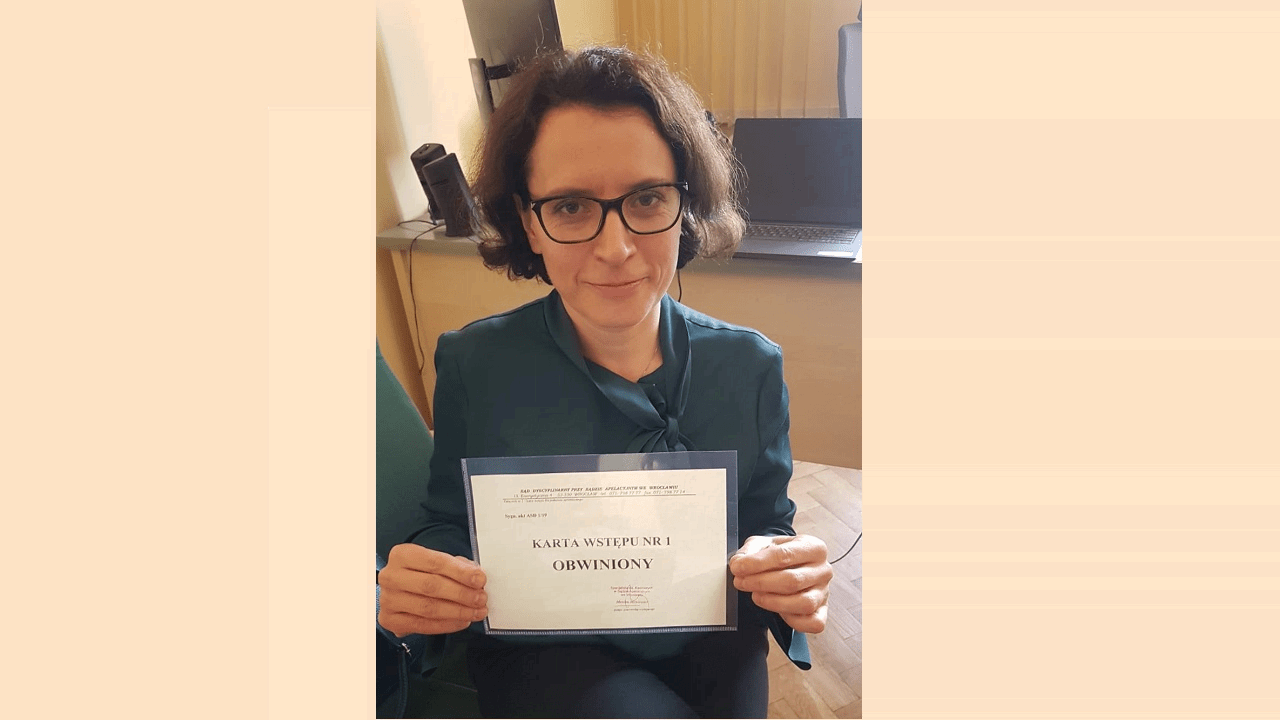Pubblichiamo, a puntate domenicali, la storia di Al Masri, Il cittadino libico destinatario del mandato di arresto della Corte dell'Aja, arresto dalla polizia italiana a Torino e poi riaccompagnato a casa con il volo di Stato.
La prima puntata racconta di Mitiga e degli orrori che vi si svolgono.
A Mitiga anche in questo momento ci sono persone private di ogni dignità, corpi in balia di torture e vessazioni, che si stanno domandando «ma nessuno si accorge di noi?»
Io, Osama Elmasry “Njeem” – Prima puntata: Mitiga
Le azioni e il brutale contesto in cui opera l’uomo che la Corte Penale Internazionale ha sottoposto a mandato di arresto per crimini di guerra e contro l’umanità. Inizia qui un racconto su una realtà che non possiamo ignorare.
Sommario: 1. Presentazione – 2. Senza pace - 3. L’Apparato di deterrenza contro il terrorismo - 4. Bolidi tra sabbia e palme - 5. Carcerati tra aerei e passeggeri - 6. L’inferno in terra.
1. Presentazione
Il “palo”, la “gabbia della Falqa”, la “stanza del telefono” sono nomi o espressioni che ai più dicono nulla, ma che per i prigionieri di Osama Elmasry Njeem suonano come spaventosi. La figura dell’uomo che la prima camera della Corte penale internazionale dell’Aja ha chiesto di arrestare nel gennaio scorso è diventata famigerata dopo il suo discusso e veloce reimpatrio in Libia da parte del nostro Governo.
Di lui, del mondo in cui si muove e agisce sappiamo però poco o nulla. Ne tracciamo dunque un quadro, affinché siano noti il contesto illegale, i gesti criminali della sua milizia, le ragioni della fama acquisita nel suo Paese. Per i media italiani è “Al Masri”. Noi preferiamo chiamarlo “Njeem”, in aderenza ai testi giuridici internazionali.
2. Senza pace
La Libia di oggi è un Paese ancora spaccato in due. L’inizio delle violenze coincide con le proteste, sfociate nella rivolta del 2011 contro il regime di Muammar Mohammed Abu Minyar Gheddafi. Da allora non si sono più placate, anche se i protagonisti (spesso solo i loro nomi) sono cambiati. Gheddafi viene ucciso il 20 ottobre 2011, quando già da almeno sei mesi si era insediato un governo di transizione riconosciuto da molti Stati. Gli scontri tra miliziani riconducibili a diverse fazioni tribali, tuttavia, non si placano fino al colpo di Stato da parte del gruppo armato Libyan National Army (LNA) guidato da Khalifa Belkasim Haftar, il 18 maggio 2014.
È questa la data che segna la rottura permanente – pur con le alterne vicende che caratterizzano i conflitti interni dominati da matrici religiose e alleanze mobili – tra i due blocchi: l’est e alcune parti meridionali, sostanzialmente la Cirenaica, sono sotto il controllo di Haftar; la parte restante della Libia è invece dominata del Governo di accordo nazionale (GNA) di Fayez Al Serraj. Di fatto si tratta di due governi rivali, aventi sede a Tobruk e Tripoli, rispettivamente.
Il 10 marzo 2021 il parlamento libico a Sirte vota la fiducia a un governo di unità nazionale, con sede a Tripoli e riconosciuto dall’ONU. Primo ministro è nominato Abdul Hamid Mohammed Dbeibeh, che s’insedia detronizzando formalmente i due regimi rivali. Nei fatti la Cirenaica, dove nel marzo 2022 si è costituito un governo parallelo con a capo Fathi Bashagha, rimane sotto il controllo di Haftar[1].
Entrambi i governi, privi di vera legittimazione popolare, si reggono sulla forza delle rispettive milizie armate e sull’appoggio di gruppi islamisti integralisti. Gli scontri ripetuti tra gli esponenti delle due fazioni, spesso diretti al controllo di singole infrastrutture energetiche, creano una costante instabilità.
All’esplodere della rivoluzione, nel 2011, un gruppo militare nato a Tripoli nel quartiere Souk al Juma si era schierato subito contro Gheddafi. Il quartiere è nella zona orientale della capitale. Non lontano c’è la base aerea di Mitiga e il gruppo partecipa alla sua presa di controllo. A guidarli è Abdel Raouf Kara.
3. L’Apparato di deterrenza contro il terrorismo
Aumenta così il prestigio dei miliziani rivoluzionari del Souk al Juma. Essi si schierano col Governo di accordo nazionale dopo avere dimostrato il proprio peso militare: si fanno chiamare Forze Speciali di Deterrenza e il relativo acronimo (Al-Radaa o RADAA) conferisce loro un alone di ufficialità in una vera e propria guerra tra bande. Nel 2016 RADAA ottiene il riconoscimento formale da parte del GNA[2].
Si completano così l’ascesa al potere del gruppo di combattenti e l’autorità del suo capo, Abdel Raouf Kara. Si consolida anche la fama del potente generale di Kara, Osama Elmasry Njeem.
Nel 2018 RADAA cambia ancora nome. Diventa l’Apparato di deterrenza per la lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo (DACTO). La nuova qualifica serve a inquadrare la milizia nella struttura del Ministero dell’interno del GNA[3] o forse anche a rimuovere dalla memoria della popolazione qualche traccia dei soprusi commessi durante la rivoluzione. Non basta però l’ufficialità a cancellare la propensione alla brutalità.
Nel 2020 il GNA accorda al DACTO poteri integrativi per assicurare lo stato di polizia locale, combattere il crimine organizzato e il terrorismo e arrestare gli individui sospetti[4]. Nel solo anno 2022 il Ministero dell’interno stanzierà in suo favore 29,5 milioni di dollari USA. DACTO è ormai una milizia potentissima, con un nulla osta, di fatto, per continuare impunemente in azioni illecite e violente per conto del Governo di accordo nazionale[5]. Molta strada si è percorsa da quando, meno di dieci anni prima, si combatteva per conquistare la base di Mitiga con le armi di fortuna affluite dall’estero malgrado l’embargo dell’ONU[6].
4. Bolidi tra sabbia e palme
6 maggio 1933. Sua Eccellenza il Governatore della Libia, Italo Balbo in persona, inaugura il circuito della Mellaha[7]: sono 13 chilometri di asfalto realizzati spianando palme e scavando sabbia di un’oasi, a pochi passi dal lago salato che dà il nome al villaggio.
Finalmente l’Italia fascista ha il circuito per ospitare il Gran premio automobilistico della Libia italiana. Per otto anni ci si era accontentati delle strade della capitale, 71 chilometri dove le prodezze dei piloti mettevano a rischio la pelle dei coloni. Ma ora si può gareggiare in un vero autodromo.
L’evento è passatempo, occasione mondana per il bel mondo coloniale. Peccato solo per quelle macchine tedesche, Auto Union e Mercedes-benz, che dal ’35 prendono a vincere sistematicamente.
Siamo a un quarto d’ora da Tripoli, ma a pochi minuti dal mare. La pista corre intorno alle saline e a un aeroporto.
L’evento è di richiamo. Un passatempo per il bel mondo coloniale ristretto tra mare e dune di sabbia. Non basta la toponomastica (lì accanto c’è la tonnara Piacentini, proprio a ovest del capo Ancona) né le divise candide del governatore o del duca di Spoleto, le grisaglie indosso ai signori o le cloche che sporgono dalle tribune sui capi delle signore a ricreare l’ambiente della Patria sull’altro versante del Mediterraneo. Neppure l’emozione dei milioni distribuiti dalla lotteria abbinata al Gran premio dura più di un giorno.
Il tempo è breve. Di lì a poco provvederà la guerra a porre fine al prestigioso avvenimento sportivo. La sabbia tornerà a ricoprire l’asfalto del circuito costruito intorno all’aeroporto, intitolato dal fascismo al sottotenente Manzini, precipitato col suo aereo il 25 agosto 1912 davanti a Tripoli.
Già, come ogni aeroporto anche questo diventerà punto strategico per trasporti e rifornimenti. L’aveva costruito il Corpo aeronautico militare del Regio Esercito, ma la parabola bellica lo affiderà al controllo inglese.
Solo a fine secolo, 1995, l’aeroporto di Mellaha – nel frattempo denominato Mitiga – viene dedicato a scopi non più solo militari, ma anche civili. Oggi è l’hub delle compagnie statali libiche, Libyan Airlines e Afriqiyah Airways, e di una società maltese, Medavia.
Forse la vita di un’infrastruttura non è mai comune. Ciascuna nasconde misteri o almeno racconta episodi inaspettati. A Mellaha o, meglio, a Mitiga la storia è oggi ed è la storia delle brutalità peggiori di questo scorcio di secolo.
5. Carcerati tra aerei e passeggeri
Tra le basse palazzine dell’aerostazione, dove sbarcano passeggeri diretti a Tripoli, cinque chilometri a ponente da qui, c’è oggi il carcere di Mitiga. Nella Libia moderna questo nome suscita sgomento; ed è il nome del regno incontrastato di Njeem.
Sono stati gli stessi miliziani di RADAA, assumendo il controllo dell’aeroporto, a costruirvi il carcere, oggi la più grande struttura di detenzione della Libia occidentale. Comprende un edificio principale, diviso in dodici sezioni, con celle multiple e celle di isolamento, e un secondo edificio, formalmente dedicato all’amministrazione. Si chiama Naqliah: ospita uffici e altre stanze, alcune di queste molto grandi, per uso “non ufficiale”[8].
È qui che vengono commessi gli orrori peggiori.
È qui che comanda Njeem.
Non è dato sapere quante persone abbia ospitato Mitiga da quando è stato costruito. Del resto, non esistono cifre ufficiali sul numero di detenuti presenti nelle prigioni libiche. Per certo nell’ultimo decennio a Mitiga sono transitati in non meno di 5.000.
In Libia tuttora i cittadini spariscono senza lasciare traccia, per non parlare dei migranti in transito dall’Africa subsahariana. Si viene incarcerati perché dissidenti o avversari politici o sospettati di appartenere a fazioni avversarie o catturati durante gli scontri armati. Ma si viene incarcerati anche perché si è omosessuali o adulteri o semplicemente perché si vuole raggiungere l’Europa: se hai attraversato il deserto e sei sopravvissuto, vuol dire che sei disposto a pagare per trovare un imbarco; già questo basta per entrare a Mitiga o in uno degli altri centri di detenzione.
In Libia esistono “prigioni segrete”. Mitiga non è tra queste. Ciò malgrado è considerata la prigione dove si consumano la maggiore parte e le più crudeli violazioni dei diritti umani.[9]
A Mitiga si entra con l’accusa di essere cristiani o atei, di avere tenuto condotte immorali o di essere affiliati all’ISIS o di combattere per Haftar. Talvolta queste accuse si cumulano, altre volte una imputazione è solo formale, celando la vera ragione dell’imprigionamento[10].
Non di rado i detenuti non vengono informati delle ragioni del loro trattenimento. Vengono arrestati da persone mascherate e senza mandato. Una volta detenuti vengono costretti a consegnare il proprio telefono cellulare, così che i carcerieri possano accedere ai loro contatti, o a fissare appuntamenti all’esterno con qualcuno di questi contatti, così che anche questi vengano catturati.
I migranti vengono portati a Mitiga dalle bande che li hanno sorpresi ai limiti del deserto oppure dagli emissari della guardia costiera libica che li ha ricondotti sulla terraferma mentre tentavano di fuggire via mare.
6. L’inferno in terra
Quando si entra nella prigione si viene perquisiti nudi, anche nelle parti intime. Alla consegna del telefono cellulare seguono subito i primi interrogatori brutali, per estorcere informazioni da chi ne è ritenuto depositario o per indurre sottomissione totale in tutti gli altri. Deve essere subito chiaro che non esistono regole cui appellarsi né avvocati difensori, salvo che per alcuni tra coloro che siano stati arrestati dietro notifica di un mandato di trattenimento. Non esistono diritti, insomma.
Vi sono celle di isolamento e celle comuni, sovraffollate, i detenuti ammassati al punto che non tutti possono sdraiarsi. Vi si dorme a turno. C’è una sezione femminile, dove i bambini sono tenuti insieme con le madri o con chi si dichiara di essere la loro accompagnatrice. Esistono anche box di rete metallica, dove sono rinchiusi uno o più detenuti.
Le violenze vengono esercitate percuotendo le persone con pugni, manganelli e tubi di plastica, noti come PRR. Ve sono anche metodi più sofisticati: si spara fingendo di volere uccidere la vittima, si pratica l’elettrocuzione, si tiene la persona appesa a testa in giù col cosiddetto balanco o la si sottopone alla falqa. Questa è una tortura praticata da secoli nell’estremo e nel medio oriente, che consiste nell’infliggere percosse ripetute alle piante dei piedi, tenute rivolte verso l’alto, con verghe o manganelli; si provocano così lesioni a tendini e nervi o microfratture alle ossa dei piedi, così da rendere impossibile alla vittima mantenere la postura eretta e costringendola a muoversi carponi.
Si infierisce sui detenuti per ottenere informazioni o una confessione, per punizione o per lo svago delle guardie[11].
Secondo una testimonianza raccolta dal Consiglio ONU per i diritti umani, uno degli stanzoni ospitati nell’area amministrativa del carcere “assomiglia a un ospedale per pazzi, dove le percosse sono obbligatorie... e il sangue vi scorre”[12].
Un’altra vittima, sparita e trattenuta a Mitiga per circa sette anni sino al 2022, ha raccontato di essere stata incatenata e sottoposta al balanco mentre gli aguzzini gli bruciavano i capelli con un accendino e con pinze gli schiacciavano pene e testicoli. Ha potuto avvisare la famiglia della propria detenzione solo dopo un anno e dieci mesi. Ha parlato così col padre, che a suo tempo aveva denunciato invano la sua scomparsa. È stato, quello, il loro ultimo colloquio, perché il padre è morto prima del suo rilascio[13].
I carcerieri si rendono protagonisti anche di violenze sessuali, soprattutto nei confronti di donne e minori. Tra le vittime, secondo la Corte penale internazionale, v’è stato anche un bambino di cinque anni[14]. La condizione di abbruttimento e di totale promiscuità in cui vengono ridotti e lasciati i detenuti ne annienta inevitabilmente la dignità. Si registrano casi di minori violentati anche da altri carcerati.
Per tutto ciò, per le condizioni antigieniche delle celle (alle donne sono negate le cure mestruali di base), per la denutrizione, a Mitiga si muore[15]. Alcuni muoiono perché costretti a dormire nel cortile nonostante la temperatura gelida. I migranti vengono anche uccisi quando, sebbene torturati, rifiutano o si rivelano impossibilitati a pagare il proprio riscatto in denaro. I più fortunati tra loro vengono consegnati a proprietari terrieri o imprenditori locali e costretti a lavorare per loro finché non potranno pagare.
Ai migranti si estorce denaro costringendoli a chiederlo ai familiari. Condotti nella sala del telefono, vengono messi in contatto con un genitore o con un fratello. La liberazione costa alcune migliaia di dollari americani. Mentre parla al telefono, il detenuto viene battuto da un carceriere col PRR, così che le sue urla vengano udite dal familiare e le sue richieste risultino più convincenti. Il metodo è ferocemente efficace. Per RADAA una delle entrate principali viene dalle rimesse bancarie dei parenti dei migranti.
[1] F. Petronella, Libia: dallo stallo alla crisi?, in www.ispionline, 22 agosto 2024. Più di recente anche F. Manfredi, Libia: calano le tensioni tra est e ovest, in www.ispionline, 29 gennaio 2025.
[2] Corte penale internazionale, mandato di arresto per Osama Elmasry/almasri Njeem, n° ICC-I1/11, 18.1.2025, p. 6.
[3] Decreto del Consiglio presidenziale del GNA n. 555/2018.
[4] Decreto del Consiglio presidenziale del GNA n. 578/2020.
[5] Urgent Action: military prosecutor forcibly disappeared, in amnesty.org, 24 luglio 2023.
[6] Risoluzione Consiglio di sicurezza ONU 1970 (2011), del 26 febbraio 2011.
[7] Il nuovo autodromo di Tripoli, in Architettura, 1935, fasc. II.
[8] Corte penale internazionale, mandato cit., p. 27.
[9] Consiglio per i diritti umani ONU, Rapporto della missione d’inchiesta indipendente sulla Libia, 20 marzo 2023, p. 11.
[10] Corte penale internazionale, mandato cit., p. 13.
[11] Corte penale internazionale, mandato cit., p. 16.
[12] Consiglio per i diritti umani ONU, Rapporto cit., p. 11.
[13] Consiglio per i diritti umani ONU, Rapporto cit., p. 10.
[14] Corte penale internazionale, mandato cit., p. 19.
[15] Corte penale internazionale, mandato cit., p. 22-24.