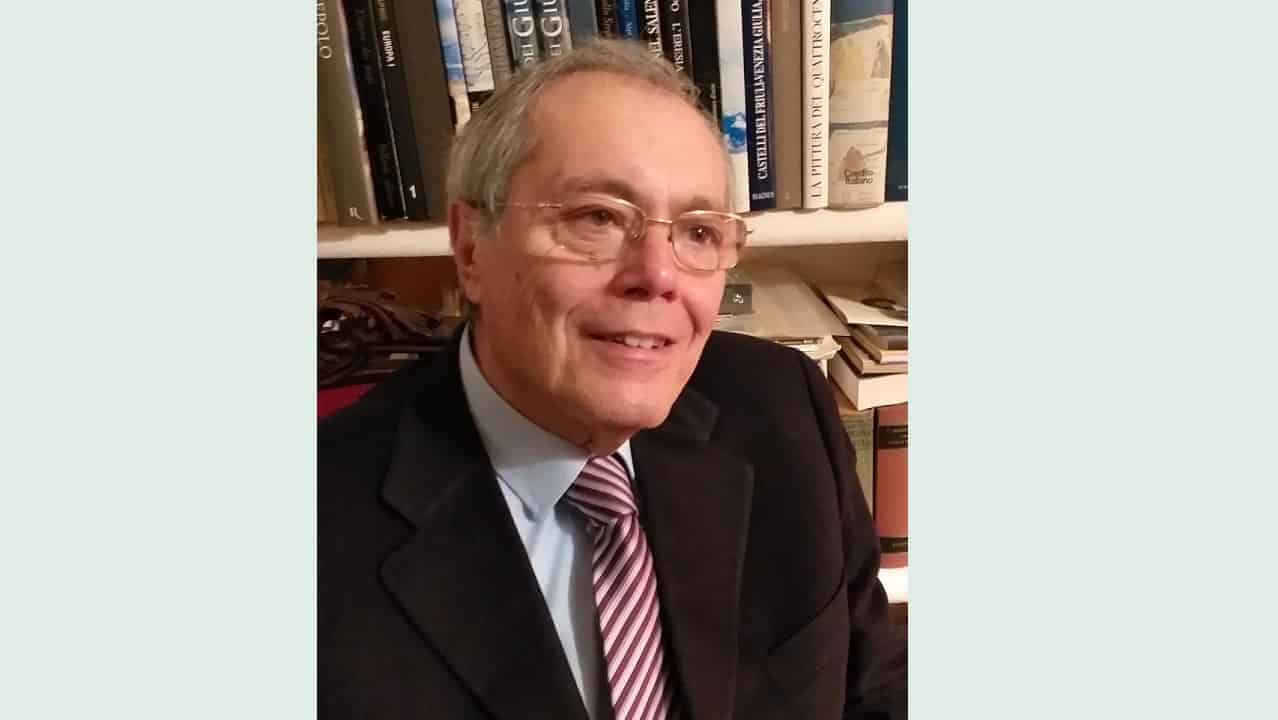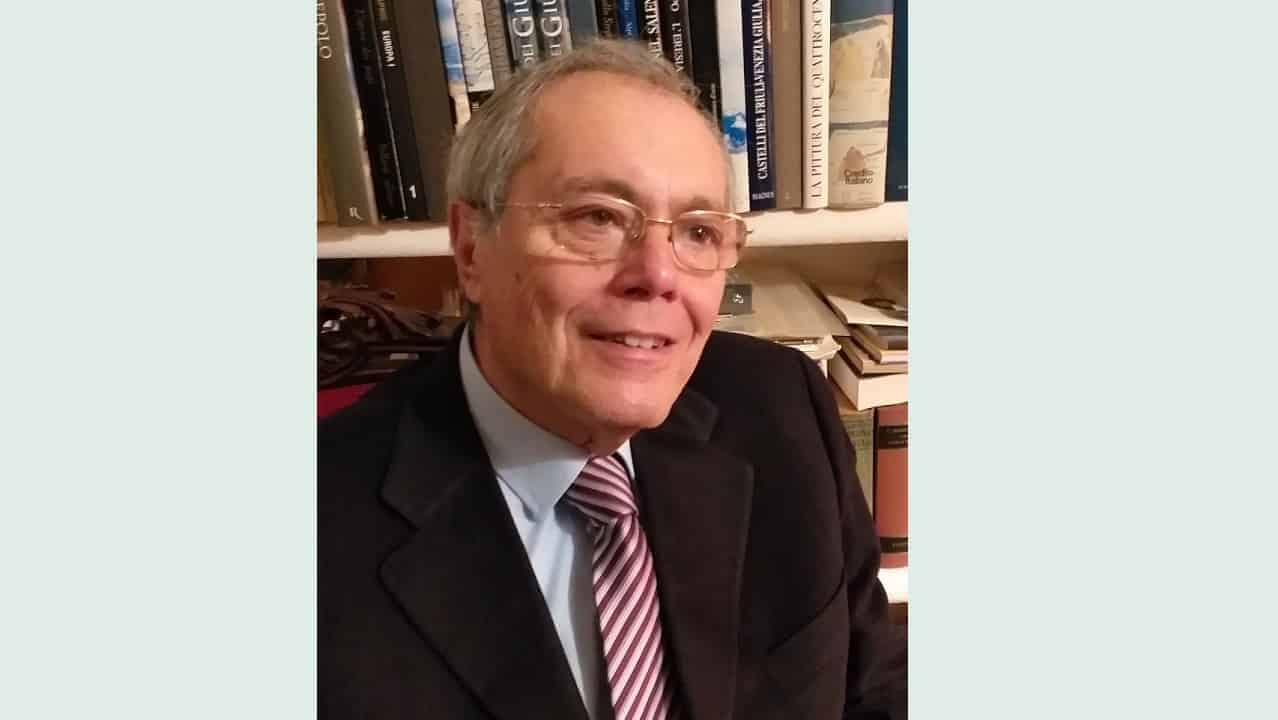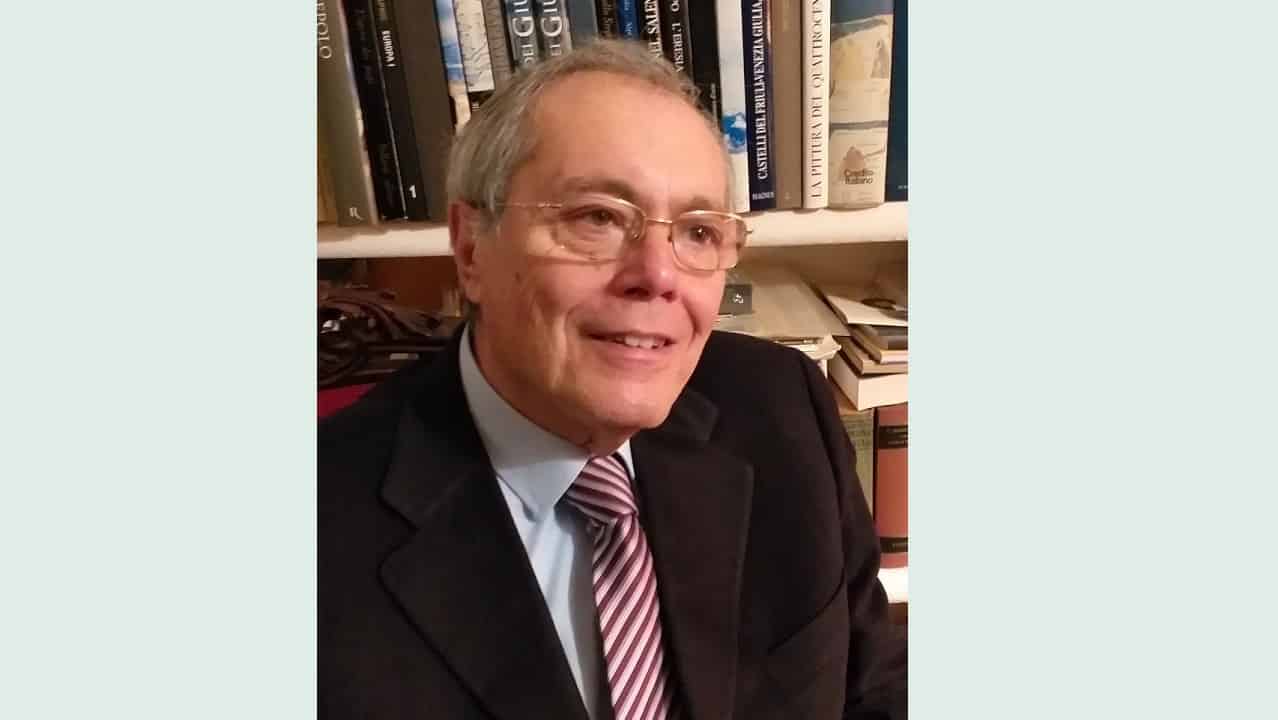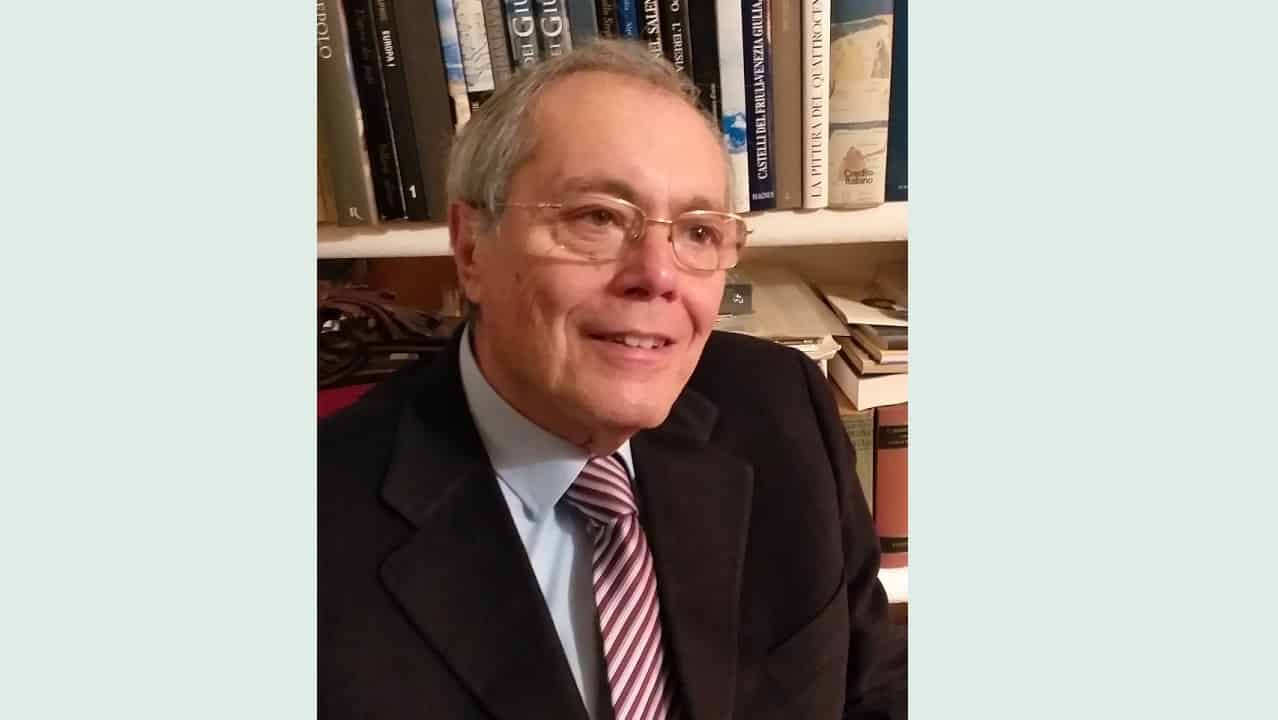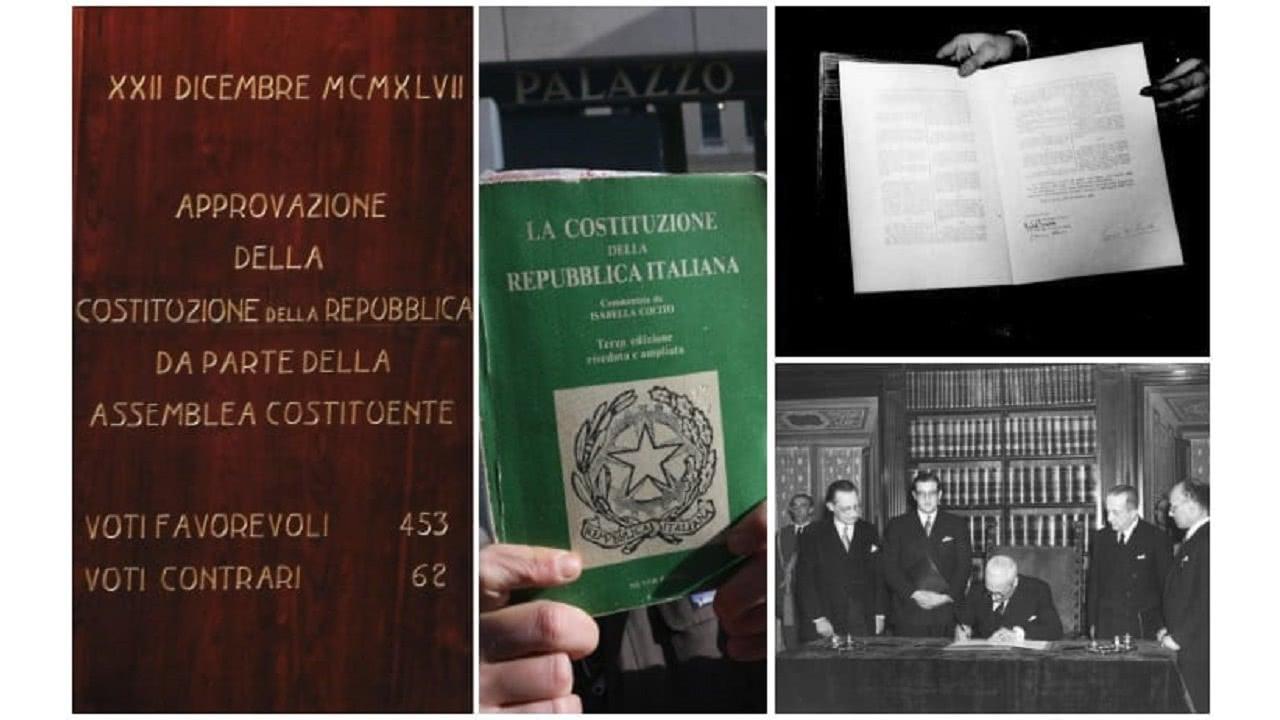Torno ad intrattenermi, sia pure con la massima rapidità, su Corte cost. n. 96 del 2025, dopo averne detto assai di recente [nel mio Ragionando attorno al “seguito” da dare a Corte cost. n. 96 del 2025 per le persone trattenute nei CPR, in questa Rivista, 8 luglio 2025], allo scopo di argomentare la tesi secondo cui, anche per il caso che la soluzione fatta propria dalla Consulta fosse stata diversa da quella adottata, l’esito della vicenda avrebbe comunque potuto risultare immutato.
Molte critiche sono – come si sa – cadute a pioggia sulla decisione in commento, facendosi in particolare notare che la Corte avrebbe potuto portare alle sue ultime e lineari conseguenze la tesi, con opportuni rilievi argomentata, della incompatibilità della disciplina sottoposta a giudizio con la Costituzione, specificamente in relazione all’art. 13. Insomma, il ragionamento svolto dal giudice costituzionale sarebbe stato ancora più solido se la pronunzia fosse stata di tipo ablativo.
Mi pongo, dunque, qui nei panni di coloro che non hanno risparmiato critiche pungenti alla Corte e m’interrogo su come quest’ultima, condividendone l’impostazione, avrebbe potuto darvi seguito. Faccio, perciò, mia stavolta la “tecnica” di rappresentazione scenica resa famosa dal film Sliding doors, diretto nel 1998 da Peter Howitt, sforzandomi di verificare quali avrebbero potuto essere i lineari svolgimenti dell’accoglimento delle questioni portate alla Consulta.
Ora, giusta la premessa per cui si è qui in presenza di una limitazione della libertà personale ed acclarate le carenze della disciplina in ordine ai “modi” della limitazione stessa, anziché far luogo – come ha fatto – ad una decisione d’inammissibilità, la Corte, impossibilitata a porre mano ad una puntuale e congrua indicazione degli stessi, avrebbe potuto avvalersi della tecnica decisoria dell’additiva di principio, specie per ciò che attiene al punctum crucis della questione, con riguardo cioè all’organo competente ad emettere il provvedimento restrittivo della libertà di cui all’art. 13 Cost. Ad essere, anzi, ancora più precisi avrebbe potuto dar vita ad una decisione sostitutiva di principio, indicando nel giudice al posto del prefetto l’organo in parola. Per vero, nel mio commento sopra richiamato mi sono sforzato di mostrare che siffatta sostituzione, operando su fonte di secondo grado, non avrebbe potuto aversi in sede di giudizio sulle leggi. Supponiamo, però, qui che essa ugualmente si fosse avuta o che un domani, restando immutato il quadro normativo vigente, si abbia, con conseguente rimozione immediata della previsione normativa in atto vigente.
Nulla di più, ad ogni buon conto, avrebbe chiaramente potuto dirsi nella 96, come pure in una prossima eventuale pronunzia del giudice delle leggi, in merito alla determinazione dei servizi da assicurare alle persone trattenute nei CPR, dovendosi a ciò provvedere con legge ovvero con altra fonte da questa comunque allo scopo espressamente chiamata in campo, fonte dunque anche di grado sublegislativo (nella specie, regolamentare), cui risulta congeniale la minuta indicazione dei servizi stessi.
Stando così le cose, mi preme qui fermare l’attenzione solo su un paio di punti, peraltro tra di loro strettamente connessi.
Il primo.
È noto che le pronunzie manipolative di principio si indirizzano, a un tempo, al legislatore ed ai pratici del diritto (amministratori e giudici). All’uno è fatto obbligo di dare adeguato svolgimento normativo alle indicazioni per essentialia somministrate dalla Corte; agli altri, di dare per l’intanto e ove possibile attuazione immediata e diretta alla norma o alle norme aggiunte dalla Corte. Tengo a precisare che si tratta, appunto, di un’attività di attuazione, non già di mera applicazione, richiedendo infatti, la stessa, in tesi, una produzione parimenti normativa, seppur con effetti circoscritti al caso, specificamente laddove posta in essere dal giudice comune.
Nella circostanza da cui ha avuto origine la pronunzia della Corte qui nuovamente annotata, una produzione siffatta non sarebbe stata comunque possibile, non trattandosi di estrarre dal principio somministrato dalla Corte stessa una regola puntuale e circoscritta da far valere per il caso, dal momento che la determinazione dei servizi da assicurare alle persone ristrette nella loro libertà personale – come si è venuti dicendo – avrebbe piuttosto richiesto un’articolata disciplina positiva non fattibile ad opera del giudice. Saremmo, dunque, stati in presenza di una decisione sostanzialmente destruens e minimamente construens, circoscritta per questo secondo aspetto – come si diceva – alla mera sostituzione del giudice con il prefetto, e bisognosa perciò di ricevere congruo seguito sul piano normativo al fine di potersi efficacemente implementare nell’esperienza.
Di qui, l’impossibilità per una persona ristretta per effetto di una decisione emessa da un’autorità radicalmente incompetente di seguitare a patire la limitazione della propria libertà in attesa dell’intervento regolatore da parte della legge e magari – come si è fatto poc’anzi notare – da parte altresì di atti di secondo grado idonei a dare a quest’ultima adeguato svolgimento.
Il secondo punto che mi preme qui rimarcare rimanda, poi, ad una generale questione, il cui esame ovviamente non può aversi in questa sede, di particolare rilievo per le vicende di giustizia costituzionale e di giustizia tout court; ed è quella relativa al carattere intercambiabile posseduto da alcune tecniche decisorie, in ispecie – per ciò che è ora d’interesse – da quella d’inammissibilità per rispetto del limite della discrezionalità del legislatore, contenente tuttavia l’accertamento della invalidità della normativa oggetto della questione portata alla cognizione della Corte, e dall’altra concernente le manipolazioni di principio dei testi di legge.
Sia chiaro. In occasione dell’adozione di una decisione della prima specie, in generale non si produce l’effetto che si ha in presenza di una decisione della seconda, in particolare non si offre l’opportunità a giudici ed amministratori di far luogo a quell’“attuazione” del principio di cui un momento fa si diceva. Non può, tuttavia, farsi passare sotto silenzio la circostanza per cui talora anche da pronunzie additive di principio non appare possibile – come si viene dicendo – estrarre regole immediatamente valevoli per la definizione del caso.
Dal punto di vista del legislatore, poi, laddove l’inammissibilità sia racchiusa, come qui, in una decisione d’incostituzionalità accertata ma non dichiarata, l’obbligo di facere a carico del legislatore stesso si ha ugualmente. Certo, non si dispone di meccanismi sanzionatori efficaci per assicurarne l’adempimento, nessuno potendo costringere manu militari il legislatore stesso ad un facere laddove non ne abbia l’intenzione. In passato, non si è mancato, anche da parte di chi scrive, di andare alla ricerca dei meccanismi in parola e si è persino ipotizzato l’eventuale riconoscimento del risarcimento del danno a beneficio di chi possa dimostrare di aver patito dall’inerzia del legislatore un’incisione in via diretta ed immediata in un proprio diritto fondamentale. Tesi che, forse, può essere giudicata ardita e che, ad ogni buon conto, è rimasta priva di ascolto tanto in dottrina quanto in giurisprudenza.
Il vero è che l’unico meccanismo davvero risolutivo può metterlo in atto solo la stessa Corte delle leggi, convertendo un’originaria pronunzia di rigetto in una di accoglimento idonea a portare al rifacimento del tessuto legislativo sfilacciato e risultante da materiali normativi incompatibili con la Carta, talora anzi a questa frontalmente contrapposti. Solo che, laddove di questa eventualità non possa, per una ragione o per l’altra, aversi riscontro, è giocoforza attendere la venuta alla luce di regole adeguate allo scopo da parte del legislatore.
Si torna così al punto di partenza. L’inammissibilità per rispetto del limite della discrezionalità del legislatore, al pari dell’additiva di principio, non può in alcune circostanze dare congruo ed immediato appagamento a beni costituzionalmente protetti; ed è triste riconoscere che – come si è veduto – talora non possono darlo neppure giudici ed amministratori.
L’unico effetto utile che può discendere da una manipolativa di principio che abbia avuto ad oggetto una disposizione normativa in applicazione della quale una persona sia stata privata della libertà personale e versi in una condizione di sostanziale detenzione è la sua immediata scarcerazione. Quest’effetto tuttavia – come si è tentato di argomentare nella mia precedente riflessione sul tema – può (e deve) aversi anche in conseguenza di una pronunzia d’inammissibilità che, nondimeno, al proprio interno racchiuda l’accertamento della incostituzionalità della disciplina positiva portata alla cognizione della Consulta. Lo ha correttamente stabilito la Corte d’appello di Cagliari, Sez. distaccata di Sassari (N.R.G. 290/2025 del 4 luglio 2025), della quale mi piace qui riprodurre, ancora una volta, fedelmente il pensiero: “in assenza di quella determinazione dei ‘modi’ della detenzione, non ‘ancora’ disciplinati dal legislatore con fonte primaria, non può che riespandersi il diritto alla libertà personale, il cui vulnus è chiaramente espresso dalla Consulta, perché qualunque ‘modo’ non disciplinato da norma primaria non riveste il crisma della legalità costituzionale ed è legalmente inidoneo a comprimerla” (altri riferimenti di giurisprudenza possono ora vedersi nella relazione tematica curata dall’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, n. 65 del 15 luglio 2025).
Si è, ancora da ultimo, opposto (dalla relazione dell’Ufficio Massimario e Ruolo della Cassazione, sopra già richiamata) che ragionare come hanno ragionato la Corte d’Appello di Cagliari ed altri giudici ancora, equivale in buona sostanza a “sterilizzare” la diversità di effetti delle decisioni d’inammissibilità e di quelle di accoglimento. Delle due, però, l’una: o si mette in atto la soluzione dell’immediata scarcerazione di persone limitate nella loro libertà personale per effetto di norme comunque acclarate come incostituzionali oppure si tiene fermo il vigore delle norme stesse, vale a dire si considerano le stesse come esistenti, pur se contrarie a Costituzione. Nel qual ultimo caso, l’unico modo per impedire loro di spiegare effetti, perdurando la colpevole inerzia del legislatore, è quello di farne oggetto di sistematiche questioni di costituzionalità, come ancora di recente patrocinato in un commento di A. Natale, dal titolo I CPR e la Costituzione. Il rischio di una impasse. Il rischio di zone franche, apparso su Quest. giust. il 7 luglio scorso. La qual cosa, però, equivale ad ammetterne appunto l’attitudine a produrre effetti.
Qui è, però, il punctum crucis della questione ora nuovamente discussa. Nella circostanza odierna, infatti, l’utilizzo di uno strumento di normazione in premessa improprio, irrispettoso della riserva assoluta di legge stabilita in Costituzione, comporta a mia opinione la radicale invalidità della disciplina in tal modo posta. È quanto, d’altronde, risulta con molta chiarezza dal passo sopra fedelmente trascritto dalla pronunzia del giudice sardo che racchiude in sé, implicitamente ma appunto palesemente, il riconoscimento del vizio di incompetenza assoluta di qualsivoglia disciplina, presente o futura, che comporti limitazione della libertà personale, senza provenire da legge o atto a questa equipollente, ovverosia il riconoscimento della invalidità in senso forte – come l’ha qualificata R. Guastini (Dalle fonti alle norme2, Giappichelli, Torino 1992, 207 ss.) –, della nullità-inesistenza insomma, non già della mera invalidità in senso debole, equivalente alla mera annullabilità, di disposizione non primaria che ne sia affetta. Detto con parole ancora diverse ma sostanziale identità di concetto, ogni disciplina limitativa della libertà personale stabilita con fonte di grado sublegislativo e non dotata perciò di un solido aggancio in disposti di legge che vi facciano rinvio è da considerare – per riprendere termini cari ad A. Spadaro (Limiti del giudizio costituzionale in via incidentale e ruolo dei giudici, ESI, Napoli 1990, 262 ss.) – anticostituzionale, più (o anzi) che incostituzionale, radicalmente viziata tamquam non esset appunto. Ed è appena il caso qui di rammentare che siffatto vizio radicale può essere da tutti acclarato, a partire ovviametne dai giudici.
Se ne ha che, per un verso, la disciplina sublegislativa sopra richiamata non richiede di essere formalmente rimossa con un atto di annullamento (anzi, a rigore, non sarebbe possibile farvi luogo, proprio perché in sé e per sé radicalmente nulla-inesistente) e, per un altro verso, in vicende quale quella che ha dato lo spunto per questa succinta riflessione, dal punto di vista degli effetti non si ha differenza alcuna tra una pronunzia d’inammissibilità che però accerti la sussistenza di un vulnus grave recato alla Carta costituzionale ed un’additiva o sostitutiva di principio non self executing, in entrambi i casi non potendosi avere che la restituzione della libertà a chi ne è stato indebitamente privato, in attesa che veda finalmente la luce una disciplina in tutto rispettosa della Carta e posta in essere con le forme giuste.