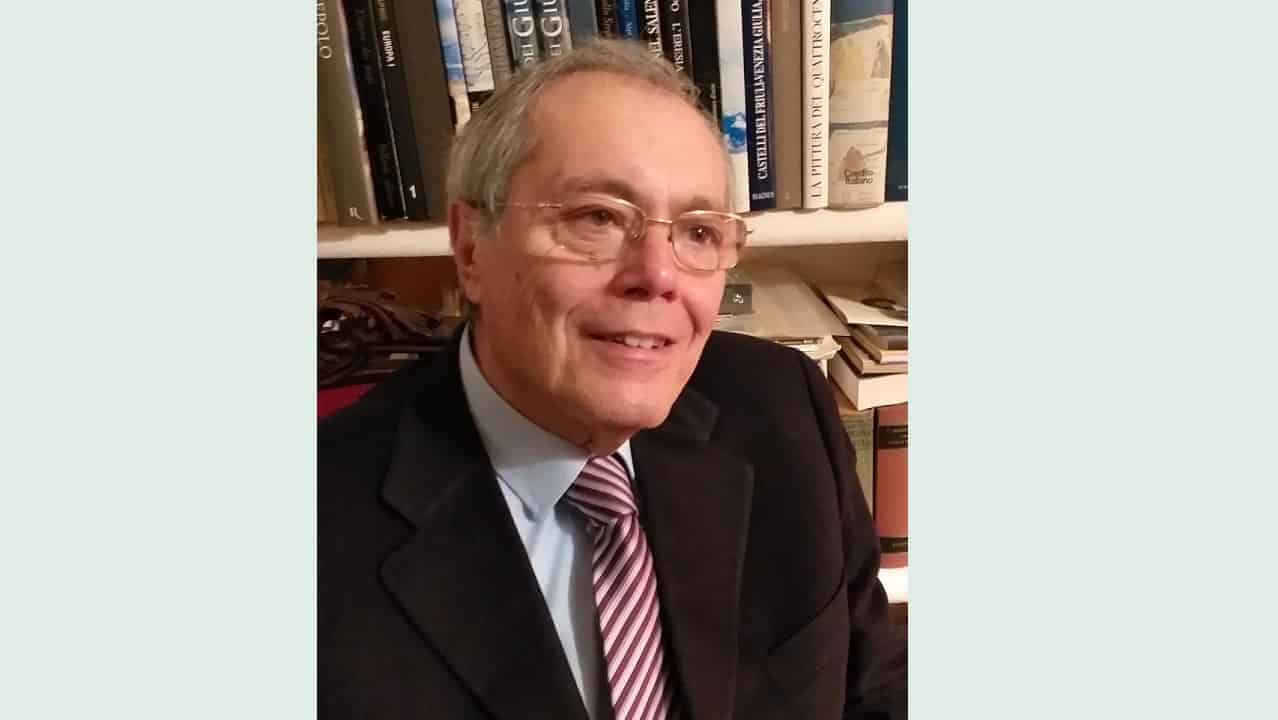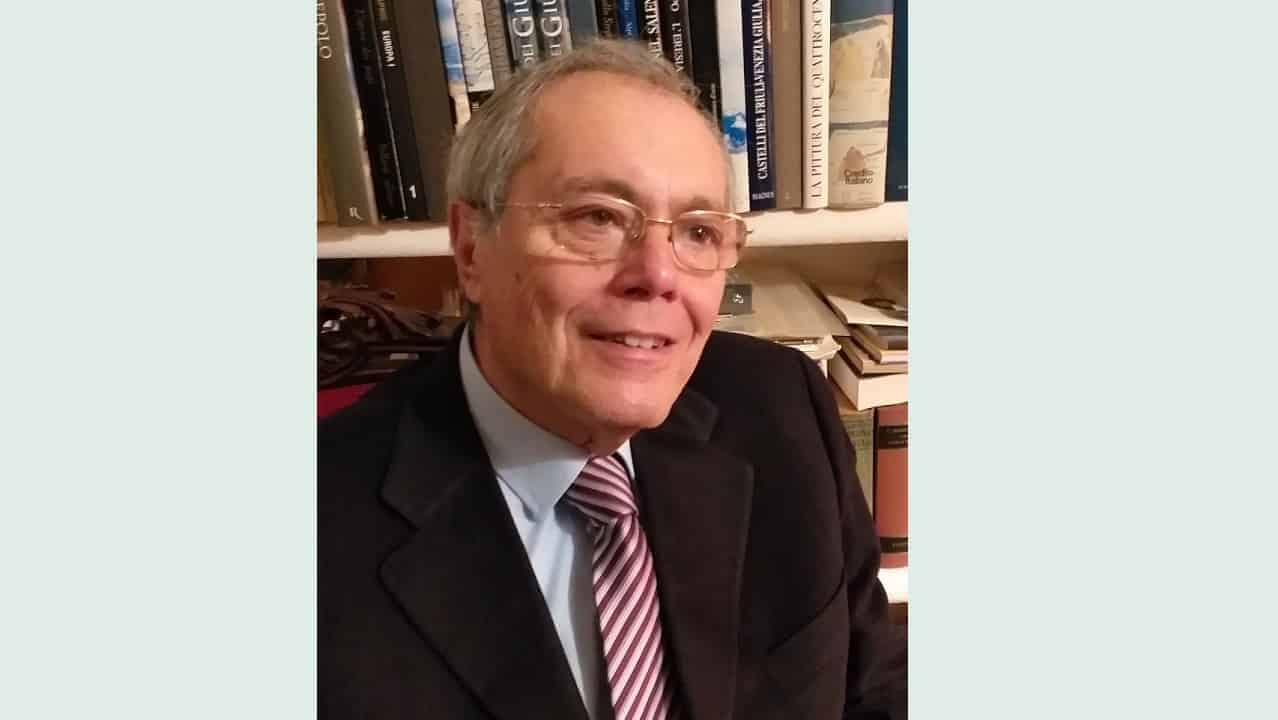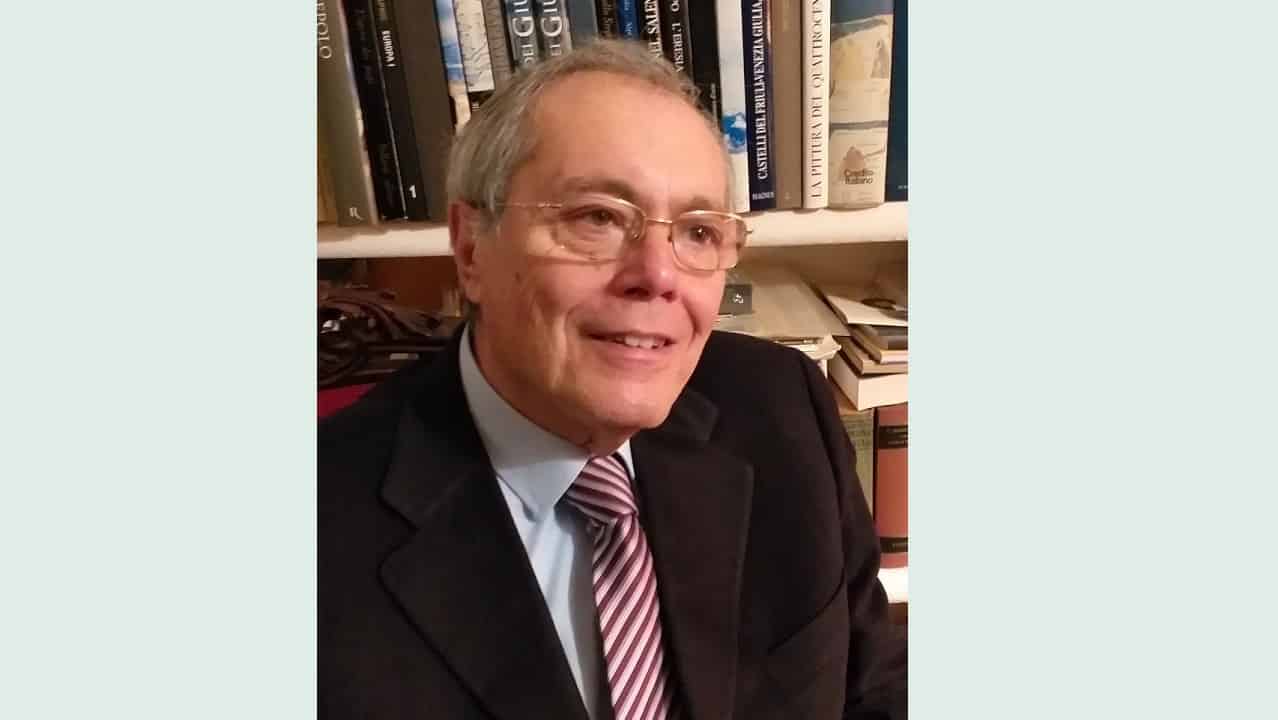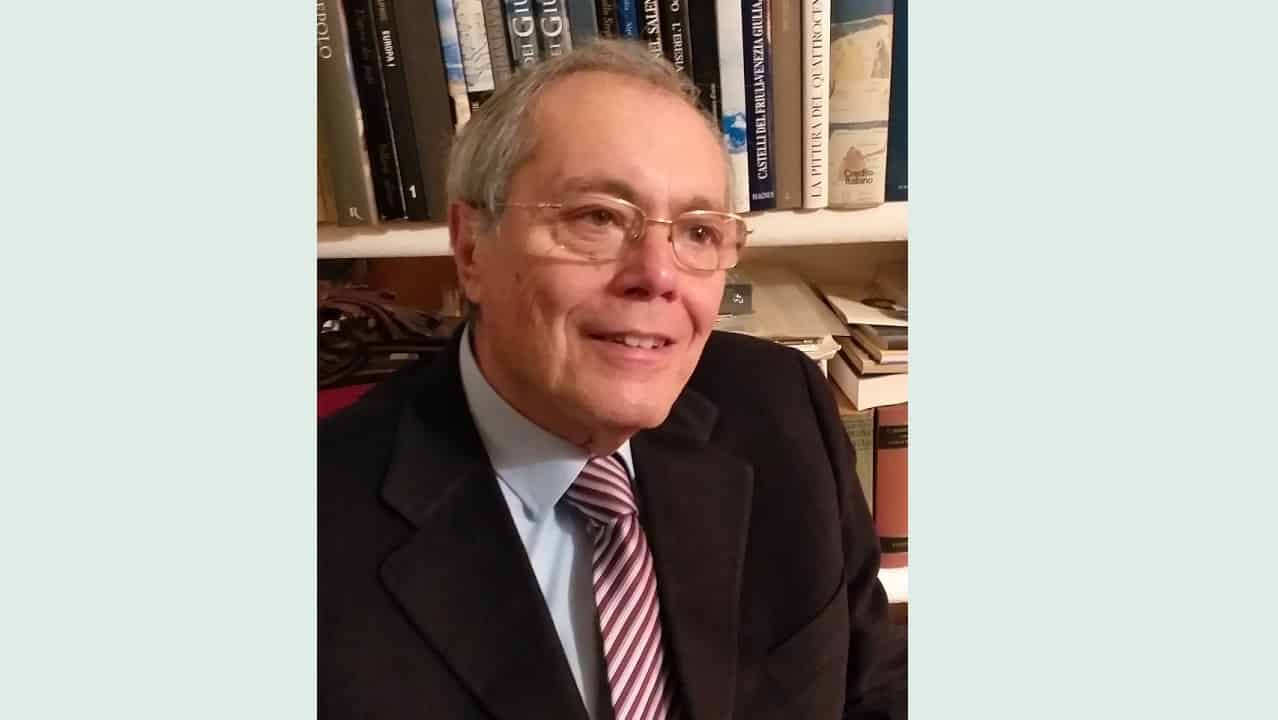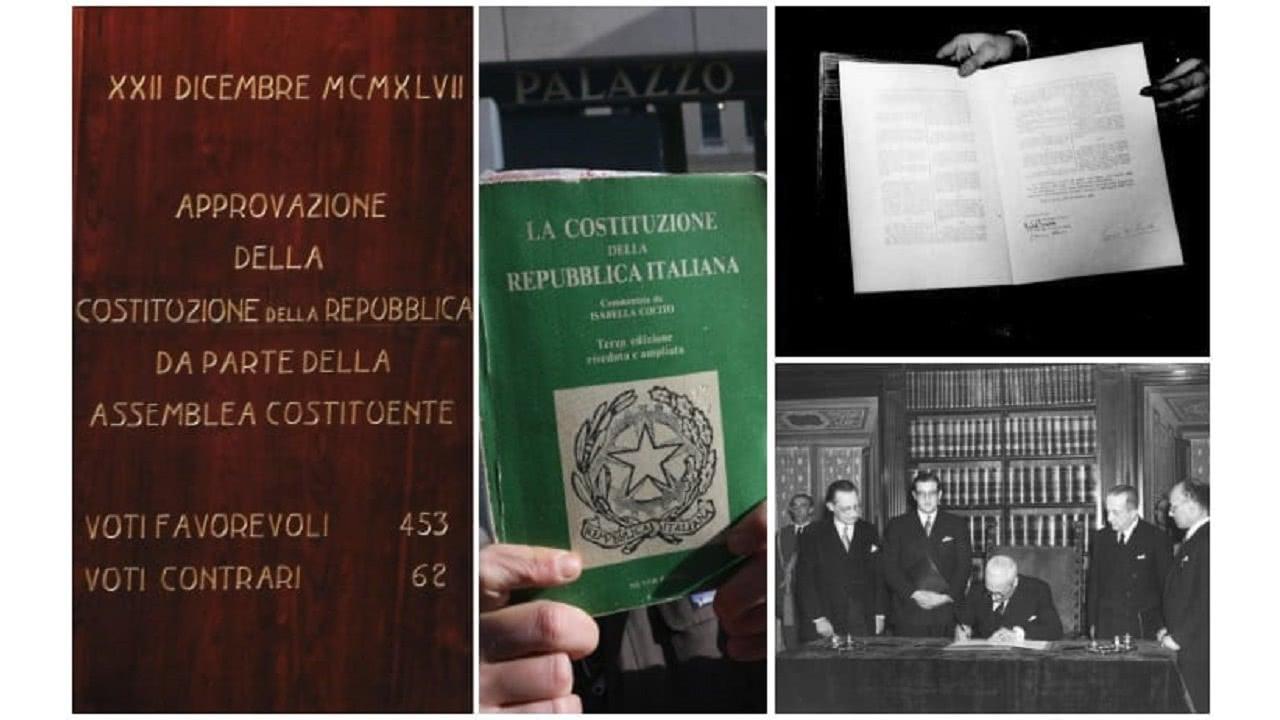Appena venuta alla luce, la pronunzia della Consulta concernente la sorte delle persone trattenute nei CPR ha subito animato un fitto dibattito tanto tra gli studiosi quanto in seno agli operatori (in ispecie ai giudici) che – è facile previsione – si espanderà rapidamente a macchia d’olio coinvolgendo una cerchia sempre più larga di commentatori.
La pronunzia appartiene di sicuro al genus delle decisioni d’incostituzionalità accertata ma non dichiarata; presenta, però, un tratto caratterizzante che la distingue da altre a questa pure, per taluni aspetti, simili in passato adottate. Più volte infatti – come si è ampiamente rilevato in dottrina[1] – si è fatto ricorso al “tipo” di decisione in parola all’esito di un’operazione di “bilanciamento” tra costi e benefici discendenti dall’eventuale caducazione della norma portata alla cognizione del giudice delle leggi; e, assumendo quest’ultimo, che i primi superino, talora di gran lunga, i secondi, si preferisce far luogo ad un verdetto che non aggravi ulteriormente il vulnus recato alla Carta costituzionale, quale invece si avrebbe per effetto della caducazione stessa[2]. Non si trascuri, perciò, che talora il vuoto di disciplina può essere ancora più incostituzionale del mantenimento della stessa o può portare alla “reviviscenza” di discipline risalenti esse pure, per ragioni varie, di problematica compatibilità con il dettato costituzionale o, come che sia, inidonee a dare appagamento a bisogni elementari della persona umana, a partire da quello – indisponibile – della salvaguardia della propria dignità.
Insomma, per dura che possa essere da digerire, la “logica” è quella del male minore.
È chiaro che la Corte perviene a quest’esito nell’assunto, da cui la stessa muove, che non le sia consentito mettere in atto una manipolazione del testo di legge, avendosene altrimenti una invasione del campo materiale riservato al legislatore e, dunque, una incisione dell’apprezzamento discrezionale di quest’ultimo, cui la Corte reputa di non poter appunto nella circostanza sovrapporre il proprio.
Ora, sul limite della discrezionalità del legislatore si è – come si sa – molto discusso e si potrebbe discutere ancora a lungo. Non è un caso, d’altronde, che in relazione a talune vicende in cui erano in gioco diritti fondamentali della persona, rimasti inappagati a causa del grave e perdurante letargo del legislatore, la Corte, magari dopo un iniziale rigetto della medesima questione accompagnato da un monito severo indirizzato al legislatore stesso, abbia rotto ogni indugio e fatto quindi luogo ad una sostanziale riscrittura di un testo normativo mal fatto, la cui incompatibilità rispetto alla legge fondamentale della Repubblica era già stata appunto acclarata ma non dichiarata.
Il caso odierno appare, tuttavia, essere parzialmente diverso. La disciplina legislativa c’era già da tempo. Solo che, muovendo dall’assunto che nella vicenda de qua si sia in presenza di una limitazione della libertà personale, i “casi” al ricorrere dei quali la limitazione stessa può aversi risultano sufficientemente normati, mentre fa difetto la determinazione dei “modi” con i quali la libertà in parola può essere compressa. La disciplina positiva, insomma, si articola in due parti, l’una giudicata congrua, l’altra priva di riscontro alcuno in fonti normative di rango primario.
Non si è, dunque, in presenza di alcun “bilanciamento”, nel senso sopra precisato, che investa l’intera disciplina sub iudice. C’è l’accertamento di una invalida omissione legislativa, parziale e però – a dire della Corte – non rimediabile a mezzo degli strumenti processuali che la Corte stessa si è forgiata e che ha con il tempo progressivamente arricchito ed affinato.
La disciplina, in realtà, si ha ma – come si dirà a momenti – non risponde alle indicazioni dell’art. 13 Cost.; e, in quanto proveniente da una fonte priva di valore di legge, non avrebbe potuto (e, così com’è, non potrebbe) essere caducata in sede di giudizio sulle leggi ed atti a queste equiparati.
Si ha qui un meccanismo, dal legislatore molte volte allestito nei campi più varî di esperienza ed in relazione alle parimenti più varie esigenze di regolazione, che somiglia alle classiche scatole cinesi, ovverosia – ove si preferisca ricorrere ad altra immagine – si ha una “catena” di atti, normativi prima e di amministrazione poi, strutturalmente e funzionalmente connessi e conducenti alla produzione di un unico, finale effetto. Per dir meglio, è chiaro che ogni atto ha un proprio effetto, non concependosi alcun atto che ne sia privo così come, circolarmente, nessun effetto che non consenta di risalire alla fonte che lo produca. Ciò che, però, maggiormente conta è l’effetto globale, unitario appunto, della “catena”.
Occorre, dunque, vedere come gli atti evocati in campo dal caso qui specificamente interessante si compongano in unità significante.
Giusta la premessa secondo cui il “trattenimento dello straniero presso centri di permanenza e assistenza comporta una situazione di ‘assoggettamento fisico all’altrui potere’” (Corte cost. n. 96 del 2025, p. 9 del cons. in dir., ed ivi richiami di giurisprudenza anteriore), risulta di conseguenza avvalorato il carattere restrittivo[3] della libertà personale e, con esso, la natura assoluta della riserva di legge cui l’art. 13 rinvia in ordine alla disciplina dei “casi” e dei “modi” di limitazione della libertà stessa.
Qui, per vero, la pronunzia della Corte parrebbe non essere esente di qualche oscillazione, dal momento che, per un verso, parrebbe accontentarsi di una regolamentazione con legge dei “modi” stessi “nel loro nucleo essenziale” (p. 10.1 del cons. in dir.), mentre per un altro verso sollecita la legge a dare una “disciplina compiuta” (si direbbe, perciò, ben oltre il “nucleo”…), comunque idonea ad assicurare “un’adeguata base legale” ad alcune istanze dalla stessa Corte in via esemplificativa indicate, in relazione “alle caratteristiche degli edifici e dei locali di soggiorno e pernottamento, alla cura dell’igiene personale, all’alimentazione, alla permanenza all’aperto, all’erogazione del servizio sanitario, alle possibilità di colloquio con difensore e parenti, alle attività di socializzazione” (p. 11 del cons. in dir.).
Ebbene, tutto ciò non si ha in forza di quanto disposto dall’art. 14, II c., d.lgs. n. 286 del 1998, che rimanda all’art. 21, VIII c., d.P.R. n. 394 del 1999, il quale a sua volta rimanda per la determinazione dei servizi da assicurare alle persone trattenute nei CPR a misure adottate dal prefetto, sentito il questore, e in esecuzione di direttive impartite dal Ministro dell’interno.
La “catena”, dunque, si compone di un atto avente forza di legge solo per il suo “anello” iniziale, di una fonte di secondo grado per l’“anello” centrale e, quindi, di “anelli” risultanti da provvedimenti amministrativi: è, insomma, una “catena” mista, risultante da atti di normazione, aventi grado diverso, e da atti di amministrazione.
Stando così le cose, lo scostamento dal disegno costituzionale appare evidente ed avrebbe pertanto meritato una conclusione ben diversa da quella cui è pervenuta la Corte.
Se la riserva di legge posta nell’art. 13 è di tipo assoluto (e non si ha motivo di dubitare che sia così), nessuna manipolazione del dettato legislativo è qui possibile, dal momento che sarebbe comunque fuori bersaglio. Il marcio è, infatti, nella disciplina sublegislativa, specificamente nella parte in cui individua nel prefetto, e non già nel giudice, l’organo competente a porre in essere le misure che riguardano le persone trattenute nei CPR. Solo che, risultando la disciplina stessa da fonte di secondo grado, nessuna pronunzia manipolativa (nella specie, sostitutiva) può riguardarla, risultando pertanto immune dall’opera sanatoria della Corte.
L’opposta soluzione potrebbe essere accolta unicamente a ragionare nel senso che la fonte di primo grado abbia fatto luogo ad un rinvio ricettizio della fonte secondaria. Viene, però, assai arduo immaginare che, specie in una materia quale questa in cui si fa questione di limitazioni alla libertà personale, la legge o atto equipollente ci abbia consegnato una pagina bianca da riempire a piacimento da parte di un futuro atto di secondo grado. Cosa diversa sarebbe stata se il rinvio ricettizio fosse stato fatto nei riguardi di una disciplina già conosciuta dal legislatore e da questi giudicata appunto idonea ad assicurare il rispetto delle condizioni poste dalla Carta costituzionale.
Il difetto di una normazione concernente profili della disciplina legislativa dalla Carta stessa considerati essenziali, allo stesso tempo in cui rende viepiù evidente l’obbligo del legislatore di attivarsi con la massima sollecitudine per colmare la lacuna legislativa acclarata dalla Corte, non consente, per l’intanto, soluzione alcuna diversa da quella della impossibilità di mettere in atto qualsivoglia misura limitativa della libertà personale.
Di cristallina chiarezza ai miei occhi appare, dunque, la conclusione del giudice della sezione specializzata della Corte d’appello di Cagliari, Sez. distaccata di Sassari (N.R.G. 290/2025 del 4 luglio 2025): “in assenza di quella determinazione dei ‘modi’ della detenzione, non ‘ancora’ disciplinati dal legislatore con fonte primaria, non può che riespandersi il diritto alla libertà personale, il cui vulnus è chiaramente espresso dalla Consulta, perché qualunque ‘modo’ non disciplinato da norma primaria non riveste il crisma della legalità costituzionale ed è legalmente inidoneo a comprimerla”.
[1] Riferimenti possono, volendo, aversi da A. Ruggeri - A. Spadaro, Lineamenti di giustizia costituzionale7, Giappichelli, Torino 2022, spec. 227.
[2] Insomma, è come nei casi di accertamento implicito di colpevolezza contenuto nell’involucro di una pronuncia formalmente proscioglitiva, cosa che può avvenire per varie ragioni (estinzione del reato, mancanza di una condizione obiettiva di punibilità, ecc.).
[3] … e, persino, privativo, stando ai criteri elaborati dalla Corte EDU sin dal caso Asinara.