
GIUSTIZIA INSIEME
ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma
ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma
Integrazione postuma della motivazione ed esaurimento della discrezionalità (nota alla sentenza n. 361 del 26.1.2024 del TAR Sicilia - Catania, IV sezione)
di Ludovico Di Benedetto
Sommario: 1 - Sintesi del fatto; 2 - Inquadramento e fondamento giuridico; 3 - Ammissibilità dell’integrazione conservativa ed esaurimento della discrezionalità; 4 - L’integrazione postuma alla prova dei fatti; 5 - Conclusioni: il delicato equilibrio tra poteri costituzionali.
1 - Sintesi del fatto
La sentenza in commento concerne un procedimento amministrativo connotato da discrezionalità tecnica (concorso pubblico), a fronte del quale si staglia un interesse legittimo pretensivo del ricorrente (ottenimento dell’incarico). La ricostruzione della parte in fatto è piuttosto agevole. Il contenzioso origina dall’impugnazione, ad opera del privato, della determinazione con la quale l’autorità pubblica, all’esito della procedura concorsuale, negando di procedere alla stipula del contratto di lavoro col primo della graduatoria, ha dichiarato vincitore il secondo classificato. La pretermissione del ricorrente è stata giustificata dall’accertamento del rinvio a giudizio per alcuni reati che, in forza delle previsioni del bando, avrebbero portato all’estromissione dalla gara qualora consolidati in cosa giudicata.
Avviato il contenzioso amministrativo, l’autorità pubblica ha emanato un nuovo provvedimento a mezzo del quale ha convalidato la precedente delibazione, specificandone le ragioni. Questo secondo atto è stato ritualmente avversato dalla parte ricorrente con motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a., adducendo, tra l’altro, un’inammissibile integrazione postuma della motivazione provvedimentale.
Il giudice amministrativo si è pronunciato con la sentenza in commento[1]. Dichiarato improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse alla luce del più recente provvedimento, quello per motivi aggiunti è stato rigettato nel merito. In sintesi e per quanto qui rileva, il collegio, richiamando un nutrito filone giurisprudenziale, ha ritenuto legittima l’integrazione successiva, in quanto operata non tramite atti processuali, bensì per mezzo di un autonomo intervento in sede amministrativa - nella specie, un provvedimento conservativo di secondo grado.
La pronuncia in commento si segnala dunque per aver assecondato la direttrice che conferisce piena cittadinanza nel nostro ordinamento, sebbene entro puntuali limiti, alla cosiddetta integrazione postuma della motivazione lite pendente. Questa tematica, in particolare, merita un excursus, al fine di comprenderne caratteri e disciplina sostanziale. Lo studio propone inoltre un collegamento con l’idea della riduzione della discrezionalità amministrativa anche per mezzo di un contegno procedimentale o processuale da parte della p.a., secondo la dottrina del one shot. La sentenza del TAR pare perciò un’ottima occasione per chiarire i recenti sviluppi in materia.
2 - Inquadramento e fondamento giuridico
La pronuncia in analisi dà per presupposta la nozione di integrazione postuma della motivazione, senza spendere parole sul punto. È bene precisare che con tale formula e altre consimili[2] si fa riferimento al fenomeno per cui l’amministrazione, parte resistente in un giudizio di impugnativa provvedimentale ormai pendente, completa la parte motiva dell’atto avversato con elementi di fatto e di diritto a suo tempo non esplicitati ma già presenti nella fattispecie[3], al dichiarato fine di evitare l’annullamento giurisdizionale per vizio motivazionale.
L’istituto non possiede, nel nostro ordinamento[4], un’esplicita base normativa; questa è una delle principali ragioni del ricco dibattito, pretorio e dottrinale, circa la sua ammissibilità. Prima però di approfondire quest’ultimo aspetto[5], è pregiudiziale risolvere alcuni nodi per comprendere i confini della figura, cioè quello della base normativa e quello della distinzione da istituti affini.
Dietro l’etichetta integrazione postuma si celano almeno tre significati[6], tutti accomunati da un elemento processuale (la pendenza di un’azione di annullamento) e da uno sostanziale (il provvedimento è viziato dal lato motivazionale e pertanto, in astratto, il contenzioso dovrebbe risolversi a favore del ricorrente; l’esito sfavorevole per la parte pubblica viene però evitato, appunto, a mezzo dell’integrazione). Le tre decodificazioni che si propongono sono le seguenti: la p.a. integra il profilo motivazionale per mezzo degli scritti difensivi presentati nel processo; il giudice amministrativo ricostruisce la complessiva motivazione provvedimentale sulla base di atti che sono ricavabili dal procedimento amministrativo e sono stati acquisiti al processo (cosiddetta motivazione implicita); il soggetto pubblico colma il vizio motivazionale tramite un sopravvenuto e autonomo atto di manutenzione.
La prima variante è generalmente ritenuta immeritevole di riconoscimento[7]; lo afferma testualmente proprio la decisione in oggetto. Piuttosto agevole capire le ragioni di questa esclusione: sul piano delle attribuzioni, non può il difensore della parte pubblica resistente assumere le vesti dell’amministrazione, in totale spregio dell’ordine legale delle competenze, fornendo valutazioni e operando decisioni che l’ordinamento riserva alla p.a.. Sul piano delle garanzie individuali, inoltre, l’integrazione avverrebbe al di fuori della cornice procedimentale fissata dal legislatore.
Quello che semmai si potrebbe arrivare a concepire, come propone autorevole dottrina[8], è che questa casistica, ridondando nella seconda sopra individuata, risulti in definitiva ammissibile. Non si tratterebbe più allora di un completamento motivazionale offerto con gli atti di parte, ma di allegare al processo tutto il materiale necessario per guidare il giudice nella comprensione della fattispecie, magari su impulso giudiziario ex art. 64 c. 3 c.p.a.. Ciò non significa che la giustificazione errata venga ampliata indicando nuove ragioni di fatto o di diritto, non potendo essere presentati elementi che non siano stati precedentemente menzionati nella motivazione. Invece, è da intendersi come la spiegazione più dettagliata di componenti già esistenti, ma non chiaramente formulate. In questi termini, il centro dell’analisi si sposta dal difensore (comunque sempre abilitato, al pari della controparte, a presentare elementi utili a fini difensivi) all’organo giudicante, chiamato, grazie al principio dispositivo e al contraddittorio endoprocessuale, a enucleare il sostrato della contesa (art. 32 c. 2 c.p.a.).
Si potrebbe dunque ritenere che la condotta processuale dell’amministrazione, se non propriamente in grado di integrare la motivazione dell’atto avversato, quantomeno sia idonea a fare luce sul rapporto sotteso (un po’ come se fossero dei chiarimenti ex art. 63 c. 1 c.p.a. non richiesti d’ufficio dal magistrato, ma offerti unilateralmente dalla parte resistente).
La giurisprudenza, invero, ha in alcune pronunce[9] assecondato questa ricostruzione, pur confinandola al rispetto di precisi presupposti, estrapolati dal tessuto costituzionale (su tutti, il diritto di difesa, art. 24 Cost., e l’equo processo, artt. 111 e 113 Cost.) ed erti per evitare che il giudice abusi delle sue prerogative[10]. Dunque, l’integrazione-chiarimento può trovare spazio nel nostro ordinamento, a patto che concerna provvedimenti vincolati, che il completamento non metta in discussione il diritto di difesa del ricorrente (recte: che quest’ultimo possa comunque contestarlo, nel medesimo processo), che gli elementi addotti siano in realtà già evincibili dalla complessiva dinamica procedimentale[11].
Due sembrano essere i capisaldi su cui poggia questa ricostruzione: l’uno, condivisibile, risiede nella distinzione tra giustificazione e motivazione in senso stretto; l’altro, più opinabile, nel richiamo, a volte implicito, altre esplicito, all’art. 21 octies c. 2 della l. 241/1990.
La dicotomia giustificazione-motivazione, con la prima intendendosi l’indicazione dei presupposti legali e fattuali del potere e con la seconda la enunciazione dell’iter logico seguito per emanare il provvedimento, ha radici lontane[12] e può essere qui ripresa nel senso che per gli atti vincolati, non venendo in gioco alcuna valutazione discrezionale, sarebbe sufficiente indicare la mera giustificazione. In tali evenienze, quindi, il successivo contegno della parte pubblica in sede processuale, anche desumibile dagli scritti difensivi, sarebbe idoneo non già ad integrare una motivazione che tale strettamente non è, quanto piuttosto a puntualizzare il provvedimento stesso nei suoi aspetti formali. Si avrà così un’integrazione postuma della giustificazione, tollerabile al ricorrere degli indicati presupposti[13].
L’altra colonna portante di questa interpretazione è, come detto, l’art. 21 octies c. 2, primo alinea. Se il provvedimento è vincolato ed il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, i vizi motivazionali che lo affliggono, intesi come patologie meramente formali, non possono condurre alla sua invalidazione. L’idea è dunque quella di dequotare[14] il vizio di motivazione a vizio di forma non invalidante secondo la disciplina sinteticamente richiamata. Queste conclusioni non sono in verità generalmente accolte. Tralasciando ardite tesi[15] che addirittura pervengono ad elevare la motivazione ad elemento essenziale del provvedimento, la cui mancanza ne comporterebbe la nullità strutturale ex art. 21 septies, è prevalente l’impostazione[16] che ritiene la patologia motivazionale come vizio sostanziale (per lo più, eccesso di potere), non sussumibile nella regolamentazione di cui all’art. 21 octies c. 2.
Non rimane, a questo punto, che approfondire il tema concernente l’ultima e più discussa casistica, quella che più propriamente si indica come integrazione postuma della motivazione, cioè il completamento adoperato per mezzo di un sopravvenuto atto conservativo. Tale sembra essere peraltro la lettura che i giudici del TAR Sicilia offrono riguardo il secondo atto emanato dall’amministrazione resistente. Su questo ci soffermeremo nel paragrafo seguente.
3 - Ammissibilità dell’integrazione conservativa ed esaurimento della discrezionalità
L’amministrazione è riconosciuta generalmente come titolare non solo di poteri di autotutela caducatori, cioè volti ad eliminare una previa statuizione (secondo i limiti previsti dagli artt. 21 quinquies e nonies, primo comma, della l. 241/90, dedicati l’uno alla revoca, l’altro all’annullamento ufficioso), ma anche di potestà di autotutela conservativa o manutentiva, finalizzate cioè a salvaguardare la precedente attività da una possibile invalidazione[17]. Quest’ultima forma di potere di secondo grado trova, dopo la novella avvenuta con la l. 15/2005, una base normativa espressa nel testo dell’art. 21 nonies c. 2 l. 241/90, dedicato alla convalida[18], ma vi si riflettono, in senso più ampio, altre varianti[19], tutte accomunate da una medesima ratio di fondo, il principio di conservazione e di economicità dell’azione amministrativa, per lo più ricondotto a sua volta al canone costituzionale di buon andamento-efficienza (art. 97 Cost. e art. 1 c. 1 l. 241 cit.)[20].
In questo contesto, è cruciale diffondersi sulla figura della convalida[21]. Per mezzo di questo strumento, la legge abilita l’amministrazione competente ad emendare i propri atti afflitti da un vizio di legittimità, evitandone così l’annullamento, attraverso una postuma manifestazione di volontà, avente efficacia ex tunc[22] e volta proprio a conservare la delibazione prodotta, sempreché ciò avvenga entro un termine ragionevole e corrisponda ad un pubblico interesse (il comma secondo dell’art. 21 nonies è in questo senso costruito simmetricamente al comma primo). Ne scaturisce una fattispecie complessa, per cui al provvedimento viziato - che rimane tale, essendo stato già emanato - si salda una successiva manifestazione di volontà della p.a. da cui far scaturire una “sintesi effettuale autonoma”[23], stavolta immune dai vizi convalidati.
I requisiti, dunque, della convalida sono, oltre ovviamente alla presenza di un atto annullabile[24], una sopravvenuta manifestazione di volontà del soggetto pubblico, secondo i più ritenuta, sulla falsariga dello schema civilistico, necessariamente esplicita[25]: la p.a., cioè, dovrà indicare il vizio e la chiara intenzione di porvi rimedio (animus convalidandi). In aggiunta, devono ricorrere ragioni di pubblico interesse, ossia il consolidamento dell’atto al fine di dare certezza e stabilità ai rapporti giuridici[26], e il rispetto di un termine ragionevole dall’emanazione, onde equilibrare l’esigenza conservativa con il legittimo affidamento dell’istante[27]. Infine, presupposto negativo della convalida è che questo strumento non porti ad uno snaturamento funzionale e contenutistico della decisione amministrativa, sotto pena di eccesso di potere.
Tutto ciò premesso in via generale, si deve affrontare una questione fondamentale ai fini del presente studio, e cioè se sia convalidabile il vizio di motivazione (sub specie di eccesso di potere)[28] e, in caso di risposta affermativa, se sia possibile farlo in corso di giudizio, esemplificando così la fattispecie surrichiamata della integrazione postuma della motivazione[29].
Mentre si ritiene comunemente che le patologie formali siano passibili di convalida[30], maggiori dubbi emergono ove si abbia a che fare con vizi sostanziali[31], da intendere come la mancanza di presupposti legali ovvero l’irragionevolezza della delibazione. La giurisprudenza, dal canto suo, ha di recente[32] confermato la distinzione, proprio in tema di motivazione: qualora l’inadeguatezza motivazionale rispecchi un vizio sostanziale della funzione (in termini di contraddittorietà, travisamento, difetto dei requisiti), la convalida è squalificata, in quanto essa non potrebbe mai assicurare il permanere, senza mutamenti, del dispositivo originale; qualora invece la patologia corrisponda solamente ad una insufficiente rappresentazione della parte motiva oppure al non corretto riepilogo della medesima, la convalida risulta ammissibile, affiorando un mero vizio formale dell’atto. Come vedremo nelle battute finali di questo paragrafo, in verità, la teorica del one shot può condurci ad una conclusione ancor più netta, e cioè ad ammettere la cosiddetta convalida persino per vizi sostanziali.
Per quanto concerne il parallelo profilo dell’integrazione lite pendente, l’impostazione tradizionale è stata in prevalenza di avviso contrario[33]. Una volta attivato un processo, come quello amministrativo ante codicem, incentrato prettamente sul momento formale del provvedimento, ammettere la convalida in corso di giudizio avrebbe significato dar la possibilità alla parte pubblica resistente di disporre unilateralmente del thema decidendum, deturpando le prerogative dell’organo giudicante - già adito - in uno con le garanzie difensive del ricorrente[34], di fatto costretto a ricorsi al buio, cioè promossi solo per poter arrivare a conoscere l’effettiva motivazione che anima la deliberazione amministrativa. Una prassi del genere, inoltre, avrebbe comportato la degradazione della motivazione a mero elemento accidentale[35], da addurre solo se e in quanto venga promossa un’iniziativa processuale[36].
A conferma dell’impostazione, si aggiunge che il legislatore, con ciò comprovando il principio generale di segno negativo, ha ammesso expressis verbis eccezionalmente la ratifica del provvedimento, cioè la convalida dell’atto viziato sotto il solo profilo dell’incompetenza relativa[37], escludendo a contrario tutte le altre.
I postulati che sosterrebbero l’inammissibilità dell’integrazione paiono, però, oggi sgretolarsi, con le riforme del processo amministrativo che hanno visto la luce negli ultimi anni[38]. Innanzitutto, l’oggetto del processo non può più dirsi confinato all’esclusivo fronte attizio, ma si è esteso ben oltre (fino a ricomprendere il rapporto pubblicistico tra p.a. e privato, secondo taluni)[39]. Esemplificazioni di questo passaggio sono rinvenibili oltre che nell’art. 21 octies c. 2 cit., negli artt. 7, 31 c. 3, 34 c. 1 lett. c) e 55 del codice. La metamorfosi, si badi, non investe solamente l’attività amministrativa vincolata, ma anche quella discrezionale.
I paventati rischi di elusione dei principi di parità delle armi e di fairness processuale sono peraltro fugati dai nuovi meccanismi processualistici, su tutti i motivi aggiunti (art. 43 c.p.a.), che permettono di mantenere l’equilibrio tra le posizioni dei litiganti: fatta la convalida-integrazione, il ricorrente ben potrà, alternativamente, rimanere inerte ed attendere l’accertamento dell’improcedibilità del processo per sopravvenuta carenza di interesse (potrebbe in tesi pensarsi anche all’estinzione per rinuncia al ricorso) oppure coltivare il contenzioso ed impiegare i motivi aggiunti per avversare, insieme con l’atto originario, quello di convalida (per vizi propri e/o per assunta inammissibilità tout court dell’integrazione)[40].
Che la p.a. poi rimanga titolare del potere di intervenire anche in autotutela, nonostante l’iniziativa processuale, lo dimostrano sia l’assenza dell’automatico effetto sospensivo del ricorso, sia la disciplina della cessazione della materia del contendere, che logicamente presuppone l’ammissibilità di una iniziativa postuma.
A rigore, inoltre, una volta ammessa la risarcibilità dell’interesse legittimo per provvedimento invalido, negare l’integrazione della motivazione, equivarrebbe ad impedire alla p.a. di adoperarsi, in armonia con i doveri solidaristici di cui all’art. 2 Cost., per cancellare o quantomeno attenuare le conseguenze dannose della propria condotta.
In ogni caso, dandosi per buona questa impostazione, non si può lasciare carta bianca alla parte pubblica. Innanzitutto, al ricorrente deve essere riconosciuto il diritto di agire per il risarcimento danni contro il funzionario responsabile (art. 28 Cost.)[41].
Ci si aspetta inoltre un ragionevole riparto delle spese processuali, dal momento che, seguendo altrimenti le ordinarie regole in materia (artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c.), sarebbe il privato a doversi sobbarcare i costi del processo, in quanto soccombente a seguito dell’integrazione tardiva[42].
In conclusione, dunque, l’estensione dei confini oggettivi del contenzioso tramite l’integrazione postuma di un provvedimento (vincolato, ma anche) discrezionale, magari sotto sollecitazione del giudice[43], non solo non sarebbe ostacolata da altri principi, ma anzi sarebbe da salutare con favore nell’ottica dell’effettività e concentrazione della tutela[44]. Con un unico ricorso, sommato a motivi aggiunti, l’istante riesce ad opporsi una volta per tutte all’azione amministrativa, trattata finalmente nel suo complesso, senza che la parte pubblica possa rivederla infinite volte; d’altronde, sul versante pubblico, grazie all’intervento manutentivo, si eviterebbero annullamenti giurisdizionali sproporzionati rispetto alla reale portata dell’interesse del privato, dimostrando che la decisione amministrativa in ultima analisi sia corretta.
Ragioni di simmetria processuale, impongono che, così come il ricorrente, in pendenza del giudizio, è in grado di beneficiare (e questo, invero, da sempre) di un rinnovato esercizio del potere amministrativo in senso a lui favorevole, allo stesso modo può anche, all’inverso, essere esposto ad un nuovo provvedimento diretto ad emendare un vizio del precedente atto[45].
Uno schema, quello appena descritto, che pare conciliarsi perfettamente con la teoria dell’esauribilità della discrezionalità per la condotta serbata dall’amministrazione (cosiddetto one shot temperato)[46]: se la p.a., in forza di questa ermeneusi, è già chiamata a completare l’esercizio del potere discrezionale entro al massimo due giudicati amministrativi, tanto vale riconoscere l’esaurimento del potere con la convalida. L’alternativa, d’altra parte, sarebbe che, estromessa l’integrazione e pronunciato l’annullamento del provvedimento, l’amministrazione possa in seconda battuta (e per un’ultima volta) emanare un atto dal medesimo contenuto dispositivo di quello precedente, ma adeguatamente motivato, passibile in ogni caso di un ulteriore ricorso, pervenendo così al medesimo risultato che si sarebbe avuto se fosse stata ammessa l’aggiunta di ragioni in pendenza del primo giudizio.
In sintesi, l’integrazione postuma si atteggerebbe così a second shot ancor prima che ci sia una res iudicatacaducatoria. Nell’insieme, il meccanismo descritto disinnescherebbe la tentazione, da parte del soggetto pubblico, di pretermettere alcune delle ragioni a sostegno della propria decisione, nell’idea di poter colmare eventuali lacune sine die[47].
4 - L’integrazione postuma alla prova dei fatti
Calando la pregressa disamina al caso in oggetto, emerge un dubbio circa la qualificazione dell’intervento postumo operato dall’amministrazione col secondo provvedimento[48]. Certamente, si può escludere che si tratti di un’inammissibile integrazione a mezzo di scritti difensivi; il collegio giudicante è d’altra parte netto nel discorrere in termini di convalida. A nostro parere, l’inquadramento giuridico più corretto parrebbe essere invero quello della seconda categoria sopra analizzata, che si è definita integrazione postuma della giustificazione, avente la sola finalità di chiarire la fattispecie all’organo giudicante.
L’interpretazione in termini di convalida - la terza tipologia studiata - non è convincente nella misura in cui, al di là della mancanza o meno di un esplicito animus convalidandi e ritenuti presenti il termine ragionevole e l’interesse pubblico, il provvedimento postumo de qua, più che finalizzato a colmare un deficit di legittimità della prima delibazione, sembra, nella sostanza, diretto a dare una rilettura dei requisiti ostativi del bando di gara, ampliandone il raggio di applicazione con lo scopo di far salvo l’atto contestato.
Che non si tratti di convalida in senso stretto, lo si evince inoltre dalla statuizione di rigetto dell’impugnazione: se di convalida si doveva discorrere, la statuizione collegiale avrebbe dovuto essere di accoglimento; ma così non è stato. Infatti, il dilemma in parola, lungi dall’essere una vuota disquisizione retorica, tocca nella sostanza la fattispecie, condizionandone i requisiti di validità nei termini delineati nei precedenti paragrafi.
Se la riteniamo ammissibile, la convalida postuma della motivazione, secondo l’orientamento restrittivo[49], per essere conforme all’ordinamento, deve sanare un mero vizio di forma, coprendo un non corretto riepilogo della parte motiva o al più una sua insufficiente rappresentazione, non già - come parrebbe nel caso concreto - l’inadeguatezza sostanziale della ratio decidendi. In definitiva, così opinando, l’esito del giudizio doveva essere diverso e la cosiddetta convalida doveva essere dichiarata illegittima. I termini del discorso sarebbero mutati se il collegio avesse fatto riferimento al tema del one shot, perché in tal caso l’intervento postumo dell’amministrazione si sarebbe atteggiato a seconda spendita di potere, volta a rimodulare nella sostanza la pregressa motivazione; entro questi confini sarebbe allora accettabile la decisione nel merito.
Tutt’altro è a dirsi se si legge la seconda determinazione amministrativa come una semplice integrazione della giustificazione. Come riferito[50], quest’ultima assolve una funzione ancillare, di chiarificazione lite pendente della situazione specifica da cui germina la contesa. Per mezzo di essa, la motivazione implicita si fa esplicita. Per essere valida, però, deve rispettare ut supra alcuni presupposti, che, all’evidenza, sono tutti presenti nel nostro caso: c’è un provvedimento vincolato, in quanto la p.a. deve limitarsi a verificare se esistano o meno pendenze penali concernenti certi crimini, non dovendo ostendere alcuna potestà discrezionale; il diritto di difesa del ricorrente è stato pienamente garantito e ciò è banalmente dimostrato dall’attivazione dei motivi aggiunti; infine, gli elementi allegati successivamente erano già estrapolabili dalla complessiva dinamica procedimentale (in particolare dal combinato disposto di alcune previsioni della lex specialis)[51], come testimoniano gli ultimi paragrafi della pronuncia. Assecondando questa lettura, si conferisce coerenza al ragionamento del collegio che ha, a questo punto condivisibilmente, escluso l’invalidità provvedimentale[52].
5 - Conclusioni: il delicato equilibrio tra poteri costituzionali
Col presente studio si è cercato di affrontare un tema che, radicato su basi teoriche che coinvolgono in profondità i caratteri propri del diritto amministrativo e del rapporto tra funzioni costituzionali, possiede, all’evidenza, un forte taglio pratico. Insomma, alle spalle della cornice giuridica, stanno tangibili rapporti economici e sociali.
La tematica qui trattata e gli approdi raggiunti, sebbene non sempre provvisti di un esplicito riconoscimento legislativo, esemplificano - in uno con altri esempi[53] - una (temibile) patologia, in grado potenzialmente di incidere sulle fondamenta della moderna concezione di amministrazione, che potremmo definire in modo un po’ provocatorio, come “accidia amministrativa”. Procedimenti lenti, istruttorie superficiali e inconcludenti, scarso coinvolgimento degli interessati, decisioni finali di dubbio gusto, sono i frutti avvelenati di questa involuzione.
Sia concesso a tale ultimo riguardo un parallelismo, non troppo peregrino come si vedrà, con lo sviluppo registrato negli ultimi tempi nel diritto penale, circa i rapporti tra Corte costituzionale e legislatore parlamentare, allorquando la prima, caducando una normativa contra Constitutionem (caso tipico, i limiti edittali), imponga al secondo l’esigenza di colmare il vuoto regolamentare così venutosi a creare. Anche qui, a fronte della sovente e spesso denunciata inerzia parlamentare, la giurisprudenza costituzionale ha reagito, dapprima ammettendo la possibilità che la stessa Consulta intervenga sulla normativa di risulta solo ove la scelta sia di fatto vincolata[54], successivamente e più di recente riconoscendo questa possibilità finanche in situazioni di discrezionalità ancora aperta ma in cui esista già una soluzione ragionevole offerta dal sistema normativo nel suo complesso[55].
Ebbene, spiccano alcuni tratti comuni tra questa ipotesi e quella oggetto del presente scritto: in ambo i casi si assiste ad un dialogo tra due poteri costituzionali, uno di matrice giurisdizionale (Corte costituzionale, giudice amministrativo), l’altro per lo più chiamato a compiere scelte discrezionali (Parlamento, amministrazione); in entrambi le difficoltà derivano dall’immobilità del secondo potere; le soluzioni adottate in tutte e due gli esempi per risolvere il problema affondano le proprie radici su ricostruzioni sistematiche di ampio respiro, estrapolate dall’esigenza di mantenimento di una razionalità complessiva (cioè, rispettivamente, evitare di lasciare irragionevoli lacune nel diritto punitivo e di tenere perpetuamente il privato soggetto al potere amministrativo).
Non si vuole certamente negare con questo che le funzioni costituzionali possano dialogare vicendevolmente, in una costante dinamica di arricchimento reciproco: influenzare l'area dell’altra autorità con l'obiettivo di una cooperazione costruttiva è insito nel sistema di separazione dei poteri voluto dalla Costituzione. L’analogia tra le descritte casistiche serve, a ben vedere, ad evidenziare la tensione verso una deresponsabilizzazione dei decisori pubblici e lo scadimento qualitativo degli ingranaggi che dovrebbero garantire il funzionamento della res publica, alla luce del fatto che o le decisioni vengono prese non correttamente o non vengono proprio assunte. Non si può continuare a sperare che sia il potere della magistratura a ricucire il sistema, distorcendo il suo ruolo e facendogli assumere ora il munus di legislatore, ora quello di amministratore[56].
[1] Al momento in cui si scrive ancora passibile di appello.
[2] Quali “motivazione successiva”, “motivazione sopravvenuta”, “integrazione successiva”. Per una definizione dottrinaria, Occhiena M., Il divieto di integrazione in giudizio della motivazione e il dovere di comunicazione dell’avvio dei procedimenti ad iniziativa di parte: argini a contenimento del sostanzialismo, in Foro amministrativo TAR, II, 2003, 528: “ [le integrazioni sono] modifiche al discorso argomentativo elaborato dall’amministrazione a sostegno del dispositivo provvedimentale dirette ad introdurre, ex novo e dopo l’adozione della decisione, dati motivanti obiettivamente suscettibili di giustificare il provvedimento emanato, che non siano riscontrabili oppure che non siano sufficientemente articolati nell’atto impugnato”.
[3] Se venissero in rilievo elementi sopraggiunti, si dovrebbe per forza riaprire un procedimento ex novo.
[4] A differenza, ad esempio, del sistema tedesco con il par. 114, seconda frase, VwGO (che, introdotto nel 1997, dispone: “L’amministrazione può indicare ulteriori ragioni a sostegno della propria decisione nei procedimenti innanzi all’autorità giurisdizionale”). La ratio della disposizione è così individuata nella risoluzione della Commissione giuridica del 1996 sul progetto di riforma della legge sul processo amministrativo: “Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale, si chiarisce che l'amministrazione può anche introdurre considerazioni discrezionali relative al diritto sostanziale durante il procedimento giudiziario”. Per approfondimenti, Axmann M., Das Nachschieben von Gründen im Verwaltungsrechtsstreit, Francoforte, 2001, 92 e ss.; per analisi di più ampio respiro, Sodan H., Ziekow J., Verwaltungsgerichtsordnung. Grosskommentar, Baden-Baden, 2018, 2326 e ss. e 2426 e ss., e Gärditz K. F., VwGO Kommentar, Colonia, 2018, 1024 e ss. e 1050 e ss.. Sulla necessità comunque di un’interpretazione restrittiva della citata disposizione, si veda Axmann M., op. cit., 182, secondo il quale: “[…] l'ammissibilità dell'integrazione ai sensi del par. 114 deve essere risolta in ogni caso negativamente se il procedimento istruttorio, in particolare il test di opportunità, appare indispensabile per la tutela giurisdizionale dell'attore o se al procedimento istruttorio viene attribuito un peso non trascurabile in un determinato ambito”.
[5] Si rinvia fin da ora al paragrafo successivo.
[6] La distinzione è presente in dottrina (Virga G., Motivazione successiva e tutela della pretesa alla legittimità sostanziale del provvedimento amministrativo, in Diritto processuale amministrativo, V, 1993, 510; Tropea G., Motivazione del provvedimento e giudizio sul rapporto, in Diritto processuale amministrativo, IV, 2017, 1242) e, da ultimo, ha attecchito, con piccole sfumature, anche in giurisprudenza: cfr. Cons. St. sez. VI 3385/2021, con nota critica di Aperio Bella F., Limiti alla convalida del vizio di motivazione in corso di giudizio, disponibile al sito giustiziainsieme.it, 2021, 1.
[7] Virga G., op. cit., 510, ma si veda subito infra; Tropea G., op. cit., 1242; Cons. St. sez. VI nn. 1026 e 1703 del 2023, n. 3385 cit., sez. VI 5984/2018 e sez. III 2247/2014, ma anche TAR Lazio, Roma, sez. III bis, n. 335/2024. Il tema è stato approfondito in TRGA Trento 81/2021 che, richiamando l’arresto del Consiglio di Stato del medesimo anno, conferma l’inammissibilità dell’integrazione a mezzo scritti difensivi.
[8] Il riferimento è a Virga G., ibidem. Ancor più radicalmente, si avverte in Giannini M. S., voce Motivazione dell’atto amministrativo, in Enciclopedia del diritto, XXVII, Milano, 1977, 267, in nota, che la questione se sia possibile per il difensore dell’amministrazione integrare la motivazione mediante gli scritti difensivi “[…] è mal posta e si risolve in un luogo comune; il problema è solo probatorio, in quanto il provvedimento può essere collegato ad altri provvedimenti, a comportamenti, a prassi, che non sono enunciati in alcun atto del procedimento di formazione ma che, se tuttavia, esistono, e se ne dimostra il collegamento, non danno luogo ad alcuna supposizione del difensore all’autorità”.
[9] Cons. St. sez. IV 1018/2014, sez. V 4194/2013, sez. VI 1241/2010; in dottrina, si rinvia a Caporale M., Dal Consiglio di Stato un tentativo di canonizzazione della motivazione postuma, in Giurisprudenza italiana, 2014, 1696.
[10] Tramutandosi “in un organo ausiliario o in un’officina di riparazione dell’amministrazione” (Axmann, op. cit., 143).
[11] Nella letteratura e nella giurisprudenza tedesca al posto del primo limite, se ne indica un altro, e cioè che l’integrazione non snaturi la funzione dell’atto; in forza del par. 114 VwGO, secondo periodo, infatti, anche un provvedimento discrezionale può essere completato nei termini riferiti nel testo: cfr. Sodan H., Ziekow J., op. cit., 2729. Si ha inammissibile mutamento dell’atto (Wesenänderung), a parere di quest’ultima dottrina (ivi, 2731), allorquando si muti il contenuto dispositivo, si sostituiscano i fatti sottesi, si converta l’atto da vincolato a discrezionale, si cambi la base giuridica della decisione discrezionale, si verifichi una carenza di competenza decisionale. Non si può tuttavia escludere che lo “snaturamento” non sia altro che una tacita (e ammissibile) abrogazione della precedente deliberazione.
[12] Iaccarino C. M., Studi sulla motivazione con particolare riguardo agli atti amministrativi, Roma, 1933, 42.
[13] Sempre ammissibile è l’integrazione della mera giustificazione secondo Guantario A., Dequotazione della motivazione e provvedimento amministrativo, in Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, XXI, 2002, 2233.
[14] Preferisce parlare di depotenziamento e non di dequotazione della motivazione, Ramajoli M., Il declino della decisione motivata, in Diritto processuale amministrativo, III, 2017, 895.
[15] Ferrara L., Motivazione e impugnabilità degli atti amministrativi, in Foro amministrativo TAR, IV, 2008, 1197 e Cassatella A., Il dovere di motivazione nell’attività amministrativa, Padova, 2013, 287. Secondo quest’ultimo in particolare la nozione di provvedimento andrebbe decodificata nella sineddoche “decisione motivata”: pertanto la motivazione assurgerebbe a rango di elemento essenziale. Ancora, in Mannucci G., Uno, nessuno, centomila. Le motivazione del provvedimento amministrativo, in Diritto pubblico, III, 2012, 885, si giustifica la tesi della nullità, in quanto la carenza di motivazione comporterebbe l’indeterminatezza dell’oggetto provvedimentale.
[16] Ci limitiamo a ricordare che la Consulta, in due occasioni (ordd. 92/2015 e 58/2017), ha avallato questa lettura, richiamando la corrispondente massima giurisprudenziale (ex multis, Cons. St. sez. III 1629/2014).
[17] La distinzione dell’autotutela in base al profilo funzionale è proposta in Giannini M. S., Istituzioni di diritto amministrativo, Milano, 1981, 557 e, più di recente, in Immordino M., I provvedimenti amministrativi di secondo grado, in Scoca F. G. (a cura di), Diritto Amministrativo, Torino, 2015, 340.
[18] In generale, si può rinviare a Santaniello G., voce Convalida (dir. amm.), in Enciclopedia del diritto, X, Milano, 1962, 503; Cannada Bartoli E., voce Conferma (dir. amm.), in Enciclopedia del diritto, VIII, Milano, 1961, 856; Mazzarolli L., voce Convalida (dell’atto amministrativo), in Enciclopedia giuridica, IX, Roma, 1988, 2.
[19] Quali la sanatoria, il ritiro, la ratifica. Diverso carattere rivestono, pur rientrando nella categoria dell’autotutela conservativa, la mera conferma, la conferma, la rettifica, la conversione.
[20] Nel diritto pubblico, questo aspetto è particolarmente evidente, dal momento che, nelle dinamiche quotidiane, emerge l’esigenza che “le energie dell’azione pubblica non vadano, entro i limiti consentiti dal sistema, disperse, là dove possono invece venire senza pregiudizio risparmiate” (Sandulli A. M., Il procedimento amministrativo, Milano, 1964, 351).
[21] Anche nel diritto civile, sulla base sempre del principio di conservazione dei valori giuridici, è codificato l’istituto della convalida del negozio annullabile (art. 1444 c.c.) - ed eccezionalmente, di quello nullo (in materia testamentaria: art. 590 c.c., in materia di donazione: art. 799 c.c.) - ma qui è la parte titolare del diritto alla caducazione a risanare il negozio, non la controparte, come invece avviene nel diritto amministrativo. Inoltre, nella convalida privatistica, a differenza di quella pubblicistica, il contenuto dell’atto negoziale rimane sempre inalterato.
[22] La rinnovazione dell’atto, cioè la produzione, all’esito di un nuovo procedimento, di un provvedimento dall’identico contenuto ma completamento risanato, non potrebbe invece che avere efficacia ex nunc. Contrario alla naturale efficacia retroattiva della convalida, Falcon G., Lezioni di diritto amministrativo, Padova, 2020, 182.
[23] In termini Cons. St. 3385/2021 cit..
[24] Non si può dunque convalidare un atto nullo, che al massimo sarà passibile di ritiro, né un atto irregolare, semplicemente rettificabile, né tanto meno i provvedimenti non invalidabili secondo il regime dell’art. 21 octies c. 2. Sicuramente estranei all’ambito applicativo della convalida risultano inoltre i poteri connotati da termini perentori, geneticamente non riesercitabili.
[25] Ciò serve anche a rendere più netta la distinzione tra convalida e figure affini. Lo sostengono, tra gli altri, Virga P., Diritto amministrativo, II, Milano, 2001, 143, e Sandulli A. M., Manuale di diritto amministrativo, Napoli, 1989, 688.
[26] In realtà, il ripristino della legalità violata parrebbe già essere una sufficiente ragione di rilievo pubblico: Falcon G., op. cit., 181, e Ramajoli M., Villata R., op. cit., 694.
[27] Dubbi su questo presupposto sono presenti in Falcon G., op. cit., 181.
[28] Il quesito in senso più ampio potrebbe invero ridursi a questo: si può convalidare - in qualsiasi forma si palesi - il vizio di eccesso di potere?
[29] Proseguendo la comparazione col diritto tedesco, il par. 45 VwVfG mentre al comma 1 n. 2 prevede la convalidabilità dei provvedimenti viziati sotto il profilo formale adducendo in via sopravvenuta la “necessaria motivazione”, al comma 2 esclude questo potere allorquando sia pendente il processo giurisdizionale.
[30] Cfr. Santaniello G., op. cit., 505; Mazzarolli L., op. cit., 2; Falcon G., op. cit., 181. A parere di Ramajoli M., Villata R., op. cit., 696-697, dal combinato disposto con l’art. 21 octies c. 2, le uniche patologie convalidabili sono quelle di incompetenza e comunque giammai quelle sostanziali: “Non appare più corretto sostenere, come in passato, che convalida e annullamento sono conseguenze possibili di un medesimo presupposto, e cioè dell’illegittimità dell’atto[…]”.
[31] La tesi positiva è ad esempio sostenuta in Antonelli V., Commento all’art. 21-nonies, in Paolantonio N., Police A., Zito A. (a cura di), La pubblica amministrazione e la sua azione. Saggi critici sulla legge n. 241/1990 riformata dalle leggi n. 15/2005 e n. 80/2005, Torino, 2006, 675.
[32] Cons. St. n. 3385 cit.. In realtà, la dicotomia è presente anche in dottrina: Nigro M., Scritti giuridici, II, Milano, 1996, 449.
[33] In giurisprudenza, ex multis Cons. St., sez. III 1656/2016, sez. V 750/2016, sez. III 2247/2014, sez. VI 2840/2009, sez. V 342/2003, sez. VI 4158/2000; TAR Lazio, Roma, sez. II 9347/2001. In dottrina, già Mortati C., Obbligo di motivazione e sufficienza della motivazione negli atti amministrativi (a proposito del procedimento di scrutinio nelle promozioni per merito comparativo), in Giurisprudenza italiana, III, 1943, 1; più di recente, Santaniello G., op. cit., 505 e Mazzarolli L., op. cit., 3. Criticamente, in Romano Tassone A., Motivazione dei provvedimenti amministrativi e sindacato di legittimità, Milano, 1987, 394, si qualifica questo orientamento come immotivato e tralaticio.
[34] Rimarca vigorosamente il punto, Occhiena M., Il divieto di integrazione in giudizio della motivazione e il dovere di comunicazione dell’avvio dei procedimenti ad iniziativa di parte: argini a contenimento del sostanzialismo, in Foro amministrativo TAR, II, 2003, 530.
[35] Di crisi della motivazione in ogni attività pubblica (giurisdizione compresa) parla Ramajoli M., Il declino della decisione motivata, in Diritto processuale amministrativo, III, 2017, 894: “[…] si decide anche senza motivare, forti di un’istanza efficientistica che condiziona norme di legge e principi di diritto”. A suo tempo, già denunciava Zito A., L'integrazione in giudizio della motivazione del provvedimento: una questione ancora aperta, in Diritto processuale amministrativo, III, 1994, 586-587, che tale ricostruzione “[…] potrebbe […] aprire la strada ad una prassi dell’amministrazione fatta di provvedimenti poco o nulla motivati […]”.
[36] Ponendosi altresì in contrasto con i canoni sovranazionali (segnatamente, l’art. 296 TFUE sull’obbligo di motivazione degli atti delle autorità europee e l’art. 41 della Carta di Nizza sul diritto ad una buona amministrazione). La motivazione come “forma sostanziale” è un Leitmotiv presso la giurisprudenza unionale: cfr. CGUE C-89/08 del 2009 (Commissione c. Irlanda).
[37] Ci si riferisce, come noto, all’art. 6 della l. 249/1968.
[38] In giurisprudenza, un primo storico arresto fu CGARS 149/1993 in Diritto processuale amministrativo, V, 1993, 507, con note critiche di Virga G., Motivazione successiva e tutela della pretesa alla legittimità sostanziale del provvedimento amministrativo, in Diritto processuale amministrativo, V, 1993, 516 e di Zito A., op. cit., 577; in realtà ancor prima, TAR Veneto, sez. I, 648/1987, in Diritto processuale amministrativo, 1989, 469. Altre pronunce di segno positivo: Cons. St. sez. VI 1054/2003 e 4993/2009; TAR Molise, 41/2003; TAR Lazio, Roma, sez. I, 398/2002. In dottrina, Giannini M. S., voce Motivazione dell’atto amministrativo, in Enciclopedia del diritto, XXVII, Milano, 1977, 267; Caianiello V., Manuale di diritto processuale amministrativo, Torino, 1988, 411; Falcon G., op. cit., 182; Virga G., op. cit., 1993, 512; Corso G., Processo amministrativo di cognizione e tutela esecutiva, in Foro italiano, 1989, 428; Vaccari S., Il giudicato nel nuovo diritto processuale amministrativo, Torino, 2017, 322.
[39] Schematizzando, gli orientamenti prevalenti in materia individuano l’oggetto del processo, alternativamente, nell’interesse legittimo, nel rapporto amministrativo, nel diritto potestativo all’annullamento dell’atto. La prima impostazione, fatta propria, tra gli altri, da Ranelletti O., Sulla esecuzione in via amministrativa delle decisioni del Consiglio di Stato e delle Giunte Provinciali Amministrative, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1951, 78 e ss., e da Giannini M. S., La giustizia amministrativa. Appunti delle lezioni, Roma, 1972, 174 e ss., poggia sull’art. 7 c.p.a. e specialmente sui commi 1 e 7, che rappresenterebbero la traduzione amministrativistica degli artt. 81 c.p.c. e 2907 c.c.. Essendo la giurisdizione amministrativa connotata soggettivamente al pari di quella civile, come quest’ultima il suo oggetto non potrebbe che essere la posizione sostanziale di interesse legittimo.
Negli ultimi tempi, si è consolidata la tesi, efficacemente sostenuta, per esempio, da Greco G., Dal dilemma diritto soggettivo-interesse legittimo, alla differenziazione interesse strumentale-interesse finale, in Diritto amministrativo, III, 2014, 479, e Patroni Griffi G., Forma e contenuto della sentenza, in Diritto processuale amministrativo, I, 2015, 25 e, nel diritto pretorio, da Cons. St. Ad. Plen. nn. 3 e 4 del 2011, n. 4 del 2018 e sez. VI n. 1321/2019, secondo la quale l’oggetto del processo amministrativo coinciderebbe col rapporto amministrativo, da intendersi come “il sistema proiettato nel tempo delle relazioni giuridicamente rilevanti […] che si instaurano tra pubbliche amministrazioni e privati in relazione all’esercizio della funzione amministrativa e alla tutela dei diritti fondamentali” (Protto M., Il rapporto amministrativo, Milano, 2008, 6). Si intende dunque interpretare l’interesse legittimo come situazione soggettiva finale, con ciò conferendosi la possibilità al giudice di verificare se la pretesa sostanziale del privato sia fondata o meno. Si esalta quella tendenza, sospinta dalla volontà di fornire al ricorrente una tutela stabile e definitiva, che avrebbe comportato la metamorfosi del processo amministrativo, da giudizio sull’atto - singolo punto dell’operato amministrativo - a giudizio sull’intero rapporto di diritto pubblico, tramite il pieno accesso al fatto e alla relazione giuridica instaurata.
A parere dell’ultima tesi, l’ambito oggettivo del processo amministrativo sarebbe l’accertamento del diritto potestativo, a necessario esercizio giudiziario, all’annullabilità del provvedimento amministrativo, conformemente alle doglianze proposte dal ricorrente (Nigro M., Giustizia amministrativa, Bologna, 2002, 228 e ss.; Clarich M., Giudicato e potere amministrativo, Padova, 1989, 133 e ss..).
Per approfondimenti sulle critiche alle tre ricostruzioni, cfr. Valaguzza S., Il giudicato amministrativo nella teoria del processo, Milano, 2016, 75 e ss. e 108 e ss..
[40] Quest’ultima è la strada scelta dal ricorrente nel contenzioso de qua.
[41] Per non parlare poi delle conseguenze sulla valutazione individuale della performance. Per completezza, inoltre, potrebbe ritenersi ammissibile l’azione risarcitoria contro l’amministrazione, sub specie di lesione degli interessi procedimentali del singolo, comunque lesi da un’azione che, in fin dei conti, risultava a monte contra legem. L’insufficienza dell’armamentario difensivo a disposizione del ricorrente è comunque messa in luce da Aperio Bella F., op. cit., 29 e ss.
[42] Pertanto, il magistrato è onerato di effettuare una prognosi postuma su quello che sarebbe stato l’esito del ricorso originario se non fosse sopravvenuta l’integrazione: se il ragionamento controfattuale conduce a ritenere che sarebbe stata più probabile la vittoria del privato, i costi del processo vanno addossati per intero alla p.a., pure qualora risulti vittoriosa nel merito. Non è tuttavia facile giustificare de iure condito questa conclusione. In tema di responsabilità processuale aggravata l’art. 96 c.p.c., applicabile al processo amministrativo per mezzo del rinvio di cui all’art. 26 c.p.a., fa infatti esclusivo riferimento al soccombente. Diverso il discorso invece nell’ordinamento tedesco, ove il par. 155 c. 4 VwGO recita: “I costi processuali derivanti dalla colpa di una parte, ricadono su questa”.
[43] Si pensi al remand cautelare o alle dinamiche dell’istruttoria. Tali poteri ovviamente devono essere impiegati dal giudice in ossequio ai canoni costituzionali di imparzialità, indipendenza e parità delle armi, e non per sostituirsi alla parte pubblica.
[44] Martucci di Scarfizzi F. S., L’integrazione postuma della motivazione alla luce dell’art.21 octies comma 2 della Legge n.241 del 1990. Profili di incidenza sugli atti regolatori adottati dalle Autorità Amministrative Indipendenti, in Diritto Mercato Tecnologia, III, 2015, 18.
[45] Perciò, se si ammette la possibilità per l’amministrazione di un riesame della legittimità in pendenza del giudizio, sembra irrazionale limitare le conseguenze di tale riesame secundum eventum: accordare, cioè, la possibilità di intervenire quando ciò richieda un atto di ritiro, e negare la stessa possibilità, invece, quando il riesame si traduca in una manutenzione della precedente determinazione. In termini, TAR Lazio n. 398 cit.; la suggestione è peraltro ripresa in Carbone A., L’azione di adempimento nel processo amministrativo, Torino, 2012, 255, ove l’autore difatti si dimostra propenso ad ammettere l’integrazione postuma.
[46] Sul tema, ci limitiamo a rinviare a Lopilato V., Cognizione ed esecuzione nel giudizio di ottemperanza, disponibile al sito giustamm.it, 2013, passim e a Cons. St. sez. VI 1321/2019 (con note di Vaccari S., Il Consiglio di Stato e la “riduzione progressiva della discrezionalità”. Verso un giudicato a “spettanza stabilizzata”?, in Diritto processuale amministrativo, 2019, 1172 e ss.; e di Orso F., Ancora sugli effetti del giudicato: un passo avanti e due indietro, ibidem, 1236 e ss.).
[47] Non è un caso che la più volte citata pronuncia n. 3385 del Consiglio di Stato in chiusura faccia esplicito riferimento al nuovo testo dell’art. 10 bis. In Cass., sez. un. n. 18592 del 2020, emanata proprio in esito all’impugnazione della citata sentenza del Consiglio di Stato 1321/2019, viene sottolineato come il principio di effettività della tutela, solennemente proclamato nell’art. 1 c.p.a., esiga la ricomposizione del rapporto di diritto pubblico in termini celeri e stabili. Sembrano essere queste le conclusioni a cui mira Tropea G., op. cit., 1258 e ss., quando richiama la possibilità di applicare il principio del dedotto e del deducibile al processo amministrativo. Il rischio di un regressus ad infinitum è paventato indirettamente anche in Ramajoli M., Il declino della decisione motivata, cit., 907, ove si cita il tema dell’inesauribilità del potere, e più esplicitamente in Ramajoli M., Villata R., op. cit., 316. Ancor prima, Piras A., Interesse legittimo e giudizio amministrativo, Milano, 1962, 447, anche in nota.
[48] I giudici del TAR sembrano avere in mente questo quesito se si guarda all’ultima parte della loro sentenza.
[49] Cfr. par. 3.
[50] Par. 2.
[51] Artt. 2 lett. g) e 4 c. 6 del bando.
[52] Le difficoltà nell’interpretare il successivo intervento della p.a. emergono, ad esempio, anche nel caso trattato in Cons. St. sez. VII 1291/2024
[53] Quali il proliferare delle leggi provvedimento, il sempre più frequente ricorso a fonti governative dal dubbio inquadramento dogmatico, l’avversione per la digitalizzazione, l’abdicazione a favore di moduli di diritto privato nell’agire amministrativo.
[54] Cosiddette “rime obbligate”, a partire da C. Cost. 236/2016 in tema di reato di alterazione di stato di neonato.
[55] “Rime consigliate”; cfr. C. Cost. 40/2019 in punto di reati in materia di stupefacenti. L’apice si è raggiunto con la pronuncia in tema di eutanasia, con la Consulta che, dopo aver lasciato un lasso di tempo per una riforma normativa, sospendendo il giudizio di costituzionalità (C. Cost. 207/2018), ha costruito sulla base del diritto vigente la regolamentazione di riferimento: C. Cost. 242/2019.
[56] Lo denuncia in tema di integrazione postuma della motivazione, Tropea G., Motivazione del provvedimento e giudizio sul rapporto, in Diritto processuale amministrativo, IV, 2017, 1250: “[…] all’ampliamento del potere sostitutivo del giudice, anche quello amministrativo, che finisce per operare come in un appello con effetto devolutivo pieno, spesso consegue una svalutazione del ruolo della pubblica amministrazione: dietro al principio di effettività della tutela sembra quindi celarsi un consistente spostamento dall’amministrazione al giudice del potere effettivo di disporre in ordine all’affare”.
La città della Palla ovale, il campione biondo, la memoria e il futuro
(alla mia città, a 15 anni dalla notte che ci cambiò la vita)
di Paolo Spaziani
Non ricordavo altro se non che fosse domenica, tra il 1987 e il 1989.
Doveva essere una domenica di primavera inoltrata perché il cielo era nitidamente azzurro, il sole, luminoso, induceva ad allentare i cappotti e le cime del Corno Grande e del Pizzo Cefalone abbacinavano di neve bianca, fresca di alcuni giorni.
Lungo il primo Corso, salendo dalla Villa verso la Piazza, si sentiva il vociare dei pronostici. Il rurale dialetto imbuffoniva le parole inglesi. Ma la consapevolezza della tecnica e della tattica induceva serietà e attenzione.
Era una delle nostre cose, il rugby. Come lo erano i nostri tratturi montani. Come le nostre nevi perenni. Come il Castello degli spagnoli e la Cattedrale di San Massimo.
Era l’unica parola inglese pronunciabile in aquilano.
Dal Duomo uscivano quelli della messa di mezzogiorno. I più mattinieri erano stati a quella delle Anime Sante, venti metri più avanti. Gli uni e gli altri si dirigevano, felici, verso i Quattro Cantoni.
Davanti all’Eden si sentiva il profumo delle bombe fritte alla panna. Vi facevano colazione gli studenti che venivano dai Gesuiti e gli anziani che scendevano da Piazza Chiarino.
La Fontana Luminosa era come una statua di ghiaccio. Tra i bellissimi corpi nudi, più basso della conca, si vedeva il Corno Grande. Quando il cielo era così terso, sembrava guardasse poco oltre i pini del Castello.
In basso, lo Stadio era ancora vuoto. Ma più tardi, dopo il pranzo domenicale, nella migliore tradizione aquilana, tutta la città, festante, vi si sarebbe riunita; per sostenere i propri figli, ma anche per onorare i rispettati avversari veneti, la grande squadra di Treviso.
Quel giorno, come ogni domenica, era il giorno della palla ovale.
«Come fai a fumare le Camel se devi giocare? Almeno prendi le Merit! Sono più leggere!»
Giuseppe, il banchista del bar dello Stadio, non sapeva che la sigaretta più buona non è quella dopo pranzo o dopo il caffè, come di solito si dice, ma quella tra il primo e il secondo tempo: quando, negli spogliatoi, il fumo del tabacco sposa l’odore lieve del prato a quello aspro e forte del sudore.
Nero Verdi contro Bianco Verdi. Una sfida classica, quasi sempre (ma non sempre) vinta da loro. Spesso più forti. Sempre fratelli leali di una battaglia comune. Ci rispettavano, li rispettavamo. Li amavamo, ci amavano.
Il rispetto era negli occhi che si incrociavano tra gli avanti nella mischia chiusa; nelle braccia dei trequarti che non placcavano mai oltre il grosso tronco; nelle urla del tallonatore prima di battere le touches; nelle mani dei mediani di mischia; nei piedi dei mediani di apertura.
Da qualche tempo i Bianco Verdi erano ancora più forti. Avevano ingaggiato il trequarti ala più forte del mondo.
Veniva dalla Nuova Zelanda, aveva vinto con gli All Blacks il primo mondiale. Era bellissimo e velocissimo. Ai mondiali, contro l’Italia, aveva segnato dopo 70 metri di corsa solitaria, dalla linea dei 22 a quella di meta.
Avevano provato a placcarlo in sette, senza riuscirvi. Era la meta che tutti i numeri 14 vorrebbero realizzare; che nessun altro ha mai realizzato.
Quel giorno avrebbe giocato contro di noi.
Lo guardai a lungo, in campo. Il corpo snello, i possenti quadricipiti, i dolci capelli biondi: sembrava nato per correre; con la palla ovale sotto il braccio.
Giocammo bene. Come spesso ci accadeva di fare al Tommaso Fattori, stadio imprendibile per i più.
Dopo essere andati sotto riuscimmo a contrattaccare. Alla mano, come nel rugby dei sogni, senza smettere, con fasi continue, in apnea, da destra, da sinistra, quindi ancora da destra. I passaggi riuscivano, le idee venivano, la stanchezza sembrava lontana.
I Bianco Verdi erano chiusi nei loro 22. Erano nelle nostre mani. Avremmo segnato da un momento all’altro.
Poi, l’imprevedibile, per chiunque non sappia della dimensione ultraterrena che il rugby può assumere nelle persone dei più grandi.
Il campione del mondo vede l’unico pallone intercettabile tra i nostri trequarti. Si getta sull’ovale. Angelicamente, lo prende sotto le sue ali. Esplodono i muscoli delle sue gambe. Bruciano l’erba del prato le sue scarpe. Evita una selva di braccia, pur retrocesse, generose, a rincorrerlo. Rimane solo, dardo luminoso irraggiungibile, nell’immensità del campo. Trafigge i pali e i nostri cuori prima di regalarci la maglia numero 14.
Avevo questi pensieri mentre camminavo per le strade ferite, tra i sassi e i cani. Le ombre di gigantesche gru nascondevano profili di case rotte. Le nevi non più perenni del Monte Corno sembravano appassire in un perenne autunno.
Nel prato deserto del Fattori rivedevo le immagini di una partita di rugby e la corsa di un campione; nel suo silenzio identificavo il dolore di una città.
Oggi, dopo quindici anni, quel dolore mi trova impreparato mentre percorro le stesse strade ben curate e guardo le stesse case sontuosamente ricostruite.
Non basta la rinnovata bellezza delle nostre piazze e dei nostri palazzi, l’azzurro intenso del nostro cielo, la bella purità di Nostra Signora di Collemaggio, la maestosa incombenza di San Bernardino, l’apollinea struttura della raffaellita San Silvestro.
I visi delle Anime Sante dapprima mi rimproverano per non essere con loro, di poi mi rassicurano di essere con me.
La voce del mio professore di latino risuona ancora dei versi di Saffo, nelle care itale note di cui li vestì Catullo.
Lei mi sorride, ricordandomi le notti d’agosto sotto il cielo stellato di Pagliare e le parole infinite al fumo di una Marlboro fumata in due.
Un altro campione biondo mi reca l’odore dell’erba del campo di Lucoli e il ricordo della gelida doccia che dividevamo di corsa mentre dalla finestra degli spogliatoi fiocchi di breve argentea illuminavano il monte di Campo Felice.
Sono la nostra memoria e il nostro futuro.
Ora che anche Santa Maria Paganica sarà ricostruita, ora che riapriranno i portici del Liceo, ora che torneranno le bombe dell’Eden, ora che il Fattori si rianimerà: ecco la mia città e i miei campioni; con la palla ovale sotto il braccio.
Al Signor Presidente della I Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati
Oggetto: audizione informale in relazione ai Disegni di legge costituzionali 23, 434,806 e 824 recanti modifiche all’art.87 e al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura.
Ringrazio anzitutto il Presidente e la Commissione per l’onore che mi viene fatto dando la possibilità di fornire il mio contributo basato sull’esperienza professionale.
Devo anzitutto osservare come i disegni di legge costituzionali in questione non si limitino a prevedere la separazione delle carriere tra la magistratura giudicante e quella requirente, ma intervengano in modo molto più profondo delineando una magistratura, ma oserei dire una giurisdizione, radicalmente diversa da quella realizzata dalla Costituzione.
Difatti al di là della separazione delle carriere verrebbe prevista, sia pure con qualche differenza tra i diversi testi:
Tutto ciò non ha nulla a che vedere con la giusta pretesa di imparzialità e terzietà da parte del giudice. Pretesa che a dire il vero già oggi risulterebbe soddisfatta se il tasso di assoluzioni è del tutto fisiologico arrivando al 50% e non rivelando alcun cedimento in senso accusatorio.
Quanto viene esplicitata è piuttosto una reazione alla crescita del giudiziario che alla fine del secolo scorso ha caratterizzato tutte le democrazie occidentali. Come viene puntualmente descritto nella relazione a tre dei DDL “il problema è quello della presenza di un giudice che oramai governa con le proprie decisioni, non solo i nodi essenziali dei diritti e delle garanzie individuali, ma anche quelli dell’economia, dell’ambiente e dello sviluppo tecnologico, sostituendosi di fatto al ruolo che un tempo esercitava la politica, improvvisando così soluzioni sul caso concreto”. Espansione del giudiziario che si è verificata in tutti i Paesi occidentali, indipendentemente dagli ordinamenti, radicalmente diversi ivi esistenti, per la crescente complessità della nostra società e per la sempre più viva domanda di diritti, cui è corrisposta l’incapacità degli altri poteri, in particolare di quello legislativo, di dare risposte tempestive. Crescita del giudiziario comunque ormai superata e anch’essa oggi in crisi, come sono in crisi tutte le professioni giuridiche, a fronte di una politica che tende a riprendere spazi e dell’onnipresenza dell’economia e delle logiche di mercato.
In Italia poi si avrebbe una magistratura “onnivora” “che confonde quella che dovrebbe essere la cultura del limite con la lotta ai poteri criminali”. Proprio l’esito dei processi, con l’alto tasso di assoluzioni e la capacità di Corti di appello e Cassazione di rivedere con serenità le decisioni dei gradi precedenti, dicono che il nostro sistema tiene e assicura adeguate garanzie. Tant’è che quanto viene giustamente lamentato sono i tempi delle decisioni che lasciano troppo spesso la persona accusata in balia dell’incertezza, tempi su cui la presente proposta di riforma costituzionale non inciderebbe e che anzi rischierebbe di peggiorare.
Quello che viene di fatto attuato è un riequilibrio di poteri ai danni del potere giudiziario con la frammentazione in due Consigli Superiori che avranno meno prestigio e autorevolezza, con una maggiore presenza politica nei Consigli Superiori e con una riduzione delle competenze dei Consigli Superiori tassativamente limitate.
I Consigli Superiori perdono le caratteristiche che sinora hanno avuto di organi di governo autonomo unendo magistrati eletti da tutti i magistrati con professori universitari e avvocati di esperienza nominati dal Parlamento. Da un lato la presenza paritaria di nominati di origine politica incide sull’autonomia dell’organo, dall’altro il fatto che i magistrati siano scelti (da chi?) e non più eletti indebolisce l’organo e la sua autorevolezza. Il timore di sconfinamenti politici che porterebbe a delimitare tassativamente le materie di competenza dei Consigli non è adeguato al tempo presente: settori che apparivano marginali sono oggi diventati centrali. Così è per l’organizzazione degli uffici (materia tabellare e criteri di organizzazione delle Procure) che rientrano tra i poteri impliciti che esercita il C.S.M. derivando, oltre che dalla legge, dal rapporto diretto che la materia ha con le assegnazioni. E così è per l’impatto che le nuove tecnologie sino ad oggi e l’intelligenza artificiale domani hanno avuto ed avranno sull’organizzazione degli uffici e sulla stessa giurisdizione.
Ingessare le competenze impedendo una loro evoluzione è quindi pericoloso per la stessa funzionalità del sistema.
Lascia anche quantomeno perplessi la norma che rende possibile la nomina di professori universitari e avvocati nella magistratura giudicante senza concorso. Se, come personalmente auspico, si approdasse a una formazione comune di base (inevitabilmente selettiva) per coloro che intendono accedere alle professioni giuridiche si potrebbe giungere a forme di osmosi e passaggio, ovviamente rigorosamente regolate, tra le diverse professioni giuridiche. Ma sempre sulla base del concorso pubblico, garanzia di professionalità e di imparzialità.
I limiti oggettivi che oggi ha l’obbligatorietà dell’azione penale dovrebbero essere affrontati a monte, evitando la proliferazione di norme penali che ne impediscono di fatto la concreta applicabilità. Alcune proposte erano state avanzate nel passato per cercare di porre rimedio a quello che sicuramente è un problema serio, ovvero una finta obbligatorietà, quale quella della riserva di codice, onde evitare il proliferare di leggi speciali contenenti fattispecie penali. L’idea di temperare l’obbligatorietà “nei casi e modi previsti dalla legge” non risolve il problema.
Francamente molti degli interventi preconizzati non hanno nulla a che fare con la separazione delle carriere e delineano una magistratura giudicante debole e suscettibile, grazie all’abrogazione dell’art 107 co.3 Costituzione, di una gerarchizzazione incompatibile con l’efficienza e con la stessa natura della giurisdizione, dato che il giudice deve essere soggetto solo alla legge e alla propria coscienza.
Quanto francamente preoccupa è che con una vera e propria eterogenesi dei fini questa riforma che vorrebbe aumentare le garanzie avrebbe invece un effetto fortemente giustizialista, rafforzando enormemente i poteri dei Pubblici Ministeri e il loro peso nei confronti dei giudici.
Separarli sia come reclutamento, sia come organo di governo autonomo significa creare un potere fortissimo, del tutto slegato dai giudicanti con cui si vivrà un rapporto di inimicizia e antagonismo. In un Paese con tradizioni autoritarie come il nostro e con una cultura, specie massmediatica, che già oggi valorizza spesso in modo abnorme il ruolo dell’accusa, è facile prevedere che non solo la magistratura requirente avrà una crescita autoreferenziale, ma subirà una crescente torsione come puro organo di accusa, teso a incastrare (più che a trovare le prove anche a favore) l’imputato, molto più forte del giudice, soggetto ai richiami dell’allarme sociale e alle pressioni dell’opinione pubblica, attento più al risultato da perseguire che alle garanzie.
La strada maestra per dare risposta alla domanda di garanzie, ma anche alla crescente crisi che oggi attanaglia le professioni giuridiche, é opposta ed è quella di unire invece che dividere, tornando all’idea di una formazione comune obbligatoria per magistrati e avvocati per creare un’osmosi ed una cultura comune. Oggi se vogliamo una giurisdizione moderna e proiettata verso il futuro occorre puntare sulla formazione, sulla specializzazione e sul governo delle tecnologie che riguardano tutte le professioni giuridiche che devono puntare su di un orizzonte comune e non su divisioni e separazioni.
Brescia, 13 dicembre 2023
(Immagine: Frederick Sargent, The Tichborne Trial (1873-1899), oil on canvas, Hampshire County Council Museums Service, Winchester, England, via Wikimedia Commons)
Lo scritto riprende alcuni dei temi trattati nel corso della relazione tenuta al convegno sul tema “Diritto d'amore” tenutosi a Roma nei giorni 25, 26 e 27 gennaio 2024 organizzato dall'Associazione Cammino. Si tratta della seconda di una serie di pubblicazioni sulla nostra Rivista in tema di "diritto d'amore" per condividere le riflessioni emerse in occasione del Convegno. Si veda Diritto d'amore e responsabilità civile di Alessandra Cordiano.
Diritto, biodiritto e amore
di Roberto Giovanni Conti
Sommario: 1. Dica in Tribunale che amo mia moglie! Il caso Loving c. Virginia fra diritto e amore. - 2. Diritto vs. amore o amore vs diritto o diritto e amore? Quando l’amore diventa rilevante per il diritto? - 3. Il cammino delle unioni civili fra persone dello stesso sesso. - 4. Il cammino dell’amore verso il diritto. - 5. Il piano dei valori fondamentali rispetto a diritto e amore - 6. La giostra dei diritti ed il diritto dal basso - 7. Tornando alle unioni civili fra persone dello stesso sesso. Andata a ritorno fra diritto straniero, diritto interno e diritto vivente. - 8. Il diritto di amarsi fino alla fine con dignità ed il “problema del “fine vita”. - 9. Il ruolo della giurisdizione. Il camminare della giurisprudenza (verso l’amore).
1. Dica in Tribunale che amo mia moglie! Il caso Loving c. Virginia fra diritto e amore.
“Mr. Cohen, dica in Tribunale che amo mia moglie e che è ingiusto che non possa vivere in Virginia insieme a lei!”
Era questo il messaggio che Richard Loving, uomo bianco, alla vigilia dell’ultima udienza innanzi alla Corte Suprema degli Stati Uniti che avrebbe trattato il caso originato dal suo matrimonio con Mildred, donna nera chiese al suo avvocato di trasmettere alla Corte. Quella coppia, dapprima costretta a lasciare la contea di Caroline, in Virginia, dove quel “tipo” di matrimonio era vietato per poi tornare nel paese d’origine, era stata condannata ad un anno di prigione per quella scelta, allo stesso tempo “tragica” e “di amore”. Una pena che i due coniugi non avrebbero scontato se solo avessero deciso di lasciare la Virginia e di non farvi più ritorno per venticinque anni. I due non si acquietarono rispetto a quella decisione e portarono la loro vicenda davanti ad una Corte.
Il caso Loving c. Virginia, passato dalle Corti dello Stato della Virginia fino a giungere alla Corte Suprema degli Stati Uniti, incise profondamente sul tessuto sociale degli Stati Uniti e viene ricordato come un leading case di portata universale, valicando gli oceani e superando la vicenda personale di quella coppia per diventare, caso di scuola, sentenza da ricordare, precedente da tenere in considerazione dentro gli States e fuori.
2. Diritto vs. amore o amore vs diritto o diritto e amore? Quando l’amore diventa rilevante per il diritto?
Si è scelto di ricordare quella vicenda perché essa racchiude in maniera potente ed immediata il grumo delle riflessioni che si proveranno a rappresentare sul tema Diritto e amore.
Espressioni antitetiche, incomunicabili o tra loro complementari e, se sì, in che misura?
Dove c’è l’uno - che si potrebbe affiancare, pur con una certa approssimazione, con la nozione di sentimento[1]il sentimento - non c’è o non dovrebbe esserci l’altro - il diritto - la regola che attribuisce il diritto ad una persona ed un dovere ad un altro e che, dunque, comprime il sentimento, invece libero per principio, ontologicamente. Francesco Gazzoni non esitava a riconoscere che “Il diritto ha difficoltà a regolamentare i c.d. fatti di sentimento, non solo per motivi di lessico giuridico, ma anche perché le vicende che coinvolgono sentimenti (e non patrimoni) sono per loro natura ambigue ed oscure, in particolare per quel che riguarda i fatti d'amore.”[2]
Si potrebbe dire, per tentare di abbozzare un ragionamento, che ciò che sta a monte dell’amore, il sentimento, costituisce dimensione assolutamente individuale, non meritevole ex se di protezione dall’ordinamento proprio perché chiusa nella sfera di ciascun individuo e soggetta, in definitiva, al governo della coscienza e non alle regole del diritto.
Ed allora, quando il sentimento, l’amore, diventa rilevante per il diritto? Quando dunque i due mondi si intercettano, forse reciprocamente, dimostrando che l’uno non può fare a meno dell’altro? Quando diventano complementari, quando attingono all’uno per dare un senso all’altro?[3]
A questo nucleo complesso di interrogativi può darsi un accenno di risposta non esaustiva, ovviamente, ma forse capace di cogliere i due punti di emersione dell’amore rispetto al diritto.
Da un lato, il carattere interiore del sentimento d’amore assume o comincia ad assumere rilevanza giuridica quando è frutto della tradizione di una comunità.
Fin qui, nulla quaestio.
Basti pensare al matrimonio o alla filiazione che sembrerebbero essere istituti giuridici nei quali, appunto, il legislatore interviene per regimentare fenomeni ben assestati nella coscienza sociale.
Questi ultimi rappresentano, forse, i due migliori esempi di quanto, appunto, il sentimento possa trovare diversa considerazione nel corpo sociale, a seconda delle forme con le quali si manifesta e delle risposte che l’ordinamento offre, nel tempo, a queste “diversità”, frutto appunto della diversa carnalità dei fatti che prende luogo in un determinato contesto sociale.
Ecco che il sentimento amoroso fra le persone può manifestarsi in forme che la coscienza sociale a volte può considerare: a) come immeritevole di tutela, per essere appunto meramente privato ed individuale- come lo sono state, per lungo tempo, in Italia, le unioni fra persone dello stesso sesso-; b) come meritevole di una sanzione-si pensi all’amore incestuoso, alla poligamia-; c) come fatto divisivo quanto alla necessità o meno che essa vengo regolato dal diritto. In tali casi la vicenda diventa impegnativa e a volte tormentata, perché l’amore sorregge alcune aspettative che vorrebbero fossero tutelate come diritti, secondo alcuni, e che invece, altri, vorrebbero confinate nel “non diritto”.
Per altro verso, la rilevanza dell’amore per il diritto cresce al crescere, esponenziale, della rilevanza che nella società assumono i diritti fondamentali[4].
Si tratta di processi che, in parte, sembrano ispirati da istanze e forze diverse ma che, in parte, risultano convergenti, nel senso che la considerazione sociale di un sentimento d’amore aiuta a disvelare aspetti dei diritti della personalità non compiutamente considerati e valorizzati in un dato contesto storico.
Tutto questo mette in gioco anzi mette a ferro e a fuoco temi caldissimi per gli operatori del diritto: il ruolo della legislazione rispetto alla Costituzione, il ruolo (ed i limiti) della giurisdizione rispetto ai diritti umani, il ruolo (o il non ruolo) della coscienza sociale nella configurazione dei diritti fondamentali stessi, di nuova e vecchia generazione, il ruolo degli avvocati come motore dei diritti ed il ruolo dei giudici come guardiani e al tempo stesso custodi dei diritti.
Un campo, dunque, sconfinato, nel quale verrebbe voglia di fermarsi e ragionare insieme per giorni, per settimane.
Per questo credo vada espresso un “grazie di cuore” a Cammino, ancora una volta capace di aprire e disvelare orizzonti che già sono stati e sono tuttora oggetto di analisi, cogliendo al fondo la centralità del tema e mettendo in campo un parterre di relatori di assoluto rilievo per l’ampiezza dei temi trattati e per l’idea stessa che Cammino ha portato negli anni avanti.
3. Il cammino delle unioni civili fra persone dello stesso sesso.
Dunque, proviamo ad esaminare una delle tante prospettive, collegate a quella che sorregge la riflessione su amore e biodiritto.
Il pensiero, già si accennava all’inizio, si indirizza quasi naturalmente verso le tematiche dei legami sentimentali che, diversi dal matrimonio nella nozione tradizionale che ad esso si è data, hanno per lunghi anni visto prevalere l’idea del “non diritto” sottesa alla ritenuta non necessità di regolamentare fenomeni considerati immeritevoli di tutela giuridica e che, nel corso del tempo, hanno visto mutare la coscienza sociale.
Questi mutamenti sono stati certificati in vari modi ed hanno trovato la loro emersione lentamente e progressivamente sul piano giurisdizionale, interno e sovranazionale, per poi essere normativizzati dal legislatore.
Pensiamo alle unioni civili fra persone dello stesso sesso, sulle quali Stefano Rodotà ha imbastito buona parte delle sue riflessioni attorno al tema del diritto e amore[5]. L’epopea, il cammino, il lungo cammino dalle prime pronunzie giurisprudenziali delle Corti di merito sul tema della trascrizione di atti di matrimonio redatti all’estero e della loro efficacia sul piano interno.
Comincia così ad emergere in questa complessità già qui solo accennata un altro tema, spesso presente rispetto alle questioni bioetiche e biogiuridiche, della rilevanza della mobilità delle persone, ormai divenuta costante del mondo che ci appartiene.
E ciò sotto un duplice profilo.
Per un verso si assiste ad una mobilità e ad una circolazione che per anni abbiamo avvertito come costante prevalente del mondo delle relazioni commerciali e che è invece diventata, anche grazie alla progressiva integrazione ed approfondimento di quei traffici, mobilità di persone, di centri di interessi “umani”, di affetti, appunto …di amori.
Per altro verso, al primo effetto ne segue un altro, tutto interno al diritto vivente, nel quale la comparazione fra ordinamenti è progressivamente diventata strumento interpretativo di portata e rilevanza enormi, anch’esso emerso nella giurisprudenza costituzionale e lentamente in quella del giudice comune. Le giurisprudenze straniere che si sono occupate di vicende bioetiche e biogiuridiche hanno così assunto progressivamente un’importanza decisiva sul piano interno rispetto alla configurazione di diritti, istituti, strumenti di protezione dei diritti prima sconosciuti.
Per non dire della configurazione delle tecniche di risoluzione delle antinomie fra norme che hanno visto, proprio in campo bioetico e biogiuridico, la Corte costituzionale – nel caso dell’omicidio del consenziente - protagonista di un revirement sulle questioni irrisolte dal legislatore porre le basi per un dialogo con il legislatore proprio evocando precedenti di Corti supreme straniere.
Ecco che comincia ad emergere il ruolo della giurisdizione, di portiere rispetto all’introduzione di fenomeni regolati e disciplinati in altri ordinamenti e non regolati nel nostro; un ruolo volto a verificare la tenuta di atti e fatti che a volte hanno, dunque, una disciplina normativa altra, di matrice ultra nazionale che si vorrebbe potere attuare anche nell’ordinamento interno, secondo i diretti interessati e che altri ritengono, invece, vada impedita valutando che il sistema interno non possa subire influenze e condizionamenti dei singoli sulla tenuta e regolazione di fenomeni sui quali deve essere il sistema nazionale a dire l’ultima parola.
4. Il cammino dell’amore verso il diritto.
Pensiamo per un attimo alle pratiche di fecondazione, alle adozioni, ai fenomeni delle gestazioni per altri, del fine vita, della “relazione di cura” e del “fine cura” e dunque ai sentimenti che si alimentano continuamente e cercano di emergere quando in gioco è la vita di una persona e gli affetti, i familiari del malato rivendicano il diritto a dire la loro ad intervenire, a rappresentare il loro sentimento di amore rispetto al medico [6].
Un grumo di questioni che, dunque, chiamano anzitutto l’ordinamento a verificare se ed in che misura i provvedimenti adottati fuori dal sistema nazionale possano ed in che misura debbano trovare applicazione ed attuazione in ipotesi di “vuoto” normativo o, addirittura di “divieto”, imperativo o meno, che il sistema interno prevede per tali situazioni.
Questioni che attengono, per l’un verso, alla verifica dell’apertura o meno del sistema ai provvedimenti, alle condotte ed ai fatti prodotti fuori dall’ordinamento ma che poi, inevitabilmente, come si accennava, finiscono a volte col produrre un effetto a cascata, occorrendo interrogarsi sul “se” ed in che misura sia possibile per un ordinamento vietare al proprio interno o non considerare atti o fatti che al di fuori di quel sistema esistono e, a volte, sono chiamati a produrre effetti nell’ordinamento interno perché considerati comunque compatibili con l’ordine pubblico. Insomma, questioni che coinvolgono la ragionevolezza e l’eguaglianza delle scelte legislative.
Non diverso risulta il discorso allorché sia la disciplina interna ad essere messa in discussione perché considerata non adeguata a fornire risposta alla domanda di giustizia o, a volte, a quella litigation strategy che ha da tempo preso piede nelle democrazie moderne come il caso Loving cui si accennava all’inizio, insieme a tanti altri sul piano interno (Englaro[7], Welby, dj Fabo solo per ricordare i più noti) insegna.
Fenomeno nel quale, dunque, sono le “cause bandiera” a sollecitare prese di posizione da parte dei giudici su quesiti, scelte- scelte tragiche spesso- alle quali il diritto scritto non sembra in apparenza pronto a dare risposta.
5. Il piano dei valori fondamentali rispetto a diritto e amore
Ed è in questo momento che torna ad assumere un tratto centrale il piano di valori fondamentali che attinge direttamente alla Costituzione, essa stessa inserita (per sua espressa volontà) in un circuito di Carte dei diritti fondamentali e per ciò stesso di “diritti viventi” che vivificano continuamente il senso dei principi fondamentali, mettendo sul tappeto problemi di non poco momento e, fra questi, quello tradizionale dell’interpretazione della Costituzione, della sua specificità rispetto a quella che può riguardare altri testi normativi.
Ora, è estremamente chiaro che interpretare un principio non equivale esattamente ad interpretare una norma di rango ordinario.
Si assiste, così, ad un meccanismo che attribuisce ai principi una molteplice valenza, essi per l'un verso abbisognando di essere interpretati, per poi diventare metro di valutazione delle leggi le quali, a loro volta, possono direttamente attuare un principio fondamentale e, in ogni caso, devono essere interpretate in modo conforme ai principi senza mai superare il contenuto di quegli stessi principi, essi costituendo il limite all'interpretazione costituzionalmente conforme[8].
Principi che possono, infine, assumere anche il tratto di fattore immediato sul quale incentrare le tutele in assenza della legge, ancorché sia ben noto che l’idea del costituzionalismo “principialista” non sia unanimemente condivisa[9].
Il tema è reso ancor più scivoloso per effetto della “concorrenza” proveniente da altre Carte dei diritti che, accanto alla Costituzione, hanno a cuore la tutela dei diritti fondamentali e che, dunque, aggiungono materiale, anch’esso destinato ad operazioni di interpretazione e di bilanciamenti, capace di condizionare - in melius o in peius, a seconda della prospettiva prescelta - la portata della tutela costituzionale. Suscitando ulteriori interrogativi circa l’opportunità ed i limiti entro i quali le giurisdizioni straniere, ancorché sovranazionali, debbano o possano intervengano su temi di portata bioetica e biogiuridica[10].
6. La giostra dei diritti ed il diritto dal basso
Tornando al focus del convegno e dell’intervento, al fondo dei nodi problematici accennati e dunque del quesito se l’amore intercetta il diritto la risposta sembra dover essere affermativa.
Non vi è, forse, l’amore che regge quei fenomeni ai quali si è accennato, il legame sentimentale che sorregge a volte la singola persona (e la relazione che questa ha con il sistema nel quale vive e con la propria vita) a volte le relazioni fra le persone coinvolte, il fascio di valori fondamentali che quelle persone chiedono, a torto o a ragione, di vedere tutelate o hanno diritto ad essere prese in considerazione dall’ordinamento anche se si trovino in una condizioni di estrema o parziale vulnerabilità?
Già qui emerge una prima possibile frizione fra il mondo dei diritti fondamentali regolati da un ordinamento e il grumo degli interessi che fanno capo allo Stato-ordinamento e che si confrontano con quei valori fondamentali.
Una giostra sulla quale i diritti fondamentali e gli interessi fondamentali o imperativi che dir si voglia dello Stato trovano (o cercano di trovare) posto e sulla quale la parola del legislatore a volte è non detta, a volte esiste, ma passa, come si diceva, per la verifica della sua tenuta rispetto al quadro dei valori fondamentali affidata all’autorità giudiziaria.
Una girandola di problemi che passano, dunque, per continue verifiche correlate ai fatti che vengono portati all’attenzione del giudice, per continue operazioni di bilanciamento[11] e di accomodamenti ragionevoli (come dice Cass. S.U. n. 24414/2021) tentati, a volte raggiunti, a volte ipotizzati.
Un diritto che, dunque, si forma spesso dal basso, dalla carnalità dei fatti, dalle soluzioni che essi suscitano, inevitabilmente condizionati dalla specificità e naturale diversità di quegli stessi fatti.
Ora, comune a tutte le questioni sembra essere la questione se un ordinamento debba o non debba offrire tutela agli atti di amore che sorreggono le vicende alle quali qui si è fatto cenno.
E se, ancora, l’ordinamento riesce ad essere con le sue norme immediatamente capace di gestire vicende che nel loro dispiegarsi assumono tratti di assoluta novità per essere inimmaginabili fino a ieri. Penso alla vicenda, recentissimamente rimbalzata sui media, della persona rimasta incinta che aveva in corso un trattamento per cambiare i tratti somatici del proprio corpo e che aveva già ottenuto dal Tribunale la rettifica anagrafica.
7. Tornando alle unioni civili fra persone dello stesso sesso. Andata a ritorno fra diritto straniero, diritto interno e diritto vivente.
Accennerò nuovamente alle questioni delle unioni civili dello stesso sesso, del fine cura e fine vita e, infine, della trascrizione dell’atto di nascita redatto all’estero relativo a casi di maternità surrogata, provando a mettere in evidenza, in modo sintetico, come in ciascuna di tali questioni emerga il cammino del legislatore, degli interpreti e della coscienza sociale.
Un cammino d’amore che nasce e continua ad arricchirsi per i tanti camminatori che su esso si confrontano.
E ciò proprio per dimostrare quanto vi sia bisogno del diritto per regolare l’amore, anche quando l’amore sembra essere negato dall’atto volitivo di terzi che incidono sui diritti incomprimibili delle persone, ovvero negato da una scelta apparentemente incompatibile con un atto di amore perché orientata a porre fine, in modo consapevole, alla vita per raggiungere la sua felicità. Fino a che punto, dunque, questa scelta d’amore può e deve essere presa in considerazione dall’ordinamento? Quanto la risposta a tale quesito è condizionata dalla casualità delle vicende, o dalle risposte offerte dalla giurisprudenza? Quanto l’ordinamento si deve quindi prendere cura della felicità delle persone?
Partiamo dalla vicenda delle unioni civili di persone dello stesso sesso.
Il cammino della giurisprudenza nazionale è stato affiancato da quello della giurisprudenza delle Corti sovranazionali.
Proprio la vicenda del matrimonio fra persone dello stesso sesso prende le mosse dal fenomeno al quale si è accennato all’inizio e approda in diverse occasioni alla Corte costituzionale.
Chiusa la porta della Corte costituzionale la vicenda è approdata alla Corte europea dei diritti dell’uomo, ove si è spalancata la porta delle tutele. Qui per la scelta, ancora una volta un atto volitivo, di alcune persone che assumevano il deficit di tutela normativa interno – divieto di pubblicazioni del matrimonio - fosse lesivo delle proprie prerogative.
Dunque, ancora una volta viene rappresentato uno scenario nel quale il sistema ritiene inizialmente che il sentimento di amore che lega le persone dello stesso sesso non meritava alcuna considerazione dall’ordinamento e dunque non rendeva giustificata alcuna regolamentazione normativa. Ma il sistema non si è fermato. E con esso la coscienza sociale.
Nel caso Oliari c. Italia la Corte edu segue i suoi paradigmi e nell’affrontare il tema della violazione convenzionale del diritto al rispetto della vita familiare riconosce il deficit normativo dell’Italia in materia di unioni fra persone dello stesso sesso. E lo fa ricordando che “dall’esame di cui sopra del contesto interno emerge l’esistenza di un conflitto tra la realtà sociale dei ricorrenti che prevalentemente vivono in Italia la loro relazione apertamente, e la legislazione che non fornisce loro alcun riconoscimento ufficiale sul territorio. Secondo la Corte l’obbligo di prevedere il riconoscimento e la tutela delle unioni omosessuali, consentendo in tal modo alla legge di rispecchiare le realtà delle situazioni dei ricorrenti, non comporterebbe alcun particolare onere per lo Stato italiano di tipo legislativo, amministrativo o di altro tipo. Inoltre, tale legislazione risponderebbe a un’importante esigenza … le statistiche nazionali ufficiali indicano che, soltanto nell’Italia centrale, vi è circa un milione di omosessuali (o di bisessuali)” - cfr. sent. Oliari c. Italia, p.173 -.
Ecco emergere l’essenza della coscienza sociale, il suo ruolo, quello di chi pretende una tutela non ammessa dall’ordinamento, quello di chi, giudice sovranazionale, agganciato alla dottrina del consenso, tuttavia prende atto che i margini di discrezionalità dei singoli paesi si è andato fortemente riducendosi per effetto dei riconoscimenti operati da diverse legislazioni al fenomeno sconosciuto in ambito nazionale, nel senso di richiedere comunque una regolamentazione normativa fino a quel momento sostanzialmente inesistente e comunque incerta nell’an e nel quomodo.
Da qui la legge sulle unioni civili n.76/2016, la regolamentazione di quegli atti di amore che, ora divenuti meritevoli di tutela ed emersi nella loro dimensione sociale e non solo individuale, diventano parametri per la disciplina del fenomeno delle unioni, prendendo in considerazione il legame d’amore e dandone disciplina.
Una disciplina che, poi, diventa anche regolazione della “fine dell’amore” con il rinvio alla disciplina in tema di assegno di divorzio.
Ecco emergere, ancora una volta, la dimensione plurale dei diritti, la dimensione che affianca al diritto il dovere di amore.
Dovere (di disciplina positiva) che prende corpo allorché l’ordinamento, all’atto di disciplinare un diritto d’amore, non può tralasciare di considerare l’ipotesi che ciò che si è inteso dapprima tutelare possa un domani cessare, determinando la presa in carico da parte del legislatore di chi in quell’atto di amore aveva investito tempo, risorse e vita.
La dimensione ontica dei diritti fondamentali si coniuga a quella che, appunto, considera sottostante ai diritti fondamentali anche un’esigenza che sta oltre l’individuo, una dimensione collettiva e impersonale che l’ordinamento prende in considerazione, appunto risultando improntato al canone fondamentale della solidarietà. Se l’amore finisce, occorre che l’ordinamento si prenda cura di chi su quell’atto di amore aveva fatto affidamento, dedicando la propria esistenza alla salvaguardia dell’altro. Si tratta dell’altra faccia dell’amore e dei diritti fondamentali coinvolti: la dimensione della doverosità dei diritti fondamentali in funzione dell’obbligo di solidarietà che affonda le sue radici, anch’esso, nella dignità della persona. Quello che a più riprese Antonio Ruggeri ricorda come carattere deontico dei valori dell’uomo[12].
Tornando alle unioni civili solo due parole sulla vicenda, approdata in Corte di cassazione, relativa alla verifica della rilevanza, ai fini dell’assegno spettante al componente dell’unione debole all’atto della crisi del rapporto e della incidenza della convivenza precedente all’unione civile che non si era potuta contrarre per un deficit di tutela normativa.
Ora, l’approdo della causa alla prima sezione avrebbe consentito certo di decidere la controversia. L’esigenza di investire le Sezioni Unite con un’ordinanza articolata (Cass.n.2507/2023) dà il senso del ruolo della giurisdizione rispetto a temi estremamente delicati. Una scelta che non va vista come defatigatoria, prudente, ma al contrario come scelta consapevole di propiziare una risposta autorevole capace di porsi in una funzione nomofilattica particolarmente avvertita proprio per la delicatezza delle implicazioni nascenti dalla soluzione finale. Una scelta che è scelta, dunque, e non è “non scelta”, ma modo di alimentare la giurisdizione, aprirla al confronto partecipato non delle sole parti, ma della dottrina, del mondo dell’Avvocatura, della formazione dei giuristi tutti. Se si accede a questa prospettiva si coglie in modo forse chiaro il senso del giudicare che oggi si alimenta continuamente di un dialogo fra giudici, ed operatori del diritto che rende la risposta finale dotata di elementi sempre più ponderati e, in definitiva, persuasivi, accettabili e quindi prevedibili. In questa luce va dunque letto l’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite-Cass. S.U. n.35969/2023-[13].
Ma il discorso sulle unioni civili fra persone dello stesso sesso non può dirsi concluso, affatto, ponendosi e permanendo la questione se le forme di tutela in atto introdotte rispecchino compiutamente la nozione di famiglia introiettata dalla coscienza sociale e se questa sia compatibile con quella scolpita in Costituzione ovvero se occorra un intervento normativo, che secondo taluni dovrebbe riguardare lo stesso art.29 Cost.[14], volto a riconoscere il “diritto al” matrimonio alle coppie dello stesso sesso. Ci si avvede, così, che il mondo del diritto rispetto al tema dell’amore è in continuo movimento e non si arresta, quasi mai raggiunge mete definitive.
8. Il diritto di amarsi fino alla fine con dignità ed il “problema” del “fine vita” e del “fine cura”.
In questo farsi continuo del diritto il tema dell’amore intercetta anche la scelta “tragica” di chi decide di porre fine alla propria esistenza.
Tema sconfinato e che qui non si intende affatto esaminare se non per ribadire quanto già detto in passato[15] e cioè che di fronte a fatti di amore, anche tragici, quale può essere quello che si esprime, attraverso l’autodeterminazione, nel porre fine alla propria esistenza è più che mai necessario l’intervento del diritto per fare uscire quei fatti dalle zone grigie ed impervie del “non diritto” e dell’incertezza.
Anche in questo ambito si riscontra una quasi incredibile sovrapposizione di questioni, dubbi ed interrogativi che avevamo visto presenti sul tema delle unioni civili, quasi a disegnare un vero e proprio format, uno schema comune, che si va via via delineando per effetto di una rinnovata attenzione a fenomeni prima non adeguatamente considerati dal corpo sociale o addirittura relegati nella sfera intima -e per questo considerata non giuridica- e poi nel tempo rivalutati, anche per effetto di iniziative giudiziarie di singole persone maturate in contesti nazionali e/o sovranazionali, di prese di posizione della giurisprudenza nazionale e straniera, di interventi sempre più incisivi delle giurisdizioni costituzionali e sovranazionali- Corte di Giustizia UE, Corte europea dei diritti dell’uomo”- di nuovi spunti scientifici.
Interesse, attenzione, considerazione che finiscono poi col riproporre l’interrogativo sull’opportunità o meno di una legislazione in materia, attivando quelle riflessioni già espresse nei paragrafi precedenti in un contesto solo apparentemente diverso ed evocando, ancora una volta, il format che sta alla base di molte questioni biogiuridiche.
Questioni che assumono spesso la dimensione della tragicità, che abbiamo di recente vissuto, forse senza coglierne la lezione, nell’esperienza pandemica e che, ancora una volta, attivano il rapporto fra amore e diritto. Il pensiero corre immediatamente alle scelte dei sanitari che, al picco della pandemia, furono chiamati a “scegliere” le priorità da riservare ai malati che facevano ricorso alle cure mediche[16].
Ci si accorge, così, quanto i temi qui accennati siano tutti tra loro avvinti anche ad altre non meno dolorose questioni biogiuridiche, emerse a proposito della scelta, anch’essa tragica, dei sanitari di interrompere le cure per soggetti ritenuti ormai “incurabili” e rispetto ai quali la prosecuzione delle terapie si tramuterebbe in indebito accanimento terapeutico. Quanto, al fondo di quali questioni, il tema dell’amore alimenta i diversi centri di interessi, gli affetti, del malato, dei familiari e degli stessi sanitari e quanto “il diritto” ha il “dovere” di intervenire?[17]
9. Il ruolo della giurisdizione. Il camminare della giurisprudenza (verso l’amore).
Vengo ora alle conclusioni del mio intervento con una riflessione suscitata da una pronunzia delle Sezioni Unite che trovo centrale per la rappresentazione del giudicare al quale sento di ispirarmi, per quel che vale.
Mi riferisco alla sentenza delle S.U. civili sul tema della trascrizione dell’atto di nascita redatto all’estero tra minore venuto al mondo con la tecnica della maternità surrogata e genitore d’intenzione.
Cass., S.U., n.38162/2022, con una decisione di sistema ispirata ad un’ottica di ragionevolezza e di equilibrio, ripercorrendo tutte le più recenti tappe della giurisprudenza interna espressa nello stesso caso, confermandole ed integrandole (Sezioni Unite del 2019 n. 12193; Corte costituzionale n. 33 del 2021 e la successiva n. 79 del 2022, ordinanza di rimessione della prima sezione civile della Corte di Cassazione n. 1842 del 2022), ha riportato ad unità e coerenza il dialogo tra le Corti interne e la Corte di Strasburgo sul delicato tema della maternità surrogata.
Vi sono infatti dei passaggi a mio avviso fondamentali per dimostrare quale sia oggi il ruolo del giudice e quanto sia avvertita la delicatezza del giudicare.
Cass.S.U. n. 38162/2022 è senza dubbio paradigmatica, giunta al termine (almeno per ora) dei percorsi di avvicinamento alla soluzione di un caso di richiesta di riconoscimento di atto di nascita compiuto all’esterno da una coppia che aveva generato i figli con un contratto di maternità surrogata.
Sono già i passaggi che la vicenda ha avuto (due volte rinviata dalla prima sezione alle Sezioni Unite della Cassazione, una volta rimessa alla Corte costituzionale che dichiarò l’inammissibilità della questione, evocando la giurisprudenza della Corte edu ed il parere reso in sede di richiesta ai sensi del Protocollo n.16) ad offrire uno spaccato, in tutta la sua complessità, di ciò che è oggi il diritto che si pratica nelle Corti.
Un diritto sempre più plurale per il numero di giudici che sono coinvolti nella decisione, giudici remittenti, (giudici di merito, sezioni semplici e Sezioni unite della Cassazione, Corte costituzionale, Corte edu, Corte di giustizia UE) e plurale per i nodi da sciogliere che involgono gli stessi diritti, ma con protezione e tecniche di tutela e risoluzione delle antinomie essi stessi plurali.
Ora, al di là della rilevanza del caso di specie, pur delicato perché eticamente sensibile, preme qui sottolineare alcuni passaggi motivazionali della decisione che mostrano come la giurisprudenza sia davvero in cammino nella sua quotidiana ricerca della soluzione più giusta e adeguata al caso.
La soluzione maturata dalle Sezioni unite, di chiusura alla trascrivibilità dell’atto straniero per contrasto con l’ordine pubblico internazionale è al contempo, al contempo, di apertura verso forme di tutela del superiore interesse del minore che muovono, a loro volta, dall’ispessimento delle ipotesi di adozione legittimante (artt. 44, lett. d) l.n.184/1983).
La soluzione che le Sezioni Unite, per ben due volte, ritengono idonea allo stato, a salvaguardare le esigenze di tutela del rapporto/relazione familiare con il genitore d’intenzione è frutto di un cammino- originato prima dalle Corti di merito e poi confermato dalla Cassazione e dalla Corte costituzionale (Cass., Sez. I, 22/06/2016, n. 12962, Corte cost. n.272/2017) - giunto alla conclusione che nemmeno il giudice costituzionale avrebbe potuto colmare la lacuna rispetto alla necessità di regolare per legge la relazione minore genitore d’intenzione che ha mantenuto una relazione familiare e che, allo stato, è priva di piena tutela, come ha pure riconosciuto la Corte costituzionale.
I passaggi motivazionali sembrano dunque dimostrativi di cosa sia, oggi, il diritto.
Da un lato, infatti, le S.U. chiariscono che, di fronte al monito al legislatore indirizzato dalla Corte costituzionale (Corte cost.n.33/2021) e rimasto inascoltato,
Nell'attesa dell'intervento, sempre possibile ed auspicabile, del legislatore, il giudice, trovandosi a dover decidere una questione relativa allo status del figlio di una coppia omoaffettiva, non può lasciare i diritti del bambino indefinitamente sospesi, ma deve ricercare nel complessivo sistema normativo l'interpretazione idonea ad assicurare, nel caso concreto, la protezione dei beni costituzionali implicati, tenendo conto delle indicazioni ricavabili dalla citata sentenza della Corte costituzionale.
Qui c’è buona parte della lezione grossiana sull’invenzione del diritto, nel senso di ricerca, di scavo[18].Uno scavo che incontra tuttavia dei limiti. Infatti, proseguono le S.U.
Anche quando non si trova al cospetto di un enunciato normativo concepito come regola a fattispecie, ma è investito del compito di concretizzare la portata di una clausola generale come l'ordine pubblico internazionale, che rappresenta il canale attraverso cui l'ordinamento si confronta con la pluralità degli ordinamenti salvaguardando la propria coerenza interna, o di un principio, come il migliore interesse del minore, in cui si esprime un valore fondativo dell'ordinamento, il giudice non detta né introduce una nuova previsione normativa. La valutazione in sede interpretativa non può spingersi sino alla elaborazione di una norma nuova con l'assunzione di un ruolo sostitutivo del legislatore. La giurisprudenza non è fonte del diritto. Soprattutto in presenza di questioni, come quella oggetto del presente giudizio, controverse ed eticamente sensibili, che finiscono con l'investire il significato della genitorialità, al giudice è richiesto un atteggiamento di attenzione particolare nei confronti della complessità dell'esperienza e della connessione tra questa e il sistema. Si tratta di temi, infatti, in rapporto ai quali lo stesso diritto di famiglia, nel mentre riflette, come uno specchio, lo stato dell'evoluzione delle relazioni familiari nel contesto sociale, tuttavia non può prescindere dal sistema, affidato anche alle cure del legislatore. Ciò vale soprattutto in una vicenda, come l'attuale, nella quale si profila un ambito di discrezionalità del legislatore che la Corte costituzionale ha inteso preservare, indicando un percorso di collaborazione istituzionale nel quadro di un bilanciamento tra la legittima finalità di disincentivare il ricorso alla maternità surrogata e l'imprescindibile necessità di assicurare il rispetto dei diritti dei minori.
Non si fermano a queste argomentazioni i giudici di legittimità ed anzi aggiungono che questo approccio è dovuto a fattori centrali che vengono così enucleati
Il rispetto del pluralismo e dell'equilibrio tra i poteri, profilo centrale della democrazia, perché la ricerca dell'effettività deve seguire precise strade compatibili con il principio di leale collaborazione e con il dialogo istituzionale che la Corte costituzionale ha avviato con il legislatore. La presa d'atto che talora la ricerca dell'effettività richiede un camminare in direzione di una meta non ancora completamente a portata di mano, perché la gradualità concorre a far assorbire il cambiamento e le novità nel sistema, con la giurisprudenza che accompagna ed asseconda l'evoluzione che si realizza nel costume e nella coscienza sociale. La coerenza degli orientamenti giurisprudenziali, giacché le nuove frontiere dell'interpretazione che aspirino a offrire stabilità e certezza non conseguono a bruschi cambiamenti di rotta, ma sono il frutto di un progredire nel dialogo con i precedenti, con le altre Corti e con la cultura giuridica. Non c'è spazio, in altri termini, né per una penetrazione diretta - attraverso la ricerca di un bilanciamento diverso da quello già operato dal Giudice delle leggi - di quell'ambito di discrezionalità legislativa che la Corte costituzionale ha inteso far salvo, né per una messa in discussione del punto di equilibrio da essa indicato.
In definitiva, la portata sistematica di tale pronuncia è enorme.
Essa dimostra, per l’un verso, come la nomofilachia si nutra del concentrico sforzo ermeneutico di tutte le Corti coinvolte, tanto nazionali che sovranazionali[19].
Senza l’ordinanza interlocutoria della prima sezione civile, che in modo assolutamente rituale ha espresso dubbi in ordine alla ricostruzione precedentemente avallata dalle stesse Sezioni Unite richiamando anche la giurisprudenza convenzionale, non si sarebbe attivato l’ulteriore dialogo con la Sezioni Unite di fine 2022.
Per altro verso, le S.U. sono ben consapevoli del “limite” oltre il quale la forza coerenziatrice del diritto non può spingersi, ricordando che la giurisprudenza “non è fonte del diritto”.
Un limite che, tuttavia, le stesse Sezioni unite vedono come mobile, non fisso, destinato ad essere continuamente rivisto in relazione al contesto, al dibattito dottrinario, alle risposte del legislatore. In quelle rime di Cass.S.U. n.38162/2022 si scorge un condensato di principi di struttura del sistema di protezione dei diritti che nessun operatore del diritto consapevole della complessità del nostro tempo dovrebbe tralasciare.
Uno scrigno[20] nel quale l’operatore del diritto avveduto può fare proprie le ragioni dell’essere, egli stesso, costruttoredel diritto se coerentemente inserito nel sistema, con il proprio ruolo e con la ricchezza che esso assume rispetto alla infinita diversità dei casi. Uno scrigno nel quale campeggiano anche, il metavalore dell’effettività, sul quale tante pagine importanti sono state scritte da Cesare Massimo Bianca[21] e Nicolò Lipari[22].
Gli operatori giudiziari che operano con l’occhio attento alla coscienza sociale[23], dando respiro e vita all’art.2 Cost. e che contribuiscono a rendere viva e attuale la tutela dei diritti, ciascuno nel proprio ruolo esercitano, dunque, il loro mestiere con fedeltà piena, assoluta ed incondizionata alla Costituzione, purché abbiano ben chiaro la responsabilità che da quel ruolo consegue, di pari ampiezza a quella che connota i tratti del giudicare. E sono dunque protagonisti di quel camminare e progredire al quale le S.U. accennano, affidando il testimone a tutte le persone d’amore qui rappresentate da chi ha avuto la pazienza di ascoltare.
Mettere a frutto anche sul tema del quale si è qui provato a discutere i principi sopra ricordati costituisce, forse, la sfida degli anni a venire, nella quale ciascuno sarà chiamato a scrivere qualche pagina del diritto “con amore”, in esso ritrovando l’essenza stessa della pace[24]. E gli interventi, lucidi e appassionati che questo Convengo ha suscitato costituisce la migliore dimostrazione di quanto la strada sul cammino in tema di diritto ed amore già tracciata dai Maestri qui ricordati richiederà la costruzione di nuovi ponti, solidi perché poggiati sulle fondamenta che i pionieri hanno silenziosamente realizzato.
[1] S. Rodotà, op.cit., 92, giustamente osserva che “L’amore e le sue definizioni costituiscono da sempre un gigantesco corpus, infinitamente costruito dalle riflessioni più diverse”
[2] F. Gazzoni, Amore e diritto ovverosia i diritti dell’amore, Napoli, 1994, 3. Per una panoramica essenziale sul tema sono fondamentali gli scritti di S.Rodotà, Diritto d’amore, Roma, 2015; A. Falzea, Fatto di sentimento, in Voci di teoria generale del diritto, Milano, 1985, 539; P. Spaziani, Diritto e sentimento: le ragioni di un ritorno al principio di effettività, in Giustiziainsieme, 6 maggio 2020. È d’altra parte intrisa d’amore profondo per il ruolo del diritto nelle relazioni di sentimento l’intera opera scientifica di Cesare Massimo Bianca, oggi testimoniata e vivificata dall’intervento a questo stesso Convegno della Prof.ssa Mirzia Bianca.
[3] Sul punto, diffusamente, P. Spaziani, cit.
[4] S. Rodotà, Diritto d’amore, cit., 76.
[5] S. Rodotà, op.cit., 103.
[6] Tema, quest’ultimo a me assai caro sul quale tornerò a dire qualcosa nel prosieguo, quest’ultimo involgendo quello delle relazioni parentali che si inseriscono nella relazione di cura per espressa previsione normativa. Basti pensare al comma 2 dell’art.1 della l.n.219/2017 “. In tale relazione sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari o la parte dell’unione civile o il convivente ovvero una persona di fiducia del paziente medesimo”, al comma 5 dello stesso art.1, l.cit. “Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica.
[7] Sulla vicenda v. ora G. Luccioli, Dignità della persona e fine della vita, Bari, 2022 e, volendo, la recensione al saggio di R. Conti, Giustiziainsieme, 17 settembre 2022.
[8] V., sul punto, R. Conti, La convenzione europea dei diritti dell'uomo, Roma, 2011, 196.
[9] L. Ferrajoli, Costituzionalismo principialista e costituzionalismo garantista, in Giur. Cost., 2010, 3, 2771 ss. Per un’efficace critica al pensiero dell’insigne studioso v. G. Pino, Principi, ponderazione, e la separazione tra diritto e morale. Sul neocostituzionalismo e i suoi critici, in Giur.cost., 2011,965 ss.
[10] Compito di delicatezza e portata micidiale, quello riservato all’interprete e che sembra essere ben disvelato da una recente pronunzia delle Sezioni Unite civili, ove si è affermato che “l'interpretazione della legge…ha ad oggetto non norme fatte e definite, ma enunciati linguistici - quelli che costituiscono le disposizioni legislative - di cui il giudice deve cogliere il significato non solo attraverso il ricorso alle regole semantiche del linguaggio comune e di quello giuridico, ma anche in rapporto a tutte le norme del sistema nel quale le singole disposizioni si collocano e con le quali interferiscono (a partire dalle norme costituzionali e dai principi generali dell'ordinamento giuridico). Tale complessa attività ermeneutica chiama il giudice ad una ponderazione dei valori sottesi alle norme giuridiche da applicare e degli scopi perseguiti dal legislatore: il giudice, nell'interpretazione della legge, deve determinarne il significato ponderando i valori, segnatamente quelli costituzionali, immanenti nell'ordinamento.” - cfr.Cass.S.U. n.8906/2020-.
[11] V. Cass. S.U. 9 dicembre 2015, n.24822, Cass. 28 aprile 2015 n.8605, Cass., S.U. 21 dicembre 2018 n.33208, Cass., S.U., 12 giugno 2019, n. 15750, Cass.S.U.19888/2019, Cass. S.U. n.20404/2019, Cass.n.9147/2020, Cass.n.8325/2020.
[12] A. Ruggeri, Appunti per uno studio sulla dignità dell’uomo, secondo diritto costituzionale, in Riv.AIC,15 dicembre 2010, par.2.
[13] V., volendo, R. Conti, La funzione nomofilattica delle Sezioni Unite civili vista dall’interno (con uno sguardo all’esterno), in Giustiziainsieme, 11 gennaio 2024.
[14] A. Ruggeri, La spinosa questione dello status dei figli di coppie omosessuali: profili di metodo e di teoria costituzionale, in Itinerari di una ricerca sul sistema delle fonti, XXVI. Studi dell’anno 2023, Torino, 2024, 124.
[15] V., volendo, R. Conti, Il cammino incerto del diritto sul fine vita, Giustiziainsieme, 15 aprile 2023. E prima ancora in R. G. Conti, Scelte di vita e di morte. Il giudice è garante della dignità?, Roma, 2019.
[16] V., volendo, Tragic choices, 42 anni dopo. Philip Bobbitt riflette sulla pandemia. Intervista di R. Conti, Giustiziainsieme, 17 maggio 2020 e in particolare le conclusioni all’intervista. V., ancora, Scelte tragiche e Covid 19, Intervista a Luigi Ferrajoli, Antonio Ruggeri, Luciano Eusebi e Giorgio Trizzino, Giustiziainsieme, 24 marzo 2020.
[17] Sui temi da ultimo accennati si è provato a riflettere, a proposito dell’art.2 l.n.219/2017, in R. Conti, Scelte di vita o di morte. Il giudice è garante della dignità? cit., 83,100.
[18] P.Grossi, L’invenzione del diritto, Roma-Bari, 2017, 82 e 115; P. Grossi, Prefazione a Il mestiere del giudice, a cura di R. G. Conti, Padova, 2020, XVI: “Il vecchio giudice, condannato ad essere ‘bocca della legge’ dai riduzionismi strategici degli illuministi (dapprima) e dei giacobini (successivamente), non può che togliersi volentieri di dosso la veste opprimente dell’esegeta, ormai del tutto inadatta, e indossare quella dell’interprete, dell’inventore, intendendo la sua operazione intellettuale irriducibile in deduzioni di semplice natura logica (come in una celebre pagina di Beccaria) e concretizzabile piuttosto in una ricerca, in un reperimento, con le conseguenti decifrazione e registrazione. Quello che mi sentirei, invece, di rifiutare, decisamente perché fonte di più che probabili malintesi, è il sintagma ‘creazione giurisprudenziale’, che usa Pastore (pp. 240 e 241) nel suo – peraltro, meditatissimo e condivisibile – intervento. Infatti, è proprio di ‘creazione ‘ e di ‘creazionismo’ che parlano gli adepti del legalismo statalistico stracciandosi le vesti di fronte a un ruolo, innaturale perché para-legislativo, conferito (almeno secondo loro) ai giudici dalla riflessione ermeneutica. Insisterei, come ho fatto anche di recente, su un ruolo inventivo, marcando bene che si fa esclusivo riferimento alla inventio dei latini consistente appunto in un ‘cercare per trovare’.
[19] R. Conti, Chi ha paura del Protocollo n.16 … e perché?, in Sistemapenale, 27 dicembre 2019.
[20] M. Bianca, Le Sezioni Unite e i figli nati da maternità surrogata: una decisione di sistema. Ancora qualche riflessione sul principio di effettività nel diritto di famiglia, Giustiziainsieme, 6 febbraio 2023.
[21] C. M. Bianca, Ex Facto oritur jus, in Riv.dir.civ. n.6/1995, 796.
[22] N. Lipari, Il diritto civile tra legge e giudizio, Milano, 2017. V., volendo, le riflessioni espresse sul saggio in R. Conti, Leggendo l’ultimo Lipari, Questionegiustizia, 11 novembre 2017.
[23] Cass. 8713/2015, Cass.n.7981/2014, Cass.S.U. n.6059/2019, Cass.n.10423/2019, Cass.n.23320/2021 Cass.S.U. n.3572/2022, cfr. SU n. 24413 del 2021, n. 27341 del 2014, Cass.n.32212/2022. V. pure Cass.n.15002/2019, secondo cui “la giusta causa di licenziamento è una nozione di legge che si viene ad inscrivere in un ambito di disposizioni caratterizzate dalla presenza di elementi "normativi" e di clausole generali (Generalklause) - correttezza (art. 1175 c.c.); obbligo di fedeltà, lealtà, buona fede (art. 1375 c.c.); giusta causa, appunto (art. 2119 c.c.) - il cui contenuto, elastico ed indeterminato, richiede, nel momento giudiziale e sullo sfondo di quella che è stata definita la "spirale ermeneutica" (tra fatto e diritto), di essere integrato, colmato, sia sul piano della quaestio facti che della quaestio iuris, attraverso il contributo dell'interprete, mediante valutazioni e giudizi di valore desumibili dalla coscienza sociale o dal costume o dall'ordinamento giuridico o da regole proprie di determinate cerchie sociali o di particolari discipline o arti o professioni, alla cui stregua poter adeguatamente individuare e delibare altresì le circostanze più concludenti e più pertinenti rispetto a quelle regole, a quelle valutazioni, a quei giudizi di valore, e tali non solo da contribuire, mediante la loro sussunzione, alla prospettazione e configurabilità della tota res (realtà fattuale e regulae iuris), ma da consentire inoltre al giudice di pervenire, sulla scorta di detta complessa realtà, alla soluzione più conforme al diritto, oltre che più ragionevole e consona. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura di norma giuridica, come in più occasioni sottolineato da questa Corte, e la disapplicazione delle stesse è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge. Pertanto, l'accertamento della ricorrenza, in concreto, nella fattispecie dedotta in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, è sindacabile nel giudizio di legittimità, a condizione che la contestazione non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga una specifica denuncia di incoerenza rispetto agli "standards" conformi ai valori dell'ordinamento esistenti nella realtà sociale (Cass. n. 25044/15; Cass. n. 8367/2014; Cass. n. 5095/11). E ciò, in quanto, il giudizio di legittimità deve estendersi pienamente, e non solo per i profili riguardanti la logicità e la completezza della motivazione, al modo in cui il giudice di merito abbia in concreto applicato una clausola generale, perché nel farlo compie, appunto, un'attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma, dando concretezza a quella parte mobile della stessa che il legislatore ha introdotto per consentire l'adeguamento ai mutamenti del contesto storico-sociale (Cass., S.U., n. 2572/2012).
[24] A. Ruggeri, Verità religiose e verità costituzionali a confronto: il profondo significato per la teoria giuridica di talune sostanziali convergenze, in Itinerari di una ricerca sul sistema delle fonti, XXVI. Studi dell’anno 2023, Torino, 2024, 366.
(Immagine: Guy Le Querrec, Budapest, Thursday 1st May, 1980, cm 30 x 40. ©Magnum Photos, Paris,fonte)
Questo contributo è parte del percorso intrapreso da questa Rivista per ricordare Giacomo Matteotti a cento anni dal suo assassinio, avvenuto il 10 giugno 1924. Il IV convegno di Giustizia Insieme, "La magistratura e l'indipendenza", Roma 12 aprile 2024 è dedicato alla memoria di Giacomo Matteotti. Per gli altri contributi già pubblicati si veda Giacomo Matteotti: il suo e il nostro tempo di Licia Fierro, Discorso alla Camera del Deputati del 30 maggio 1924 di Giacomo Matteotti, "Il delitto Matteotti" e quel giudice che voleva essere indipendente (nel 1924) di Andrea Apollonio, Una risalente (ma non vecchia) vicenda processuale: il pestaggio fascista in danno dell’on. Giovanni Amendola del 26 dicembre 1923 di Costantino De Robbio, La magistratura al tempo di Giacomo Matteotti di Giuliano Scarselli.
A margine del Processo Matteotti: la coerenza di un magistrato in tempo di regime
di Costantino De Robbio
Sommario: I magistrati, l’idealismo e le “sliding doors”. - 2. Un esempio dal secolo scorso: l’omicidio dell’onorevole Giacomo Matteotti e l’istruttoria preliminare al processo. - 3. La caduta del fascismo e la riapertura del processo. - 4. La versione di Del Giudice. - 5. La conclusione del processo agli assassini di Matteotti… e di questa storia.
1. I magistrati, l’idealismo e le “sliding doors”.
Non credo sia mai esistito un magistrato che abbia preso servizio il primo giorno di lavoro con l’idea di essere disposto a farsi corrompere, ad abbassare la testa, a volgere lo sguardo altrove.
Sarebbe una contraddizione in termini troppo stridente: studiare per anni il diritto e le leggi, impadronirsi con fatica e sudore della tecnica idonea a rendere giustizia avendo come fine di denegarla, stravolgerla, usarla per perpetrare abusi ed ingiustizia.
Eppure capita di leggere di giudici e pubblici ministeri che hanno piegato la funzione rivestita a interessi illegali, arrivando a tradire il giuramento di fedeltà allo Stato; forse meno che nel resto della società, ma quando accade è una rovina per tutti, una sconfitta non solo individuale o di categoria, ma collettiva.
E allora, se neghiamo in radice che esista un vizio originario, dobbiamo necessariamente accedere all’idea che vi stato per alcuni di noi un momento in cui la purezza primigenia si è offuscata, un episodio, un’occasione che ha rappresentato una sliding door che ha posto quel magistrato ad un bivio tra la coerenza dell’ideale iniziale e il cedimento a quel mondo che si aveva scelto di combattere.
Probabilmente ciascun giudice, ciascun pubblico ministero ha in mente uno o più momenti della propria storia in cui ha visto davanti a sé questo bivio e, fortunatamente, per la maggior parte la scelta è stata quella della coerenza.
Meno comune è l’esperienza di chi si è trovato a compiere questa scelta sapendo che il prezzo da pagare per rimanere dalla parte giusta era molto più importante della rinuncia ad un’indebita prebenda o a uno scatto di carriera non meritato, ma coinvolgeva la propria incolumità o addirittura la propria vita.
È quanto accade in momenti di particolare fibrillazione della tenuta morale di un Paese, messa in discussione fino alla radice da elementi infettanti (terrorismo, mafia, logge deviate).
È l’esperienza che capita, altresì, a chi vive in un regime non democratico; come avvenuto in Italia un secolo fa, ai tempi del fascismo.
In queste circostanze la scelta della coerenza ai principi per cui si è prestato giuramento comporta prima o poi la fine della propria tranquillità esistenziale e l’inizio di una vita di umiliazioni professionali e personali, senza alcun riconoscimento da parte di altri del valore del sacrificio compiuto.
Si sceglie, in quei casi, altresì di esporre se stessi e i propri cari ad attentati alla incolumità, fino a mettere in preventivo l’idea di morire.
Chi si è trovato a fare questa scelta estrema e non ha deviato, accettando tutte le conseguenze della fedeltà alle istituzioni, merita giustamente il titolo di eroe.
Molti li conosciamo, sono il nostro piccolo Pantheon e l’esempio quotidiano che ci spinge ad andare oltre i nostri limiti; altri sono un po’ meno noti, seppur non meno meritevoli di ricordo.
Questa è la storia di Mauro Del Giudice, un giudice istruttore della Corte di Appello di Roma di cento anni fa.
2. Un esempio dal secolo scorso: l’omicidio dell’onorevole Giacomo Matteotti e l’istruttoria preliminare al processo.
Il nuovo viaggio di Giustizia Insieme nei fascicoli del passato, scaturito dalla collaborazione con l’Archivio di Stato, parte stavolta dalla consultazione e dallo studio di un incartamento processuale relativo a un fatto di sangue a tutti noto: l’omicidio di Giacomo Matteotti.
Il reato è tra i più efferati e dolorosi della storia del nostro Paese ed ha scosso dalle fondamenta fino a rischiare di travolgerlo il regime fascista, per la brutalità senza precedenti nei confronti di un parlamentare simbolo della morente libertà di pensiero.
In questa sede si è scelto di esaminare le carte dal punto di vista particolare che costituisce il focus di attenzione della nostra rivista: esaminando criticamente il modo in cui il processo ai responsabili dell’omicidio è stato vissuto da uno dei magistrati che se ne sono occupati, di come abbia rappresentato la sua personale sliding door esistenziale; e del modo in cui abbia attraversato questa immaginaria porta con la schiena dritta.
Il fatto: il 10 giugno del 1924 il deputato Giacomo Matteotti venne rapito in pieno giorno mentre camminava sul Lungotevere da cinque uomini che, dopo averlo picchiato fino a fargli perdere i sensi lo caricarono in una macchina e si allontanarono per destinazione ignota.
Erano passati solo dieci giorni dal celebre discorso con cui l’onorevole, tra le proteste e le minacce di morte profferite nei suoi confronti dai fascisti che cercavano invano di ridurlo al silenzio, aveva in Parlamento contestato la legittimità delle elezioni – che saranno poi, anche se nessuno all’epoca poteva immaginarlo, le ultime per venti anni – e denunciato minuziosamente, per ore in un interminabile ed eroico canto del cigno della democrazia le violenze e le aggressioni che rendevano illegittima la votazione e la stessa esistenza del partito fascista[1].
Con quel discorso Matteotti si era definitivamente accreditato come fiero oppositore del regime nascente e consapevolmente condannato a morte certa[2].
L’omicidio e le sue finalità risultarono dunque evidenti a chiunque, senza bisogno di evidenze probatorie, che pure giunsero immediatamente e, sorprendentemente copiose.
Proprio come avvenuto qualche mese prima con l’aggressione a Giovanni Amendola[3], la troppa sicurezza o forse la consapevolezza di poter contare sull’impunità instradarono infatti l’istruttoria su binari veloci: non solo l’assalto al deputato era stato visto da numerosi testimoni oculari, ma altri avevano annotato la targa della Lancia che già dalla sera prima stazionava, in modo sospetto, davanti all’abitazione di Matteotti. Durante la colluttazione tra l’onorevole socialista e i suoi aggressori, prima che quegli fosse caricato a forza nell’autovettura e portato via, si avvicinarono addirittura alla scena alcuni ragazzini, spinti dalla curiosità, finché uno degli assalitori intimò loro di allontanarsi e, per rafforzare l’intimazione, diede uno schiaffo in volto ad uno di loro. Il ragazzino più tardi riconoscerà in Amerigo Dumini, noto picchiatore fascista, l’autore della percossa in suo danno.
Prima ancora che fosse noto il tragico esito del sequestro di persona, Amerigo Dumini, Albino Volpi[4] e gli altri esecutori materiali del delitto furono tratti in arresto, sull’onda di un’indignazione popolare che rischiava di travolgere il regime fascista e lo stesso Mussolini.
Il 19 giugno del 1924, il giorno stesso in cui l’istruttoria gli veniva formalmente affidata, Mauro Del Giudice si recava a Regina Coeli per interrogare gli arrestati insieme al rappresentante dell’accusa Guglielmo Tancredi.
Uno di essi, Aldo Putato, confessò di avere partecipato al rapimento, anche se si dichiarò estraneo all’omicidio non essendo salito in macchina, e indicò come ideatori ed esecutori dell’azione Dumini e Filippo Filippelli, segretario personale del fratello del Duce e direttore di un quotidiano di diretta emanazione del partito fascista.
Quest’ultimo, a sua volta interrogato, rese dichiarazioni sul coinvolgimento come mandanti di Cesare Rossi, segretario amministrativo del Partito Fascista e braccio destro di Benito Mussolini, e Giovanni Marinelli, capo ufficio stampa del Duce e anche lui a questi vicinissimo. Entrambi furono arrestati dai magistrati Del Giudice e Tancredi
Rapidamente si era dunque arrivati a raccogliere elementi di prova sul vertice del partito di Governo nell’eliminazione fisica del deputato simbolo dell’opposizione.
Mentre la strategia minimizzatrice adottata – confessione degli esecutori materiali con oscuramento del movente e negazione della responsabilità dei mandanti – vacillava sotto le contraddizioni emerse nel corso degli interrogatori, il 16 agosto del 1924 veniva rinvenuto sepolto in una macchia fuori Roma il cadavere di Giacomo Matteotti, insieme ad effetti personali – tra cui la giacca insanguinata e lacerata al costato – il cui esame smentiva la versione concordata (Dumini aveva confessato di aver rapito Matteotti per estorcergli notizie su un omicidio di un fascista avvenuto in Francia in cui riteneva coinvolto il deputato socialista, che era deceduto per emottisi durante la colluttazione, mentre la lacerazione della giacca al costato era prova di una coltellata al cuore della vittima con esito mortale).
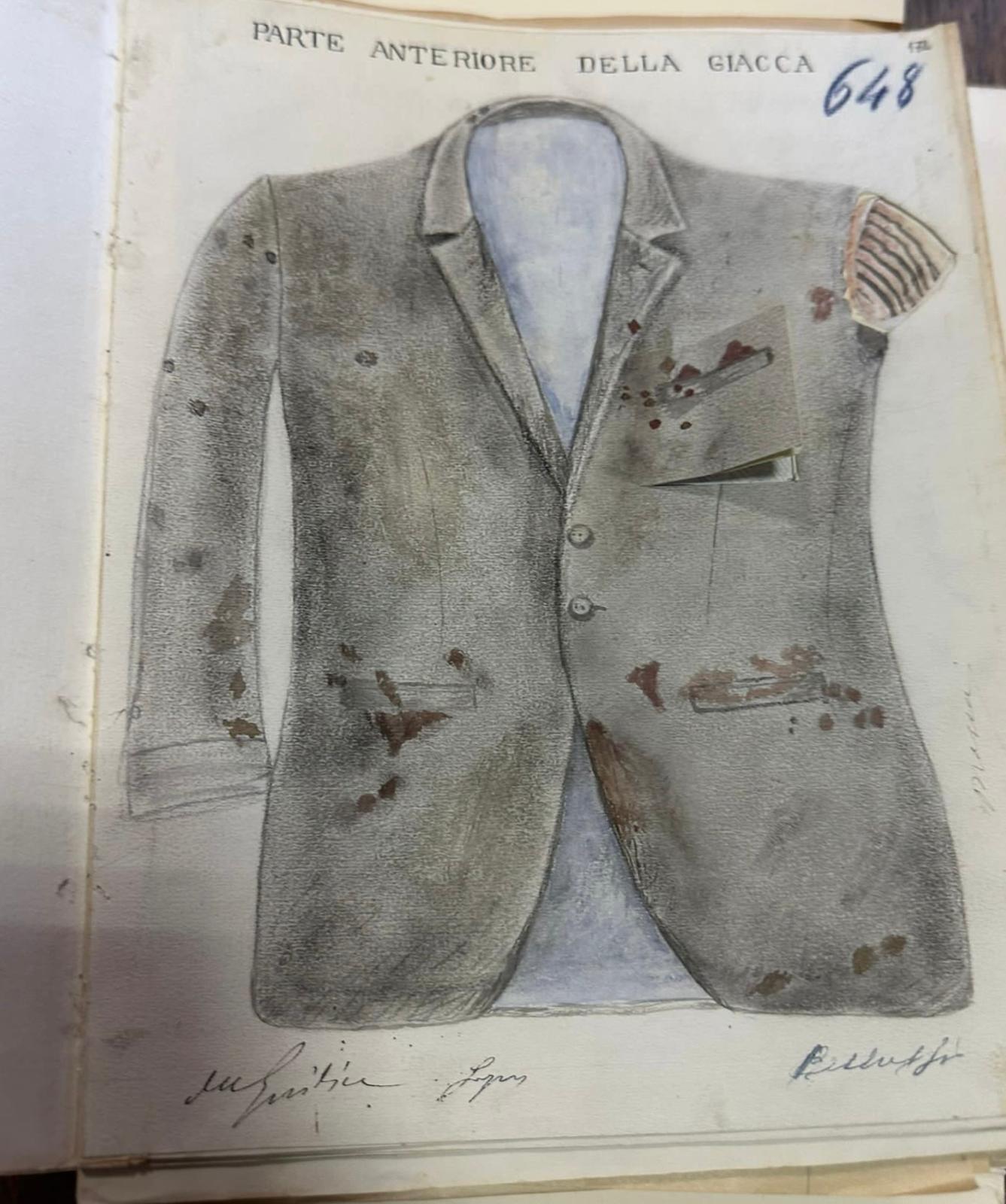
(Disegno della perizia del 1924 della giacca di Giacomo Matteotti con evidenziate le tracce di sangue)
Il ritrovamento del cadavere portò a una nuova ondata di indignazione in tutto il Paese, con manifestazioni popolari e durissime dichiarazioni di politici, proprio mentre Cesare Rossi, ritenendosi sacrificato da Mussolini, minacciava apertamente di rivelare notizie sul suo coinvolgimento diretto come ideatore dell’assassinio: mai come in quelle settimane il regime fascista vide da vicino lo spettro del crollo.
Tra le circostanze che vennero in soccorso al Duce, consentendogli di ribaltare una situazione che sembrava disperata, merita menzione la seguente, perché direttamente ricollegata al protagonista di questa storia: nel dicembre del 1924, a istruttoria praticamente finita, il Direttore del quotidiano Il Popolo denunciò come corresponsabile del delitto il Capo della Polizia Emilio Del Bono.
Essendo quest’ultimo parlamentare, da tale denuncia nacque l’obbligo di aprire una Commissione Regia di inchiesta; questa chiese immediatamente gli atti alla Corte di Appello di Roma, salvo poi restituirli dopo qualche mese, dopo avere decretato il proscioglimento di Del Bono.
L’episodio provocò la immediata stasi delle indagini penali e consentì a Mussolini di riprendere fiato e organizzare una strategia per uscire dal vicolo cieco, anche perché con la trasmissione degli atti al Parlamento era venuta meno ogni pretesa di riservatezza sulle indagini fino a quel momento gelosamente custodite dai due magistrati.
Gli atti rimasero al Senato per cinque o sei mesi e tornarono nella loro sede naturale verso la metà del 1925.
Si trattò di mesi decisivi per la sorte del processo e del Paese: dopo i primi momenti di smarrimento e di orrore per la sorte toccata al più tenace oppositore del regime, l’Italia fu di nuovo soggiogata dalla violenza delle milizie fasciste e dall’impudenza del suo leader, che in Parlamento arrivò a rivendicare con fierezza la responsabilità dell’uccisione di un parlamentare, da parte di cinque assalitori armati, come conseguenza del suo essersi opposto al regime e averne denunciato le illegalità con cui aveva appena vinto le elezioni.
Questo cambiamento di contesto non poteva non riflettersi sulla gestione del procedimento penale in esame: se fino a quel momento l’istruttoria, sull’onda emozionale diffusa ovunque, aveva proseguito indisturbata ed era rapidamente giunta all’individuazione dei responsabili e alla raccolta di convincenti elementi di prova a loro carico, dopo la (provvidenziale) sosta si erano create le condizioni per organizzare la reazione: il primo passo, fin troppo prevedibile, fu la sostituzione dei magistrati, rivelatisi troppo indipendenti, con altri pronti a più miti consigli.
Alla ripresa dell’attività istruttoria prima Tancredi e poi Del Giudice furono infatti promossi ad altro incarico. Il posto di rappresentante dell’accusa fu affidato a Nicodemo Del Vasto, cognato del capo dell’ala più oltranzista del partito fascista Roberto Farinacci.
Quest’ultimo assumerà poche settimane dopo, quasi contestualmente, la carica di segretario nazionale del partito e la difesa di Amerigo Dumini nel processo per l’omicidio Matteotti.
È raro riscontrare in modo così plastico l’intromissione della politica nelle sorti di un procedimento penale.
La stessa sensazione dovette averla la vedova di Matteotti (e non solo lei), che prendendo atto del mutato clima revocherà la costituzione di parte civile, così dichiarando il venir meno della sua speranza di ottenere giustizia.
L’accusa divenne fatalmente molto meno determinata e la sentenza istruttoria, abbandonando l’ipotesi originaria di omicidio premeditato si attestò su quella, assai più morbida di omicidio d’impeto. Rossi e Marinelli furono immediatamente scarcerati per effetto di un’amnistia nel frattempo emanata dal Governo.
Il processo conseguente, che si celebrò a Chieti, completò l’opera di destrutturazione dell’ipotesi accusatoria e pervenne a condanna per omicidio preterintenzionale, con condanna a pene miti per i pochi imputati che non si poterono fare a meno di condannare.
3. La caduta del fascismo e la riapertura del processo.
Venti anni dopo, caduto il regime fascista, lo Stato italiano ebbe tra le sue esigenze primarie quella di ristabilire il senso di giustizia così scientemente e costantemente calpestato (anche) nelle aule dei Tribunali.
Tra i primi atti della nascente democrazia vi fu dunque un decreto luogotenenziale che revocò i provvedimenti di amnistia per i “delitti di matrice fascista puniti con pena superiore a tre anni” e conseguentemente dichiarò inesistente, tra gli altri, la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Chieti il 24 marzo 1926.
Il procedimento penale per l’omicidio di Giacomo Matteotti venne riaperto, anche se molti degli imputati originari erano nel frattempo deceduti.
La nuova istruttoria mise in luce, meritoriamente, non solo le responsabilità del brutale omicidio ma anche i depistaggi e le manovre del governo fascista per condizionare gli esiti del processo e assicurare l’impunità agli assassini del deputato.
Venne dunque ascoltato per rogatoria il vecchio giudice istruttore Mauro Del Giudice, ormai ottantasettenne, ritiratosi dopo la pensione sul Gargano, sua terra di origine.
La sua deposizione, resa il 9 settembre del 1944 e il memoriale che consegnò ai magistrati, entrambi presenti tra gli atti consultabili presso l’Archivio di Stato, rappresentano documenti di eccezionale valore per comprovare la distorsione dell’attività giudiziaria allora compiuta e consegnano agli atti e alla storia l’esempio di un funzionario dello Stato dalla schiena dritta in uno dei tempi più bui della nostra storia.
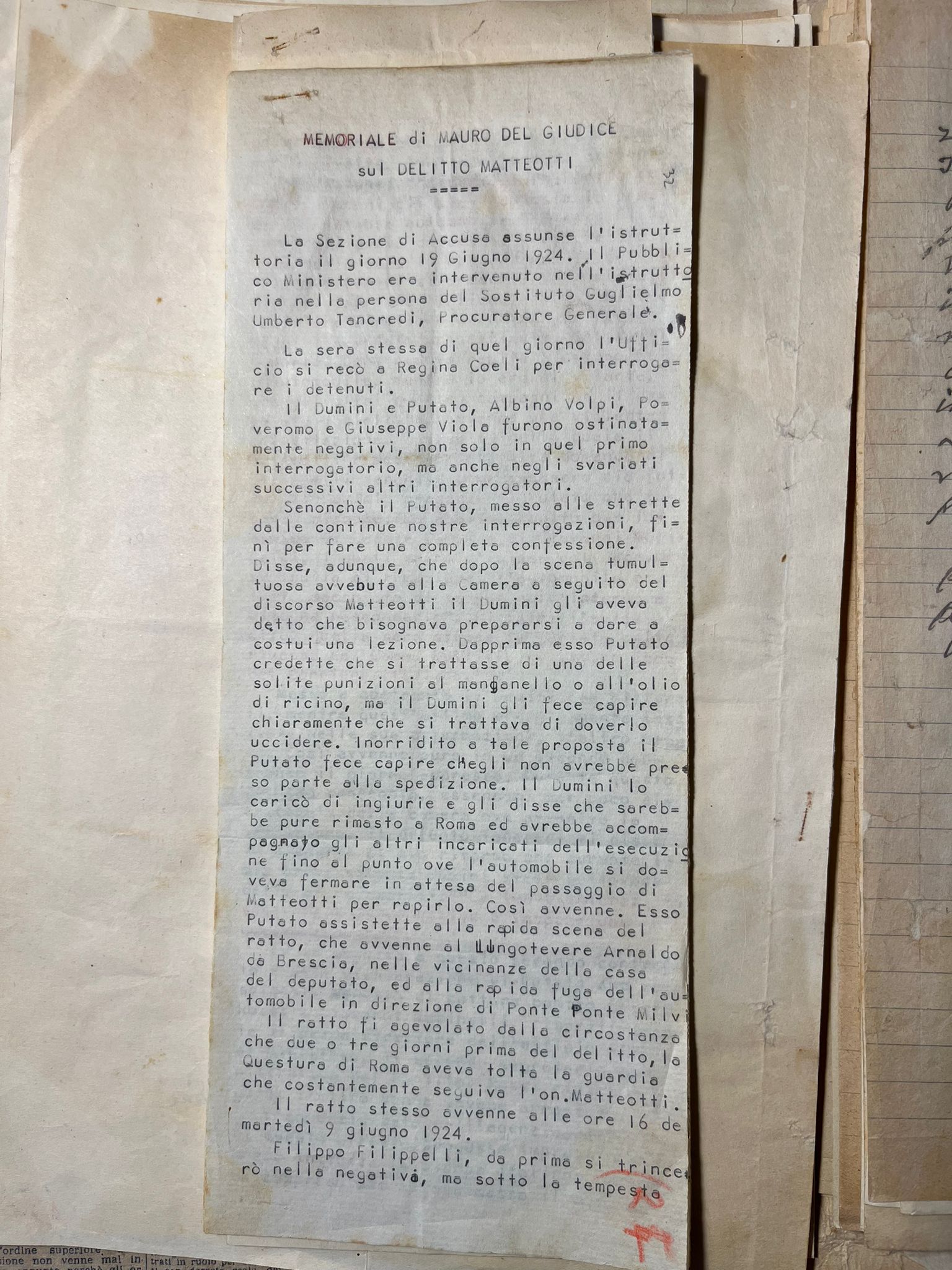
4. La versione di Del Giudice.
La prima cosa che il Del Giudice riferì al magistrato che lo escusse fu che nel momento in cui aveva dovuto trasmettere l’incartamento processuale con gli atti istruttori fino a quel momento compiuti alla Commissione senatoria le indagini erano terminate e complete, “tanto che si sarebbe potuto fare allora la sentenza di rinvio di tutti gli imputati al giudizio della Corte di Assise”.
È una precisazione importante perché comprova che l’intervento ab externo ha di fatto privato il magistrato della possibilità di portare a una rapida e proficua definizione dell’istruttoria.
Con la richiesta in visione delle carte si era dunque ottenuto il primo risultato di fermare il treno della giustizia nella sua corsa verso l’accertamento processuale delle responsabilità del delitto.
Furono stroncati anche i germogli di una crescita di livello dell’istruttoria, che dal singolo fatto di reato si apprestava a mettere a fuoco il coinvolgimento del fascismo nella gestione violenta ed illegale della cosa pubblica.
In proposito, dal memoriale di Del Giudice emergono due atti istruttori di primaria importanza:
In merito a questa possibilità, il Del Giudice ebbe a dichiarare che “il Procuratore Generale dell’epoca, non solo si rifiutò di fare la richiesta” ma disse a Fagella[6]: “Se Del Giudice continua su questo passo, io ritirerò dall’istruttoria il mio rappresentante Tancredi” io dissi al Fagella: “puoi rispondergli che m’importa poco tutto ciò: io potrò continuare l’istruttoria da solo”.
Di fatto, al ritorno delle carte nella loro sede naturale (la sezione istruttoria della Corte di Appello), il rappresentante dell’accusa era stato sostituito; a questo episodio il Del Giudice aggiunge quello, meno noto, della contestuale sostituzione del cancelliere addetto alla gestione del voluminoso fascicolo (oltre 44 faldoni): era stata dunque azzerata la memoria storica dell’attività istruttoria compiuta pochi mesi addietro.
Come si è detto, il mutamento della figura del pubblico ministero ha comportato un ammorbidimento della linea dell’accusa e questo è un effetto sicuramente voluto, attesa la nomina di un congiunto di uno dei massimi leader del partito fascista, dal cui vertice era stato ordinato ed organizzato il reato.
Mauro Del Giudice, attraverso la sua testimonianza, ha consentito di verificare in modo diretto e inoppugnabile la fondatezza del predetto assunto, fornendo una analitica e convincente rappresentazione del mutamento di atteggiamento dell’organo dell’accusa conseguente all’arrivo del nuovo collega.
Egli dichiara infatti a verbale che il Del Vasto adottò in un primo momento un atteggiamento naturale, chiedendo allo stesso Del Giudice un confronto per orientarsi in quel mare di carte. I due, ricorda ancora il magistrato, concordarono sulla ricostruzione del fatto come omicidio doloso premeditato.
Dopo qualche giorno, tuttavia, l’atteggiamento di Del Vasto mutò radicalmente, così come i suoi convincimenti giuridici sul caso: “Dopo circa 15 giorni, un mattino si presentò nel mio gabinetto il Del Vasto e con aria impacciata mi fece capire che egli, meglio studiando il processo, era pervenuto nella convinzione che tra il ratto e l’assassinio, non correva il rapporto di mezzo a fine, perché Marinelli e Cesare Rossi avevano sì dato il mandato e procurato i mezzi agli esecutori materiali di rapire Matteotti ma non di ucciderlo”.
Solo apparentemente si tratta della ricostruzione di una normale dialettica tra giuristi sulla esatta qualificazione giuridica da assegnare a un fatto, una scena quotidiana e fisiologica nella vita di ogni magistrato.
Come il Del Giudice avvertì immediatamente, dietro questo mutamento di opinione si nascondeva una raffinata strategia tendente alla sostanziale impunità dei responsabili dell’omicidio.
Negare “il rapporto di mezzo a fine” tra la prima fase dell’azione criminosa (le percosse fino alla riduzione in stato di incoscienza dell’onorevole e il caricamento del corpo in macchina con allontanamento) e la seconda (l’uccisione della vittima e l’occultamento del cadavere) porta alla inevitabile conclusione di una derubricazione dell’accusa da omicidio doloso in quella assai meno grave di omicidio preterintenzionale, con conseguente abbattimento della pena in caso di condanna, cessazione pressocché immediata della carcerazione preventiva e rimessione in libertà degli esecutori materiali.
Ancora, la paventata derubricazione comporta fatalmente lo scagionamento dei soggetti accusati di avere rivestito ruolo di mandanti, a cui non si può certo accollare l’esito imprevedibilmente letale di quella che voleva essere una semplice azione dimostrativa.
Per quanto ben costruita, la tesi era tuttavia difficile da sostenere in presenza delle evidenze probatorie presenti nel fascicolo, come Del Giudice non mancò di replicare immediatamente al rappresentante dell’accusa: “Rimasi stupefatto a questo parlare e risposi: questa supposizione che fai e che non risulta affatto dagli atti costituisce una tale mostruosa costruzione giuridica da far ridere i polli, giacché renderebbe inesplicabili entrambi i delitti”.
Non si può che concordare con questa conclusione: è difficile ipotizzare che i fascisti abbiano voluto limitarsi a picchiare Matteotti e a rapirlo per poi rilasciarlo, conoscendone il coraggio: si trattò di un’azione compiuta a volto scoperto e che avrebbe esposto i suoi autori ad una inevitabile denuncia, in contrasto con quella garanzia di impunità su cui gli imputati hanno più volte esplicitamente affermato, sia durante l’istruttoria che dopo, di aver fatto conto.
È più che evidente che un’azione così connotata prevedeva come esito la soppressione del rapito.
Altrettanto inesplicabile risulterebbe un omicidio non preventivato e scaturito dalla inaspettata reazione del Matteotti: va ricordato che gli aggressori erano almeno sei, alcuni dei quali armati e che uno di loro non ha esitato ad estrarre il coltello e a rivolgerlo al cuore di Matteotti, reazione – questa sì – del tutto sorprendente se si ipotizza che l’ordine fosse quello di risparmiare la vita del rapito, tanto più che il Volpi era un criminale ben aduso ad azioni violente e non un politico coinvolto per caso in un’azione delittuosa.
In sostanza, quando afferma che slegare i due delitti avrebbe reso entrambi inesplicabili il Del Giudice parla a ragion veduta, avendo come si è detto curato l’istruttoria sin dal primo momento e ben sapendo dunque consistenza e valore degli elementi probatori raccolti.
Ma è evidente che anche lui non sta già giocando più una partita giuridica, ma sta opponendo resistenza ad un chiaro tentativo di ingerenza ab externo.
Non a caso, subito dopo la rievocazione dell’incontro le sue dichiarazioni a verbale proseguono con il seguente ricordo: “Non gli nascosi il mio modo di pensare, che cioè quello che egli diceva gli era stato comandato dal Ministero, e che io, come Presidente della Sezione di Accusa, non avrei mai seguito le pretese della Procura Generale”.
Eccole, le sliding doors della vita del protagonista di questa storia: di fronte al tentativo di coinvolgerlo nell’operazione di negazione della verità processuale emersa e di piegare la giustizia a fini ad essa estranei, il Del Giudice si oppone fermamente e in modo irrevocabile, abolendo il sottile muro dell’ipocrisia della discussione giuridica e dichiarando esplicitamente la consapevolezza della posta in gioco e la sua irrevocabile scelta di campo.
Ad ulteriore conferma che il confronto era solo apparentemente giuridico ma implicava in realtà due differenti direzioni da imprimere al processo, una sola delle quali libera da condizionamenti così come sarebbe stato doveroso, il Del Vasto non tornerà più a far visita a Del Giudice, lasciando il compito di proseguire l’opera ad un collega dotato di potere di condizionamento assai più incisivo del suo: il Presidente della Corte di Appello (e diretto superiore di Del Giudice) Donato Fagella.
Anche quest’ultimo, dichiara a verbale il Del Giudice, si mostrava qualche giorno dopo il descritto incontro con Del Vasto improvvisamente propenso alla derubricazione dell’imputazione in quella di omicidio preterintenzionale e, alla sorpresa del Del Giudice perché anche lui aveva improvvisamente cambiato idea, rispondeva facendo esplicito riferimento a “esigenze politiche che richiedevano che si evitassero scandali che potevano compromettere il regime”.
A quel punto, visto che le vere finalità dell’incontro erano state esplicitate, anche il Del Giudice rispondeva con la medesima chiarezza: “allora gli dissi chiaro e aperto: che avevo capito ciò che si pretendeva da me e che io non mi sarei mai prestato a simili ribalderie, giacché alla infamia pubblica, io preferivo la persecuzione, la miseria, ed anche, occorrendo, la morte”.
Per quanto il lettore odierno sia in grado di contestualizzare un discorso del genere e comprendere in pieno la portata del pericolo cui il magistrato si esponeva con queste dichiarazioni, è difficile restituire oggi la piena valenza di un gesto del genere, reso in un momento in cui entrambi gli interlocutori sapevano bene che le conseguenze evocate dal Del Giudice erano non solo possibili ma quotidianamente applicate.
Si stava del resto parlando di un processo contro uomini che avevano aggredito e accoltellato a freddo un parlamentare della Repubblica in pieno giorno solo perché questi aveva mostrato di non voler sottostare al regime fascista, proprio come stava facendo Mauro Del Giudice in quel momento.
Né si poteva sperare che la toga garantisse rispetto o salvezza a fronte di criminali che avevano ricevuto mandato esplicito di neutralizzare con la forza ed eliminare fisicamente gli oppositori a qualsiasi livello e la cui forza stava proprio in quel senso di impunità che Mauro Del Giudice, e lui soltanto, con la sua ostinazione minacciava di compromettere.
Il clima di quasi palpabile terrore che si respirava all’epoca traspare peraltro da altri, interessanti cenni menzionati dal Del Giudice nel verbale e nel memoriale quasi come obiter dicta: dalla circostanza che la scorta di Matteotti era stata improvvisamente revocata due giorni prima dell’attentato all’inquietante particolare che dal giorno del primo interrogatorio a Regina Coeli i compiti di polizia giudiziaria con connessa attività di accompagnamento dei magistrati agli interrogatori erano passati dalla polizia penitenziaria alla milizia fascista.
Si può solo immaginare dunque la drammaticità reale, quasi fisica, di uno scambio di frasi quale quello appena riportato, appena mitigata da quella sorta di via di fuga che il Del Giudice offriva a quelli di cui si era appena con le sue parole dichiarato nemico irriducibile: egli aggiungeva infatti che era disposto ad essere trasferito ad altra Corte di Appello per evitare “imbarazzi”.
Il Fagella, dopo aver risposto che l’ipotesi non era praticabile perché un suo trasferimento avrebbe creato scandalo e che “quello che si voleva era che lui scrivesse la sentenza” (si intende, nel modo conforme al desiderata del Governo), tornava a trovarlo pochi giorni dopo per comunicargli che sarebbe stato “accontentato”, ovvero trasferito.
Evidentemente dall’altra parte si era capito che l’unico modo per ottenere la agognata impunità per gli assassini era di allontanare fisicamente Del Giudice dal fascicolo; lo “scandalo” di un trasferimento che tutti gli uomini di buon senso avrebbero letto come condizionamento del Governo sulle sorti del processo diveniva dunque il male minore. Anche perché il numero delle persone di buon senso sembrava diminuire giorno dopo giorno, in una spirale irreversibile verso la dittatura.
Così, Mauro Del Giudice fu trasferito a Catania e con lui rimosso l’ultimo ostacolo alla trasformazione di una brillante istruttoria nel processo che divenne noto come “la farsa di Chieti”, che si concluse – come era ampiamente prevedibile – con la derubricazione dell’imputazione in quella di omicidio preterintenzionale, il riconoscimento dell’attenuante della “debole costituzione” della vittima e condanne a pene simboliche e di fatto non eseguite perché coperte quasi tutte dall’amnistia.
Il giudice istruttore che aveva preso il posto di Mauro Del Giudice fu promosso Procuratore Generale presso la Corte di cassazione e divenne in seguito Senatore del Regno.
5. La conclusione del secondo processo agli assassini di Matteotti… e della nostra storia.
Dopo le dichiarazioni rese dal Del Giudice a distanza di venti anni e la nuova istruttoria si aprì un nuovo processo, questa volta con la corretta imputazione di omicidio premeditato, a carico degli imputati sopravvissuti Dumini, Viola e Poveromo.
I tre furono condannati all’ergastolo. Le sliding doors erano girate anche per loro.
Al nostro Del Giudice, privato della carriera, di fatto esiliato e allontanato da tutti, rimase la soddisfazione di avere scelto la porta giusta e dopo venti anni avere ottenuto la restituzione del diritto alla parola, che lui ha scelto di esercitare per il mero, impareggiabile sentimento di essere rimasto fedele alla propria idea di magistrato e uomo dello Stato: “Ripeto che parlo per vero dire, non già perché mosso da alcun sentimento di rancore o per vendicarmi della persecuzione ventennale subita per avere fatto allora il mio dovere di magistrato indipendente. Sono sull’orlo della tomba ed assai prossimo a render conto a Dio della mia vita trascorsa negli uffici giudiziari. Debbo perciò essere creduto”.
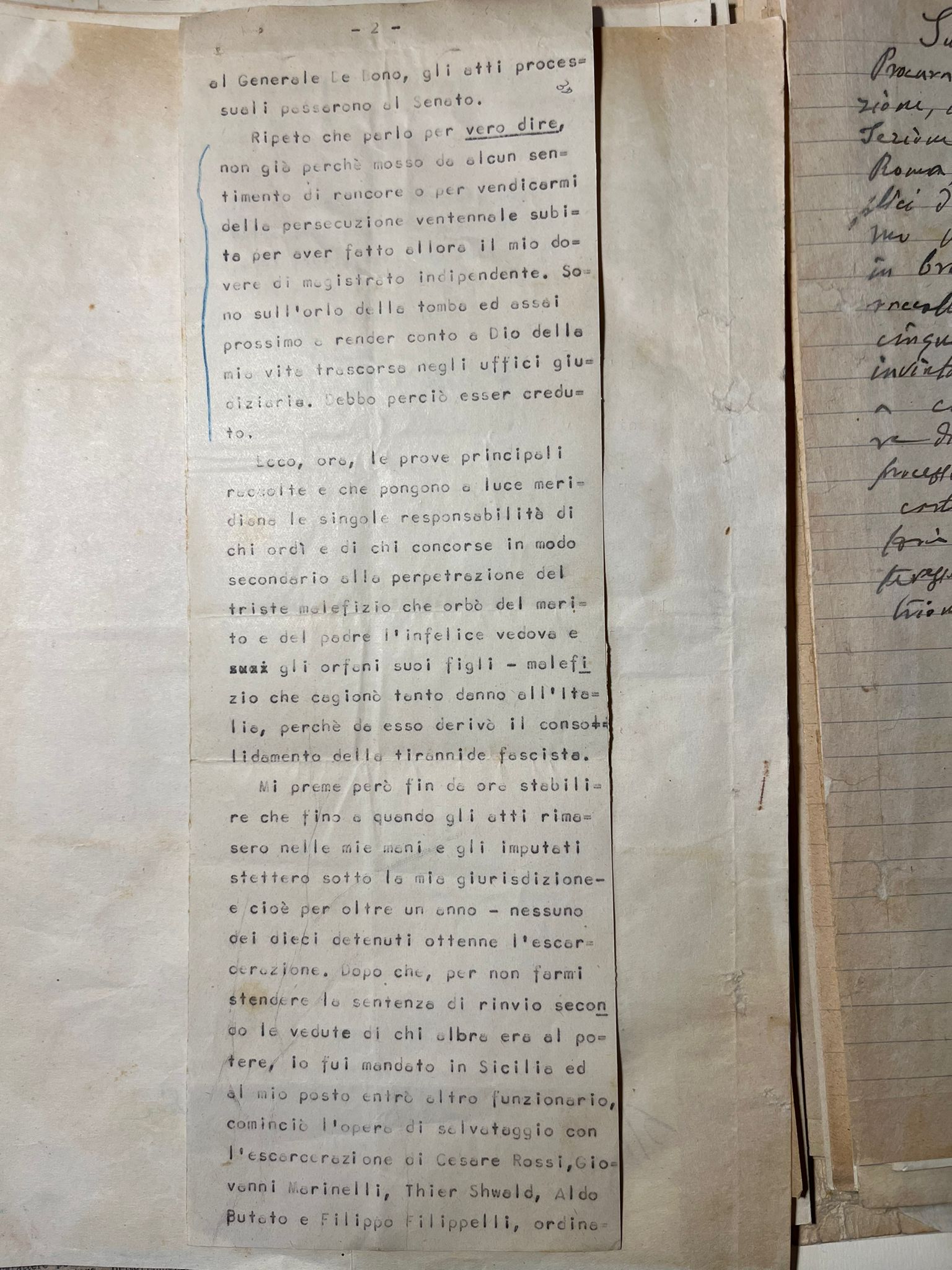
[1] Discorso alla Camera del Deputati del 30 maggio 1924 di Giacomo Matteotti.
[2] Vale la pena ricordare che, tornando a sedersi al suo scranno, Matteotti disse ai suoi compagni di partito con un sorriso: “Bene, io il mio discorso l’ho fatto. Ora voi preparate il discorso funebre per me”.
[3] Una risalente (ma non vecchia) vicenda processuale: il pestaggio fascista in danno dell’on. Giovanni Amendola del 26 dicembre 1923 di Costantino de Robbio, Giustizia Insieme, 24 febbraio 2024.
[4] Il Volpi si era già macchiato, tra le altre, dell’aggressione a Giovanni Amendola per la quale si rinvia ancora una volta al nostro articolo, già menzionato in nota 3.
[5] Il sequestro, ricorda ancora il Del Giudice, fu revocato subito dopo che gli fu tolta la gestione del procedimento.
[6] Donato Fagella è il Presidente della Corte di Appello di Roma; lo incontreremo di nuovo di qui a breve.
Le immagini riproducono documenti conservati presso l’Archivio di Stato di Roma, con il quale la nostra Rivista ha recentemente instaurato un rapporto di collaborazione

To install this Web App in your iPhone/iPad press icon.
