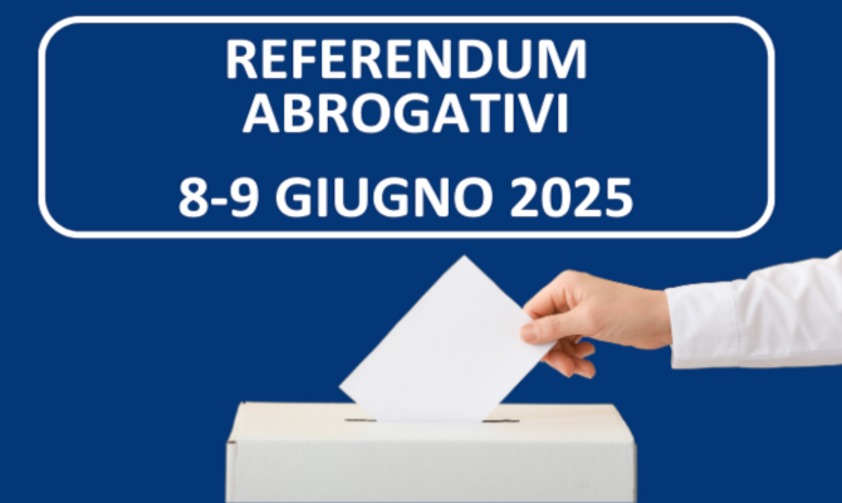Riceviamo e pubblichiamo questo appello firmato da molte docenti universitarie.
Il reato di femminicidio presentato dal Governo: le ragioni della nostra contrarietà
Il disegno di legge n. 1433 del 31 marzo 2025, rubricato “Introduzione del delitto di
femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle
donne e per la tutela delle vittime”, intende introdurre una fattispecie di reato autonoma
per il femminicidio, punita con l’ergastolo.
Nel ribadire l’assoluta importanza delle iniziative di contrasto alla violenza contro le donne, che dovrebbero essere stabilmente iscritte nell’agenda politica ed intraprese con decisione, manifestiamo la nostra contrarietà a questa proposta di riforma per diverse ragioni.
Innanzitutto preme evidenziare che, sebbene priva di una fattispecie autonoma di femminicidio, grazie alle modifiche normative intervenute negli ultimi anni, la disciplina italiana, almeno sul piano sanzionatorio, già coglie lo specifico disvalore della condotta, consentendo di applicare la pena dell’ergastolo all’uccisione di una donna per motivi di genere (i recenti episodi di cronaca lo dimostrano). Nell’attuale quadro normativo - che senz’altro necessita di interventi di riforma - la nuova fattispecie incriminatrice non sembra pertanto incrementare l’effettività della tutela penale, ma, come da più parti si sottolinea, assume una valenza meramente simbolica. Pur consapevoli dell’importanza di questa dimensione del diritto e del suo ruolo sui processi culturali, è fondato il timore che l’enfasi posta sulla rilevanza promozionale e pedagogica di tale intervento legislativo impedisca di avviare una riflessione sull’insieme delle pratiche sociali, politiche, pubbliche ed istituzionali che di fatto giustificano o favoriscono la violenza maschile.
Senza entrare in questa fase nel merito delle tecniche di tipizzazione, che appaiono carenti sotto il profilo della determinatezza e afferrabilità processuale, né della previsione di una pena fissa, si può dubitare del fatto che la minaccia della pena dell’ergastolo sia in grado di far desistere dall’azione criminosa colui che non abbia interiorizzato il valore della libertà femminile e il principio del rispetto della persona. Questi auspicati effetti di deterrenza non hanno mai ricevuto alcuna conferma, come emerge, del resto, dall’esperienza degli Stati Sudamericani, che hanno variamente incriminato il reato di femminicidio in presenza di un numero elevatissimo di donne assassinate.
Al contrario, osservando la realtà, si può constatare come qualsiasi intervento repressivo svincolato da azioni di perequazione sociale ed economica e da strategie di prevenzione, di tipo innanzitutto culturale, risulti del tutto inefficace.
Con il nostro intervento non intendiamo contrapporci ad iniziative di contrasto alla violenza contro le donne, né sminuire la rilevanza del problema; vorremmo sollecitare, invece, una riflessione più ampia e articolata del tema, che tenga conto della complessità del fenomeno, le cui cause sono profondamente radicate nella cultura e, a più livelli, nella struttura della nostra società. Il contesto sociale, economico e lavorativo in cui viviamo riflette un’immagine della donna frequentemente subalterna e mortificata, che favorisce o giustifica atteggiamenti di delegittimazione, sopraffazione e manipolazione, precursori di sempre più gravi atti di violenza.
L’obiettivo prioritario deve essere il contrasto alle molteplici forme di discriminazione e violazione dei diritti umani che sono considerate “fisiologiche” della differenza di genere e che impediscono la piena affermazione dei diritti delle donne e la corretta percezione delle condotte di prevaricazione e abuso. Ed è in questa prospettiva che è necessario intervenire, evitando strumentalizzazioni populistiche, sempre più spesso indifferenti ai canoni che necessariamente informano lo strumento penale, quali la extrema ratio e la tassatività, e utili più per accreditare l’impegno del legislatore che per offrire risposte effettive ed efficaci.
Lunedì, 26 maggio 2025
Elena Mattevi Università di Trento
Ilaria Merenda Università Roma Tre
Kolis Summerer Libera Università di Bolzano
Silvia Tordini Cagli Università di Bologna
Valeria Torre Università di Foggia
Cecilia Valbonesi Unitelma Sapienza
Maria Virgilio Università di Bologna
Anna Costantini Università di Torino
Malaika Bianchi Università di Parma
Lucia Risicato Università di Messina
Valentina Badalamenti Università di Bologna
Costanza Bernasconi Università di Ferrara
Annamaria Peccioli Università di Genova
Mariavaleria del Tufo Suor Orsola di Benincasa
Gilda Ripamonti Università degli Studi dell’Insubria
Monica Tortorelli Università del Molise
Chiara Perini Università degli Studi dell’Insubria
Sofia Braschi Università di Pavia
Licia Siracusa Università di Palermo
Debora Provolo Università di Padova
Francesca Rocchi Università di Teramo
Margareth Helfer Università di Innsbruck
Caterina Paonessa Università di Firenze
Anna Maria Maugeri Università di Catania
Emma Venafro Università di Pisa
Francesca Curi Università di Bologna
Rosa Palavera Università degli Studi di Urbino
Valentina Masarone Università degli Studi di Napoli
Antonia Menghini Università di Trento
Rosaria Sicurella Università di Catania
Marta Lamanuzzi Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Gaetana Morgante Sant’Anna - Pisa
Valeria Scalia Università di Catania
Tiziana Vitarelli Università di Messina
Matilde Botto Università di Bologna
Daria Perrone Università eCampus
Stefania Sartarelli Università degli Studi di Perugia
Simona Raffaele Università degli Studi di Messina
Alessandra Szegö Università del Piemonte Orientale
Anna Lisa Maccari Biagi Università di Siena
Francesca Moro Università di Trento
Lucrezia Franceschetti Università di Trento
Sara Riccardi Università di Pisa
Maria Federica Carriero Università La Sapienza di Roma
Chiara Silva Università di Padova
Eliana Reccia Università della Campania Luigi Vanvitelli
Sofia Regini Università di Trento
Antonella Merli Università di Camerino
Rebecca Girani Università di Bologna
Cristina de Maglie Università di Pavia
Claudia Cantisani Università di Pisa
Arianna Visconti Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Clara Rigoni Università di Losanna
Marina Di Lello Finuoli Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Simona Tigano Università di Catania
Eliana Greco Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Maria Giovanna Brancati Università Luiss Guido Carli
Lucia Maldonato Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Alice Ferrato Università di Padova
Marta Bertolino Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Sara Prandi Università di Torino
Lara Ferla Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Antonella Pirrelli Università di Pavia
Maria Teresa Collica Università degli Studi di Messina
Maria Beatrice Mirri Università La Sapienza di Roma
Maria Teresa Trapasso Università La Sapienza di Roma
Emanuela Fronza Università di Bologna
Silvia Massi Università Uninettuno
Amalia Orsina Università di Catania
Teresa Travaglia Università degli Studi di Messina
Priscilla Bertelloni Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza
Filomena Pisconti Università di Bari
Kelly Mae Smith, Università di Trento
Francesca Consorte Università di Parma
Magdalena Cogo Università di Trento
Alice Savarino Università di Basilea
Maristella Amisano Università della Calabria
Sul tema si veda anche: Nominare il femminicidio. Non in nostro nome di Maria Virgilio e Nominare la violenza maschile contro le donne: diritto penale e giustizia tra conflitto simbolico e responsabilità politica di Ilaria Boiano, Reato di femminicidio, partiamo dalle parole di Maria Virgilio.
Immagine: Eugenio Spreafico, Dal lavoro. Il ritorno dalla filanda (1890-1895; olio su tela, 101 x 194,5 cm; Monza, Musei Civici).





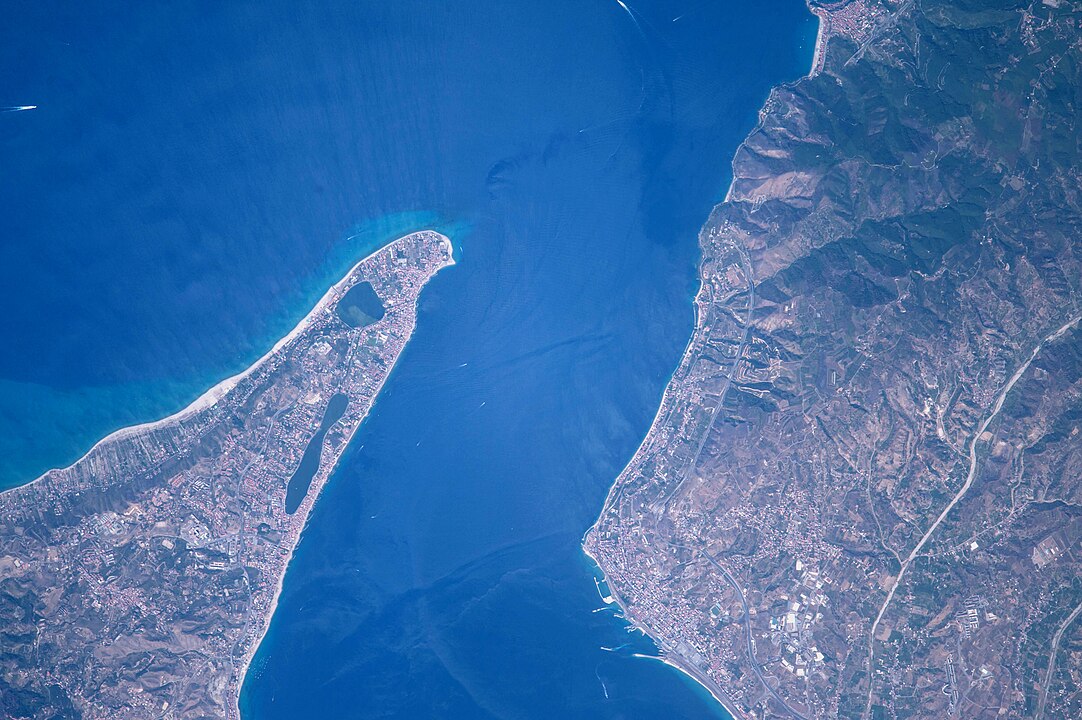
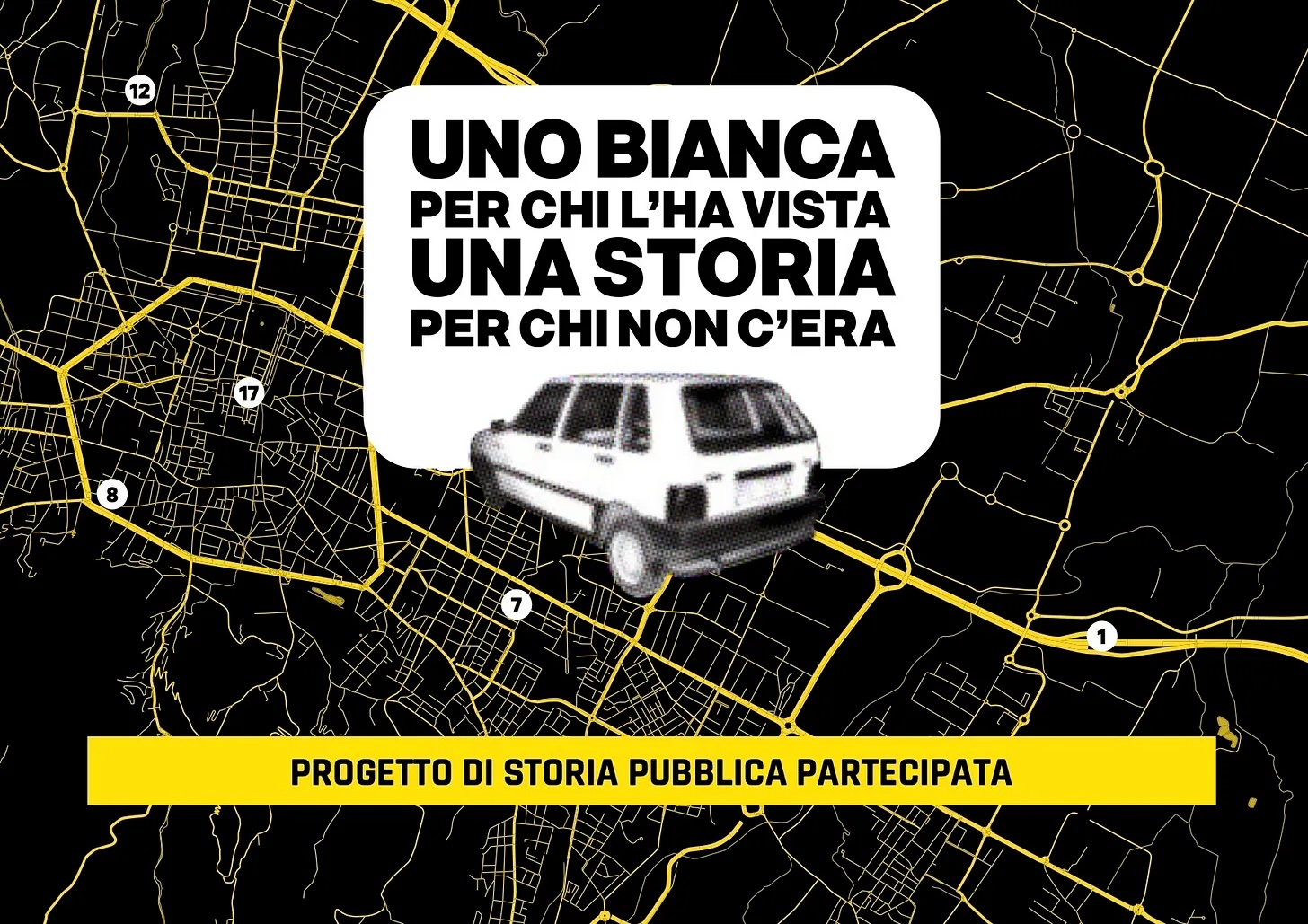


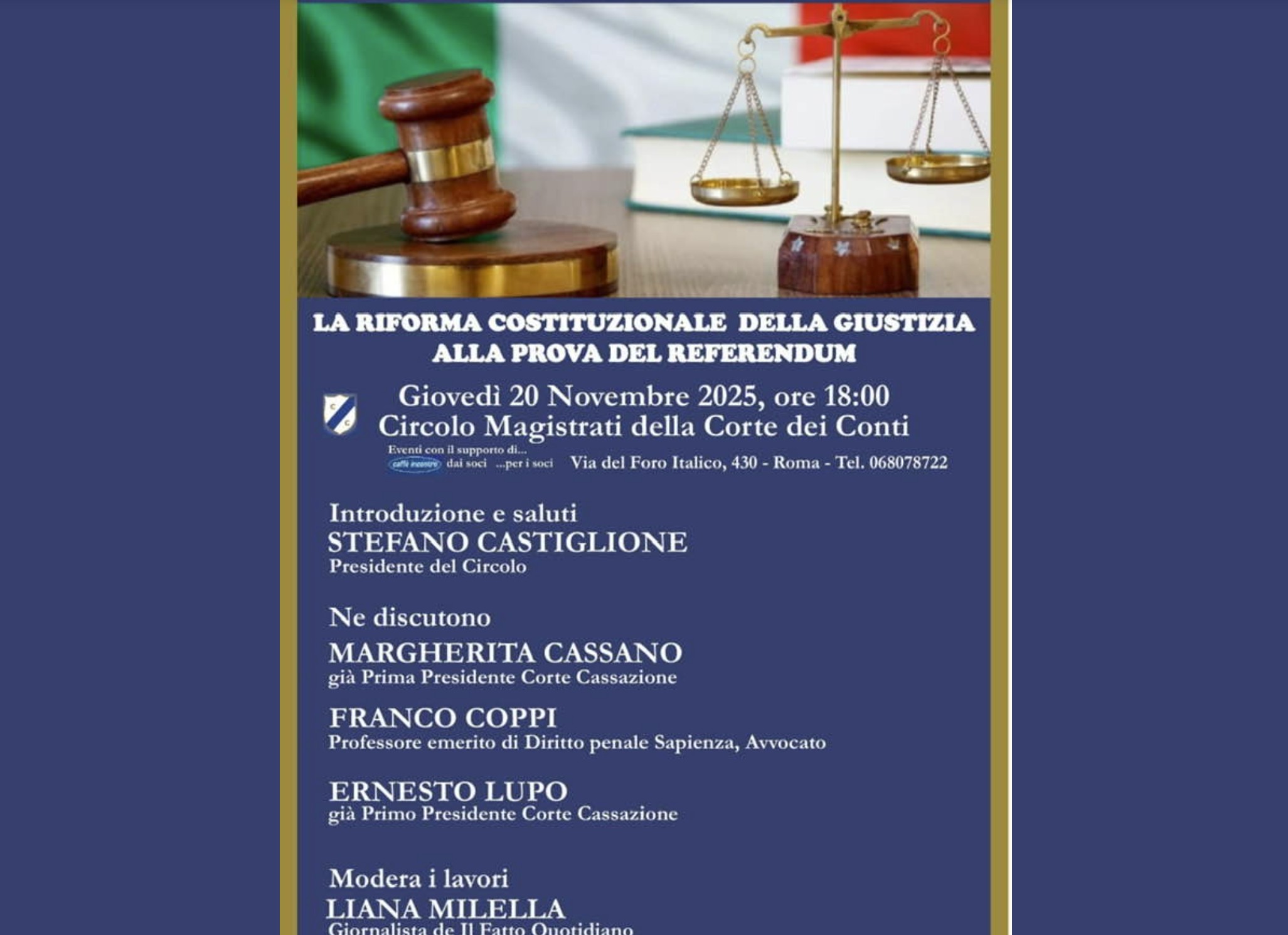





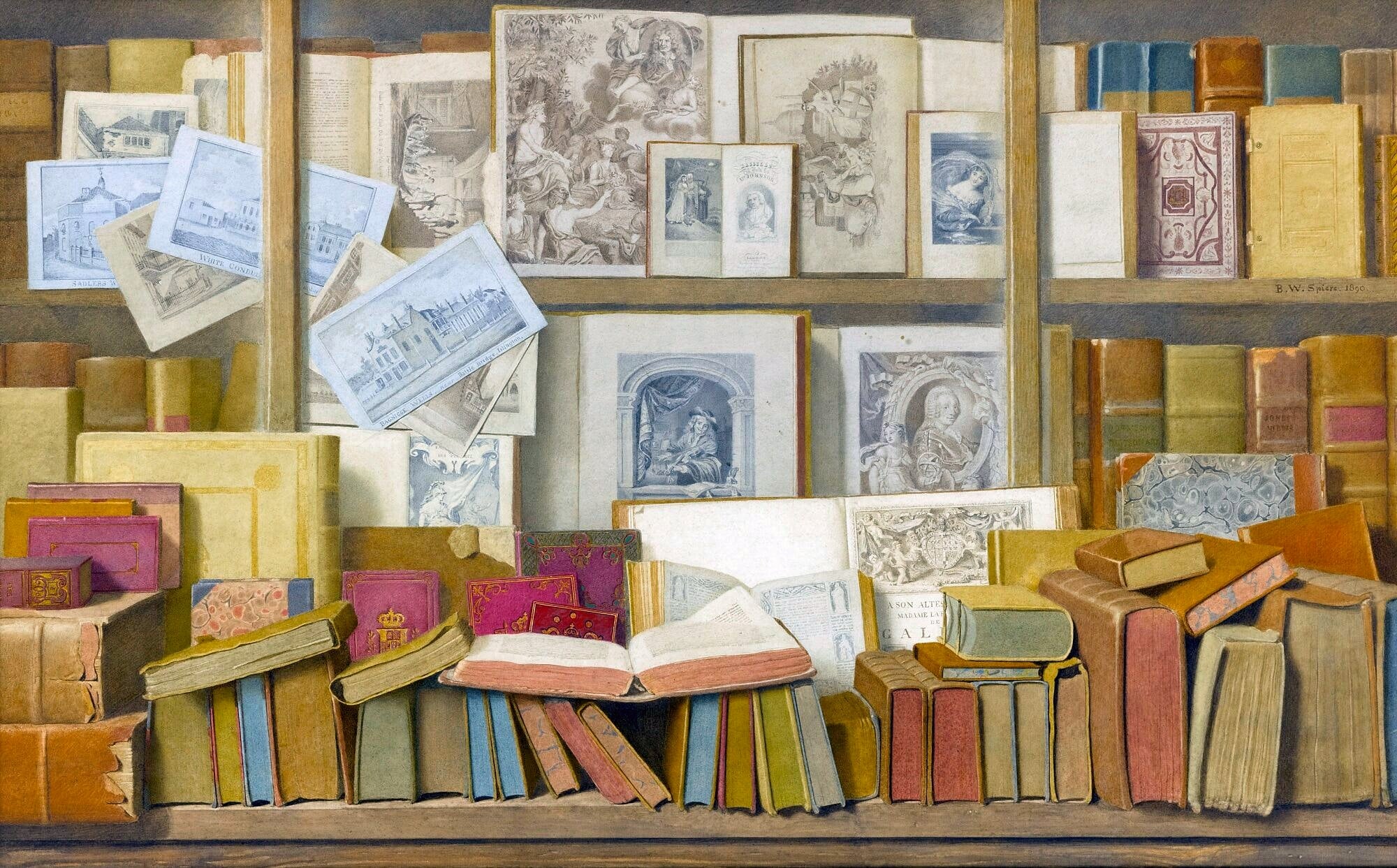



![La Corte di giustizia sulla nozione di “paese sicuro” e l’esclusione di particolari categorie soggettive- Corte giust, 1 agosto 2025, Cause riunite C‑758/24 [Alace] e C‑759/24 [Canpelli]](/foto/3586.jpeg)