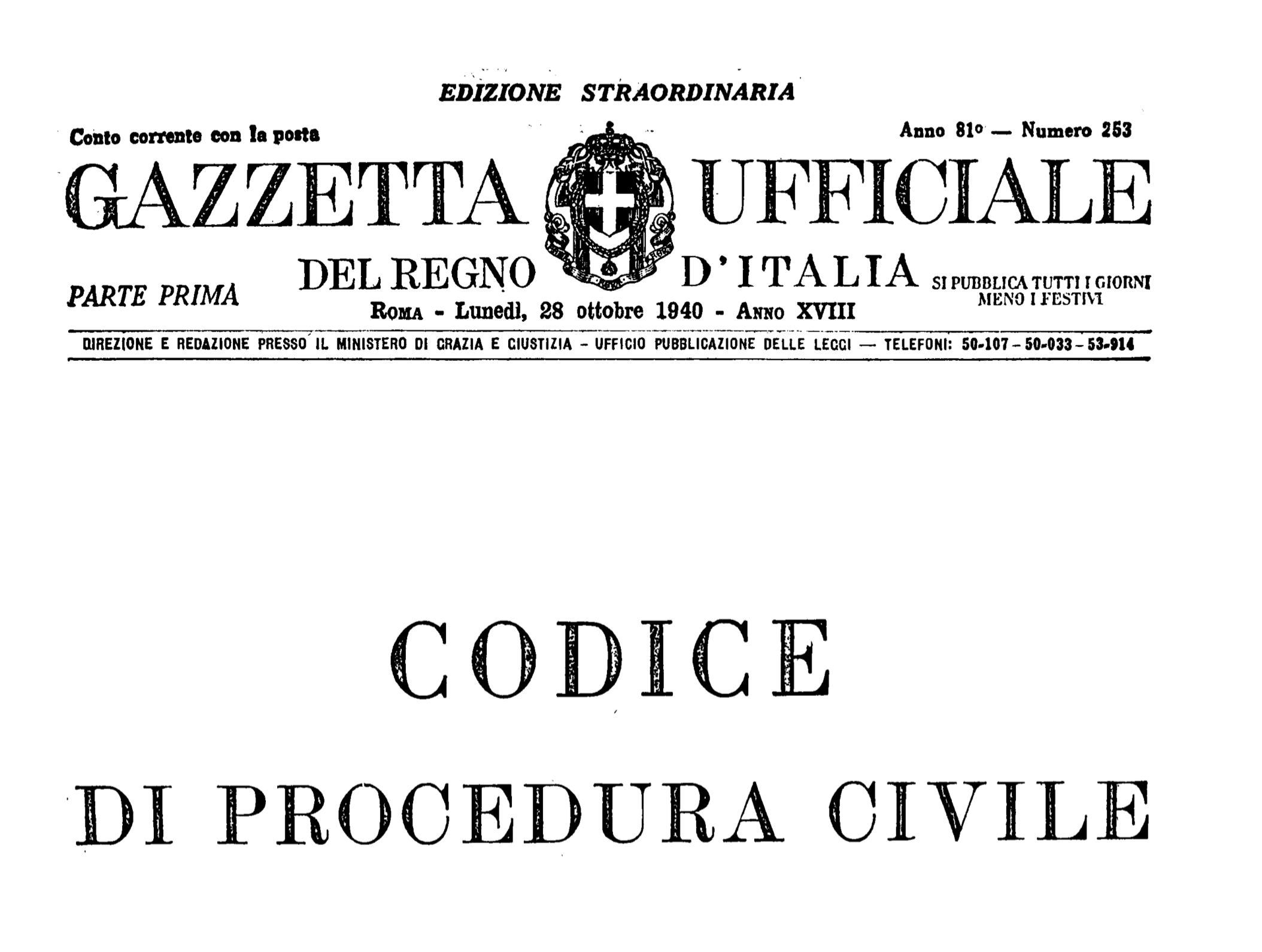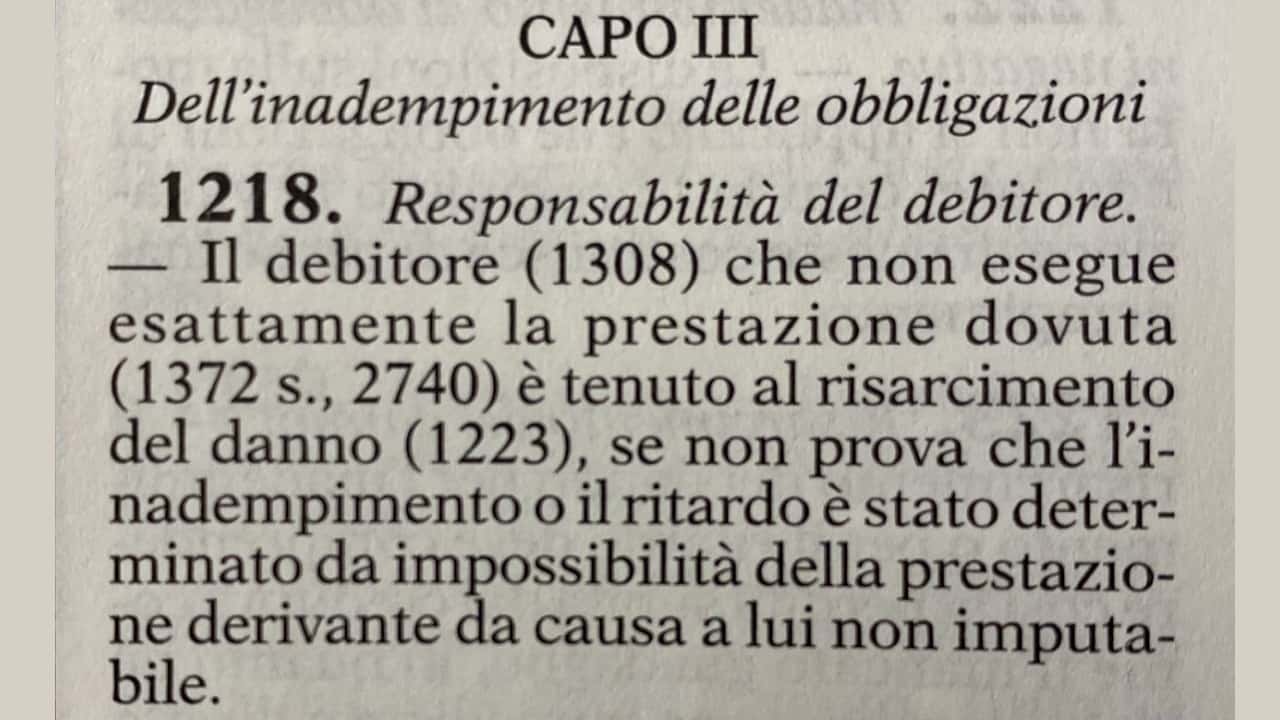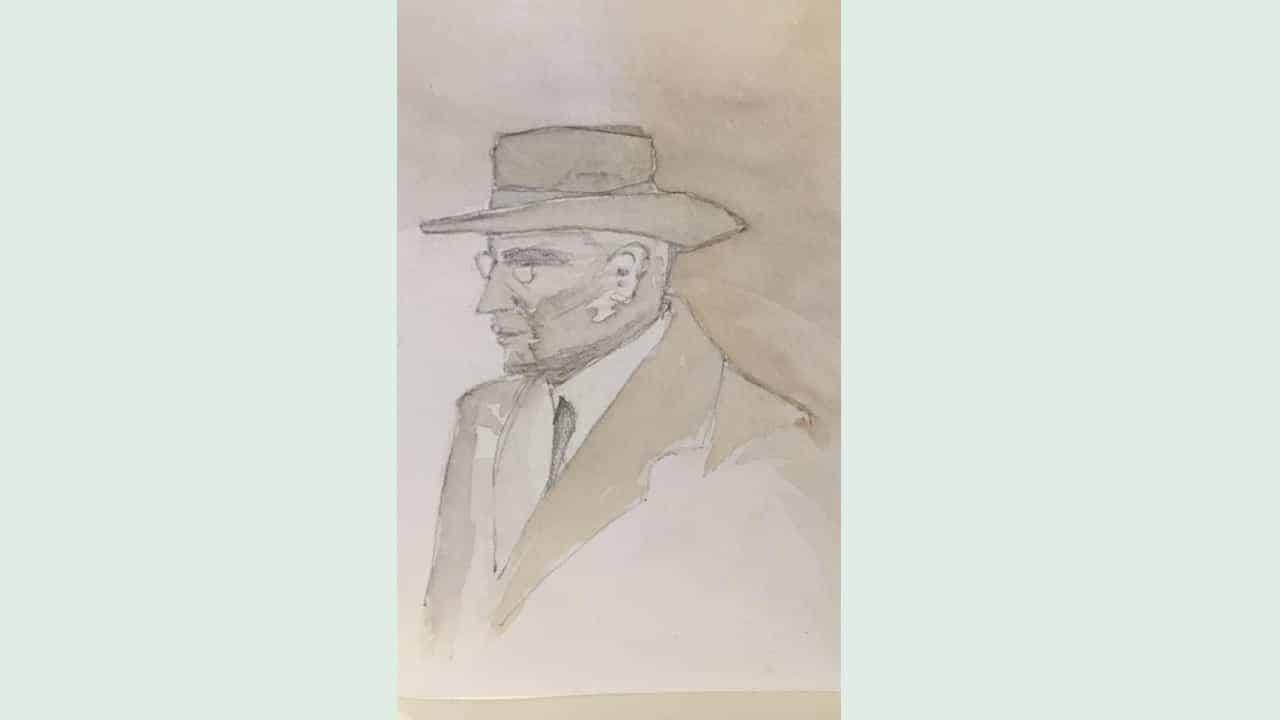
Chiovenda e il computer. Il processo “da remoto” e la teoria dell’azione
di Paolo Spaziani
[in copertina Chiovenda, acquerello, di Paolo Spaziani]
Il c.d. processo civile “da remoto”, previsto dalla normativa emergenziale introdotta in questi tempi di pandemia per ridurre il rischio del contagio, può trasformarsi da istituto temporaneo ed eccezionale in modalità ordinaria di celebrazione del giudizio civile? Nel presente scritto si cerca di immaginare come avrebbe risposto a questa domanda Giuseppe Chiovenda, avuto riguardo alle implicazioni derivanti da una sua dolorosa esperienza personale di studioso (la perdita di un manoscritto) e al concetto di tutela giurisdizionale desumibile dal suo sistema scientifico, fondato sulle teorie dell’azione e del rapporto giuridico processuale.
Sommario: 1. Chiovenda, il manoscritto perduto e il processo telematico – 2. Il processo “da remoto” e la teoria chiovendiana dell’azione – 3. La tutela giurisdizionale come “bene” giuridico – 4. Gli attributi ontologici della tutela giurisdizionale come “bene” giuridico. Il processo “da remoto” come “non processo”.
1. Chiovenda, il manoscritto perduto e il processo telematico
Giuseppe Chiovenda diede alle stampe la prima edizione dei Principii di diritto processuale civile nel 1906, la seconda nel 1908 e la terza nel 1912-1923.
Precisamente, le prime 4 “puntate” della terza edizione furono pubblicate tra il 1912 e il 1913; la quinta “puntata”, con l’Indice e la Prefazione, divenuta famosissima, fu pubblicata nel 1923, allorché uscì il libro nella sua completezza, con il sottotitolo Le azioni. Il processo di cognizione.
Già da queste poche notazioni sulla cronologia dell’opera e sul sottotitolo, che ne riflette il contenuto, emergono due circostanze che incuriosiscono immediatamente il lettore.
Si tratta di due circostanze apparentemente distinte ma in realtà strettamente collegate tra loro.
La prima è quella relativa al notevole intervallo temporale (oltre dieci anni) che intercorre tra la pubblicazione delle prime quattro “puntate” e la pubblicazione della quinta.
La seconda è quella relativa alla mancanza, nell’opera, della trattazione relativa al processo di esecuzione.
Su questa seconda circostanza si è soffermato l’ultimo, grande e affezionatissimo discepolo del maestro di Premosello, Virgilio Andrioli.
Andrioli racconta che Chiovenda aveva bensì redatto, sin dal 1915, anche la parte relativa al processo di esecuzione, ma che, sfortunatamente, il manoscritto contenente questa trattazione era stato da lui smarrito, nel dicembre di quell’anno, alla stazione ferroviaria di Milano[1].
Pur non essendovi motivo di dubitare della buona fede di Andrioli, l’episodio da lui raccontato, che non trova riscontri in successive ricerche, sembra piuttosto inverosimile.
In primo luogo, lo stesso Chiovenda, nel 1923, dettando la Prefazione alla terza edizione dei Principii, pubblicata secondo l’articolazione sopra ricordata, non avrebbe accennato affatto ad una presunta lacuna dell’opera dovuta alla mancanza della trattazione relativa al processo di esecuzione, ma, al contrario, avrebbe avuto modo di precisare che tale trattazione, la quale evidentemente egli considerava estranea al sistema delineato nei Principii, avrebbe dovuto formare oggetto di un separato, futuro volume[2].
In secondo luogo, è quanto meno plausibile che Chiovenda, se effettivamente avesse già completato, all’età di 43 anni, una trattazione sistematica del processo di esecuzione, avrebbe verosimilmente trovato il tempo di riscrivere il libro prima di morire, all’età di 65 anni. È un fatto, invece, che egli, dal 1915 al 1937, non si sarebbe mai occupato dell’esecuzione forzata, in funzione di una trattazione completa ed analitica degli istituti che la riguardano[3].
In terzo luogo, l’episodio del presunto smarrimento del manoscritto sul processo esecutivo mal si concilia con un diverso episodio, raccontato da un altro grande processualista, Franco Cipriani.
Cipriani, premesso di avere conosciuto, nell’anno 1990, l’ultima figlia di Chiovenda, la signora Beatrice Chiovenda Canestro[4], ricorda che quella, dopo averlo accolto «con squisita cortesia» nella sua villa alle porte di Roma[5], gli aveva fatto successivamente l’onore di riceverlo anche nella casa avita di Premosello ove, in un armadio chiuso da più di trent’anni, erano conservate tutte le carte paterne[6].
Nell’occasione – continua Cipriani – egli non solo aveva avuto l’opportunità, riaprendo quell’armadio ed esaminando quelle carte, di rinvenire la famosa lettera di Francesco Carnelutti dell’8 settembre 1923, contenente la proposta di fondare quella Rivista di procedura civile[7] che Chiovenda avrebbe voluto chiamare Rivista di diritto processuale civile e che, dal 1946, avrebbe assunto il nome di Rivista di diritto processuale[8]; ma aveva avuto anche l’opportunità di chiedere alla signora Beatrice notizie più precise sullo smarrimento, da parte del padre, di quel manoscritto sul processo esecutivo di cui aveva parlato Virgilio Andrioli[9].
Ebbene – precisa al riguardo Cipriani – a questa domanda la signora Beatrice aveva risposto che il padre non aveva smarrito alcun manoscritto, ma aveva invece subìto il furto di una valigia contenente il manoscritto di un libro che aveva poi riscritto[10].
La signora Beatrice non aveva saputo indicare l’oggetto del libro, né l’anno del furto, ma, poiché si ricordava benissimo della disperazione del padre («è come se avessi perso un figlio»), aveva escluso che l’episodio risalisse al 1915, quando ella era ancora molto piccola, concludendo che doveva essersi verificato alcuni anni più tardi, verosimilmente tra il 1919 e il 1920[11].
Qualche tempo dopo questo colloquio – prosegue Cipriani – la signora Beatrice aveva fatto nuova luce sull’episodio, dopo aver ritrovato, tra le carte paterne, un piccolo libro mastro sulle entrate e sulle uscite familiari.
Nella prima pagina di questo piccolo libro mastro era infatti scritto: «1920. Il presente continua il registro contenuto nella valigia rubatami a Milano il 15 settembre 1920».
Nelle pagine successive, poi, si leggevano, l’una dopo l’altra, le seguenti annotazioni:
- «15 settembre 1920: ritorno da Lodi a Milano per ricerche furto valigia. £ 700»;
- «16 settembre 1920: Corriere della Sera per smarrimento valigia. £ 54,60»;
- «18 settembre 1920: Bologna-Milano-Como alla ricerca della valigia rubatami. £ 600»;
- «28 settembre 1920: a Gino Marazza rimborso per manifesti valigia. £ 55,10».
Avute queste notizie – conclude Cipriani – gli era stato facile accertare che Chiovenda aveva fatto pubblicare un annuncio sul Corriere della Sera del 17 dicembre 1920, con cui aveva promesso di pagare la ricompensa di £ 1.000 a chi avesse consegnato al portiere di Via Cusani 4 a Milano (lo stabile in cui abitava il suo giovane amico, Avv. Achille Marazza, futuro ministro del lavoro nel VI governo De Gasperi), i libri e le carte contenute nella valigia rubata[12].
Alla luce delle informazioni fornite dalla signora Beatrice a Cipriani e delle ulteriori ricerche da quegli effettuate, può ritenersi accertato che Chiovenda, diversamente da quanto riferito da Andrioli, non aveva smarrito, nel 1915, il manoscritto contenente la trattazione del processo esecutivo, ma aveva perduto, nel 1920, a seguito del furto della valigia ove era contenuto, il manoscritto di un libro che aveva poi riscritto.
Si trattava, verosimilmente, della parte finale dei Principii, quella che sarebbe stata contenuta nella quinta “puntata”, il che spiega il sofferto ritardo con cui Chiovenda diede alle stampe l’ultima parte della sua mirabile opera, il cui disegno generale potè essere completato soltanto nel 1923, a distanza di oltre un decennio dalla pubblicazione delle prime quattro “puntate”[13].
Orbene, chiunque abbia provato personalmente esperienze simili, sa che la perdita di un manoscritto è la « più grande sventura che possa capitare ad uno studioso»[14], specie quando si tratti di uno scritto che è parte di un’opera più ampia e che, pertanto, per un verso, non può essere, semplicemente, abbandonato (come Chiovenda avrebbe potuto fare se si fosse trattato del libro sull’esecuzione forzata) senza compromettere la parte di opera fortunatamente conservata, mentre, per altro verso, non può essere neppure, agevolmente e pianamente, riscritto, poiché deve inserirsi nel sistema di cui quell’opera è espressione; sicché la “riscrittura” presuppone uno sforzo intellettuale che, in quanto già precedentemente avvenuto e, per così dire, “consumato” nella psiche dell’autore, molto difficilmente, e comunque a prezzo di estrema fatica e di intensa sofferenza, può essere replicato alle stesse condizioni e con il medesimo rigore concettuale.
Si spiegano dunque lo sforzo profuso e le numerose iniziative assunte dal maestro di Premosello, tra il settembre e il dicembre del 1920, nella ricerca dell’opera smarrita, prima di rassegnarsi alla sua definitiva perdita, nonché la scelta di non badare a spese (1000 Lire nel 1920 era una somma veramente ragguardevole) pur di rientrane in possesso.
In questa situazione, si può facilmente immaginare l’opinione che avrebbe avuto Chiovenda del computer, se avesse saputo della meravigliosa capacità di questa macchina di consentire, attraverso la memorizzazione e il salvataggio dei files, l’agevole e sicura conservazione delle opere dell’ingegno umano in un ideale ambiente immateriale, evitando i rischi connessi allo smarrimento o alla sottrazione del tradizionale, fragile supporto materiale di natura cartacea.
La considerazione di Chiovenda per il computer e le sue risorse, alla luce della sventura vissuta, sarebbe stata altissima.
Egli non solo ne avrebbe promosso l’uso nell’attività scientifica e professionale, ma avrebbe trovato modo di farne virtuosa applicazione nella teoria e, soprattutto, nella pratica del processo.
Si può persino immaginare che la stessa prima disposizione (la norma-manifesto) del suo famoso Progetto di riforma del procedimento civile, elaborato nell’ambito della I sottocommissione della Commissione reale per il dopo guerra, licenziato il 30 giugno 1919 e pubblicato nel 1920[15], non sarebbe stata intitolata soltanto alla oralità e alla concentrazione processuale[16], ma sarebbe stata intitolata alla oralità, alla concentrazione processuale e all’informatizzazione, considerata sotto il triplice profilo della creazione di archivi informatici di giurisprudenza, legislazione e dottrina (c.d. informatizzazione degli strumenti di ricerca), della utilizzazione, in funzione probatoria, di scritture formate e sottoscritte in forma elettronica (c.d. documento informatico con firma elettronica o digitale) e della telematizzazione dei servizi di cancelleria, delle comunicazioni e delle notificazioni, nonché della digitalizzazione e standardizzazione degli atti processuali, fossero essi atti di parte o provvedimenti del giudice (c.d. processo telematico).
Insomma, si può essere ragionevolmente certi, avuto riguardo alla dolorosa vicenda della perdita del manoscritto, che se Chiovenda avesse potuto anche lontanamente immaginare i benefici connessi all’informatizzazione, la sua appassionata e lunga ‹‹propaganda››[17] per la riforma del processo civile, sarebbe stata spesa, oltre che a favore dell’oralità, dell’immediatezza e della concentrazione processuale, anche a favore dell’immediata introduzione del processo telematico, quale progetto vertente alla realizzazione di un sistema informatico di automatizzazione dei flussi informativi tra i soggetti del giudizio che, senza incidere sulla struttura processuale (adempimenti, termini, contenuto degli atti, criteri di allegazione e prova), rendesse più sicuro, agile e tempestivo il sistema di scambio degli atti, sulla base di una previa equiparazione normativa dei documenti informatici e telematici a quelli tradizionali.
2. Il processo “da remoto” e la teoria chiovendiana dell’azione
Sotto ben altra luce Chiovenda avrebbe invece verosimilmente veduto il c.d. processo “da remoto”, che, diversamente dal telematico, non costituisce un progetto volto a migliorare l’efficienza del giudizio, ma uno strumento introdotto in questi tempi di pandemia dalla legislazione emergenziale, al fine di contemperare l’esigenza di trattazione dei processi non rinviabili con quella di evitare gli assembramenti di persone cui darebbe vita la loro celebrazione secondo le forme ordinarie.
Quale strumento finalizzato a rispondere alle eccezionali esigenze poste dalla situazione di emergenza sanitaria, il c.d. processo “da remoto” è, dunque, destinato a durare per il limitato periodo di tale emergenza, mentre il c.d. processo telematico è destinato ad essere introdotto “a regime”, sul rilievo che il processo, come tutte le attività umane, deve potere essere migliorato nella sua funzionalità, attraverso l’utilizzo delle risorse che il progresso tecnologico e scientifico mette oggi a disposizione.
Del processo “da remoto” si sono occupati i decreti-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito nella l. 24 aprile 2020, n.27) e 30 aprile 2020, n. 28 (convertito nella l. 25 giugno 2020, n.70).
Questi decreti-legge, continuando nel solco tracciato dal primo provvedimento emergenziale (il d.l. 8 marzo 2020, n.11) hanno distinto due fasi temporali: la prima (il cui dies ad quem, inizialmente fissato al 15 aprile 2020, è stato poi prorogato all’11 maggio 2020), contraddistinta dal rinvio d’ufficio, con specifiche eccezioni, delle udienze nei procedimenti pendenti in tutti gli uffici giudiziari, nonché dalla sospensione, per il periodo di durata della fase medesima, dei termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento; la seconda (il cui dies ad quem, dapprima fissato al 30 giugno 2020, è stato poi prorogato al 31 luglio e infine riportato nuovamente al 30 giugno 2020), contraddistinta dal rinvio discrezionale con determinazioni rimesse ai capi degli uffici giudiziari.
Con riguardo alla prima fase, è stata prevista eccezionalmente la celebrazione dei soli procedimenti in cui sia urgente ed indifferibile la tutela di diritti fondamentali della persona, dei procedimenti in materia di assegno di mantenimento, di assegno divorzile e alimentare, dei procedimenti relativi a stranieri, minori, incapaci o in materia di famiglia, parentela, matrimonio o affinità, e, in genere, di ogni procedimento la cui ritardata trattazione possa causare grave pregiudizio alle parti (art.83, comma 3, lett. a), d.l. n. 18 del 2020).
Con riguardo alla seconda fase, è stata prevista la celebrazione dei soli procedimenti per la cui trattazione i capi degli uffici non abbiano discrezionalmente stabilito un rinvio a data successiva alla fine del periodo emergenziale (art.83, comma 7, lett. g), d.l. n. 18 del 2020).
Sia in relazione alla prima fase (per le udienze relative ai procedimenti non differibili) che in relazione alla seconda fase (per le udienze relative ai procedimenti non discrezionalmente rinviati) è stata prevista la possibilità che l’udienza sia svolta mediante collegamenti “da remoto” individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, a condizione che non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, e purché sia salvaguardato il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti (art.83, comma 7, lett. f), d.l. n. 18/2020).
Nelle more della conversione del d.l. n.18 del 2020, questa norma, non ostante il suo carattere eccezionale, è stata interpretata in senso estensivo.
Si è infatti osservato che il termine udienza è stato evidentemente utilizzato in un accezione ampia, comprensiva non solo dell’udienza in senso proprio (vale a dire l’udienza pubblica tenuta con la partecipazione dei difensori ed, eventualmente, del pubblico ministero), ma anche della camera di consiglio non partecipata, istituto che, a seguito della riforma disposta con d.l. 31 agosto 2016, n.168 (convertito nella l. 25 ottobre 2016, n.197), ha acquistato particolare importanza nel giudizio di legittimità, nell’ambito del quale ha assunto la denominazione di adunanza camerale (artt. 380 bis e 380 bis.1 c.p.c.).
Si è dunque affermato che la norma emergenziale dovrebbe oggi poter consentire una celebrazione dell’adunanza camerale nella quale «uno o più tra i componenti del collegio giudicante risultino assenti dall’aula e dalla sala della camera di consiglio, trovandosi in collegamento audiovisivo o anche solo audio da remoto»[18].
Questa possibilità, nel silenzio del legislatore, troverebbe tuttavia conferma sia nei principi generali che in norme specifiche.
I principi generali sarebbero quello della libertà delle forme (art.121 c.p.c.) e quello della sanatoria della nullità per il raggiungimento dello scopo (art.156, terzo comma, c.p.c.)[19].
Le norme specifiche sarebbero quelle, contenute nello stesso d.l. n.18 del 2020, previste per la giustizia amministrativa e contabile, le quali stabiliscono che «il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto›› e che ‹‹il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge» (artt.84, comma 6, e 85 d.l. n.18 del 2020).
Queste norme, si osserva, dovrebbero essere analogicamente applicate alle udienze e alle camere di consiglio della Corte di cassazione, «non rinvenendosi ragione di sorta per giustificare un collegamento da remoto dei componenti del collegio giudicante nell’ambito del processo amministrativo o contabile, con esclusione invece dei processi civili ovvero di quelli tributari»[20].
Alla tesi secondo la quale l’art.83, comma 7, lett. f), d.l. n. 18/2020, sarebbe suscettibile di interpretazione estensiva è stato obiettato che tale possibilità risulterebbe invece preclusa all’esito della conversione del successivo d.l. n. 28/2020, recante disposizioni di coordinamento e integrative della disciplina posta dal decreto-legge precedente (art.3).
Poiché infatti la legge di conversione del d.l. n. 28 del 2020 (l. n.70/2020) ha modificato la lett. c) del comma 1 dell’art.3 di quest’ultimo decreto-legge (a sua volta modificativo della lett. f) del comma 7 dell’art.83 del d.l. n. 18/2020), stabilendo che «il luogo posto nell’ufficio giudiziario da cui il magistrato si collega con gli avvocati, le parti ed il personale addetto è considerato aula d’udienza a tutti gli effetti di legge», sarebbe evidente che la norma non ha ad oggetto la camera di consiglio non partecipata, ma esclusivamente l’udienza in senso stretto[21], ammettendo la presenza “da remoto” per le parti, i difensori e gli altri soggetti del processo, ma non anche per il giudice, il cui eroico presidio dell’ufficio sembrerebbe l’ultima concessione che il progresso tecnologico lascia all’udienza tradizionale, quale luogo reale di incontro, nel palazzo di giustizia, tra i protagonisti del giudizio.
Il problema della possibilità dell’interpretazione estensiva dell’art.83 comma 7, lett. f), d.l. n.18/2020, è stato superato in sede di conversione del decreto-legge, atteso che la l. n. 27 del 2020 ha introdotto, nello stesso art.83, il comma 12 quinquies, secondo cui «dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nei procedimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera dì consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge»[22].
Restano invece le suggestioni interpretative suscitate dalla predicata applicazione analogica dalle disposizioni del medesimo decreto-legge dettate in tema di giustizia amministrativa e contabile (artt.84, comma 6, e 85), le quali assumono un rilievo particolarmente importante, poiché, diversamente da quelle dettate in tema di giustizia civile e penale, sono prive di una previsione volta a circoscriverne temporalmente l’efficacia, sicché esse evocano la possibilità che l’udienza “da remoto” si affranchi dal carattere di istituto processuale temporaneo e straordinario, funzionale a sopperire alle contingenti esigenze dell’emergenza sanitaria, per ergersi a modalità ordinaria di celebrazione del giudizio.
La plausibilità dell’introduzione “a regime” di una modalità di celebrazione dell’udienza civile mediante collegamenti “da remoto” tra i diversi soggetti del processo potrebbe essere fondata anche sui già richiamati principi della libertà delle forme e della sanatoria per raggiungimento dello scopo[23]: se infatti la tecnologia offre la possibilità di avere una presenza virtuale dei protagonisti dell’udienza civile del tutto sovrapponibile alla presenza fisica, non si vede perché non si debba poter preconizzare una “smaterializzazione” di questo momento del giudizio, evidentemente non più indispensabile ai fini dell’esercizio dei diritti delle parti e dei poteri del giudice e, più in generale, ai fini della proficua interlocuzione tra i soggetti processuali.
Anche sotto tali diversi profili, è stato peraltro osservato, restrittivamente, che, a rigore, il principio della libertà delle forme non dovrebbe poter essere invocato in funzione della “liberalizzazione” delle modalità di svolgimento dell’udienza o della camera di consiglio, poiché queste non sono annoverabili tra gli “atti processuali”», a cui è circoscritta l’operatività del principio, trattandosi piuttosto di ‹‹riferimenti di luogo e di tempo organicamente predisposti alla stregua di mezzo per il compimento di “atti”››[24].
Del pari, la formale mancanza di una ‹‹determinazione di durata›› per la misura dettata in tema di giustizia amministrativa non potrebbe indurre il dubbio che il suo confine applicativo trascenda il periodo di emergenza sanitaria, trovando essa la propria ‹‹ratio›› proprio in tale emergenza[25].
A prescindere dalla interpretazione estensiva od analogica delle norme contenute nei provvedimenti emergenziali, nonché dal riferimento ai principi contenuti nel codice di procedura civile, la stessa opinione restrittiva assume, tuttavia, che la modalità “da remoto” di celebrazione del processo civile sia ormai «entrata nel sistema», talché essa potrebbe essere utilizzata, verificandosene la necessità, anche per rispondere ad esigenze diverse da quelle poste dalla pandemia da coronavirus[26].
Deve dunque riconoscersi, in termini generali, che la legislazione emergenziale ha costituito l’occasio legis per un’apertura del dibattito processualistico ad un utilizzo del collegamento “da remoto” e del convegno “virtuale” dei soggetti del processo, quale possibile modalità ordinaria di celebrazione delle udienze e delle camere di consiglio.
Un’apertura che viene compiuta con prudenza[27] e con la consapevolezza dei limiti, normativi e materiali, di questo sistema[28]; e pur tuttavia, un’apertura, che potrebbe determinare l’inizio di una vera e propria rivoluzione nelle modalità di celebrazione del processo civile[29].
Viene dunque da chiedersi cosa avrebbe pensato di questa possibile rivoluzione Giuseppe Chiovenda, tenuto conto che egli, come abbiamo sopra immaginato, avrebbe senz’altro apprezzato i benefici della tecnologia e dell’informatica, ove funzionali al miglioramento della efficienza del giudizio.
Il sistema chiovendiano, come è noto, ruota intorno a due capisaldi concettuali: il concetto dell’azione, «intesa come l’autonomo potere giuridico di realizzare per mezzo degli organi giurisdizionali l’attuazione della legge in proprio favore»; e il concetto del rapporto giuridico processuale, «o sia di quel rapporto giuridico che nasce tra le parti e gli organi giurisdizionali dalla domanda giudiziale indipendentemente dall’esser questa fondata o no»[30].
Strutturalmente, il rapporto giuridico processuale è un rapporto trilaterale, poiché si instaura tra il soggetto che propone la domanda di tutela giurisdizionale (l’attore), il soggetto nei cui confronti la domanda è proposta (convenuto) e il soggetto che deve rendere la tutela (il giudice).
Oggetto del rapporto è il diritto dell’attore ad ottenere dal giudice la tutela giurisdizionale e la soggezione del convenuto all’esercizio di questa tutela.
Si instaura, dunque, nel processo, un rapporto giuridico del tutto analogo a quello che si rinviene nel diritto sostanziale, inteso in senso soggettivo: un rapporto, cioè, fondato sulla relazione strumentale tra un soggetto attivo (titolare di una situazione giuridica soggettiva di vantaggio) e un soggetto passivo (titolare di una situazione giuridica soggettiva di svantaggio).
La relazione tra la situazione di vantaggio e quella di svantaggio è di carattere strumentale poiché entrambi, nell’ambito di un meccanismo che ne prevede l’operatività secondo modalità reciprocamente contrarie, sono tuttavia finalizzate alla realizzazione di un medesimo interesse.
Questo interesse, che costituisce il fine della giurisdizione, si identifica con l’attuazione della legge: esso ha carattere pubblico, in quanto interesse superindividuale che trascende quello privato dell’attore che invoca la tutela giurisdizionale.
Nella funzione pubblicistica della giurisdizione, che trova il suo fine nell’interesse statuale all’attuazione della legge, è stata ravvisata la peculiare innovazione del sistema chiovendiano[31].
In verità, già Calamandrei, nel 1937, pur riconoscendo alla nuova scuola chiovendiana il merito di avere illuminato «l’aspetto di ordine pubblico» delle norme del processo, tuttavia osserva che la nuova concezione del diritto processuale, quale «ramo autonomo del diritto pubblico che, regolando nella giurisdizione una delle funzioni della sovranità, tocca i fondamenti stessi dello Stato››, ha avuto un «precursore» in Lodovico Mortara.
È al Mortara, secondo Calamandrei, che si deve quella «collocazione del processo civile nel più vasto quadro del diritto pubblico» e «quella riaffermazione della importanza costituzionale» della giurisdizione che avrebbe condotto ad individuarne il fondamento non più nella finalità privatistica di «far vincere le cause ai litiganti» ma in quella pubblicistica di affermare la volontà dello Stato attraverso l’attuazione del diritto obiettivo[32].
La situazione giuridica soggettiva di vantaggio, che costituisce il profilo attivo del rapporto giuridico processuale, prende il nome di azione.
Veniamo dunque al secondo – e principale – caposaldo concettuale del sistema chiovendiano.
Anche con riferimento ad esso, si è individuato nella scuola chiovendiana una peculiare innovazione – forse la più importante – rispetto all’insegnamento della dottrina tradizionale.
Si ricorda infatti, agevolmente, che per questa dottrina – ancora oggi identificata con la scuola dei ‹‹grandi “proceduristi” di matrice francese ed esegetica››, contrapposta a quella dei ‹‹“processualisti” di stampo tedesco e sistematico››[33], di cui Chiovenda sarebbe stato l’‹‹iniziatore e Maestro››[34] – l’azione giudiziaria non era una situazione soggettiva autonoma ma integrava la rappresentazione dinamica del medesimo diritto sostanziale di cui si chiedeva la tutela in giudizio.
Precisamente, secondo colui che dei proceduristi prechiovendiani è considerato il più autorevole esponente, Luigi Mattirolo, l’azione giudiziaria non era altro che il diritto sostanziale ‹‹alla seconda potenza››: dunque, non era un istituto autonomo ma rappresentava semplicemente ‹‹la qualità propria del diritto di potere invocare a sua tutela le garantie giudiziarie››[35].
Alla tradizionale impostazione che escludeva l’autonomia dell’azione rispetto al diritto fatto valere in giudizio aveva aderito lo stesso Chiovenda allorché aveva, per la prima volta, trattato ex professo il tema nella “voce” Azione del Dizionario pratico del diritto privato diretto dal suo maestro Vittorio Scialoja. Nell’occasione, l’ancora giovane autore aveva scritto che ‹‹in realtà l’azione, o diritto di far valere il diritto, non è che il diritto stesso fatto valere, il diritto in un nuovo aspetto o in una nuova fase, passato dallo stato di riposo allo stato di combattimento››[36].
La concezione dell’azione quale posizione soggettiva autonoma dal diritto sostanziale esercitato in giudizio, viene per la prima volta esposta dal maestro di Premosello nella celeberrima prolusione letta dalla cattedra della facoltà giuridica bolognese il 3 febbraio 1903[37], che, non a caso, è considerato il giorno della fondazione[38] o, secondo taluno[39], la data di nascita della nuova scienza del diritto processuale civile.
Anche sotto questo profilo, tuttavia, il sistema chiovendiano deve ritenersi tutt’altro che innovativo, poiché quella stessa concezione, che Chiovenda raccoglie dalla dottrina tedesca[40], in Italia non solo era stata anticipata, ancora una volta, da Lodovico Mortara[41], ma era già ‹‹chiarissima››[42] anche a Domenico Viti[43], che pure ‹‹era un processualista vecchio stile››[44].
Del resto, nella teoria chiovendiana, l’azione, pur essendo concettualmente autonoma e diversa dal diritto soggettivo sostanziale, sussiste solo nell’ipotesi in cui la domanda risulti fondata e deve dunque distinguersi dalla mera possibilità di agire, che ne integrerebbe una condizione[45].
In altre parole, l’autonomia dell’azione non ne comporta anche l’astrattezza, talché essa può ritenersi esistente solo in concreto, vale a dire in presenza del diritto soggettivo sostanziale di cui si invoca la tutela.
Questo diritto, dunque, pur non confondendosi con l’azione, ne condiziona comunque la sussistenza, potendosi riconoscere il diritto di agire soltanto a chi ha avuto ragione (azione in senso concreto – diritto ad un provvedimento sul merito di carattere favorevole) e non, più in generale, a chi abbia solo affermato di avere ragione (azione in senso astratto – diritto ad un provvedimento sul merito, non importa se favorevole o sfavorevole)[46].
La vera peculiarità del sistema chiovendiano non sta allora né nella ribadita funzione pubblicistica della giurisdizione civile né nel riaffermato carattere dell’autonomia (che non si accompagna ancora al riconoscimento pure di quello dell’astrattezza) dell’azione; essa peculiarità si rinviene, invece, piuttosto nella risposta data alla questione di fondo affrontata nella celebre prolusione bolognese.
Questa questione, donde scaturisce il titolo stesso della famosa lezione tenuta in quella storica data, riguarda non tanto i caratteri specifici dell’azione quanto piuttosto quelli derivantile dalla sua appartenenza all’ambito dei diritti soggettivi.
La questione fondamentale, in altre parole, è quella relativa alla collocazione dell’azione nel sistema dei diritti e alle conseguenze di tale collocazione.
L’adesione alla tesi dell’autonomia comportava automaticamente il riconoscimento all’azione della dignità di diritto soggettivo a sé stante: se infatti l’azione non va confusa con il diritto sostanziale, vuol dire che è un diritto autonomo, distinto da quello.
La configurazione dell’azione giudiziaria quale diritto a sé stante determinava, peraltro, sul piano dogmatico, una difficoltà apparentemente insormontabile, che solo Chiovenda, tra i processualisti del suo tempo, ha la lucidità di avvertire e il genio di risolvere.
Nella dottrina classica, la nozione di diritto soggettivo[47] era connessa inestricabilmente a quella di interesse.
Il concetto di interesse veniva, a sua volta, legato a quello di bisogno e veniva rappresentato graficamente come una linea di tensione che, dipartendosi da una persona o soggetto (inteso, appunto come centro autonomo di interessi) si puntualizzava su una cosa od oggetto (inteso, appunto, come bene della vita, idoneo a soddisfare un bisogno umano e, quindi a realizzare l’interesse).
Posto dinanzi alle innumerevoli linee di tensione intercorrenti tra le persone e i beni idonei a soddisfare i loro bisogni, l’ordinamento giuridico, inteso in senso soggettivo, svolgeva, nell’ambito di questa concezione, il compito fondamentale di selezionare gli interessi, discriminandoli tra interessi meritevoli di tutela e interessi immeritevoli di tutela.
Mentre rispetto a questi ultimi non apprestava alcuna protezione, lasciandoli nudi interessi, rispetto ai primi attribuiva poteri, doveri e facoltà strumentali a consentirne la realizzazione.
Quando, nella valutazione effettuata dall’ordinamento, l’interesse meritava la massima tutela possibile, lo strumento attribuito raggiungeva la dimensione del diritto soggettivo, il quale rappresentava, dunque, il massimo, tra i poteri concessi dall’ordinamento ad un soggetto, per la tutela di un proprio interesse.
Chiovenda avverte chiaramente la difficoltà dogmatica di adattare al diritto soggettivo di azione questo sistema, non apparendo esso compatibile con l’idea della funzione pubblicistica della giurisdizione.
Se infatti l’oggetto di questa non va ricercato nella ripartizione della ragione e del torto tra i litiganti, ma nell’affermazione della volontà dello stato attraverso l’attuazione del diritto oggettivo, sembra evidente che l’esercizio del diritto di azione non verta alla realizzazione di un interesse privatistico (e cioè all’apprensione, per il soggetto attivo, di un bene della vita, con sacrificio del soggetto passivo) ma esclusivamente a rendere possibile lo svolgimento di un potere sovrano.
Chiovenda comprende, pertanto, che la collocazione dell’azione nel sistema dei diritti esigeva la configurazione di una nuova categoria di diritti soggettivi, nella quale potessero trovare contemperamento ed armonizzazione due concetti apparentemente inconciliabili.
Occorreva, cioè, che l’esercizio dell’azione permettesse, ad un tempo, l’apprensione di un bene giuridico idoneo al soddisfacimento di un bisogno privato (nel che si sarebbe realizzata l’essenza del diritto soggettivo quale potere dato dall’ordinamento per la tutela di un interesse) e l’affermazione della volontà dello Stato mediante l’attuazione del diritto obiettivo (nel che si sarebbe realizzata l’essenza della giurisdizione quale funzione pubblica, espressione della sovranità statuale).
Si trattava, quindi, di individuare una categoria di diritti nei quali l’interesse privato, coincidendo con quello pubblico all’attuazione della legge, potesse essere soddisfatto attraverso un meccanismo simile a quello in cui si estrinseca il potere autoritativo statuale.
Un meccanismo, precisamente, che, per un verso, non subordinasse la conservazione del bene della vita già presente nella sfera giuridica del titolare del diritto, all’osservanza di un dovere negativo di astensione da parte di tutti gli altri soggetti dell’ordinamento, secondo la modalità di esercizio e di realizzazione dei diritti assoluti; ma che, per altro verso, neppure prevedesse il conseguimento del bene della vita costituente il punto di riferimento oggettivo dell’interesse del privato, mediante l’attribuzione al soggetto passivo di un dovere positivo di cooperazione, secondo la diversa modalità operativa dei diritti relativi.
Occorreva invece riconoscere, al soggetto passivo del rapporto processuale, chiamato dinanzi al giudice, una situazione di soggezione del tutto assimilabile a quella di colui che viene attinto da un provvedimento autoritativo costituente espressione di una potestà pubblica; e, correlativamente, di individuare, nel soggetto attivo del medesimo rapporto, il potere giuridico di suscitare, con la vocatio in ius, l’attuazione della legge in proprio favore.
Nell’ “attuazione della legge” si sarebbe realizzata la funzione pubblicistica dell’azione quale mezzo attraverso il quale, sia pure su impulso del privato, si afferma tuttavia la volontà dello Stato per mezzo degli organi giurisdizionali.
Nell’attuazione della legge “in proprio favore” se ne sarebbe invece realizzata la funzione privatistica, quale diritto soggettivo strumentale al soddisfacimento dell’interesse all’apprensione di quel bene della vita che è la tutela giurisdizionale.
Rifiutata, dunque l’idea, largamente condivisa nella dottrina tedesca, secondo cui questo diritto dovesse essere diretto contro lo Stato, Chiovenda configura l’azione come un diritto contro l’avversario,[48], cui viene quindi riconosciuta la titolarità della correlativa situazione passiva di soggezione e, dopo averne ritenuto inappropriata la qualificazione di diritto facoltativo[49], sceglie di denominarlo, con felice ed incisiva espressione, diritto potestativo, dando così prova, non solo (e non tanto) della sua capacità di coniare nuovi termini giuridici[50], ma anche (e principalmente) della sua mirabile e feconda capacità di elaborazione sistematica.
3. La tutela giurisdizionale come “bene” giuridico
Con la creazione della figura del diritto potestativo Chiovenda raggiunge la quadratura del cerchio: quella di conciliare la funzione pubblicistica della giurisdizione, quale luogo di esercizio di una potestà sovrana, con la funzione privatistica del diritto soggettivo, quale potere concesso dall’ordinamento ad un soggetto per la tutela dell’intesse alla conservazione (diritto assoluto) o al conseguimento (diritto relativo) di un bene della vita idoneo a soddisfare un bisogno umano.
Sotto questo profilo, sia detto per inciso, la configurazione dell’azione quale diritto potestativo contro l’avversario si mostrava felice anche sul piano descrittivo e classificatorio, poiché la circostanza che esso fosse diretto (non alla conservazione, erga omnes, di un bene già presente nella sfera giuridica del titolare, ma) al conseguimento, erga unum, di un bene ancora estraneo alla detta sfera giuridica, consentiva di mantenere la summa divisio dei diritti soggettivi in diritti assoluti e diritti relativi.
L’azione, infatti, date le sue caratteristiche, si prestava agevolmente ad essere ricompresa nella seconda categoria, differenziandosi dal tradizionale archetipo dei diritti relativi (il credito) solo per le modalità di conseguimento del bene giuridico, che non presupponeva la realizzazione di una pretesa, attraverso la spontanea cooperazione del debitore o la coercizione della sua volontà, ma il mero esercizio di un potere unilaterale, cui seguiva una modificazione giuridica alla quale il soggetto passivo, con la chiamata in giudizio, era semplicemente assoggettato.
In tal modo, tra l’altro, si ricomponeva la simmetria del sistema, poiché anche il genus dei diritti relativi risultava suddiviso in due species (quella dei diritti di credito e quella dei diritti potestativi) alla stessa stregua del genus dei diritti assoluti, tradizionalmente articolato nelle due species dei diritti reali e dei diritti della personalità.
A questa ricostruzione del pensiero chiovendiano, che non ambisce ad assumere i caratteri indiscutibili del dogma, si potrebbe ragionevolmente obiettare che il maestro di Premosello non ha mai parlato, esplicitamente, della tutela giurisdizionale come di un bene giuridico.
L’obiezione sembrerebbe cogliere nel segno, specie se si torni ancora a riflettere sulla circostanza che nella concezione chiovendiana l’azione, come situazione soggettiva, presenta bensì il carattere dell’autonomia, ma non anche quello dell’astrattezza.
Se Chiovenda avesse chiaramente individuato nella tutela giurisdizionale un bene giuridico ulteriore e diverso rispetto a quello costituente il punto di riferimento del diritto soggettivo sostanziale, avrebbe ammesso la sussistenza del diritto di azione a prescindere dalla fondatezza della domanda.
Invece Chiovenda, pur rendendosi conto che la prestazione oggetto del rapporto processuale è soggettivamente distinta da quella che forma oggetto del rapporto sostanziale (in quanto resa non dal soggetto passivo di questo rapporto ma dall’organo dello Stato istituzionalmente preposto a fornire la tutela giuridizionale), non si spinge tuttavia a porne in luce anche la differenza oggettiva, fondata sul riconoscimento di una specifica utilità giuridica alla prestazione oggetto del diritto di azione (consistente nella tutela giurisdizionale di merito, indipendentemente dall’accoglimento o meno della domanda), distinta da quella della prestazione dovuta dal soggetto passivo del rapporto sostanziale, nella quale soltanto sembrava sostanziarsi il soddisfacimento del bisogno umano posto a fondamento dell’interesse tutelato.
Le ragioni per le quali Chiovenda evita di prendere specifica posizione su questo punto sono probabilmente due.
In primo luogo, la teoria dei beni giuridici, appartenendo, ratione materiae, al diritto sostanziale, sembrava esulare dalle competenze del processualista, il quale, una volta riconosciuta l’autonomia del diritto di azione rispetto al diritto soggettivo sostanziale – ed una volta provveduto alla sistematizzazione di tale diritto nell’ambito dei diritti soggettivi – poteva ritenersi soddisfatto, senza avvertire la necessità di dovere ulteriormente indagare sulla questione se il punto di riferimento oggettivo dell’interesse tutelato attraverso questo diritto (la tutela giurisdizionale) fosse suscettibile di essere qualificato come bene giuridico idoneo di per sé a fornire una utilità capace di soddisfare un bisogno umano o se, essendo sprovvista di tale utilità, poteva servire tale bisogno solo se avesse consentito effettivamente (e dunque, fondatamente) l’apprensione del bene finale avuto di mira con l’esercizio del diritto soggettivo sostanziale per cui quella tutela era stata invocata.
In secondo luogo, nell’ambito della scienza del diritto privato sostanziale, la teoria dei beni avrebbe vissuto proprio in quei decenni un vero e proprio sconvolgimento che avrebbe determinato la sostituzione delle certezze poste a fondamento del codice civile del 1865 (imperniato sulla centralità del diritto di proprietà) con le incertezze desumibili dalla disciplina del nuovo codice civile del 1942, fondato sulla centralità dell’impresa.
Nel codice civile del 1865, la nozione di bene giuridico era indissolubilmente legata ai due concetti della materialità e dell’idoneità a formare oggetto di proprietà (art.406 c.c. 1865).
Il carattere della materialità – in forza del quale solo le cose potevano essere considerate beni – non appariva compatibile con l’evoluzione dei rapporti economici e giuridici da una dimensione statica (fondata sul rapporto tra il proprietario e i suoi beni, mobili e, soprattutto, immobili) ad una dimensione dinamica, fondata sull’esercizio dell’attività produttiva e, più in generale, sullo svolgimento di relazioni commerciali sempre più intense.
La legislazione speciale[51], introdotta nel periodo di transizione tra i vecchi codici civile e di commercio e il nuovo codice recante una disciplina unificata nel senso della commercializzazione del diritto privato[52], poneva in luce l’esistenza di beni immateriali, ossia di utilità che, pur non essendo cose, erano tuttavia in grado di soddisfare bisogni umani, e dunque di porsi come punto di riferimento oggettivo di interessi privati che l’ordinamento poteva reputare meritevoli di tutela.
Il legislatore del 1942, avvertendo il limite della nozione contenuta nell’art.406 del codice del 1865, avrebbe eliminato il riferimento al diritto di proprietà, ma non sarebbe riuscito ad allontanarsi dalla tradizionale concezione materialistica che faceva coincidere il concetto di bene giuridico con quello di cosa.
Ne sarebbe derivato il recepimento, all’inizio del Libro III del nuovo codice civile, di una nozione incompleta e contraddittoria di bene giuridico, insufficiente a ricomprendere la più ampia fenomenologia che si riscontrava nel vivo delle relazioni economiche e che sarebbe stata in parte recepita dallo stesso codice nel Libro IV, attraverso la tipizzazione delle più rilevanti fattispecie contrattuali.
Mentre in queste figure negoziali sarebbero state rappresentate relazioni economico-giuridiche in cui il punto di riferimento oggettivo dell’interesse delle parti era costituito da utilità immateriali, quali, ad es. un’attività (art. 1703 c.c.) o un risultato (art.1655 c.c.), la nozione di bene, pur allargata a ricomprendere l’oggetto di tutti i diritti e non solo di quello di proprietà, avrebbe continuato ad essere circoscritta alle sole cose materiali (art.810 c.c.).
Gli inconvenienti di questa contraddizione sarebbero emersi nitidamente all’esito della redazione, nello stesso Libro IV, della disciplina generale del contratto e delle obbligazioni, con implicazioni negative che ancora oggi producono indesiderate conseguenze sul piano della coerenza sistematica e della correttezza applicativa.
La mancanza di una soddisfacente nozione di bene giuridico nel Libro III, avrebbe indotto il legislatore ad omettere, nella parte del Libro IV dedicata ai requisiti costitutivi del contratto (art.1325 ss. c.c.), la definizione di quello, tra i predetti requisiti, che avrebbe dovuto indicare il punto di riferimento oggettivo degli interessi perseguiti dalle parti del rapporto negoziale.
In tal modo, la nozione di oggetto del contratto, accolta dal nuovo codice, sarebbe risultata bensì rigorosamente delimitata con riguardo ai suoi necessari attributi (art.1346 c.c.) ma non anche definita quanto alla sua essenza, con risultati deprecabili, sul piano dell’unità concettuale complessiva del sistema, desumibili dal mancato raccordo – e spesso persino dalla reciproca contraddittorietà – tra le singole norme.
Accade così che lo sconcertato interprete, nel leggere la disciplina della vendita, ancora oggi debba notare come l’oggetto di questo contratto venga identificato con il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto (art.1470 c.c.), il che sembra provare un po’ troppo, poiché il trasferimento è l’effetto della vendita e non può evidentemente costituirne l’oggetto.
Del resto, se non si dubita che l’oggetto della vendita di cose future sia, appunto, la ‹‹cosa futura›› (art.1472 c.c.), non si vede perché l’oggetto della vendita di cose presenti non debba essere la cosa presente.
Peraltro, nella disciplina generale dell’oggetto del contratto, le ‹‹cose future›› vengono piuttosto identificate con l’oggetto della prestazione, la quale viene a sua volta identificata con l’oggetto del contratto (art.1348 c.c.).
Ma, invece, nella disciplina generale dell’obbligazione, la prestazione viene identificata, più generalmente, con l’oggetto dell’obbligazione (art.1174 c.c.), e non del contratto, che dell’obbligazione costituisce una delle possibili fonti (art.1173 c.c.).
In una situazione nella quale l’evoluzione dei rapporti giuridici ed economici metteva in luce l’insufficienza della tradizionale nozione di bene giuridico legata ai concetti della materialità e della proprietà – e, tuttavia, la scienza giuridica del diritto sostanziale non riusciva (ed non sarebbe riuscita neppure in sede di redazione del nuovo codice civile) ad elaborare una nozione nuova e coerente, idonea a ricomprendere tutte le utilità immateriali costituenti possibili punti di riferimento di altrettanti interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico –, si può comprendere la scelta di un processualista come Chiovenda di evitare di attribuire apertis verbis alla tutela giurisdizionale, in sede di elaborazione della teoria del diritto potestativo di azione, la dignità di bene giuridico immateriale a sé stante, e di continuare invece a subordinare l’esistenza di questo diritto all’accertamento di quello avente ad oggetto il bene materiale per il conseguimento o la conservazione del quale la predetta tutela era stata invocata.
La mancata affermazione esplicita del carattere di bene giuridico immateriale della tutela giurisdizionale non vuol dire, tuttavia, che nel pensiero del maestro di Premosello essa non sia effettivamente percepita come tale.
Tale percezione risulta, anzi, evidente se si tenga presente, come ci ha ricordato un altro insigne maestro, Andrea Proto Pisani[53], che nel sistema chiovendiano assume preminente importanza la classificazione delle ‹‹varie specie di tutela giurisdizionale›› in tutela ‹‹di condanna, d’accertamento, di costituzione››, nonché la corrispondenza tra queste e le diverse specie di diritti soggettivi, tra cui spicca la figura del diritto potestativo, il quale può essere oggetto della tutela di accertamento e – soprattutto – di quella costitutiva ma ‹‹non mai›› di quella di condanna, in quanto ‹‹potere›› che ‹‹non richiede condotta altrui››.
Vi è dunque un’utilità dell’azione (ontologicamente diversa nelle diverse modalità funzionali di tutela giurisdizionale), distinta rispetto a quella del bene che costituisce il punto di riferimento dell’interesse sostanziale.
Il riconoscimento della dignità di bene giuridico alla tutela giurisdizionale in quanto tale emerge, inoltre, direi in modo definitivo e incontestabile, dal ritenuto carattere generale della tutela di mero accertamento, di cui lo stesso Proto Pisani ricorda il rilievo sistematico.
Secondo Proto Pisani, proprio il riconoscimento, nel pensiero chiovendiano, di una portata generale alla tutela di accertamento (portata generale negata, invece, anche autorevolmente, dalla dottrina del tempo[54]) costituisce, infatti, il ‹‹punto cardine dell’analisi diretta ad affermare l’autonomia del diritto di azione rispetto al diritto soggettivo sostanziale››, essendo fondato su una condizione di fatto (il c.d. “vanto” o la c.d. “contestazione”) ‹‹tale che senza l’immediato accertamento negativo o positivo l’attore ne risentirebbe danno››[55].
4. Gli attributi ontologici della tutela giurisdizionale come “bene” giuridico. Il processo da remoto come “non processo”
L’evidente, ancorché implicita, qualificazione della tutela giurisdizionale quale bene giuridico immateriale a sé stante, emerge, infine, dall’affermazione dei suoi attributi o connotati ontologici, indispensabili in funzione del raggiungimento dell’obiettivo (l’attuazione della legge in proprio favore) per il quale il diritto potestativo di azione è conferito.
Si è già evidenziato che il primo dei 204 articoli del Progetto di riforma del processo civile, elaborato da Chiovenda nell’ambito dei lavori della I sottocommissione della Commissione reale per il dopo guerra, era intitolato all’oralità e alla concentrazione processuale.
Più precisamente, in questo progetto, il processo civile è costruito intorno ai principi dell’oralità, della concentrazione processuale, dell’immediatezza e dell’identità fisica del magistrato durante tutto il corso della lite di primo grado[56].
In base al principio dell’oralità, il processo deve trovare il suo momento centrale nel dibattimento orale in udienza, ove si devono succedere, l’una dopo l’altra, le fasi di trattazione, di assunzione delle prove e di discussione.
L’assunzione delle prove si deve svolgere sotto il controllo e l’impulso continuo del giudice, cui è attribuito il potere di intervenire, anche in modo penetrante, senza formalità, per stimolare le parti e i testimoni, nonché di assumere ogni autonoma iniziativa per il chiarimento dei fatti e l’acquisizione della verità[57].
Per il principio della concentrazione, l’udienza deve essere tendenzialmente unica, rimanendo tuttavia salva sia la possibilità di rinviare al primo giorno seguente non festivo in ragione dell’ora tarda (art.58) sia la possibilità delle parti di allegare l’impedimento a comparire ovvero ad iniziare o proseguire il dibattimento (art.61).
Il principio dell’identità fisica del giudice presuppone la diretta ed immediata percezione da parte del giudice dell’attività che viene svolta in sua presenza, la mancanza della quale costituisce causa di invalidazione dell’istruttoria e presupposto della sua rinnovazione.
Infine, per il principio dell’immediatezza, la deliberazione della sentenza deve avvenire subito dopo la chiusura della trattazione.
L’attuazione di questi principi, come sarebbe dimostrato dalla disciplina processuale austriaca che ad essi si ispira e che costituisce il modello al quale occorre tendere[58], è essenziale in funzione della rapidità dell’accertamento giudiziale e dell’efficiente e tempestivo raggiungimento della finalità del processo,
Questa attuazione, peraltro, è a sua volta subordinata all’osservanza di un ulteriore principio che costituisce il presupposto dell’operatività di tutti gli altri.
Occorre, precisamente, che al rispetto del principio della immediatezza in senso oggettivo (che esprime l’esigenza che il provvedimento giudiziale segua, senza soluzione di continuità, la trattazione processuale della causa e sia emesso proprio e solo dal giudice che ad essa abbia presenziato) si accompagni il rispetto del principio dell’immediatezza in senso soggettivo (il quale esprime la necessità di assicurare il contatto diretto, in situazione di prossimità, tra il giudice e gli altri soggetti del processo e l’immediata percezione da parte del primo dell’attività posta in essere dai secondi[59]).
In altre parole, le attività consistenti nell’interrogatorio delle parti, negli interventi in funzione di stimolo o di impulso verso le parti o gli ausiliari del giudice, nel tentativo di conciliazione o di soluzione concordata della controversia, nelle iniziative a chiarimento di circostanze oscure in funzione della ricerca delle verità e infine – e soprattutto – quelle concernenti l’assunzione delle prove costituende orali e l’ascolto della discussione e delle conclusioni delle parti, possono essere proficuamente svolte soltanto nel rispetto dell’immediatezza e cioè, non solo nella reciproca vicinanza, ma sulla base di quel contatto diretto e immediato che solo la prossimità materiale in un unico locale circoscritto e reale (l’aula d’udienza) può assicurare.
Gli attributi dell’immediatezza, della oralità e della concentrazione non costituiscono meri elementi strutturali del processo chiovendiano, ma costituiscono attributi ontologici della tutela giurisdizionale, come bene giuridico, quale emerge dal sistema complessivo del maestro di Premosello.
In difetto di tali connotati, per Chiovenda non sarebbe dunque ontologicamente concepibile la tutela giurisdizionale, poiché essa non potrebbe assumere la dignità di bene giuridico costituente punto di riferimento oggettivo del diritto potestativo di azione e risulterebbe inidonea al raggiungimento della finalità della giurisdizione.
Il diritto di azione verrebbe così svuotato di ogni contenuto, poiché non sarebbe possibile, attraverso il suo esercizio, conseguire l’obiettivo per il quale risulta conferito dall’ordinamento, consistente, obiettivamente, nell’attuazione della legge e, subiettivamente, nell’ottenimento di un provvedimento sul merito della domanda.
Se volessimo, oggi, contemperare il concetto chiovendiano di tutela giurisdizionale quale “bene” giuridico, nel senso che si è cercato di precisare, con la prescrizione costituzionale in tema di giusto processo (art.111 Cost.), potremmo dire che, in funzione della giustizia del processo, a Chiovenda non basterebbe che siano assicurate l’autonomia, l’indipendenza e la posizione di terzietà e di equiditanza del giudice; che alle parti sia garantita la piena esplicazione del diritto di difesa e di quello al contraddittorio; che i testimoni siano preservati da intimidazioni o suggestioni. Egli pretenderebbe, altresì, che l’incontro di tutti questi soggetti nella celebrazione di quel momento processuale fondamentale che è l’udienza, avvenisse nel rispetto di quei principi ontologicamente legati all’essenza stessa della giurisdizione, i quali presuppongono il contatto diretto e immediato dei soggetti processuali in posizione di prossimità.
Il processo da remoto, quale processo fondato su una modalità di celebrazione dell’udienza alternativa alla relazione di prossimità tra i vari soggetti del giudizio, non sarebbe, pertanto, nella concezione chiovendiana, un processo imperfetto o sbagliato ma sarebbe un “non processo”, perché precluderebbe in radice la possibilità di svolgere la funzione istituzionale della giurisdizione e di raggiungerne il fine.
[1] V. Andrioli, in Riv. dir. proc., 1986,700.
[2] G. Chiovenda, Principii di diritto processuale civile, Napoli, 1923, VIII e XI: ‹‹Uscirà quanto prima, in separato volume, la dottrina dei rapporti processuali di esecuzione e di conservazione››.
[3] Il procedimento di esecuzione non è trattato né nei Principii né nelle Istituzioni, ove del resto, secondo A. Proto Pisani, in Foro it., 1973, V, 209, Chiovenda neppure ‹‹ebbe il tempo di sistemare … la materia trattata nell’ultima parte dei Principii››.
[4] Cfr. F. Cipriani, Quel lieto evento di tanti anni fa (una visita a Premosello Chiovenda), in Riv. dir. proc., 1991, 225 ss., nonché in Scritti in onore dei Patres, Milano, 2006, 265 ss., donde saranno tratte le successive citazioni.
[5] F. Cipriani, ult. cit., 266.
[6] F. Cipriani, ult. cit., 268.
[7] F. Cipriani, ult. cit., 270, 277, 278.
[8] Sul tema v., da ultimo, B. Cavallone, Una fondazione asimmetrica (un carteggio inedito dell’autunno del 1923), in Riv. dir. proc., 2018, 611 ss.
[9] F. Cipriani, Alla scoperta di Giuseppe Chiovenda, in Chiovenda, Scritti ossolani, Anzola d’Ossola, 1992, 11 ss., nonché in Scritti in onore dei Patres, cit., 287 ss., donde saranno tratte le successive citazioni.
[10] F. Cipriani, ult. cit., 290.
[11] F. Cipriani, ult. cit., 290-291.
[12] F. Cipriani, ult. cit., 291.
[13] Una conferma indiretta del fatto che la quinta “puntata” dei Principii, uscita nel 1923, corrispondeva alla sostanziale e sofferta riscrittura del manoscritto perduto nel 1920, può trarsi dalla circostanza che essa, pur essendo dedicata ai procedimenti speciali, non faceva alcuna menzione di quello monitorio, appena introdotto dalla legge 9 luglio 1922, n. 1035 (frutto del genio di Lodovico Mortara), mentre si soffermava ancora sulla autorizzazione maritale, abrogata dallo stesso Mortara, in qualità di ministro della giustizia, con la legge 19 luglio 1919, n.1176.
[14] Così proprio F. Cipriani, Storie di processualisti e di oligarchi, La procedura civile nel Regno d’Italia (1866-1936), Milano, 1991, p. 220, nota 33.
[15]G. Chiovenda (a cura di), La riforma del procedimento civile proposta dalla Commissione per il dopo guerra (Relazione e testo annotato), Napoli, 1920.
La Commissione Reale per il dopo guerra fu istituita, su iniziativa del Sen. Vittorio Scialoja, con legge 21 marzo 1918, n. 361, per proporre i provvedimenti necessari a risolvere i problemi giuridici ed economici del Paese dopo la fine della prima guerra mondiale. Essa si divise in due sottocommissioni, la prima per i problemi giuridici, la seconda per quelli economici. La I sottocommissione, presieduta dallo stesso Scialoja, di cui Chiovenda era devoto discepolo, si divise a sua volta in Sezioni e l’VIII Sezione, incaricata delle riforme del diritto privato, si ripartì ancora in tre Gruppi, il primo per il codice civile, il secondo per il codice di commercio e il terzo per il codice di procedura civile. Chiovenda assunse la presidenza del terzo gruppo, che si avvalse anche del contributo del giovane Enrico Redenti, anche egli legato a Scialoja per essere allievo di Vincenzo Simoncelli, che di Scialoja era stato non solo fedele discepolo (la sua sorprendete chiamata sulla cattedra di procedura civile dell’Università di Roma era stata l’arma con cui Scialoja aveva chiuso le porte del più importante ateneo italiano a Lodovico Mortara) ma anche collega fidatissimo (erano contitolari del celebre studio legale Scialoja-Simoncelli) e genero carissimo (ne aveva sposato la figlia Giulia), e che purtroppo era scomparso, prematuramente e dolorosamente, nel 1917. Con il placet di Scialoja, il terzo gruppo lavorò alacremente tra il settembre 1918 e il giugno 1919 (cfr. F. Cipriani, Storie di processualisti e di oligarchi, cit., 197, il quale riferisce di averne ritrovato i verbali delle riunioni tra le carte di Chiovenda a Premosello), allorché vide la luce il progetto per la riforma del procedimento civile, che lo stesso Chiovenda avrebbe illustrato il 21 dicembre successivo allo scialojano circolo giuridico di Roma, dolendosi che il il Prof. Vittorio Scialoja, all’epoca ministro degli esteri, non fosse potuto intervenire, pur essendo stato, ‹‹come presidente della sottocommissione per gli studi giuridici, l’instancabile organizzatore ed eccitatore del lavoro››.
Sul progetto, che recava ben 204 articoli, nonché sulla celeberrima relazione di accompagnamento, si tornerà, infra, nel par.4.
[16] L’art.1 del progetto chiovendiano del 1919-1920, recante la rubrica ‹‹Oralità e concentrazione processuale››, disponeva che ‹‹le cause si trattano oralmente all’udienza …››.
[17] Il termine “propaganda”, quasi a mo’ di refrain, veniva ripetutamente utilizzato dallo stesso Chiovenda, sia negli scritti che negli interventi orali, per promuovere la riforma del processo civile all’insegna dell’oralità, dell’immediatezza e della concentrazione: cfr. F. Cipriani, Storie di processualisti e di oligarchi, cit., 129, il quale riferisce che verosimilmente la “propaganda” era iniziata l’11 marzo 1906, nell’ambito di una conferenza tenuta al circolo giuridico di Napoli. Sempre secondo F. Cipriani, ult. cit., 255, l’ultimo scritto di Chiovenda sull’oralità si identificherebbe con il saggio comparso sul primo numero della Rivista di diritto processuale civile, nel gennaio del 1924, recante il titolo L’oralità e la prova.
[18] G. Fichera, La Cassazione civile e il Covid-19: ex malo bonum?, in Il Caso.it, 23 marzo 2020, 11; Id., L’adunanza camerale distanziata protocollata, in Il Caso.it, 20 aprile 2020, 4.
[19] G. Fichera, La Cassazione civile, cit., 10; Id., L’adunanza camerale, cit., 5.
[20] G. Fichera, La Cassazione civile, cit., 12; Id., L’adunanza camerale, cit., 5.
[21] F. Terrusi, La Corte di cassazione ai tempi del Coronavirus, ovvero per una nomofilachia processuale solidale, in A. Didone e F. De Santis (a cura di), Il processo civile solidale dopo la pandemia, Milano, 2020, 44 e ss., particolarmente 56.
[22] Cfr. F. Terrusi, La Corte di cassazione, cit., 56; G. Fichera, L’adunanza camerale, cit., 6.
[23] L’evocazione del principio della libertà delle forme si ritrova anche in A. Pepe, La giustizia civile ai tempi del coronavirus, in IlCaso.it, 2020, 6.
In generale, sul tema dell’adunanza cameale civile di legittimità nel rapporto tra disciplina ordinaria e disciplina emergenziale, cfr. R. Frasca, Note sull’adunanza camerale civile in Cassazione al lume della disciplina delle forme del processo ed ora in tempi di coronavirus, in GiustiziaInsieme.it, 2020.
[24] F. Terrusi, La Corte di cassazione, cit., 58-59.
[25] F. Terrusi, La Corte di cassazione, cit., 59.
[26] F. Terrusi, La Corte di cassazione, cit., 60-61.
[27] F. Terrusi, La Corte di cassazione, cit., 61.
[28] G. Fichera, La Cassazione civile, cit., 13 ss.; Id., L’adunanza camerale, cit., 6 ss.
[29] L’art.83 del d.l. n. 18/2020 è stato modificato dall’art.221 d.l. 19 maggio 2020 n.34 (c.d. decreto-rilancio). Quest’ultima norma, a sua volta modificata dalla legge di conversione (l. 17 luglio 2020, n.77), disciplina le modalità di trattazione dei processi civili nel periodo 30 giugno 30 ottobre 2020, consentendo, per un verso, la partecipazione “da remoto” all’udienza delle parti e dei difensori su istanza dell’interessato (art.221, comma 6) e, per altro verso, lo svolgimento con tale modalità dell’udienza stessa, previo consenso preventivo delle parti, allorché non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, e purché l’udienza sia tenuta con la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti (art. 221, comma 7).
[30] G. Chiovenda, Principii, cit., IX.
[31] Cfr., sia pure in senso critico, S. Satta, Gli orientamenti pubblicistici della scienza del processo, in Riv. dir. proc. civ.,1937, I, 32 ss., nonché S. Satta, Orientamenti e disorientamenti nella scienza del processo, in Foro it., 1937, IV, 276 ss. In senso ricognitivo v. G. Tarello, Chiovenda, Giuseppe, in Dizionario Biografico Treccani, XXV, per il quale la dottrina chiovendiana «rovesciava l’idea liberale (secondo cui il processo civile è l’attività giurisdizionale pubblica al servizio dei privati) in senso autoritario (per cui anche nel processo civile l’interesse privato, con l’azione, adempie ad una funzione pubblica promuovendo, con l’attuazione della legge, un interesse dello Stato)».
[32] P. Calamandrei, Lodovico Mortara, già in Riv. dir. civ., 1937, 466, e poi in Opere giuridiche, X, Napoli, 1985, 156 ss.
[33] Così B. Cavallone, Una fondazione asimmetrica, cit., 616.
[34] Così L. Mortara, Lettera, in Studi di diritto processuale in onore di Giuseppe Chiovenda nel venticinquesimo anno del suo insegnamento, Padova, 1927, XIII.
[35] L. Mattirolo, Istituzioni di diritto giudiziario civile italiano, Torino, 1899, 7.
[36] G. Chiovenda, Azione, voce del Dizionario pratico del diritto privato, ora in G. Chiovenda, Saggi di diritto processuale civile (1894-1937), a cura di A. Proto Pisani, III, Milano, 1993, 3 ss., particolarmente 5.
[37] G. Chiovenda, L’azione nel sistema dei diritti, Bologna, 1903, pp.128.
[38] Cfr. F. Carnelutti, Giuseppe Chiovenda, in Riv. dir. proc. civ., 1937, I, 298, secondo cui il ‹‹discorso sull’azione›› tenuto a Bologna è ‹‹il manifesto della nuova scuola››; analogamente E.T. Liebman, Giuseppe Chiovenda, in Riv. dir. comm., 1938, I, 94, che identifica la prolusione tenuta dalla cattedra dell’Alma Mater con il ‹‹vero manifesto programmatico del nuovo indirizzo di studi››.
[39] V., in particolare, S. Satta, Dalla procedura civile al diritto processuale civile, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1964, 29, nonché Id., La dottrina del diritto processuale civile (scritto nel 1974 ma pubblicato) in Riv. dir. proc., 1992, 703, il quale, attraverso la metafora del c.d. ‹‹mutamento di sesso››, ipotizza una trasformazione della disciplina da mera pratica (‹‹procedura civile››) a scienza vera e propria (‹‹diritto processuale civile››), individuandone ‹‹l’avvento›› o ‹‹addirittura la data di nascita›› nel giorno 3 febbraio 1903.
[40] Per il rilievo che la tesi dell’autonomia dell’azione viene affermata da Chiovenda ‹‹sulle orme di Adolph Wach››, cfr. F. Cipriani, Il 3 febbraio 1903 tra mito e realtà, in Scritti in onore dei Patres, Milano, 2006, p.253.
[41] Cfr. L. Mortara, Manuale della procedura civile, I Torino, 1897, p.14, secondo cui l’azione è ‹‹il diritto di provocare l’esercizio dell’autorità giurisdizionale dello stato contro le violazioni che stimiamo patite da un nostro diritto subiettivo››.
[42] Così F. Cipriani, ult. cit., 253, nota 10.
[43] Cfr., sul tema, il perspicuo ed illuminante saggio di G. Monteleone, Domenico Viti e l’eredità scientifica di Giuseppe Chiovenda, in Giur. it., 1997, IV, 89 ss..
[44] Così F. Cipriani, Storie di processualisti e di oligarchi, cit., 92.
[45] G. Chiovenda, L’azione, cit., 10: ‹‹La mera possibilità, capacità, libertà d’agire che spetta a tutti i cittadini, non per sé un diritto … ma piuttosto una condizione del diritto d’agire››.
[46] Cfr., incisivamente, G. Chiovenda, L’azione, cit., 19: ‹‹La domanda infondata è per sé atto lesivo dell’ordinamento››.
[47] C.M. Bianca, Diritto civile, 6, La proprietà, Milano, 1 e ss.; W. Cesarini Sforza, Diritto soggettivo, in Enc. dir., XII, 1964, 659 e ss.; V. Frosini, Diritto soggettivo, in Nuov. dig. it., V, 1047 e ss.. C. Maiorca, Diritto soggettivo, in Enc. giur. Treccani, XI, 1989.
[48] G. Chiovenda, L’azione, cit., 9, 11 e 14.
[49] Più che nell’esercizio di una facoltà l’esercizio dell’azione si traduce in quello di una potestà, poiché ‹‹ha per contenuto un puro potere giuridico e non un dovere altrui››: così G. Chiovenda, L’azione, cit., 20.
[50] Su tale capacità si soffermerà, non senza un pizzico di civetteria, lo stesso Chiovenda, quando, ormai maturo dominus del diritto processuale civile italiano, detterà, nel 1923, la celebre prefazione ai suoi Principii: cfr. G. Chiovenda, Principii, cit., XIII.
[51] Si allude, in particolare, al R.D. 29 giugno 1939, n. 1127 e alla L. 22 aprile 1941, n. 633, i quali rappresentano forse i primi esempi positivi volti a sganciare il concetto di bene da quello di cosa, mediante il riconoscimento della dignità di beni (evidentemente, immateriali), rispettivamente, alle invenzioni industriali (protette con il diritto di brevetto) e alle opere dell’ingegno (protette con il diritto di autore).
[52]L’espressione viene largamente utilizzata dalla dottrina civilistica, in particolare da quella commercialistica, per evidenziare la tendenza del legislatore del 1942 ad attribuire prevalenza, nel nuovo codice unificato, alla disciplina contenuta nel previgente codice di commercio del 1882, anziché a quella contenuta nel previgente codice civile del 1865. Sul tema v., per tutti, G. Levi, La commercializzazione del diritto privato: il senso dell’unificazione, Milano, 1996.
[53] A. Proto Pisani, Ricordando Giuseppe Chiovenda: le note alla ‹‹Azione nel sistema dei diritti›› del 1903, in Foro it., 2003, V, 61 e ss.
[54] Lo stesso Chiovenda, nel dettare la Prefazione alla terza edizione del Trattato delle prove di Lessona, pubblicata a cura del figlio Silvio, dopo la morte prematura dell’autore, ricorderà che tra gli ‹‹argomenti›› con cui era ‹‹fecondo discorrere›› con il prefato, vi era quello dell’azione di accertamento ‹‹come figura generale del nostro diritto››, che Lessona non ammetteva, ritenendo che contro il “vanto” altrui la legge italiana non consentisse altra azione che quella risarcitoria: cfr. G. Chiovenda, Prefazione, in C. Lessona, Trattato delle prove in materia civile, terza ed., III e V, a cura di S. Lessona, Firenze, 1922-1924, 3 ss..
[55] A. Proto Pisani, ult. cit.
[56] G. Chiovenda, Relazione sulla proposta di riforma, in La riforma del procedimento civile proposta dalla Commissione per il dopo guerra, cit., 19.
[57] Cfr. M. Taruffo, La giustizia civile in Italia dal 700 ad oggi, Bologna, 1982, 197.
[58] Cfr. G. Chiovenda, Relazione, cit., 19, ove si sostiene, anche attraverso l’allegazione di dati statistici, che in Austria il 45% delle cause viene deciso in un mese, il 35% in tre mesi, il 15% in sei mesi, il 4% in un anno e solo l’1% in più di un anno. Va qui rilevato che per Chiovenda (e in generale per la nuova scuola “sistematica”, che attribuiva importanza fondamentale all’indagine storica e all’insegnamento della dottrina tedesca), l’ordinamento processuale austriaco rappresentava un esempio da seguire. Chiovenda, in particolare, aveva manifestato il suo ammirato interesse per la riforma predisposta in Austria da Franz Klein (entrata in vigore il 1° gennaio 1898) sin dalla prolusione al corso di libera docenza tenuto a Roma, nel 1901 (cfr. G. Chiovenda, Le forme nella difesa giudiziale del diritto (1901), in Saggi di diritto processuale civile, I, Roma, 1931, p. 353 ss.).
[59] Già nel 1911, Chiovenda aveva parlato di ‹‹rapporto immediato tra giudici e le persone le cui dichiarazioni sono chiamati ad apprezzare››: cfr. G. Chiovenda, La riforma del procedimento civile, in Saggi, cit., 1993, 296.