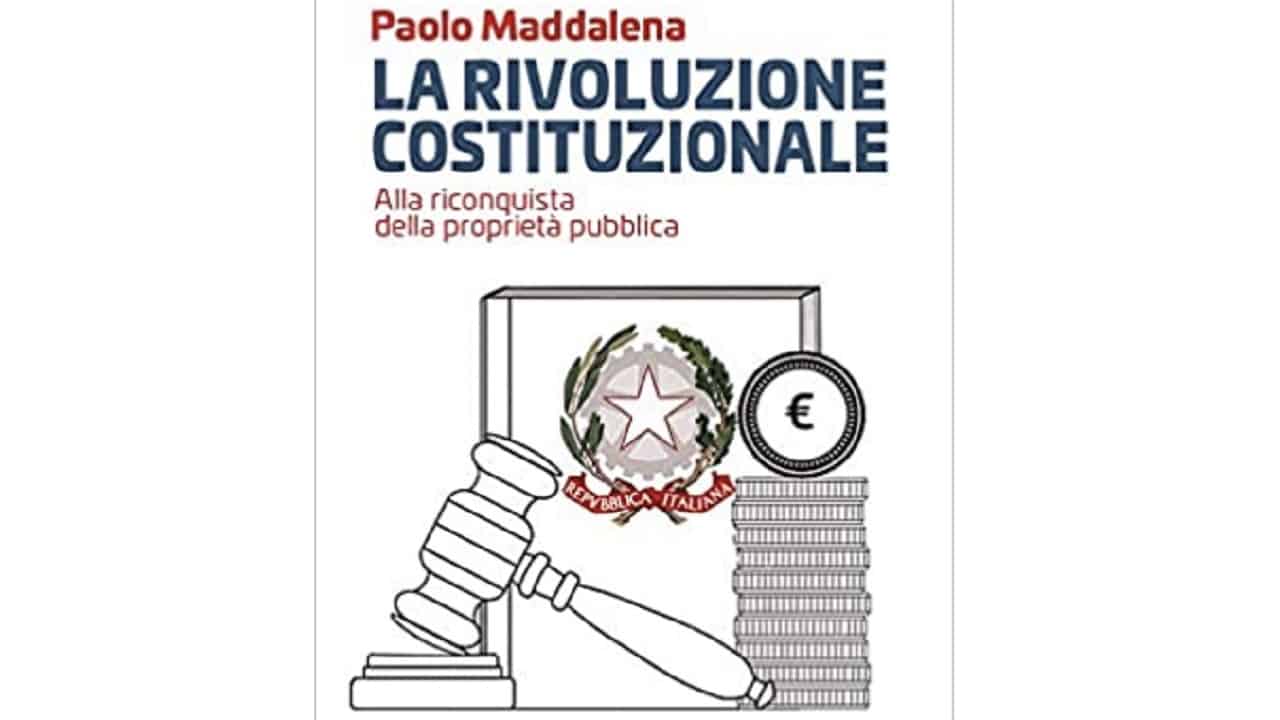Derrida, il giudice, il fare giustizia
di Giancarlo Montedoro
Leggendo Justices si scopre la solitudine del giudice, la solitudine che comporta il fare giustizia.
Si tratta di un libretto di Jacques Derrida.
Esemplare piccolo saggio per un’analisi Law and Literature.
È la traduzione del testo di una conferenza pronunciata presso l’Università della California, Irvine, il 18 aprile 2003 al colloquio “J” Around the work of J. Hillis Miller.
Un omaggio al filosofo ed amico J. Hillis Miller fatto con tono di sincera ammirazione ed empatia che caratterizza l’opera di Derrida sempre connotata da espressioni affettive e scavi filologici che muovono alla scoperta del lato emotivo dell’uomo.
Miller è stato collega di Derrida nell’insegnamento universitario, era un critico letterario, famoso negli States, della scuola degli Yale critics di cui è stato esponente anche Harold Bloom.
Derrida – amico di Miller - si interroga sull’Io di Miller e così attraverso l’amicizia scopre l’essenza della giustizia.
Quasi a volersene appropriare come di un altro se stesso, Derrida si chiede quale gusto avesse Miller per se stesso.
Cosa si prova ad essere Miller?
Cosa pensava Miller del suo Io?
Un interrogativo sull’Io, simile a quello di Rimbaud, per cui Io è un altro. Io is another one.
Derrida cerca Miller, e, nel cercarlo diviene Miller per non tradirlo e non sentirsi tradito dall’amico.
Miller sempre sfugge. Miller va reso presente con le parole per rendergli giustizia.
Un io è sempre una responsabilità. Così – dice Derrida – opera la legge, il diritto, la giustizia.
A partire dall’Io ma da un Io aperto, un Io che è cancellato (magari solo temporaneamente) per risolversi nell’Altro.
Miller appare a Derrida – giusto a sua volta perché empatico ed amante della amicizia e della singolarità - un giusto.
Uno che rende giustizia ai testi. Rende giustizia ai testi perché li decostruisce.
L’analisi del libro di Miller The disappearance of God (un libro dedicato all’analisi del poeta vittoriano Hopkins ma questo poco importa) conduce Derrida a scoprire che Miller era alla ricerca del fondamento teologico mistico dei poeti interpretati, della loro Haecceitas nel senso di Duns Scoto.
La decostruzione, in questa logica, si rivela una lettura “errante” dei testi, volta non alla ricerca di una sola unica interpretazione come giusta e corretta, ma come ricerca (lettura) aperta all’errore, alla possibilità del fraintendimento, alla dinamica consapevole che il testo è vertigine che non conduce a nessuna origine.
L’origine essendo poi l’autore, impossibile da cogliere nella sua singolarità.
Il testo perde il suo primato e diviene l’occasione per l’apertura del gioco interpretativo, inteso come gioco parassitario, non solo nel senso che il parassita si appropria di una cosa/casa che non gli appartiene ma anche ( e soprattutto ) nel senso che il parassita è compagno nel pasto, in una posizione insieme di prossimità e distanza, somiglianza e differenza, interiorità ed esteriorità rispetto all’autore del testo “parassitato”.
Uno scambio di ruoli fra l’interprete e l’autore del testo (fra il giudice ed il legislatore diremmo da giuristi) che appare spaesante ma è inevitabile perché sempre sotteso all’ars interpretandi nel suo processo di aporetica mimesi e distanziamento agonistico.
Lo scambio (possibile – inevitabile) fra giudice e legislatore insito in ogni atto interpretativo è il grande rimosso della metodologia giuridica gius-positivistica.
La decostruzione non si presenta tuttavia come una metodologia alternativa.
Non è una teoria, non è una critica, non è un’analisi, nemmeno un metodo, è qualcosa che avviene. Solo avviene. Come la psicanalisi.
È il soggetto ça déconstruit che pratica la decostruzione anche senza saperlo, la fa.
Questo è il giusto.
Uno che ha il gusto di se stesso, una virtù certamente, un senso esemplare della responsabilità davanti agli altri ed alle loro opere.
Solo chi ha gusto di se stesso è responsabile si presenta come responsabile.
Responsabile è chi rinuncia a se stesso. L’amore – dice Derrida – è l’accordo di due rinunce per dire l’impossibile.
La giustizia, pur meno radicale dell’amore, è fatta dello stesso gesto di rinuncia, è impastata della stessa materia.
E rinuncia a se stesso chi è soddisfatto di se stesso. Non certo il “risentito” della schiatta dei personaggi nietzschiani – dostoevskiani che imperano nel nostro tempo.
Questo è un dono, essere giusti.
La giustizia in questo eccede il diritto, si pone al di là del diritto.
Il diritto come sistema di leggi, mantiene il suo legame con la forza.
Nel cuore del diritto – dice Derrida – nel testo “Forza di legge” leggendo passi di Zur Kritik der Gewalt di Benjamin, c’è una forte ambiguità legata all’utilizzo della violenza.
O anche del calcolo, del diritto calcolabile – weberiano - inteso, nel suo complesso, come sistema di pesi e contrappesi, atto a garantire misura e proporzione.
Ma nella violenza sottomessa alla legge e nel calcolo dell’operare del macchinismo giuridico si cela spesso l’insidia – quasi un residuo non scontabile - della violenza originaria, della lex talionis.
La giustizia va oltre la violenza ed oltre il calcolo.
Essa è incalcolabile, non segue nessuna regola, nessun equilibrio.
Rende a ciascuno il suo ma seguendo la logica paradossale del dono, senza scambio, senza contro dono, senza debito, senza restituzione.
La giustizia è nella decisione, nella sua gratuità, nella sua immedesimazione nell’ Altro (levinassiano) nel tentativo (sempre parziale , sempre umano) di conciliare universalità e singolarità.
La giustizia non è legalità.
Crea regola (ma non nel senso che fuoriesce dalla cornice legislativa) ma nel senso che rende giustizia a ciò che è singolare (rimanendo nella cornice, nel carapace linguistico della legge, nel suo esoscheletro ha detto Antonello Cosentino in un recente interessante dibattito promosso dalla Rivista dedicato al saggio di Tomaso Epidendio).
La giustizia è la legge della singolarità.
La legge della singolarità è la misura della nostra libertà.
La giustizia è quindi (anche) l’esperienza dell’impossibilità, della sua impossibilità.
E la conferma della (nostra) solitudine (come uomini, come giudicati, come giudici).
La giustizia è sempre a –venire, mai realizzata.
Il suo tempo è messianico.
La giustizia richiede un perenne senso di inadeguatezza.
Perennemente aperta, è una “veglia” sulla nostra universalità.
È al fondo, apocalittica.
Comunque connessa ai libri sacri dai quali procede (una parola Dio ha detto, due ne ho udite ; per arrivare all’uno occorre saper contare fino a due, ha detto, in lode del pluralismo, Barbara Spinelli commentando il Salmo 62).
Il diritto – fatto di materiali politico economici – è decostruibile. Va decostruito.
La giustizia – pur consistendo nella decostruzione (del diritto) – non è decostruibile.
Questo atto ginnico/gnomico aporetico e paradossale nel che consiste la giustizia deve le sue caratteristiche al fatto che si confronta con l’unicità dei singoli , con la loro insostituibilità, con la loro verità profonda, con quello in-scape, (il termine inscape viene usato dal poeta inglese Gerard Manley Hopkins, per definire quel complesso di caratteristiche che conferiscono unicità ed esclusività ad un'esperienza interiore individuale) che è l’oggetto oltre che della poesia, della ricerca critico-letteraria che la poesia ricrea.
La giustizia è così praticata dal giusto in modo quasi naturale.
Il giusto è chi pratica la giustizia.
Ma la tensione fra il soggetto e la sua azione è sempre una ricerca irrisolta.
La giustizia è perfezione cercata ma anche finita, iniziata ma anche giunta al termine, è il risultato ma anche il muoversi per raggiungerla, quindi la distanza che perennemente segna il soggetto che la cerca ed il compimento dato dall’atto che decide.
La giustizia rende a se stessa la forma di ogni creatura o ambisce a renderla, nella letteratura e nel diritto.
È un universale che non annichilisce, ma al fondo della scoperta dell’unicità, appare la solitudine dell’uomo, non mitigata nemmeno dalla trascendenza, perché poi – a ben vedere – la solitudine dell’uomo – dice Derrida leggendo Miller - è la solitudine di Dio.
Entrambi giusti ma entrambi soli.
Entrambi simili, creatori nel segreto incomunicabile di un’istante che possiamo anche pensare eterno.
La giustizia non si riferisce a norme calcolabili, si è giusti come si respira, per essenza, in modo spontaneo, liberamente come il fiume che scorre dalla fonte al mare.
La giustizia è immanente ed emanante.
Essa si irradia e, nello stesso tempo, non può essere compresa fino in fondo, per la sua connessione al singolare, per l’abbandono necessario della pretesa del Logos, della verità.
La giustizia è questo abbandono (relativo ma ineludibile) del Logos.
E si torna all’umiltà. Ed al mistero.