Recensione di «Arringhe» (De Frede editore, Napoli, 2025) dell’avvocato Gaetano Iannotta
1. La retorica forense è la disciplina teorica e metodologica che studia i principi, le tecniche e le strutture dell'argomentazione giuridica persuasiva, l'organizzazione del discorso e l'uso delle figure retoriche sulla base della retorica classica applicata al diritto. Si ritiene che essa abbia ha avuto origine a Siracusa nel V secolo a.C. in seguito alla fine della tirannia di Trasibulo (465 a.C.), quando si sviluppò una intensa attività giudiziaria per la restituzione di proprietà espropriate ai cittadini. In questo contesto nacque la figura del ῥήτωρ, cioè colui che doveva persuadere le giurie popolari nei processi, e i primi maestri riconosciuti di questa arte furono Corace e Tisia, che teorizzarono l'arte del discorso giudiziario con metodi e manuali pratici.
Nel quadro teorico della retorica giuridica si inserisce l'eloquenza forense, che è una tecnica con finalità legate alle cause giudiziarie. La sua nascita si colloca in ambito greco con la figura di Egesia di Magnesia (circa nel 250 a.C.), che si ispirò all'eloquenza attica e ebbe come modelli di oratori Carisio e Lisia. Nell'antica Roma, l'eloquenza forense trovò un suo sviluppo maturo e sistematico con il processo formulare romano e figure come Cicerone e Quintiliano diventarono esempi di questa arte, che era legata strettamente al diritto e all'oratoria in tribunale e si esercitava in luoghi, come il tribunale romano, strutturati quasi come teatri per l'ascolto pubblico delle arringhe.
Nel corso dei secoli l'eloquenza forense si è adattata ai mutamenti culturali e alle esigenze locali fino ai tempi recenti.
Nell'Ottocento, in Italia, l’eloquenza forense fu studiata in sedi specifiche, come la Scuola di eloquenza pratica legale promossa durante il periodo napoleonico, e coltivata in corsi specializzati come l'Accademia estemporanea di eloquenza forense a Milano per formare i giovani avvocati all'arte oratoria.
Nel Novecento, lo stile dell'eloquenza forense si è trasformato diventando più lineare, sobrio e essenziale, valorizzando la chiarezza e la brevità in linea con i cambiamenti sociali e culturali1.
Per quel che è dato sapere, attualmente nelle Università italiane l’insegnamento all'eloquenza forense e alla retorica giudiziaria è sporadico. Sia in Italia che in Europa, la retorica giudiziaria è spesso oggetto di attività formative nell'ambito dei corsi di giurisprudenza, ma la denominazione specifica di «Cattedra di eloquenza forense» è più rara e solitamente integrata in corsi più ampi di diritto, argomentazione o comunicazione giuridica2.
2. Autore di molteplici studi, che rivelano la pluralità dei suoi interessi, Gaetano Iannotta, come giurista, ha scritto e curato opere sull'eloquenza forense, Inoltre, è fondatore dell'Accademia di Eloquenza Forense e direttore di una collana di studi dedicata a questa materia.
Nel 2019 ha pubblicato uno studio sulla evoluzione di questa arte [L’eloquenza antica. L’oratore eloquente. Tecniche di argomentazione e persuasione nella difesa penale. Difese penali di Enrico de Nicola3], con una attenzione particolare all'eloquenza forense di Enrico De Nicola, che è sato uno dei più grandi oratori giudiziari italiani per la sua straordinaria capacità di esprimere concetti complessi con parole essenziali e senza artifici, valorizzando la brevità e la forza di ragionamento piuttosto che l'emotività o la retorica vuota e così segnando un cambiamento verso uno stile più sobrio e razionale, ispirato alle forme classiche attiche. Nel 2020 ha tracciato un agile quadro della storia della eloquenza forense in Italia e delle sue diverse articolazioni regionali [L’eloquenza forense in Italia» dedicato a Vincenzo Maria Siniscalchi4].
3. Come avvocato, nel recente «Arringhe» [De Frede editore, Napoli, 2025] , Iannotta offre al lettore sette sue arringhe (con esito positivo per gli imputati) che danno piena prova della sua competenza nell’uso delle tecniche di eloquenza forense moderna fondate su uno stile chiaro, conciso, logico e raziocinante, strumenti che soddisfano una esigenza di rapidità, efficacia e sobrietà consone al contesto giudiziario moderno perché funzionali a una comunicazione che sia intensa e dinamica ma non sacrifichi la profondità e l’acutezza del pensiero giuridico.
Si tratta di arringhe pregevoli sviluppate applicando i canoni tecnici più rilevanti della migliore retorica forense contemporanea:
· la brevità e la chiarezza, che si conseguano sintetizzando efficacemente la causa e i fatti principali, evitando giri di parole e artifici inutili
· l’esposizione dei fatti seguendo il loro ordine naturale, che si consegue raccontando gli eventi nell'ordine in cui si sono svolti per mantenere verosimiglianza e comprensibilità
· l’utilizzo di una logica raziocinante, che consiste nell’usare la ragione e le prove per sostenere le argomentazioni, senza affidarsi a espedienti suggestivi o manipolativi
· l’uso mirato delle figure retoriche classiche, che si realizza evitando ripetizioni (epifore e simili), sottrazioni (preterizioni, reticenze), e mascheramenti (antìfrasi) per enfatizzare o creare effetti di persuasione senza appesantire il discorso
· il ricorso a una introduzione efficace e senza artifici, che serve a preparare l’ascoltatore con un preambolo conciso e diretto, senza mirare a attrarne l’attenzione con tecnicismi o eccessi di stile
· l’approdo a una conclusione persuasiva razionale, cioè a una perorazione fondata sulla logica che riassuma e rafforzi i punti effettivamente dimostrati senza puntare su aspetti emotivi.
I testi riguardano una variegata tipologia di casi giudiziari penali: i reati di disastro aereo e lesioni colpose (In difesa del Colonnello Giuseppe Manzini), di traffico di munizioni e armi da guerra (In difesa di Ivan Vettorazzi), di furto e rapina (In difesa di Lorenzo Decasilliati), di bancarotta fraudolenta, evasione e frode fiscale (In difesa di Giorgio Masetti e In difesa di Brenno Caffari), di tentato omicidio (In difesa di Pietro Petriccione) di resistenza a pubblico ufficiale (In difesa del Dottore Giacomo Grande).
Si tratta di processi svoltisi in diverse sedi giudiziarie d’Italia nel periodo che va dal 1997 al 2003 sicché, oltre alle pregevoli soluzioni giuridiche elaborate (e accolte dai giudici), le arringhe offrono degli scorci interessanti, non soltanto dal punto di vista giudiziario, della società italiana degli ultimi decenni.
4. Per altro verso, con la pubblicazione di «Arringhe» l’Avvocato Iannotta fornisce materia per sollecitare l’incremento di un approccio formativo che può risultare proficuo per i giovani avvocati (ma utile anche per i magistrati).
Al riguardo, vale richiamare quello che l‘Autore ha raccomandato in altro suo scritto5:
«Il giovane deve studiare principalmente le orazioni giudiziarie degli oratori più degni di stima sforzandosi di comprendere lo sviluppo delle idee e l’esame della logica che ha seguito l’oratore.
Se il giovane riuscirà a penetrare nel pensiero e nello spirito dell’oratore da imitare, e a vedere le cose alla stessa sua luce, sarà in grado di discernere le virtù oratorie dai suoi difetti, dopo di che ne emulerà l’aspetto migliore.
Difatti, l’oratore deve all’oratore, come nel passato così nel presente; non è facile trovare la strada delle orazioni mai pronunciate!
Non vi è oratore che non sia stato influenzato da un altro (…).
Leggere e rileggere, se da un lato significa arricchire la propria cultura, dall’altro lato significa assimilare il testo, prendere possesso, raggiungere omogeneità stilistica con esso.
Questo tipo di lettura è chiaramente un’operazione creativa, poiché non è solo acquisizione di conoscenza, ma è già quasi un ricreare (…).
Nell’arte non c’è mai imitazione pura e semplice: l’arte è produttiva ed è proprio il foro a rendere ragione di questa produttività. L’arte nel foro diventa allora essenza produttiva naturale per generare una presenza nuova, una presenza diversa che prima ancora di essere rappresentazione è rinascita di un modello ideale.
Ciò che deve essere chiaro è che lo stile dell’eloquenza forense non è il frutto di una scelta, ma, in astratto, degli scopi che l’ordinamento giuridico di un tempo impone al giudice o all’avvocato e dalla naturale vocazione di chi si dedichi a meglio rendere l’una o l’altra esigenza della funzione penale. È dall’incontro tra i vari aspetti di questa e i vari temperamenti degli uomini che traggono origini le distinzioni tra le scuole e gli stili (…).
E allora potrà definirsi arte solo quell’imitazione forense che si snoderà in tre fasi: bravura nel selezionare i grandi oratori per emularne i pregi; capacità di seguire il principio individuationis per ricavarne uno stile personale; abilità di adeguare il proprio stile al sistema penale del tempo in cui si opera».
5. Gli apporti di Iannotta alla eloquenza forense non sono rilevanti soltanto per il loro valore intrinseco ma anche per le ulteriori osservazioni alle quali invitano.
Sarebbe assai interessante ─ ma richiederebbe una competenza estesa, variegata e necessariamente plurisoggettiva ─ approfondire la conoscenza di quali siano i canoni di eloquenza forense nelle varie aree del mondo, così da utilizzare questa materia come prisma per l’interpretazione di diversi fenomeni culturali fra loro interconnessi.
Valga solo l’accenno a alcuni esempi sparsi: l’insistenza sullo stile conciso, chiaro e efficace dell'eloquenza forense in Francia6; la formalizzazione di questa tecnica come insegnamento universitario moderno, ma con un approfondimento particolare circa tradizione antica in Grecia; l’attenzione alla persuasione delle giurie popolari e non solo dei giudici nei sistemi anglosassoni, la mescolanza di tecniche linguistiche forbite e formali, assieme a varianti più colloquiali a seconda del contesto, in Cina; il particolare stile di comunicazione in ambito legale, in Giappone; l’evocazione di principi religiosi, interpretazioni dottrinali e consuetudini locali nei paesi islamici.
Ma a porre questioni nuove e in una dimensione che non può più essere soltanto nazionale sono soprattutto gli sviluppi futuri dell’eloquenza forense ─ soprattutto in un sistema di comunicazione giudiziaria che vira decisamente verso la forma scritta7 più che orale ─ che, in misura attualmente crescente si serve degli strumenti della intelligenza artificiale.
Il contesto odierno mostra un impoverimento dell'uso della retorica e dell'oratoria tradizionale nei processi civili e penali, a causa di vari fattori: la quantità dei processi e l’allungamento della loro durata, la scarsa formazione specifica in materia di retorica, logica, teoria e psicologia dell’argomentazione.
In questa prospettiva la ricerca della coesione nelle argomentazioni e evitare le fallacie sono elementi minimi fondamentali per gli sviluppi futuri della funzionalità dell'eloquenza forense e della retorica giudiziaria.
Infatti, un discorso coeso facilita la sua comprensione e accettazione da parte del giudice, mentre evitare le fallacie logiche rende l'argomentazione più solida e affidabile8. La spinta (normativa e culturale) verso l'essenzialità nei testi difensivi e nelle arringhe orali rende il processo più rapido e efficiente, pur senza sacrificare la qualità della persuasione, che rimane al centro della retorica giudiziaria.
Allora l'eloquenza forense futura sarà legata alla capacità di costruire argomentazioni efficaci perché coese, evitando fallacie e bias cognitivi.
L’educazione retorica moderna dovrà concentrarsi non solo sulle tecniche specifiche ma anche su modelli performativi e dialettici per rendere la formazione professionale più responsabile e mirata, sottolineando il valore di una retorica che non si limiti a esprimere la posizione parte ma faciliti anche un processo fondato sulla ragionevolezza, rendendo la decisione finale più articolata e nutrita dal confronto con argomentazioni ben strutturate.
La retorica giudiziaria futura dovrà guardare al patrimonio della retorica classica come base per la formazione dell’abilità argomentativa e persuasiva, sfruttando metodi come quello casistico e le strutture articolate del discorso (esordio, narrazione, prova, confutazione, perorazione). Questi modelli antichi offrono una piattaforma solida per l'apprendimento e possono essere adattati alle esigenze moderne.
Inoltre, è prevedibile che l’evoluzione della retorica giudiziaria finisca per includere un uso sapiente delle nuove tecnologie, adattando le tecniche oratorie e persuasive ai contesti digitali (processi telematici, presentazioni multimediali, intelligenza artificiale nel supporto argomentativo).
In questo nuovo contesto, l'evoluzione della eloquenza forense dovrebbe procedere verso la massima efficienza comunicativa con un recupero consapevole delle strutture classiche e un crescente rigore logico. Il rapporto con i nuovi strumenti va, quindi, inteso come una sinergia: l’intelligenza artificiale non può sostituire la capacità persuasiva, emotiva e retorica propria dell’eloquenza in tribunale, ma può supportare l’avvocato automatizzando alcuni compiti ripetitivi, aiutandolo a concentrarsi maggiormente sulla costruzione efficace dell’argomentazione e sull’interazione umana.
In definitiva, è necessario formare un giurista forense (avvocato e magistrato) che conosca retorica, neuroscienze, psicologia e logica e sappia usare queste discipline per costruire un discorso persuasivo e deontologicamente appropriato, sicché l’eloquenza forense classica resta insostituibile nelle attività che richiedono giudizio critico, umanità, capacità di persuasione e interazione diretta, elementi che l’intelligenza artificiale non può replicare.
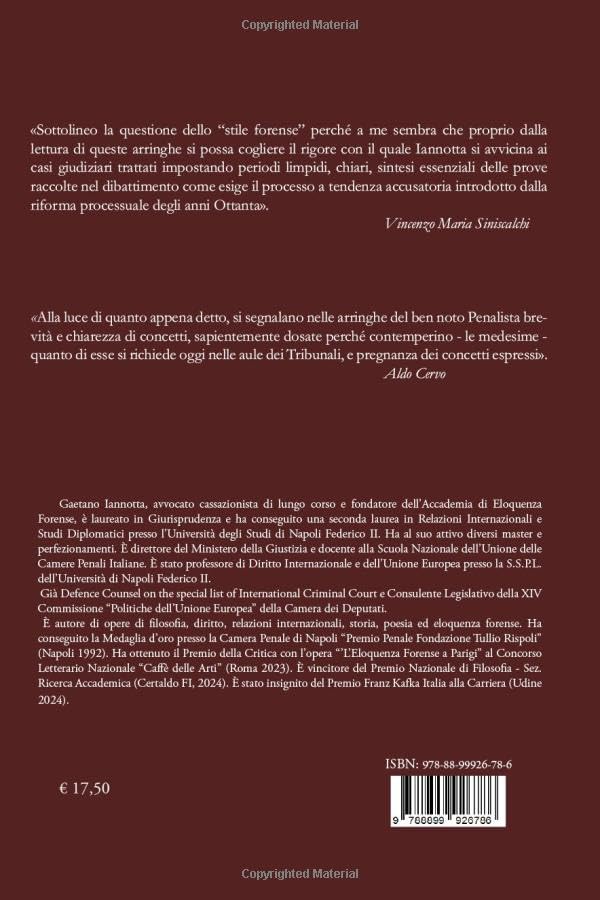
1S.T. Salvi, Avvocati oratori’. Eloquenza forense e trasformazioni di una professione tra Otto e Novecento, in: Historia et ius, Rivista di storia giuridica dell’età medievale e moderna www.historiaetius.eu - 12/2017 - paper 14, pp.1-26.
2Nell'Università di Urbino è attivo il corso di «Argomentazione giuridica e retorica forense» (anno accademico 2024/2025) che tratta in modo approfondito la retorica e le tecniche argomentative usate dai giuristi e dagli avvocati, con un confronto tra antico e moderno. Si studiano l'organizzazione del discorso, gli elementi persuasivi (logos, pathos, ethos), le figure retoriche, le tecniche di coinvolgimento, la comunicazione non verbale e le fallacie argomentative.
L'Università di Siena offre un corso denominato «Retorica forense», che si propone di approfondire la retorica giudiziaria nell'esperienza greca e romana.
L'Università di Messina ha organizzato in passato un corso di eloquenza forense destinato a sviluppare le competenze retoriche specifiche nell'ambito giuridico.
3Enrico De Nicola [1877-1959] è stato un politico e avvocato italiano di grande rilievo storico e culturale e il primo Presidente della Repubblica Italiana.
4Vincenzo Maria Siniscalchi [1931-2024] è stato un avvocato e politico italiano, dotato di eccellenti capacità oratorie.
5G. Iannotta, Sul miglior stile di eloquenza forense, Diritto di difesa, Rivista della dell’Unione della Camere Penali Italiane, 23 novembre 2023.
6m. Garçon, Sull’oratoria forense, prefazione di A. Altavilla, traduzione di G. Crescenzi, Milano 1957.
7G. Sposito, Dalle parole ai fatti. Il futuro scritto dell’oratoria forense, Ciceroniana On Line VI, 2, 2022, pp. 281-289.
8Su questi aspetti sia consentito rinviare a: A.Costanzo–S.Novani, La logica dell’analisi e della sintesi dei dati processuali, Torino, 2025, parte II, cap. 3.

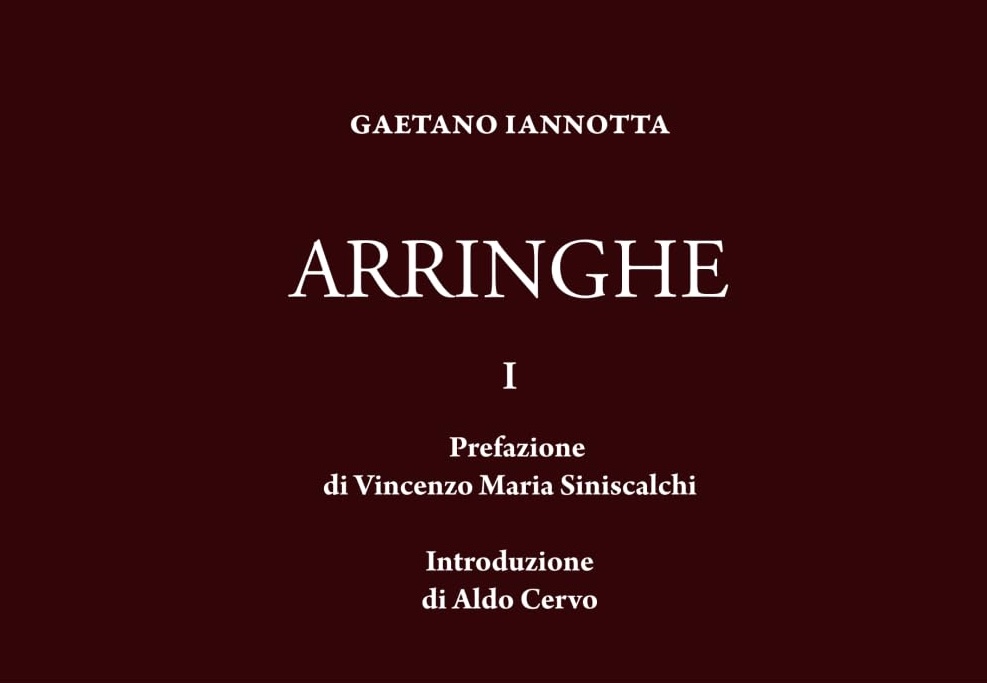

 E poi Aggiungi alla schermata principale.
E poi Aggiungi alla schermata principale.