Sulla dichiarazione di ripudio del fascismo nella richiesta di concessione di spazi pubblici (nota a Cons. Stato, Sez. II, 19 settembre 2024, n. 7687)
di Alice Cauduro
Sommario: 1. Il caso di specie. – 2. L’attuazione del divieto della “riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista” nella concessione di spazi pubblici: la ricostruzione della giurisprudenza amministrativa. 3 – Cenni conclusivi sulla pubblica amministrazione nella ‘ispirazione antifascista nella nostra Costituzione’.
1. Il caso di specie.
Con la sentenza del Consiglio di Stato qui commentata il giudice amministrativo torna ad affrontare il tema dell’applicazione da parte della pubblica amministrazione della XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione della Repubblica italiana secondo cui “È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista” (comma 1).
La vicenda da cui origina il ricorso riguarda la contestata legittimità della delibera n. 781 del 19 dicembre 2017 della Giunta del Comune di Brescia, avente ad oggetto “Indirizzi in merito alla concessione di spazi ed aree pubbliche, sale ed altri luoghi di riunione di proprietà comunale”, per la previsione in essa contenuta dell’obbligo di allegare alla richiesta di concessione di spazi pubblici anche una esplicita dichiarazione di ripudio del fascismo.
Con la suddetta delibera il Comune di Brescia ha stabilito “l'obbligo di allegare alla domanda di concessione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e l’utilizzo di sale ed altri luoghi di riunione di proprietà comunale [anche] una dichiarazione esplicita di adesione ai principi della Costituzione” (pp. 3-4). La deliberazione prevede che alla richiesta si alleghi una dichiarazione “che contenga i seguenti impegni del richiedente: di riconoscersi nei principi e nelle norme della Costituzione; di non professare e non fare propaganda di ideologie neofasciste e neonaziste, in contrasto con la Costituzione e la normativa nazionale di attuazione della stessa; di non perseguire finalità antidemocratiche, esaltando, propagandando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la Costituzione e i suoi valori democratici fondanti” (pp. 2-3).
Trattasi di indirizzi espressamente finalizzati alla concreta attuazione del citato comma 1 della XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana, nonché della relativa normativa attuativa[1].
Dalla deliberazione emerge che l’esigenza del Comune di Brescia di adottare tali indirizzi è sorta a seguito di episodi di manifestazioni di ideologia nazista e fascista ed è avvertita anche in altri Comuni tanto da portare gli stessi all’adozione di analoghi atti[2]; in effetti, tra gli altri, anche i Comuni di Pavia, Siena, Prato, Firenze, Torino, di recente si sono mossi in tal senso[3]. Una deliberazione dal contenuto simile a quella impugnata davanti al Tar Lombardia è stata approvata anche dal Comune di Rivoli e ha dato origine ad analogo contenzioso innanzi al Tar Piemonte, richiamato nella pronuncia che qui si commenta (sul punto infra § 2).
Nel caso qui esaminato l’associazione CasaPound, tramite il suo legale rappresentante, lamentava l’imposizione dell’obbligo previsto dalla delibera comunale, in quanto asseritamente lesivo della libertà di manifestazione del pensiero dell’associazione e dei suoi aderenti, nella parte in cui si chiede di allegare alla domanda una dichiarazione – ad avviso dell’associazione ricorrente – in grado di “compromettere le proprie convinzioni” con condividendo l’associazione stessa i “presunti valori dell’antifascismo”, senza che ciò significhi che essa non rispetti la Costituzione italiana e il metodo democratico da essa individuato[4].
Nella ricostruzione del fatto il giudice di prime cure (Tar Lombardia, sez. II, Brescia, 26 gennaio 2020, n. 166) riportava gli argomenti della ricorrente a sostegno del ricorso per l’annullamento della delibera, specie laddove sosteneva che la deliberazione di indirizzo impugnata violasse diversi diritti e libertà fondamentali (artt. 2, 3, 17, 18, 21 e 49 Cost.) e che «l’unico limite opponibile alle libertà costituzionalmente tutelate di cui alle norme ricordate sarebbe quello rappresentato dall’obbligo di rispetto dell’ordine pubblico e, conseguentemente, di tenere riunioni pacifiche e senza armi, di dare il preavviso all’autorità e di rispettare i limiti imposti dalla legge penale»; che «la pretesa di ripudiare il fascismo non avrebbe nulla a che vedere con tali prescrizioni e con il loro rispetto da parte del richiedente. In ogni caso, una tale dichiarazione sarebbe del tutto inutile, in quanto non preserverebbe la società da comportamenti riprovevoli come quelli xenofobi, omofobi, razzisti ecc»; infine, rilevando i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, l’associazione affermava che «la famigerata professione di antifascismo […] perseguirebbe una finalità del tutto estranea a quella che deve perseguire il Comune nella sua azione amministrativa, limitata dalla legge statale ad alcune specifiche materie. Allo stesso modo, quindi, l’utilizzo delle attribuzioni amministrative per subordinare l’accesso dei cittadini alle strutture e agli spazi pubblici a tale aberrante condizione costituirebbe uno sviamento del potere amministrativo, che sarebbe utilizzato per finalità che non sono quelle sue proprie».
In primo grado i giudici amministrativi respingevano il ricorso premettendo anzitutto che il “riconoscersi nei principi e nelle norme della Costituzione italiana” e il “ripudio del fascismo” costituiscono un’endiadi, «nel senso che l’adesione ai principi e alle norme costituzionali non è scindibile rispetto al ripudio del fascismo e del nazismo»[5].
Escludevano poi la violazione del «principio di uguaglianza e dei diritti di riunione e associazione anche in partiti politici» in quanto la «dichiarazione richiesta dal Comune non pregiudica in alcun modo la costituzione dell’associazione, ma solo, eventualmente, la possibilità per la stessa di utilizzare gli spazi pubblici del Comune di Brescia».
Non vi sarebbe neanche violazione della libertà di manifestazione del pensiero in quanto l’amministrazione locale non impone una “proclamazione di pensiero” ma impone «una condizione specifica all’utilizzo da parte dei privati dei beni pubblici, rappresentata dall’impegno a non destinarli a scopi non in contrasto con la Costituzione, quali quelli propri di un soggetto che non prenda le distanze dal pensiero fascista».
Gli stessi giudici ravvisavano altresì il rispetto del principio di ragionevolezza nella scelta di «precludere l’utilizzo di beni pubblici a soggetti che non intendano "respingere decisamente" il fascismo e il nazismo e cioè due ideologie i cui ideali e principi si pongono in reciso contrasto con i valori costituzionali, tra cui, in primo luogo la libertà di pensiero e di parola».
Sarebbe rispettato anche il principio di proporzionalità in quanto la richiesta di dichiarazione è preordinata «all’acquisizione di garanzie atte ad assicurare che l’uso del bene pubblico non sia strumentale all’esercizio di attività non rispettose dei principi costituzionali e, in particolare, del divieto di ricostituzione del partita fascista e di fare propaganda filo-fascista».
Riconoscevano così la legittimità degli indirizzi in tal senso adottati dalle pubbliche amministrazioni, affinché, «nell’esercizio della discrezionalità che gli è propria, abbiano cura di evitare che i beni pubblici possano essere utilizzati per scopi non conformi alla Costituzione, a prescindere dall’innegabile e aggiuntiva possibilità di intervenire, in esito all’esercizio dell’attività di controllo, con provvedimenti dichiarativi della decadenza immediata dalla concessione nel caso di turbativa dell’ordine pubblico legata a condotte del concessionario»[6].
E, in effetti, la pubblica amministrazione ha sempre il potere «di adottare, in caso di inosservanza degli obblighi del concessionario, i provvedimenti sanzionatori previsti dalla legge […], nonché, in particolare, […] la potestà, di carattere generale, di pronunciare la revoca della concessione tutte le volte che ragioni di interesse pubblico, e in particolare ragioni istituzionali per l’ente concedente, in relazione al bene, lo esigano»[7].
Come non può limitarsi «la libertà di pensiero, che peraltro non può giustificare comportamenti contrari alla Costituzione e alla legge, nemmeno può limitarsi il potere dell’ente pubblico di perseguire l’interesse collettivo alla cui tutela è preposto, escludendo da un uso esclusivo dei beni pubblici soggetti che si facciano portatori del pensiero fascista e che per la sua tutela e diffusione potrebbero avvalersi degli stessi beni sottratti all’uso della collettività». E, in effetti, da tempo si è evidenziato che nell’amministrazione dei beni pubblici «è il demanio comunale a spiccare per l’importanza dei suoi collegamenti con i bisogni collettivi della comunità locale»[8].
Di diverso avviso i giudici amministrativi siciliani che in quegli stessi anni si sono trovati a decidere della legittimità di provvedimenti di diniego di occupazione temporanea di suolo pubblico subordinata alla dichiarazione di ripudio del fascismo. In quei casi, infatti, i giudici avevano sostenuto l’illegittimità di tali provvedimenti per lesione del c.d. diritto al silenzio laddove «impone al richiedente la concessione di suolo pubblico di effettuare affermazioni che appaiono, almeno in parte, lesive del diritto inviolabile (ai sensi dell’art. 2 Cost.) alla libertà di manifestazione del pensiero sancita dall’art. 21 Cost. nella parte in cui tutela anche la libertà di pensiero e il diritto al silenzio, cioè a non manifestare le proprie convinzioni», dal momento che «le limitazioni alla libertà di cui all’art. 21 Cost. che discendono dall’ordinamento costituzionale e, in particolare, dalla XII disp. trans. della Cost. non si riverberano sulla libertà di formazione del pensiero nel cosiddetto “foro interno”, […] in disparte ogni considerazione in ordine all’assoluta impossibilità di controllare quest’ultimo, è la connotazione pubblica della manifestazione del pensiero a delineare la rilevanza penale delle condotte tipizzate dalla legge Scelba (n. 645 del 20 giugno 1952) secondo l’interpretazione del giudice costituzionale (Corte cost. 25 novembre 1958 n. 74)»[9]. Tali considerazioni non sono condivise dalla pronuncia del Consiglio di Stato qui commentata.
2. L’attuazione del divieto della “riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista” nella concessione di spazi pubblici: la ricostruzione della giurisprudenza amministrativa
Sulla legittimità della concessione di spazi pubblici condizionata alla dichiarazione esplicita di ripudio del fascismo si era espresso in modo analogo, invece, il Tar Piemonte, Sez. II, 18 aprile 2019, n. 447 l’anno precedente, su ricorso presentato dalla stessa associazione Casa Pound, con riferimento al provvedimento del Comune di Rivoli che aveva rigettato l’istanza di occupazione temporanea di suono pubblico presentata dalla suddetta associazione.
Anche in quel caso la ricorrente aveva sostenuto che l’amministrazione locale «non può imporre ai cittadini di aderire a non meglio identificati “valori dell’antifascismo” che non sono richiamati in alcuna parte del testo costituzionale, né a “ripudiare il fascismo e il nazismo”, atteso che il ripudio attinge alla sfera interna dell’individuo, che non può essere coartata dall’amministrazione in assenza di comportamenti e manifestazioni esteriori che si pongano in contrasto con le norme costituzionali o con le leggi dello Stato»[10].
Il giudice amministrativo in quell’occasione aveva evidenziato che «i valori dell’antifascismo e della resistenza e il ripudio dell’ideologia autoritaria propria del ventennio fascista sono valori fondanti la Costituzione repubblicana del 1948» e che il «limite alla libertà di manifestazione del pensiero, di riunione e di associazione degli individui» non possono esplicarsi «in forme che denotino un concreto tentativo di raccogliere adesioni ad un progetto di ricostituzione del distolto partito fascista».
Anche in quella vicenda il giudice amministrativo aveva ritenuto non irragionevole la richiesta dell’amministrazione, nel valutare la meritevolezza del’interesse dedotto, «della dichiarazione di impegno rispetto dei valori costituzionali e, in particolare dei limiti costituzionali alla libera manifestazione del pensiero connessi al ripudio dell’ideologia autoritaria fascista nell’adesione ai valori fondanti l’assetto democratico della Repubblica italiana, quali quelli dell’antifascismo e della resistenza».
In quel caso l’associazione CasaPound aveva reso una dichiarazione diversa da quella richiesta espressamente dal Comune, omettendo «volutamente, la parte di dichiarazione relativa al ‘ripudio del fascismo e del nazismo’ e all’adesione ‘ai valori dell’antifascismo’». Tuttavia, secondo i giudici, «dichiarare di aderire ai valori della Costituzione, ma nel contempo rifiutarsi di aderire ai valori che alla Costituzione hanno dato origine e che sono ad essa sottesi, implicitamente ed esplicitamente significa vanificare il senso stesso dell’adesione, svuotandola di contenuto e privandola di ogni valenza sostanziale e simbolica». Così, anche in quel caso, il ricorso era stato respinto considerando legittimo il diniego di concessione del Comune che, «a fronte dell’assenza di un effettivo impegno della ricorrente al rispetto dei valori costituzionali dell’antifascismo, ha ritenuto insussistenti i presupposti di interesse pubblico per la concessione di spazi pubblici per finalità private di propaganda politica».
Tale impostazione è ripresa dal Consiglio di Stato nella pronuncia qui commentata che – nel rigettare il ricorso presentato dall’associazione Casa Pound per la riforma della sentenza del Tar Lombardia sopra ampiamente richiamata – ha anzitutto ricordato l’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui la concessione di spazi pubblici, in quanto comporta un utilizzo a fini privati di aree o locali che vengono sottratti all’uso comune, «è espressione di una potestà ampiamente discrezionale, sia nell’an, sia nella definizione di tempi, modi e condizioni dell’occupazione»[11].
Sicché – afferma il Consiglio di Stato – nell’esercizio del potere comunale di stabilire i criteri per l’occupazione di spazi pubblici «l’amministrazione ben può perseguire l’obiettivo di evitare che essi vengano utilizzati per il perseguimento delle finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, ovvero per la pubblica esaltazione di esponenti, principi, fatti, metodi e finalità antidemocratiche del fascismo - comprese le idee e i metodi razzisti - o ancora per il compimento di manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste».
Trattasi, secondo i giudici, di un «obiettivo di sicuro interesse pubblico, alla luce di quella che la Corte costituzionale ha definito ‘l’ispirazione antifascista nella nostra Costituzione’[12]». La riconosciuta ‘matrice antifascista’ della Costituzione repubblicana emergerebbe sia dalla sua genesi sia «soprattutto dalla sua struttura e dal contenuto», attesa la discontinuità delle norme e dei principi costituzionali rispetto a quelli del regime precedente[13], in questo senso il primo comma della XII disposizione non è da intendersi come norma meramente “transitoria”, come ampiamente sostenuto dalla dottrina e giurisprudenza[14]. Secondo la ricostruzione argomentativa dei giudici di secondo grado, la XII disposizione – in deroga all’art. 49 cost. che riconosce il diritto di tutti i cittadini di associarsi liberamente in partititi, nonché degli artt. 17 e 21 Cost. che sanciscono la libertà di riunione e di manifestazione del pensiero – è volta a «scongiurare un ritorno ‘sotto qualsiasi forma’ del fascismo, che segnerebbe la fine dell’esperienza democratica con essa iniziata e il disconoscimento dei diritti e delle libertà che le sono proprie». E a tale previsione ha inteso dare attuazione il legislatore anzitutto con la legge del 20 giugno 1952, n. 645 (c.d. legge Scelba), seppure – come già ricordato dal giudice amministrativo – senza voler offrire un’attuazione limitata alla repressione penale, poiché questa «va estesa ad ogni atto fatto che possa favorire la riorganizzazione del partito fascista»[15].
Proprio considerando tale finalità nella pronuncia qui commentata i giudici hanno affermato che «l’obbligo posto dalla giunta del Comune di Brescia non può dirsi sproporzionato» […] e «anche la parte di dichiarazione contestata dall’associazione appellante – lungi dal rappresentare una sorta di ‘professione di fede’ o un giuramento di fedeltà fine a sè stessi – debba intendersi come strettamente correlata all’uso dello spazio pubblico di cui si chiede la concessione, fondandosi sulla presunzione non irragionevole che chi si rifiuti di ripudiare il fascismo, e quindi mantenga un legame con quell’esperienza, possa poi utilizzare quello spazio per perseguire finalità antidemocratiche».
Il ricorso è perciò respinto condividendo gli argomenti dei giudici di prime cure e riportando espressamente quello secondo cui: «se non può essere limitata la libertà di pensiero, che peraltro non può giustificare comportamenti contrari alla Costituzione e alla legge, nemmeno può limitarsi il potere dell’ente pubblico di perseguire l’interesse collettivo alla cui tutela è preposto escludendo da un uso esclusivo dei beni pubblici soggetti che si facciano portatori del pensiero fascista e che per la sua tutela e diffusione potrebbero valersi degli stessi beni sottratti all’uso della collettività».
Proprio con riferimento alla libertà di manifestazione del pensiero si è parlato in dottrina di «limite ideologico del neofascismo» contenuto nella XII Disposizione che sarebbe perciò tesa a «spogliare l’ideologia neofascista dalla garanzia costituzionale delle libertà»; in tal senso, più in generale, la Costituzione «intende chiaramente vietare non solo gli atti conclusivi di ricostituzione del partito fascista, ma anche tutti i comportamenti idonei a porne le premesse, attraverso l’istaurazione di un clima favorevole»[16].
3. Cenni conclusivi sulla pubblica amministrazione nell’‘l’ispirazione antifascista nella nostra Costituzione’.
Con la sentenza qui commentata, il Consiglio di Stato – riprendendo gli argomenti del giudice di prime cure e dei precedenti conformi qui richiamati – offre interessanti spunti di riflessione non solo sull’attuazione del divieto della «riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista» nell’attività amministrativa della concessione di spazi pubblici, ma più in generale sul ruolo della pubblica amministrazione nell’ ‘ispirazione antifascista della nostra Costituzione’.
La pubblica amministrazione è stata messa alla prova dalla matrice antifascista della Costituzione italiana anche in altre occasioni e in ambiti diversi dell’azione amministrativa.
Nelle competizioni elettorali locali, infatti, alcune associazioni politiche sono state escluse dalle commissioni elettorali circondariali in diversi Comuni sul territorio nazionale proprio in ragione della loro ispirazione al disciolto partita fascista. Non a caso il contenzioso sul punto è richiamato nella pronuncia che qui si commenta.
Con rifermento a quelle vicende la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che non è ammissibile che «un raggruppamento politico partecipi alla competizione elettorale sotto un contrassegno che si richiama esplicitamente al partito fascista bandito irrevocabilmente dalla Costituzione con norma tanto più grave e severa, in quanto eccezionalmente derogatorio al principio supremo della pluralità, libertà e parità delle tendenze politiche»[17].
Si è affermato che «un movimento politico che si ispira ai principi del disciolto partito fascista deve essere incondizionatamente bandito dalla competizione elettorale, secondo quanto impone la XII esposizione transitoria e finale della Costituzione, il cui precetto sul piano letterale ideologico non può essere applicato solo alla repressione di condotte finalizzate alla ricostruzione di un’associazione vietata […] ma deve essere esteso ad ogni atto o fatto che possa favorire la riorganizzazione del partito fascista, per sua essenza stessa antidemocratico, e quindi anche al riferimento inequivoco ai suoi principi fondanti, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 645 del 1952»[18].
Nel tempo si è ribadito che «il diritto di associarsi in un partito politico, sancito dall’arte. 49 Cost., e quello di accesso alle cariche elettive, ex art.51 Cost., trovano un limite nel divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista imposto dalla XII disposizione transitoria finale della Costituzione. Detto precetto costituzionale, fissando un’impossibilità giuridica assoluta e incondizionata, impedisce che un movimento politico formatosi e operante in violazione di tale divieto possa in qualsiasi forma partecipare alla vita politica e condizionarne le libere democratiche dinamiche. […] l’attuazione di tale precetto, sul piano letterale come sul versante teologico, non può essere limitata alla repressione penale delle condotte finalizzata alla ricostituzione di un’associazione vietata, [ma] deve essere estesa ad ogni atto fatto che possa favorire la riorganizzazione del partito fascista»[19]; si riconosce così il potere della commissione di ricusare la lista o i simboli attraverso i quali si persegue il fine originariamente vietato dall’ordinamento.
Sia nel caso della concessione di spazi pubblici, sia nell’ammissione alle competizioni elettorali l’esercizio di libertà e diritti dei privati richiede l’esercizio del potere della pubblica amministrazione. Si tratta di un ambito di applicazione della XII Disposizione costituzionale che si distingue da quello che di recente ha visto l’intervento della giurisprudenza penale con riferimento al divieto di utilizzo di simboli e del cosiddetto saluto romano[20].
La sentenza del Consiglio di Stato qui commentata offre un’articolata e chiara ricostruzione del fondamento e dei contenuti del potere della pubblica amministrazione di prevedere una dichiarazione di ripudio del fascismo nel rilascio della concessione di spazi pubblici con l’obiettivo di evitare che gli stessi siano «utilizzati per il perseguimento delle finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, ovvero per la pubblica esaltazione di esponenti, principi, fatti, metodi e finalità antidemocratiche del fascismo – comprese le idee e i metodi razzisti – o ancora per il compimento di manifestazioni usuali del distorto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste». Sarebbe proprio questo – si è detto – l’«obiettivo di sicuro interesse pubblico, alla luce di quella che la Corte costituzionale ha definito ‘l’ispirazione antifascista della nostra costituzione’»[21].
È qui di interesse ricordare che secondo la Corte costituzionale la XII Disposizione della Costituzione repubblicana «ha conferito in modo tassativo al legislatore non solo la potestà-dovere di fissare sanzioni penali in casi di violazione del divieto costituzionale di ricostituzione del disciolto partito fascista, ma anche di ricercare il modo e le forme più idonei e più incisivi per la realizzazione della pretesa punitiva nella salvaguardia dei diritti fondamentali che la costituzione riconosce a tutti i cittadini, al fine di combattere più efficacemente e sollecitamente possibile quel pericolo che la citata disposizione, in accordo con l’ispirazione antifascista della nostra costituzione è inteso direttamente imperativamente prevenire».
La legislazione penale si è fatta nel tempo interprete dell’obiettivo costituzionale del ripudio del fascismo e «il legislatore ha compreso che la riorganizzazione del partito fascista può anche essere stimolata da manifestazioni pubbliche capaci di impressionare le folle»[22].
In linea con tale orientamento si è in seguito affermato che «non può sostenersi la illegittimità costituzionale di una norma legislativa che attui il disposto della XII disposizione transitoria, la quale, in vista della realizzazione di un ben determinato scopo, pone limiti all’esercizio dei diritti di libertà enunciati dagli evocati precetti costituzionali»[23].
Va detto che il contenuto del comma 1 delle XII Disposizioni fin dal dibattito in Assemblea costituente è stato lungi dall’essere pacificamente interpretato come norma “transitoria”[24].
E il carattere “finale”, e non meramente transitorio, del “divieto di riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista” (comma 1 della XII Disposizione) – oggi generalmente riconosciuto – è riconducibile al suo legame con l’art. 54 comma 1 Cost. secondo cui “tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica “e l’art. 139 Cost. che sottrae alla revisione costituzionale la forma repubblicana[25]. In tale prospettiva la c.d. legge Scelba avrebbe fornito al bene giuridico dell’“ordine pubblico democratico e costituzionale” una tutela anticipata[26]. Sicché l’attuazione di tale precetto – lungi dal limitarsi alla repressione penale che richiede il pericolo concreto d di ricostituzione del partito fascista[27] – come già ricordato dalla giurisprudenza amministrativa, «deve essere estesa ad ogni atto o fatto che possa favorire la riorganizzazione del partito fascista»[28], facendo così della pubblica amministrazione un importante “strumento di attuazione”.
Come ricordato dai giudici di prime cure nella vicenda qui commentata non sarebbe «in questione […] la rilevanza penale di condotte riconducibili alla connotazione pubblica della manifestazione del pensiero, bensì il significato da attribuire al “silenzio” che l’associazione ricorrente vorrebbe serbare sul tema, rifiutandosi di sottoscrivere le dichiarazioni richieste dall’atto di indirizzo del Comune di Brescia. In buona sostanza, con tale provvedimento non si richiedono né abiure, né professioni di fede che non si traducano nella mera riaffermazione dei valori fondanti della Carta costituzionale e del nostro Ordinamento»[29].
Sulla questione dell’attuazione della XII Disposizione, ancora oggi attuale, si è di recente ricordata l’idea che «se la democrazia muore nel cuore del popolo, nessuna forza giuridica potrà farla resuscitare»[30].
Non c’è dubbio che né le leggi (né l’azione dell’amministrazione) possano di per sé sole proteggere la democrazia e, tuttavia, proprio la «perdurante esigenza di garanzia antifascista», che è stata ricondotta a una «sorta di disattuazione strisciante»[31] della XII Disposizione, sembra imporre estrema attenzione alla compiuta attuazione della previsione del divieto della “riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista”.
Di interesse sarebbe perciò lo studio del ruolo della pubblica amministrazione, in generale, nell’‘l’ispirazione antifascista nella nostra Costituzione’.
La questione dell’attuazione delle XII disposizioni finali da parte della pubblica amministrazione nella specifica attività di concessione di spazi pubblici assume certo contorni differenti rispetto a quelli della legislazione penale, forse meno “problematici” con riferimento alla limitazione della libertà di manifestazione del pensiero; in tali casi l’obbligo di dichiarare il ripudio del fascismo, imposto come condizione della concessione di spazi pubblici da parte della amministrazione locale, non pone luna imitazione della libertà di manifestazione del pensiero che, in caso di diniego, può essere esercitata su spazi privati entro i limiti della legislazione penale.
Proprio alla luce della ricostruzione offerta dalla giurisprudenza amministrativa richiamata, ci si chiede se non sia ultroneo, se non addirittura fuorviante, considerando ‘l’ispirazione antifascista della nostra Costituzione’, qualificare come ampiamente discrezionale l’esercizio del potere della pubblica amministrazione che si sostanzia nel condizionare la concessione di spazi pubblici alla dichiarazione di ripudio del fascismo.
In tale prospettiva, ragionando sul ruolo della pubblica amministrazione nel garantire l’effettiva attuazione del comma 1 delle XII Disposizioni, subordinare la concessione di spazi pubblici alla dichiarazione di ripudio del fascismo sembra piuttosto espressione di una discrezionalità della pubblica amministrazione necessariamente orientata dall' "ispirazione antifascista della nostra Costituzione".
[1] La delibera richiama espressamente sia la legge 20 giugno 1952, n. 645 (c.d. legge Scelba) sia l’art. 1 del d. l. 26 aprile 1993, n. 122, conv. con mod. in legge 25 giugno 1993.
[2] Nella premessa della deliberazione si rileva che “alcuni Comuni, sulla scorta di recenti episodi e manifestazioni che hanno inneggiato o propagandato ideologie naziste, fasciste e/o razziste, hanno approvato o si stanno attivando per approvare un atto di indirizzo al fine di ottenere uno specifico impegno al rispetto dei principi fondamentali contenuti nella Costituzione italiana per quanto concerne l’utilizzo di spazi ed aree pubbliche”.
[3] Per una ricostruzione della vicenda che ha portato all’ordinanza cautelare del Tar Brescia, 8 febbraio 2018, n. 68 e alle delibere dei Comuni sopra richiamati si rinvia a F. Paruzzo, Il Tar Brescia rigetta il ricorso di CasaPound: l’antifascismo come matrice e fondamento della Costituzione, in Osservatorio costituzionale, AIC, fasc. 2/2018, pp. 2 ss.
[4] Cit. virgolettato estratto dal ricorso, come riportato nel testo del Tar Lombardia, sez. II, Brescia, 26 gennaio 2020, n. 166.
[5] Tar Lombardia, sez. II, Brescia, 26 gennaio 2020, n. 166: «la deliberazione censurata, nella sua formulazione integrale, richiede agli interessati di dichiarare di “riconoscersi nei principi e nelle norme della Costituzione italiana e di ripudiare il fascismo e il nazismo”, facendo ricorso, nella sostanza, a una vera e propria endiadi, nel senso che l’adesione ai principi e alle norme costituzionali non è scindibile rispetto al ripudio del fascismo e del nazismo».
[6] E. Silvestri, voce Concessione, I. Concessione amministrativa, in Enc. dir., vol. VIII, 1961, p. 370, osserva che «le concessioni amministrative sono espressione di una potestà pubblica e tendono quindi al conseguimento di fini pubblici».
[7] Cit. A. M. Sandulli, voce Beni Pubblici, in Enc. dir., vol. V, Milano, 1959, p. 290; in generale, sul rapporto tra “Concessione, potere pubblico e interesse pubblico” F. Fracchia, voce Concessione amministrativa, in Enc. dir., Annali I, 2007, p. 267 ss.
[8] V. Caputi Jambrenghi, I beni pubblici e d’interesse pubblico, in Diritto amministrativo, a cura di L. Mazzarolli, G. Pericu, A. Romano, F. A. Roversi Monaco, F. G. Scoca, Bologna, 1993, II ed., p. 1126.
[9] Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, sez. giur., ordinanza, 13 dicembre 2019, n. 797; poi anche Tar Sicilia, sez. I, 15 aprile 2021, n. 1241.
[10] Cit. virgolettato estratto dal ricorso, come riportato nel testo del Tar Piemonte, Sez. II, 18 aprile 2019, n. 447.
[11] Ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. V, 2 dicembre 2015, n. 5442; Consiglio di Stato, Sez. quinta, 7 giugno 2022, n. 4660; Consiglio di Stato, Sez. V, 8 maggio 2024, n. 4129. L’occupazione di suolo pubblico da parte di privati comporta la sottrazione di spazi pubblici all’uso comune coinvolgerebbe l’amministrazione non solo nella «mera scelta delle aree da occupare, ma anche nella scelta della dimensione, dei tempi e dei modi dell’occupazione, nonché nella previsione delle restrizioni delle forme di temperamento ritenute, di volta in volta, opportune dal punto di vista viabilistico, urbanistico, architettonico, paesaggistico, al fine di bilanciare la pluralità di interessi coinvolti», cit. Cons. St. n. 4129 del 2024.
[12] In questi termini espressamente Corte cost., sent. n. 254 del 1974.
[13] I giudici amministrativi – nella sentenza commentata – argomentano che «in questo senso il primo comma della XII disposizione – che non è da intendersi come norma meramente “transitoria” – sarebbe legata sia all’art. 54 comma 1 Cost che recita: “tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica”, sia all’articolo 139 Cost. che esclude la possibilità di revisione costituzionale per la “forma repubblicana”». Sula “continuità degli ordinamenti statutario, fascista e repubblicano” dedica interessanti passaggi L. Paladin, voce Fascismo (dir. cost.), in Enc. dir., vol. XVI, 1967, p. 887, 888.
[14] Cfr. Tar Lombardia, sez. II, Brescia, 26 gennaio 2020, n. 166, come ripreso espressamente da Cons. Stato, Sez. II, 19 settembre 2024, n. 7687.
[15] Cons. Stato, sez. V, 6 marzo 2013, n. 1354, così potendo la commissione elettorale circondariale esercitare un potere di ricusazione ed estromissione dalla competizione di quelle liste o simboli che si rifanno specificatamente al partito fascista «bandito irrevocabilmente dalla Costituzione».
[16] Cit. P. Barile, voce Libertà di manifestazione del pensiero, in Enc. dir., vol. XXIII, Milano, 1973, p. 470; sull’art. 21 Cost. M. Manetti, A. Pace, Art. 21. La libertà di manifestazione del pensiero, in G. Branca, A. Pizzorusso (a cura di), Commentario della Costituzione, Bologna, 2006, p. 212; la qualifica come “libertà funzionale” C. Esposito, La libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento democratico, Milano, 1958, p. 3.
[17] Cfr. Cons. Stato, Sez. I, 23 febbraio 1994, n. 173; Cons. Stato, Sez. V, 6 marzo 2013 n. 1355; Cons. Stato, Sez. III, 29 maggio 2018, n. 3208.
[18] Cfr. Cons. Stato, Sez. III, 29 maggio 2018, n. 3208; già Cons. Stato, sez. V, 6 marzo 2013, n. 1354.
[19] Cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 marzo 2013, n. 1354, dove si dice altresì che la disciplina costituzionale «dettando un requisito originario per la partecipazione alla vita politica, fonda il potere implicito della commissione di ricusare le liste che si pongano in contrasto con diritto precetto».
[20] Cass. Pen. SS. UU., sent. 17 aprile 2024, n. 16153.
[21] In questi termini, Corte cost., sent., n. 254 del 1974, richiamata nella pronuncia qui commentata.
[22] Corte cost., sent. n. 74 del 1958.
[23] Corte cost., sent. n. 15 del 1973. Sulle manifestazioni usuali del disciolto partito fascista, in una prospettiva penalistica, si rinvia a P. Caroli, Il potere di non punire, Uno studio sull’amnistia Togliatti, Napoli, 2020, p. 278 ss.
[24] Alla seduta del 4 marzo 1947 dell’Assemblea costituente l’intervento di Calamandrei aveva già evidenziato il carattere non transitorio di questa disposizione: «Non so perché questa disposizione sia stata messa fra le transitorie: evidentemente può essere transitorio il nome “fascismo”, ma voi capite che non si troveranno certamente partiti che siano così ingenui da adottare di nuovo pubblicamente il nome fascista per farsi sciogliere dalla polizia. Se questa disposizione deve avere un significato, essa deve esser collocata non tra le disposizioni transitorie, e non deve limitarsi a proibire un nome, ma deve definire che cosa c'è sotto quel nome, quali sono i caratteri che un partito deve avere per non cadere sotto quella denominazione e per corrispondere invece ai requisiti che i partiti devono avere in una Costituzione democratica. […]».
[25] La pronuncia qui commentata evidenzia che «il primo comma della XII disposizione, che vieta “la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista”, non può ritenersi meramente ‘transitoria’, ossia destinata a trovare applicazione per un periodo di tempo determinato (com’è, per esempio, il secondo comma), ma, come osservato anche in letteratura, è norma ‘finale’, in quanto, legandosi all’art. 54, co. 1, Cost. secondo cui “tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica” e all’art. 139 Cost., che sottrae alla revisione costituzionale “la forma repubblicana” (secondo Corte cost., sent. n. 1146 del 1988, da intendersi comprensiva di tutti quei principi che “appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione Italiana” e quindi innanzitutto dei ‘diritti inviolabili’, su cui si v., tra le più recenti, Corte cost., sent. n. 135 del 2024), rifinisce il disegno costituzionale ponendo una clausola di salvaguardia che in deroga all’art. 49 Cost., che riconosce il diritto di tutti i cittadini di associarsi liberamente in partiti, nonché agli artt. 17 e 21 che sanciscono le libertà di riunione e di manifestazione del pensiero (sul punto si v. Corte cost., sentt. n. 74 de 1958 e n. 15 del 1973) – è volta a scongiurare un ritorno “sotto qualsiasi forma” del fascismo, che segnerebbe la fine dell’esperienza democratica con essa iniziata e il disconoscimento dei diritti e delle libertà che le sono propri».
[26] Da ultimo Cass. Pen. SS. UU., sent. 17 aprile 2024, n. 16153.
[27] Cfr. Corte cost., sent. n. 15 del 1973; Cass. Pen. SS. UU., sent. 17 aprile 2024, n. 16153.
[28] Cons. Stato, sez. V, 6 marzo 2013, n. 1354.
[29] In questi termini già Tar Lombardia, sez. II, Brescia, 26 gennaio 2020, n. 166, poi ripresa dal Consiglio di Stato qui commentato.
[30] Cit. P. Barile, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Bologna, 1984, p. 413; di recente richiamato nelle sue osservazioni conclusive da F. Paruzzo, La XII Disposizione transitoria e finale: tra garanzia “antirazzista” della legge Mancino e specificità della matrice antifascista, in Rivista AIC, fasc. 3/2024, p. 131.
[31] B. Pezzini, Attualità e attuazione della XII Disposizione finale: la matrice antifascista della Costituzione repubblicana, in AA. VV., Le frontiere del Diritto costituzionale. Scritti in onore di V. Onida, Milano, 2011, p. 1402. Parla di «poche occasioni pratiche di applicazione» P. Barile, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, cit., 411.

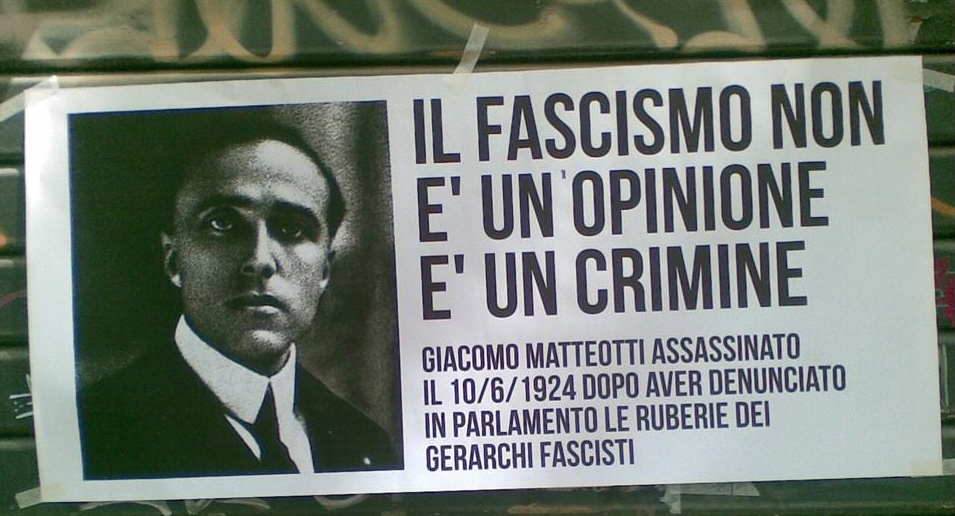

 E poi Aggiungi alla schermata principale.
E poi Aggiungi alla schermata principale.