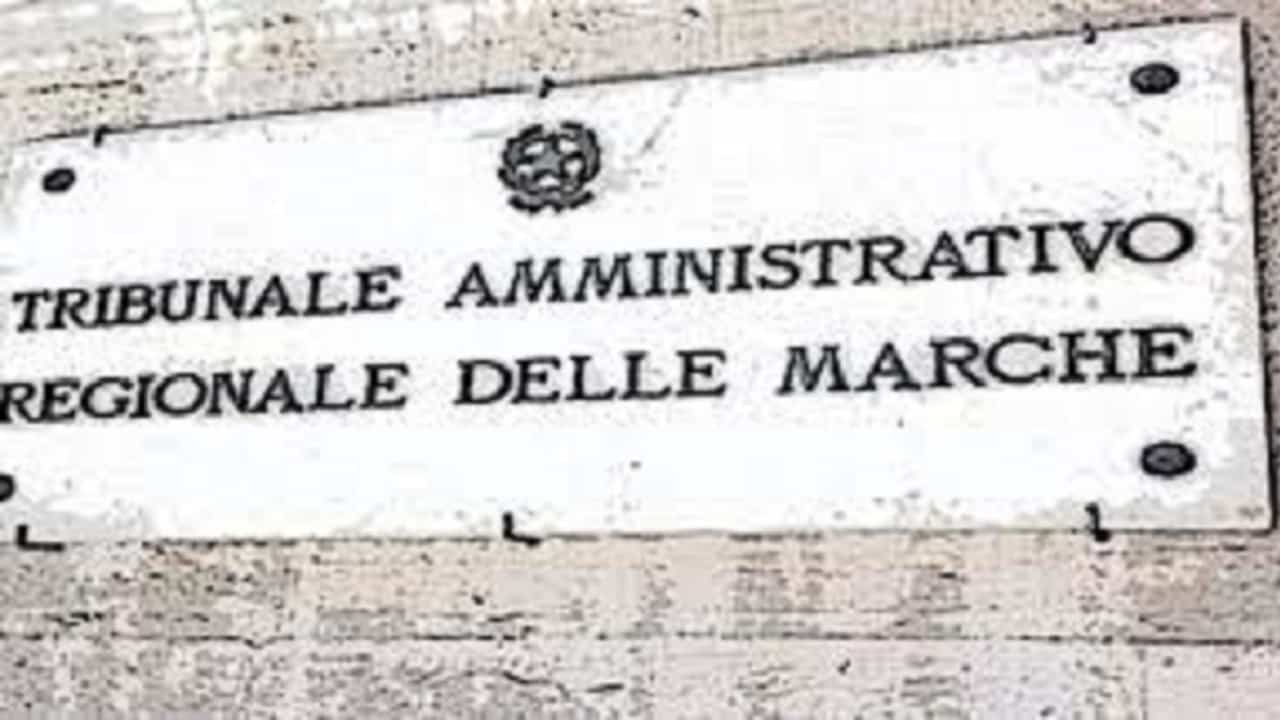Giudizio di ottemperanza nei confronti di comune in stato di dissesto (nota a T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 13 novembre 2024, n. 3777)
di Vinicio Brigante
Sommario: 1. Il dissesto degli enti locali. Un osservatorio privilegiato di studio. - 2. Il caso di studio. Poste debitorie degli enti locali e giudizio di ottemperanza. - 3. Cause ed effetti del dissesto degli enti locali. Effettività dei diritti e risanamento dell’ente locale. - 3.1 I costi della gestione del governo del territorio per le casse degli enti locali. L’incidenza dei procedimenti espropriativi. - 3.2 Profili di ammissibilità del giudizio di ottemperanza nei confronti di un ente locale in dissesto. - 4. Riflessioni conclusive. Autonomia, diritti e territori
1. Il dissesto degli enti locali. Un osservatorio privilegiato di studio
Il tema del dissesto degli enti locali e delle innumerevoli questioni allo stesso collegate rappresentano un osservatorio ideale per lo studio delle questioni che interessano la pubblica amministrazione e la tenuta dei diversi istituti[1]. Si tratta di un ambito regolatorio oggetto, solo negli ultimi mesi, di una sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione[2]e di una questione di legittimità costituzionale pendente, sollevata da un tribunale amministrativo regionale[3], per sottolineare la centralità e la carica problematica che lo stesso ricopre nel contesto delle dinamiche istituzionali contemporanee.
L’intero impianto normativo in materia di procedure di risanamento e, più in generale, la disciplina che riguarda gli enti deficitari o dissestati, è contenuto nel titolo VIII del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il «Testo Unico degli Enti Locali» (TUEL), testo adottato per un proposito e un’esigenza, generalmente avvertita, di conferire e assicurare organicità e certezza all’organizzazione delle amministrazioni comunali, anche nelle ipotesi in cui le stesse si trovino in una condizione di sofferenza finanziaria; obiettivi che le successive riforme, non hanno sempre garantito, e che talvolta hanno palesemente tradito.
Si tratta di un sistema che si basa su una progressione graduale e crescente del livello di criticità finanziaria.
La natura polisemica del concetto stesso di crisi finanziaria, declinata in stato deficitario o di dissesto dal legislatore qualora la stessa sia riferita agli enti locali, consente di confrontare risultati teorici ed empirici, canoni interpretativi e una serie eterogenea di questioni connesse che possono assurgere a campo di osservazione ideale per la verifica della tenuta delle soluzioni interpretative seguite.
Il dissesto, che si configura ex art. 244 del TUEL nell’ipotesi in cui l’ente non sia in grado di assolvere alle funzioni e di erogare i servizi indispensabili[4] - il c.d. dissesto funzionale - rappresenta, come noto, la forma più grave in cui può manifestarsi la crisi finanziaria di un’amministrazione[5].
Si tratta di una condizione nella quale l’ente locale riesce a “mala pena a gestire l’ordinario e lo fa solo mediante l’ausilio delle anticipazioni di liquidità e proprio il ricorso sistematico a tale strumento porta a considerare la perdurante sofferenza di liquidità non più come frutto di un mero disallineamento temporale tra incassi e pagamenti quanto, piuttosto, come la patologica manifestazione finanziaria di reiterati ed evidenti squilibri[6]”.
La dichiarazione di dissesto - che non rappresenta, almeno tendenzialmente, una scelta discrezionale dell’ente ma è una determinazione vincolata e ineludibile[7] - equivale a una dichiarazione di insolvenza che pone l’ente stesso in una condizione di limitata capacità di agire e conduce a una, seppur parziale, delegittimazione degli organi[8], poiché l’attività dell’amministrazione è, in parte, affidata alla gestione di un organo straordinario, distinto dagli organi istituzionali ordinari[9].
Il legislatore - sin dal d.l. 25 febbraio 1995, n. 77 - ha preso atto della necessità di regolare la vicenda peculiare della crisi finanziaria dell’ente locale attraverso la previsione della presenza di altri soggetti e di (ri)attribuire, in seguito alla dichiarazione di dissesto, il potere in un’ottica funzionale al risanamento, con una scelta che incide sensibilmente sulla capacità di agire della persona giuridica pubblica, intesa come amministrazione ordinaria[10].
In quest’ottica, l’organo straordinario di liquidazione deve provvedere al risanamento dell’indebitamento pregresso, una precisa scelta, che vincola l’attribuzione del potere - o, se si vuole, comporta la privazione dello stesso in capo all’amministrazione ordinaria - al profilo temporale, poiché l’ambito oggettivo sul quale insiste il potere è rappresentato da tutte le conseguenze derivanti dalle operazioni di gestione che hanno dato origine e hanno determinato l’ammontare dei debiti che hanno condotto al dissesto[11].
Lo stato di dissesto comporta, tra gli altri, il divieto di spesa per l’ente e, di conseguenza, da ciò dovrebbe desumersi il divieto di agire in ottemperanza in ordine a obblighi specifici di dare o di fare.
Già nella vigenza della previgente normativa in tema di dissesto degli enti locali - il d.l. 2 marzo 1989, n. 66 - la deliberazione di dissesto comportava la sospensione delle azioni esecutive dei creditori nei confronti dell’ente, anche se la tendenza della giurisprudenza amministrativa dell’epoca si dirigeva nel senso di accogliere, in ogni caso, proprio il ricorso per ottemperanza in danno del comune in stato di dissesto; l’approvazione del piano di risanamento finanziario comportava la sospensione delle sole azioni esecutive promosse solo secondo le norme del codice di procedura civile[12], fino alla riforma del 1993[13], che prevedeva espressamente che vi fosse inammissibilità dell’azione anche in occasione di un giudizio di ottemperanza[14].
Si tratta di un profilo delicato, nel quale i principi e gli interessi che si confrontano sono diversi e gli inevitabili conflitti tra posizioni antagoniste impongono da rifuggire da soluzioni rigide, poiché si tratta della garanzia dei diritti dei cittadini e dei vincoli economici che sugli stessi, a vario titolo, gravano.
Potrebbe qualificarsi la vicenda a partire da una ridefinizione dello stesso concetto di territorio, vincolato ai confini dell’ente locale, che è condizionato da pesi economici e debiti, poiché lo stesso non sembra, almeno per il tema in esame, idoneo a qualificare gli interessi economici legittimati ad entrarvi in rapporto[15].
2. Il caso di studio. Poste debitorie degli enti locali e giudizio di ottemperanza
Giova, al fine di apprezzare le asperità del tema e individuare gli incerti confini dell’attività di fare che comportano, anche indirettamente, un costo per l’amministrazione in stato di difficoltà finanziaria, ricostruire la vicenda in esame che ha interessato il comune di Taormina.
Il ricorrente chiedeva al giudice amministrativo di accertare l’illegittimità, invalidità o inefficacia, nonché per l’eventuale disapplicazione, degli atti amministrativi sulla base dei quali l’amministrazione aveva occupato e realizzato un’opera sul fondo di proprietà dello stesso privato ricorrente.
Il tribunale amministrativo regionale accoglieva il ricorso, disponendo, contestualmente, che l’ente intimato provvedesse alla restituzione o all’acquisizione dell’immobile del ricorrente, con le determinazioni conseguenti, con conseguente condanna in capo all’amministrazione locale del pagamento delle spese di giudizio, circostanza che avrebbe, peraltro, comportato un peggioramento della situazione finanziaria dell’ente.
L’amministrazione, nonostante il decorso del termine, non provvedeva all’esecuzione del dictum della sentenza di prime cure, e, persistendo nell’inadempimento, induceva la ricorrente a proporre ricorso per ottenere l’ottemperanza.
Si desumevano, però, possibili profili di parziale inammissibilità del ricorso, limitatamente alla statuizione sul capo della sentenza proprio relativo al peso economico che sarebbe gravato sull’amministrazione condannata, in considerazione dello stato di dissesto.
Si intimava al comune di restituire i terreni illegittimamente occupati, previa riduzione in pristino stato, con la previsione del risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima o provvedere, in alternativa, all’acquisizione dell’immobile mediante valido titolo di acquisto.
Si osservava che la procedura espropriativa non era portata a termine proprio per mancanza di copertura finanziaria, ulteriore circostanza che aveva indotto l’ente comunale a dichiarare lo stato di dissesto. Il ricorso disinvolto alle procedure espropriative, anche oltre le reali esigenze, con un peggioramento delle condizioni dell’amministrazione, ha rappresentato, per anni, una prassi diffusa.
Il ricorso per l’ottemperanza era dichiarato, almeno in parte inammissibile, e doveva essere accolto per la restante parte nel rispetto di alcuni limiti.
Come affermato da diversi arresti pretori, il ricorso per ottemperanza è generalmente ammissibile, anche qualora l’ente versi in stato di dissesto, nelle ipotesi in cui l’amministrazione debba, in forza di una sentenza, esercitare un “potere di natura discrezionale non riducibile alla mera liquidazione di crediti di natura patrimoniale derivanti o meno da titolo giudiziario[16]”.
Per contro, ove sia in contestazione l’obbligo di emanazione dell’atto amministrativo - in questa ipotesi, peraltro ricorrente, nelle ipotesi di squilibrio finanziario dell’ente locale, si tratta del decreto di esproprio[17] - che contempli il titolo di spesa, la competenza amministrativa e contabile resterebbe saldamente ancorata in capo all’organo straordinario per il divieto generale di esecuzione individuale e in forza del principio della par condicio creditorum.
La conclusione non si pone in termini contrari rispetto alle conclusioni cui è pervenuta la Adunanza Plenaria, con la sentenza 5 agosto 2020, n. 15, la quale stabilisce che il provvedimento di acquisizione sanante, genetico dell’obbligazione e, quindi, del debito è attratto necessariamente nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione, qualora lo stesso sia adottato entro il termine di approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria.
La vicenda indagata ha ad oggetto un giudizio di ottemperanza che insiste su determinati effetti patrimoniali, di competenza dell’organismo di liquidazione stante lo stato di dissesto, che sarebbero solo conseguenziali alle scelte, non ancora compiute, ma residue in capo all’ente locale, nella sua composizione ordinaria.
La tesi sostenuta va nella direzione di ritenere che il giudizio di ottemperanza, finanche nei confronti di un ente in dissesto, nei confronti del quale sarebbero precluse azioni creditorie a carattere esecutivo, è ammissibile nei limiti della coercizione di obblighi derivanti dal giudicato, che impongano però l’esercizio di attività amministrativa, non riducibile alla mera liquidazione di un credito di natura pecuniaria o, come nel caso di specie, che impongano principalmente obblighi di fare, come l’obbligo di restituzione o, in alternativa, l’acquisizione dell’immobile mediante valido titolo di acquisto ovvero tramite la procedura disciplinata dall’art. 42 bis del Testo Unico sulle espropriazioni per pubblica utilità[18].
Dalla sentenza ottemperanda non discende un dovere, in termini di attività vincolata, di emanazione dell’atto di acquisizione sanante, con ciò che ne consegue in termini di situazione debitoria, poiché in capo all’amministrazione residua un potere discrezionale di scelta tra la restituzione e l’acquisizione del suolo appreso illegittimamente, peraltro proprio in ragione della deficitaria situazione finanziaria che aveva impedito di completare il procedimento ablatorio reale; da tale scelta sarebbero dipese conseguenze diverse per le casse dell’ente locale.
L’organo straordinario di liquidazione è competente solo in seguito alla decisione discrezionale[19] - che, nel caso di specie è rappresentata dalla scelta tra restituzione e acquisizione - cui l’amministrazione non aveva ancora provveduto e dalla quale sarebbero dipese la natura e l’entità delle obbligazioni, di facere e di dare, rimesse alla competenza dell’organo straordinario.
D’altronde, anche in base a una lettura sistemica delle scelte legislative in tema di regolazione dello stato di dissesto degli enti locali, l’organo straordinario di liquidazione, per sua natura, non può esprimere valutazioni caratterizzate da discrezionalità, ma scelte di natura tecnico-contabile[20] ispirate all’obiettivo del rientro dal debito.
L’amministrazione, non avendo ancora svolto l’attività imposta dal giudicato, era da ritenersi inottemperante.
Per altro verso, il Collegio ritiene insussistenti i presupposti di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) del codice del processo amministrativo per l’accoglimento dell’istanza di fissazione della penalità di mora, posto che la sopra richiamata disposizione esclude l’applicazione della c.d. astreinte[21] nel caso in cui la stessa debba ritenersi “manifestamente” iniqua ovvero sussistano ulteriori “ragioni ostative”, coincidenti in questo caso con la non risalente formazione del titolo in epigrafe e, per quanto di interesse, con la peculiare condizione di dissesto del Comune intimato.
Da ultimo, sempre nella prospettiva dello stato di decozione finanziaria dell’ente, il ricorso è da ritenersi inammissibile nella parte in cui si chiede l’esecuzione del dictum per la condanna dell’ente al pagamento delle spese di lite, poiché, per interpretazione pressoché unanime, rispetto alla suddivisione di competenze tra amministrazione ordinarie e organo straordinario, rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione non solo le poste passive pecuniarie già contabilizzate alla data della dichiarazione di dissesto, ma anche tutte le svariate obbligazioni che, pur se stricto jure sorte in seguito, costituiscano comunque la conseguenza diretta ed immediata di “atti e fatti di gestione” pregressi alla dichiarazione di dissesto” e, nel caso di specie, la condanna al pagamento delle spese di lite rappresenta un’obbligazione che, per se stricto jure sorta in seguito, proprio con la sentenza, rinviene la genesi in un fatto - si potrebbe discorrere, più compiutamente, di comportamento[22] - precedente, cioè l’occupazione illegittima del terreno.
3. Cause ed effetti del dissesto degli enti locali. Effettività dei diritti e risanamento dell’ente locale
Dalla pronuncia in esame emergono principalmente due questioni, che si impongono all’attenzione dell’interprete e che riguardano da un lato le cause e dall’altro le conseguenze della situazione di deficit finanziario in cui può trovarsi un ente locale.
La prima, collegata alle cause che hanno concorso all’aggravarsi della situazione debitoria, riguarda il governo del territorio da parte delle amministrazioni comunali e, nello specifico, il ricorso, spesso indiscriminato e oltre le reali esigenze, a procedimenti espropriativi cui non si riesce a far fronte da un punto di vista economico.
La seconda, riferibile all’ammissibilità di esperire azioni esecutive nei confronti dell’amministrazione che si trovi nella condizione di cui all’art. 244 del TUEL, impone di volgere uno sguardo alle conseguenze, nella prospettiva della tutela che deve essere, in ogni caso, garantita nei confronti dei cittadini e dei creditori.
In termini generali, la condizione di deficit finanziario della pubblica amministrazione, specie se locale, rappresenta un tema che deve essere analizzato come problema complesso, con componenti economiche, giuridiche e sociali che devono essere isolate, ma senza smarrire e tenendo in debita considerazione le interconnessioni, le interdipendenze, le compatibilità con altri problemi[23].
Non ci si può, in altri termini, limitare alle previsioni del TUEL e alle relative interpretazioni[24], per evitare di analizzare le questioni da un punto di vista angusto, che non restituisca l’importanza di un tema che rappresenta, a ben vedere, uno dei punti di tenuta e di equilibrio della democrazia locale.
Cause ed effetti devono essere letti in modo congiunto e si devono comporre, per pervenire a soluzioni efficaci, in un quadro di attribuzioni e di competenze che sembrano, in realtà, seguire dinamiche che ricalcano lo schema e il regime del fallimento previsto per i soggetti privati, determinato e orientato da altre necessità.
Si devono indagare i limiti interni delle soluzioni predisposte dal TUEL, per verificare, proprio da tale punto di partenza, la disponibilità degli interessi economici ad entrare in contatto con i territori e con le relative problematiche.
3.1 I costi della gestione del governo del territorio per le casse degli enti locali. L’incidenza dei procedimenti espropriativi
Il tema del governo del territorio e, nello specifico, i profili debitori che sono legati ai procedimenti espropriativi rappresentano probabilmente la sede elettiva per analizzare la tenuta delle cause che hanno concorso a generare e aggravare il dissesto degli enti locali, una sorta di filo rosso che attraversa e caratterizza la natura del debito dell’amministrazione.
Le ragioni sono intuibili e sono legate all’esposizione finanziaria che, a vario titolo, può generare da un procedimento di espropriazione per pubblica utilità[25].
Il problema di fondo, giuridico, ma ovviamente prima ancora socioeconomico, in cui si imbatte chiunque voglia occuparsi di urbanistica e di enti in dissesto è quello del concorso e quindi della contrapposizione tra poteri e diritti[26], cioè dell’aspettativa di soddisfazione dell’interesse individuale del privato e del composito e contestuale interesse dell’amministrazione, all’acquisizione del bene e al risanamento.
Il territorio è percepito non solo come confine-limite, idoneo a qualificare, quasi ad esserne condizione o requisito, gli interessi economici destinati a entrarvi in rapporto, ma come spazio o potenzialità, al quale però si collega un rischio, assunto in maniera non sempre consapevole e che potrebbe, però, minare l’equilibrio finanziario dell’ente stesso.
Sarebbe finanche banale ritenere che la risposta potrebbe rinvenirsi in politiche maggiormente aperte alle interazioni con soggetti privati, anche in fase di programmazione, economica e territoriale, perché il valore dei risultati potrebbe imporre una riqualificazione, non sempre adeguata, del ruolo dei poteri pubblici.
Si deve volgere, invece, con attenzione lo sguardo agli obiettivi generali di governo del territorio a monte, che dovrebbero apparire omogenei per garantire una gestione razionale di un sistema complesso, anche se spesso le modifiche territoriali sono state rimesse alla episodicità dei singoli interventi, con le evidenti pericolose conseguenze in tema di pesi, non programmati, che hanno gravato sulla finanza dell’ente solo in un momento successivo, senza l’apposita copertura programmatoria.
Rispetto a un tema così delicato per la natura degli interessi coinvolti, ci si dovrebbe avvantaggiare di chiare individuazioni di funzioni e responsabilità, per evitare di esporre la finanza locale a un passivo che spesso diviene insostenibile. Al di là di altri possibili riferimenti a misure e a soluzioni specifiche, rimane evidente la necessità, per gli enti locali, di adottare politiche che esprimano una concezione del territorio non soltanto finanziariamente condizionata, ma sostenibile nella sua accezione ampia[27].
3.2 Profili di ammissibilità del giudizio di ottemperanza nei confronti di un ente locale in dissesto
Per altro verso ci si deve interrogare, sul versante delle conseguenze, sull’ammissibilità del giudizio di ottemperanza nei confronti di un’amministrazione[28] che versi in una condizione di difficoltà finanziaria.
Le conseguenze immediate della dichiarazione di dissesto sono rappresentate dalla preclusione assoluta, in capo ai creditori, di intraprendere azioni esecutive[29] nei confronti dell’ente e l’interruzione della maturazione degli interessi e degli effetti della rivalutazione monetaria per i debiti insoluti.
Si deve però, sin da ora, precisare che si tratta di un’inesigibilità temporanea di interessi e rivalutazione, collegata al dissesto, che dura fino al rientro in bonis dell’ente[30], che avviene con l’approvazione del rendiconto della gestione dell’organo straordinario di liquidazione.
Il tema si è posto all’attenzione dell’interprete di recente, in ipotesi di occupazione illecita, alla quale ha fatto seguito la presentazione del piano di riequilibrio pluriennale, l’istituto che dovrebbe consentire all’amministrazione di evitare lo stato di dissesto, ma le conclusioni sono pienamente valide per il caso indagato.
L’azione di ottemperanza dovrebbe essere preclusa sino all’approvazione del piano di riequilibrio, poiché la stessa è equiparata, come noto, a una procedura esecutiva. Il ricorso è inammissibile, sul piano logico prima che giuridico, poiché non avrebbe senso consentire un giudizio esecutivo destinato ex lege alla sospensione fino alla definizione, in termini positivi o negativi, della relativa situazione temporanea di squilibrio finanziario[31]. Non sarebbe, infatti, assicurata la pretesa creditoria oggetto della stessa azione proposta in giudizio.
Le situazioni debitorie degli enti locali, regolate dal titolo VIII del TUEL, non dovrebbero inibire in radice il giudizio di ottemperanza, che può proseguire fino all’adempimento di obblighi di fare, per poi paralizzarsi quanto agli obblighi di dare. L’obbligo di fare però - che nell’ipotesi indagata potrebbe riguardare la restituzione di suoli oggetto di occupazione illegittima, previo ripristino originario stato - a ben vedere potrebbe comportare, in ogni caso, un aggravio finanziario, un’ulteriore spesa per l’amministrazione.
Nel caso in cui l’ente locale abbia avviato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e abbia domandato la sospensione del giudizio di ottemperanza è ammissibile e procedibile il ricorso nei limiti della domanda volta a ottenere, mediante la scelta discrezionalmente rimessa all’amministrazione (o, in sua sostituzione, in fase di esecuzione del giudicato, al Commissario ad acta), l’adozione del provvedimento di acquisizione sanante ovvero di restituzione del fondo con quantificazione delle somme dovute a titolo di risarcimento e indennizzo secondo i criteri indicati nella sentenza definitiva, al fine precipuo dell'inserimento del debito così liquidato nel piano di risanamento secondo il sistema e le procedure di cui agli artt. 243 bis o, in caso di dissesto finanziario, nel piano di rilevazione della massa passiva.
L’interpretazione elaborata in questi termini appare convincente, poiché la sospensione del giudizio di ottemperanza deve riguardare le azioni esecutive aventi per oggetto immediato e diretto il pagamento di somme di denaro, ma tale effetto sospensivo non può predicarsi, in maniera equivalente, in relazione agli obblighi di fare, poiché non viene in rilievo l’interesse ad un ordinato assetto delle esigenze di bilancio, ma l’interesse ad ottenere l’adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto, per come identificata nella decisione da ottemperare.
Si tratta di un pur complesso punto di equilibrio tra interessi confliggenti, quelli dell’ente, quelli dei cittadini, quelli dei creditori che trovano il proprio terreno di confronto sull’orlo del baratro di una situazione deficitaria[32].
La modulazione dell’ammissibilità di un’azione a carattere esecutivo deve essere condotta in concreto, volgendo lo sguardo allo stato complessivo dello squilibrio, alla probabilità che si verifichi un tempestivo rientro dal debito[33], alla stessa capacità amministrativa dell’ente locale.
4. Riflessioni conclusive. Autonomia, diritti e territori
Una rappresentazione di sintesi, ma interlocutoria e che si proponga di andare oltre la relazione diretta tra ammissibilità del giudizio di ottemperanza e divieti di spesa, ma che sia afferente agli sviluppi tentacolari del tema del dissesto degli enti locali deve rintracciarsi nel filo rosso che lega autonomia, diritti e territori[34], rifuggendo da considerazioni banali, tra le quali quella che induce a sostenere che vi sia un’incapacità del livello di governo locale a rispondere alle domande dei cittadini e alle esigenze degli interessi economici, almeno di quelli che devono essere mediati del potere stesso.
Diritti e interessi economici vivono e spesso si confrontano sullo stesso terreno, caratterizzato, come nelle ipotesi poste sotto indagine, da risorse economiche limitate, condizione dalla quale derivano diversi divieti di spesa e quindi inammissibilità di ricorrere alle poste disponibili, anche se oggetto di statuizioni giurisdizionali.
Non si possono, però, sacrificare né i diritti dei cittadini residenti in un comune in dissesto, già vittime di misure di risanamento spesso improntate all’aumento delle aliquote delle imposte e alla riduzione dei servizi, né gli interessi economici che possono rappresentare la leva per consentire un rientro più celere della condizione finanziaria deficitaria.
Le soluzioni che il legislatore ha predisposto per garantire la soddisfazione del credito nei confronti di un ente che, in partenza, è in condizione di non garantire le funzioni ordinarie sono state modulate, nel corso del tempo, in base a determinati fattori, esogeni e pertanto non disponibili, ma anche endogeni alla stessa amministrazione interessata, come le carenze organizzative che hanno contribuito al debito.
Il riferimento e al contempo l’obiettivo di medio termine che deve essere perseguito è il rientro definitivo dalla posizione debitoria, il risanamento in termini di risultato autonomo, che però si garantisce e si raggiunge in un tempo nel quale devono, contestualmente, essere garantite funzioni essenziali attribuite per legge.
Il punto di partenza, la situazione debitoria, impone di leggere la stessa funzione amministrativa comunale in una dimensione più ampia, complessiva, in termini di rinnovati equilibri e rinnovata sostenibilità.
L’esercizio della funzione e il risanamento sono potenzialmente in antitesi ma si tratta di un conflitto apparente, poiché si tratta di porre rimedio a un danno arrecato dagli amministratori locali cui deve far seguito una logica programmatoria che persegua l’obiettivo della coesione economica e sociale a livello locale.
Il contesto della dimensione locale, anche qualora sia studiato a partire da una situazione di insolvenza, deve restituire una dialettica che tenga in considerazione l’organizzazione e la funzione, nell’ottica finale dell’autonomia dalla quale può desumersi la capacità che il territorio stesso può esprimere, proprio perché sede elettiva nella quale i diritti sono garantiti e tutelati.
[1] Tra gli studi più pregevoli si devono segnalare gli scritti di G. Verde, Le leggi sul dissesto degli enti locali dopo gli interventi della Corte costituzionale, in Dir. proc. amm., 1995, 2, 234 ss. e di M. Sandulli, Il “completo risanamento” dei debiti degli enti locali in dissesto, in Riv. dir. proc., 1996, 1, 7 ss.
[2] Cass., sez. un., 14 maggio 2024, n. 13205, in tema di riparto di giurisdizione per le controversie che vertono sulle sanzioni interdittive comminate agli amministratori locali responsabili del dissesto.
[3] T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 20 settembre 2024, n. 5039, sent. non def. n. 5039, la dichiarazione del dissesto è un atto di competenza dell'organo consiliare rigidamente vincolato, la cui adozione è doverosa e sufficientemente motivata dalla mera ricognizione dell'incapacità dell’ente di garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, ovvero di assicurare il pagamento dei crediti liquidi ed esigibili di terzi con gli strumenti forniti dalle norme di contabilità. Il sindacato giurisdizionale sull’atto de quo è necessariamente incentrato sulla verifica del corretto esercizio del potere di azione in ordine all’accertamento dei presupposti di fatto previsti dalla legge, non potendo consentirsi al giudice amministrativo alcuna valutazione delle scelte operate. (Nella fattispecie in esame, la sezione reputa legittima l’adozione della deliberazione finale di dissesto finanziario, preceduta dall’approvazione del rendiconto della gestione nonché dalla presa d’atto dell’impossibilità di ripiano. Assume che gli incontestabili dati di bilancio militano nel senso di ritenere realizzato il presupposto della dichiarazione di dissesto, sulla scorta di un accertamento dell’evidenza dei dati medesimi, a nulla rilevando le ipotetiche soluzioni prospettate dai revisori dei conti, quanto all’alienazione degli immobili di proprietà comunale ovvero ad altre forme di anticipazione finanziaria).
[4] Si v. lo studio pubblicato con cadenza annuale, M. Degni (a cura di), VII Rapporto Ca’ Foscari sui comuni. I comuni nella nuova governance europea della finanza pubblica, Roma, Castelvecchi, 2024.
[5] Sul tema, nell’ottica della tutela dei creditori, cfr. C. Bergonzini, Quando il dissesto si nasconde nei dettagli. Criticità finanziarie del Comuni e tutela dei creditori: un bilanciamento da rivalutare, in Federalismi, 2023, 15, 5 ss.; tra i lavori monografici, per una lettura di taglio economico del tema, si v. R. Civitillo, Il dissesto finanziario degli enti locali, Milano, Franco Angeli, 2022.
[6] Si tratta di un passaggio, particolarmente significativo, della delibera con la quale il comune di Frignano ha dichiarato il dissesto, 29 luglio 2022, del. n. 24; si v., per apprezzare la multifattorialità del dissesto, anche la delibera con la quale il comune di Paolisi ha dichiarato il dissesto, 28 dicembre 2022, del. n. 43, dalla quale si evince che “al di là dei fattori contabili, ha inciso la risalente inadeguatezza della macchina comunale, che avrebbe bisogno dell’innesto di buone pratiche e di robusta assistenza tecnica, con l’inserimento di adeguate figure professionali, tra le quali rileva l’assenza di un responsabile del servizio finanziario”.
[7] Come osserva G. Rivosecchi, I controlli sulla finanza pubblica tra i diversi livelli territoriali di governo, in Riv. trim. dir. pubbl., 2019, 3, 760, si tratta dell’accertamento della corrispondenza tra determinati fatti giuridico-contabili ai parametri normativi.
[8] Emblematica è l’espressione utilizzata da F. Pica, La crisi finanziaria del Comune di Napoli: lezioni da una esperienza, in Riv. econ. Mezz., 2014, 1-2, con il dissesto si prende atto del fatto che l’ente è morto, in quanto ha fallito senza rimedio alla sua effettiva missione.
[9] Si deve osservare, infatti - come fatto di recente da T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 2 novembre 2023, n. 5936, in Foro amm., 2023, 11, II, 1538 - che l’incarico di componente dell’organo straordinario di liquidazione di un comune non costituisce un rapporto di pubblico impiego, infatti, la revoca di tale incarico non è annoverabile tra gli atti di gestione del rapporto di pubblico impiego.
[10] Sul profilo inerente la tenuta degli equilibri dinamici di perfomance in un regime separato, si v. V. Manzetti, Quale “performance” amministrativa negli enti locali in situazione di grave squilibrio di bilancio?, in Federalismi, 2019, 17, 10 ss.
[11] Cfr. Cons. St., sez. V, 9 maggio 2003, n. 2455, in Foro amm. CdS, 2003, 1612.
[12] Così T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 4 luglio 1994, n. 335, in Foro it., 1995, III, 352; ex multis, rispetto all’equiparazione del giudizio di ottemperanza alle azioni esecutive, si v. T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 29 maggio 2012, n. 2514, in Foro amm. TAR, 2012, 5, 1695, “quando una norma - come l’art. 21 comma 3, d.l. n. 8 del 1993, convertito con modificazioni dalla l. n. 68 del 1993 - non consente al creditore dell’amministrazione di agire in sede giurisdizionale con le azioni esecutive (in quanto la soddisfazione deve aver luogo nell’ambito di una procedura amministrativa concorsuale), non si può ritenere ammissibile il giudizio di ottemperanza”.
[13] Si v. M. Nunziata, In tema di “dissesto finanziario” degli enti locali, in Amm. cont. St. en. Pubbl., 1994, 1-6, 74 ss.; Cons. St., ad. plen., 24 giugno 1998, n. 4, in Giur. It., 1998, 597, “l’art. 21 comma 3 d.l. 18 gennaio 1993 n. 8, conv. con modificazioni dalla l. 19 marzo 1993 n. 68 - con il quale è stata disposta l’estinzione delle procedure esecutive pendenti (previo pagamento dell’importo dovuto) e la non proponibilità di nuove azioni esecutive nei confronti degli enti locali dissestati - è applicabile sia in relazione all’esecuzione forzata dinanzi al giudice ordinario, sia quando il creditore dell’ente locale presenti al giudice amministrativo il giudizio per l’esecuzione del giudicato disciplinato dall’art. 27 n. 4 t.u. 26 giugno 1924 n. 1054; in questo caso, il giudice dell’ottemperanza non può prendere misure dirette alla soddisfazione dei ricorrenti in violazione del principio della «par condicio creditorum», salve le azioni decisorie (che hanno un sostanziale contenuto di cognizione), di controversie ancora non pendenti”.
[14] Cons. St., sez. IV, 4 febbraio 2003, n. 544, in Foro amm. CdS, 2003, 503.
[15] Si v. C. Barbati, Territori e interessi economici: le “politiche dei luoghi” per lo sviluppo locale, in Scritti in memoria di Roberto Marrama, I, Napoli, ES, 2012, 31 ss., 36.
[16] Ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 22 maggio 2024, n. 3297; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 24 maggio 2023, n. 687.
[17] Sul tema, anche in ragione degli ultimi orientamenti della giurisprudenza di legittimità, cfr. A. Quarta, Effetti del decreto di esproprio e situazioni possessorie. L’ultima parola della Cassazione, in Giur. it., 2023, 6, 1258 ss.
[18] Sul tema, si v. G. Manfredi, Acquisizione sanante, ottemperanza, indennità, in Giur. it., 2021, 6, 1431 ss.; sul profilo debitorio, E. Barile, In tema di dissesto degli enti locali (Nota a Cons. St., ad. plen., 5 agosto 2020, n. 15), in Foro it., 2020, 12, III, 667 ss.
[19] Cons. St., sez. IV, 17 novembre 2023, n. 9874, l’atto di acquisizione sanante, generatore dell’obbligazione (e, quindi, del debito), è attratto nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione, e non rientra quindi nella gestione ordinaria, sia sotto il profilo contabile sia sotto il profilo della competenza ammnistrativa, se detto provvedimento ex art. 42-bis t.u. espropriazione è pronunciato entro il termine di approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria e si riferisce a fatti di occupazione illegittima anteriori al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
[20] Cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. V, 18 marzo 2024, n. 997.
[21] Proprio in tema di azioni esecutive in seguito a procedimenti espropriativi, si v. M.M. Cellini, La penalità di mora nel processo amministrativo tra precarietà della statuizione ed effettività della tutela giurisdizionale, in Riv. dir. proc., 2021, 1, 380 ss.
[22] Secondo la nota ricostruzione di H.A. Simon, Il comportamento amministrativo, Bologna, Il Mulino, 2001 (rist.).
[23] Si tratta dell’impostazione teorica elaborata da G. Marongiu, Complessità sociale, identità politica e formazione, in P.F. Casini (a cura di), Sui banchi della politica, Roma, Ed. Cinquelune, 1990, ora anche in La democrazia come problema, II, Bologna, Il Mulino, 1994, 137.
[24] Cfr. C. Bergonzini, P. Brambilla, La riforma del Titolo VIII: soluzioni per la criticità finanziaria dei Comuni, in M. Degni (a cura di), VI Rapporto Ca’ Foscari sui comuni. I comuni dentro la sfida del PNRR, Roma, Castelvecchi, 2023, 121 ss.
[25] Sui profili finanziari della programmazione urbanistica, cfr. A. Moscarini, Proprietà privata e Costituzione dopo le sentenze della Consulta nn. 348 e 349 del 2007, in Dir. soc., 2008, 4, 669 ss.
[26] Ci si limita a rinviare a P. Stella Richter, Proprietà immobiliare e pianificazione urbanistica, in Studi in memoria di Franco Piga, I, Milano, Giuffrè, 1992, 947 ss., che osserva, in termini generali, che il procedimento espropriativo deve tenere, sin dalla fase di programmazione, in debita considerazione, tutti gli interessi che insistono, anche indirettamente, sulla vicenda; L. Mercati, La buona amministrazione del patrimonio immobiliare pubblico, in Scritti per Maria Luisa Bassi, Napoli, ES, 2022, 193.
[27] Cfr. C. Raffestin, Per una geografia del potere, Milano, Unicopli, 1981, 155, ogni pratica spaziale indotta da un sistema d’azioni o di comportamenti, anche embrionali, si traduce in una produzione territoriale, con effetti finanziari che gravano sui soggetti, pubblici o privati, che si fanno carico dell’esecuzione.
[28] In termini generali, sull’esigibilità dei crediti nei confronti degli enti locali, cfr. R. Mininno, Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo come modalità (alternativa) di recupero forzoso dei crediti verso gli enti locali, in Riv. es. forz., 2023, 4, 974 ss.; si v. anche A. Cascone, L’ottemperanza “civile” in trasformazione, in Dir. econ., 2022, 3, 221 ss.
[29] Sul tema, in una lettura che generi dalla procedura esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione, cfr. A. Auletta, L’esecuzione forzata contro la pubblica amministrazione, Milano, Giuffrè, 2020.
[30] Cfr. Cass., sez. I, 10 marzo 1999, n. 2049, in Giust. civ. mass., 1999, 532, in tema di procedura esecutiva iniziata nei confronti dell’amministrazione precedentemente alla dichiarazione del relativo stato di dissesto è inammissibile l’intervento anche di altri creditori, per il pagamento di interessi su crediti vantati nei confronti dell’ente, ma scaduti dopo la dichiarazione di dissesto.
[31] T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 6 aprile 2021, n. 501.
[32] Cfr. A. Crismani, Il dissesto finanziario degli enti locali tra tutela dei creditori, “diritto a un tribunale” e tutela della finanza pubblica, in questa Rivista, 2022.
[33] Si tratta di un aspetto che impone di tenere in considerazione gli articolati rapporti tra tessuto economico, società e amministrazione, sui cui profili, ex multis, cfr. G. Montedoro, Economia e società circolare: quali trasformazioni dello Stato e del diritto amministrativo?, in Dir. soc., 2020, 1, 175 ss.
[34] Per riprendere il titolo del celebre studio di S. Sassen, Territorio, autorità, diritti. Assemblaggi dal Medioevo all’età globale, Milano, Mondadori, 2008; L. Giani, L’amministrazione tra appropriatezza dell’organizzazione e risultato: spunti per una rilettura del dialogo tra territorio, autorità e diritti, in Scritti per Maria Luisa Bassi, Napoli, ES, 2022, 765 ss.