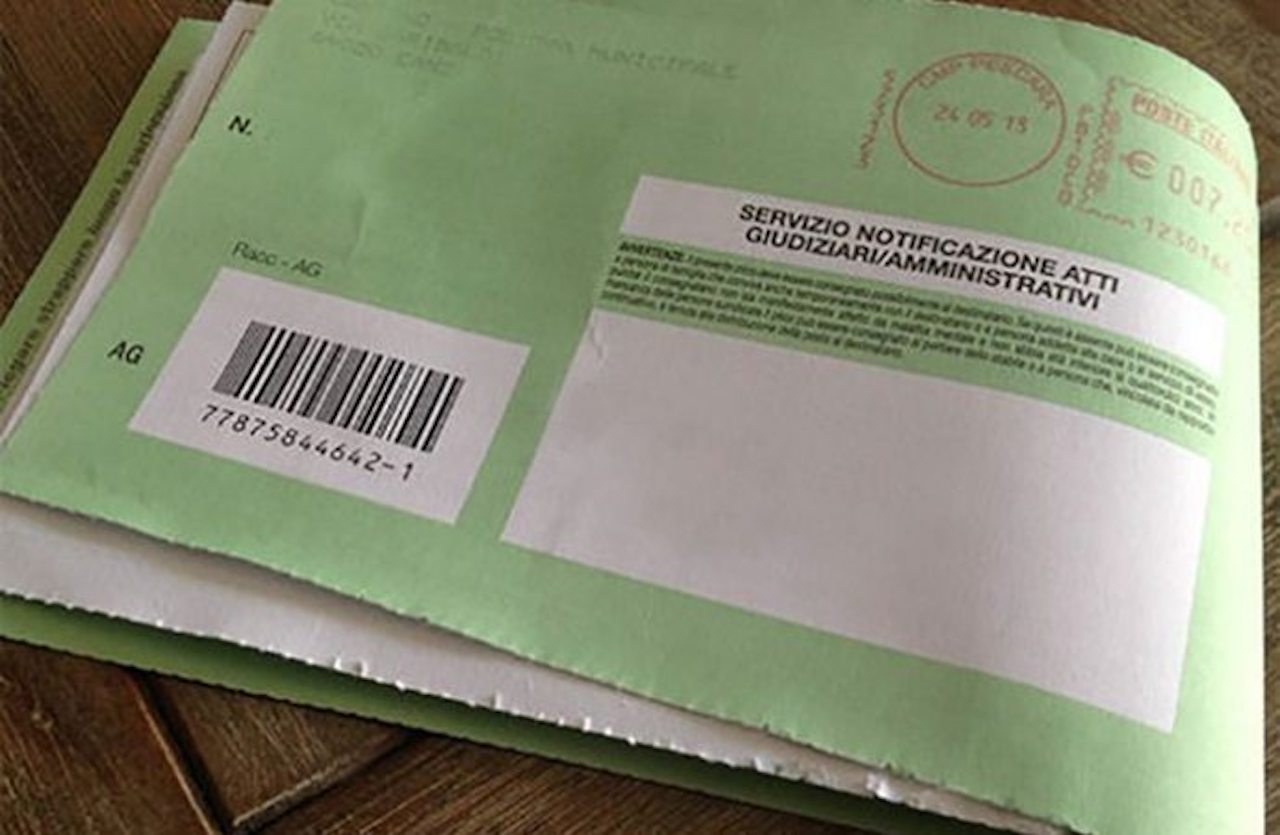Autotutela sugli atti del commissario ad acta nel giudizio avverso il silenzio (nota a Cons Stato, Sez. IV, 18 03 2021, n. 2335) di Roberto Fusco
Sommario: 1. Il caso di specie. – 2. La natura giuridica del commissario ad acta nel giudizio di ottemperanza e la contestabilità dei provvedimenti commissariali. – 3. Il ruolo e i poteri del commissario ad acta nell’ambito del giudizio avverso il silenzio. – 4. Il decisum della sentenza: l’assenza del potere di autotutela della pubblica amministrazione sui provvedimenti commissariali. – 5. La permanenza del potere di provvedere della pubblica amministrazione dopo la nomina del commissario. – 6. Alcune brevi considerazioni conclusive.
1. Il caso di specie.
La sentenza in commento[1] si sofferma sul tema dell’annullabilità in autotutela dei provvedimenti adottati dal commissario ad acta nominato, in sostituzione della pubblica amministrazione, nell’ambito del giudizio avverso il silenzio inadempimento. Il potere di autotutela in relazione ai provvedimenti commissariali presuppone plurime questioni tra loro interconnesse riguardanti la figura del commissario, ossia: la sua natura; le relazioni intercorrenti tra il commissario, il giudice che lo nomina e l’ente sostituito; le differenze del suo ruolo nel giudizio di ottemperanza e in quello avverso il silenzio; e, infine, la natura dei provvedimenti commissariali e i relativi strumenti utilizzabili per la loro contestazione.
Si anticipa sin d’ora che il Consiglio di Stato, confermando la propria giurisprudenza prevalente sul punto, ha negato la sussistenza del potere della pubblica amministrazione di incidere in autotutela sugli atti adottati in sua vece dal commissario ad acta, prevedendo che per la loro contestabilità l’amministrazione debba esperire, al pari del privato, il rimedio del reclamo.
Il caso di specie, da cui origina la pronuncia in commento, riguarda l’impugnazione di una sentenza del T.A.R. per il Molise[2] che ha accolto il ricorso avverso il provvedimento dirigenziale con il quale il Comune di Campobasso ha annullato in autotutela il provvedimento di un commissario ad acta[3]. La sentenza di primo grado ha negato all’ente comunale il potere di incidere in autotutela sull’atto commissariale, ritenendo che la relazione intercorrente tra il commissario (nominato nell’ambito di un giudizio avverso il silenzio-inadempimento) e l’ente sostituito abbia carattere inter-soggettivo e non semplicemente inter-organico. Sulla base di tale impostazione sono stati annullati i provvedimenti con i quali l’amministrazione comunale aveva rimosso in autotutela il provvedimento commissariale e l’atto comunale che aveva preannunciato il rigetto dell’istanza di rilascio del titolo edilizio. L’ente comunale ha proposto appello avverso la succitata sentenza, sostenendo che gli atti commissariali emanati sarebbero stati imputabili al Comune e, quindi, ordinariamente annullabili d’ufficio dallo stesso, essendo il potere di autotutela dell’amministrazione un potere “immanente” e non “espropriabile”. Inoltre, sempre secondo l’amministrazione appellante, la procedura di reclamo non sarebbe applicabile al rito avverso il silenzio rifiuto e, in ogni caso, non priverebbe l’amministrazione del suo potere di autotutela.
L’adito Collegio, dopo aver rigettato la richiesta di sospensione dell’esecutività della sentenza avanzata dall’appellante in sede cautelare[4], ha respinto il proposto appello ritenendo fondato il primo motivo di ricorso svolto in prime cure secondo il quale, alla luce del rapporto inter-soggettivo tra il commissario e l’ente sostituito, alla pubblica amministrazione non può essere riconosciuto il potere di autotutela sugli atti commissariali.
2. La natura giuridica del commissario ad acta nel giudizio di ottemperanza e la contestabilità dei provvedimenti commissariali.
La nomina del commissario ad acta[5] costituisce la principale modalità attraverso la quale il giudice amministrativo, nell’ambito del giudizio di ottemperanza, si sostituisce alla pubblica amministrazione per dare attuazione alle sentenze di merito e agli altri provvedimenti ad esse equiparati ogniqualvolta la pubblica amministrazione ometta di darvi esecuzione[6].
L’indagine sulla natura giuridica del commissario nominato in sede di ottemperanza è da sempre stata fondamentale al fine di individuare il regime giuridico dei provvedimenti commissariali[7]. Come icasticamente evidenziato in dottrina, infatti, il commissario ad acta può essere rappresentato come “un punto di sutura e di saldatura tra attività giurisdizionale e attività amministrativa”[8].
Prima dell’adozione del codice del processo amministrativo la dottrina e la giurisprudenza avevano elaborato tre principali teorie circa la natura giuridica del commissario ad acta di nomina giudiziale[9].
Una prima teoria qualifica il commissario come organo ausiliario del giudice. Questa tesi poggia su due fondamentali pronunce della Corte costituzionale[10] e del Consiglio di Stato[11] secondo le quali l’attività sostitutiva del giudice dell’ottemperanza ha natura giurisdizionale e l’attività del commissario è strumentalmente connessa ad essa; gli atti del commissario, in quanto riconducibili all’ufficio giudiziario, devono essere qualificati della stessa natura (giudiziale) e, pertanto, la loro contestazione spetta al giudice dell’ottemperanza che ha l’obbligo di accertarne la rispondenza al giudicato[12].
Una seconda teoria qualifica il commissario come un organo straordinario dell’amministrazione resistente, che deve operare secondo le logiche (e le regole) dell’attività amministrativa, ponendo in essere atti imputabili alla pubblica amministrazione[13]. Da questa impostazione discende che l’impugnazione dei provvedimenti da parte dei privati debba essere effettuata mediante un’autonoma azione annullatoria e non rivolgendosi direttamente (con reclamo) al giudice dell’ottemperanza. Inoltre, l’ente sostituito, non avendo la legittimazione ad impugnare un atto proprio, sarebbe stato privo di tutela nei confronti degli atti commissariali[14], eccetto il potere di autotutela sugli stessi[15].
Infine, occorre dar conto di una terza teoria che qualifica il commissario come un organo misto, ossia un organo che è allo stesso tempo organo ausiliario del giudice dell’ottemperanza (in quanto deputato alla funzione di attuazione del giudicato promanante dal giudice) e organo straordinario dell’amministrazione sostituita (in quanto inserito coattivamente nelle strutture organizzative dei quest’ultima per provvedere in sua vece)[16]. Esso va inteso come un soggetto dalla doppia natura, che da un lato è un delegato (ausiliario) del giudice e opera come suo alter ego e, dall’altro lato, svolge una funzione sostanzialmente amministrativa in sostituzione dell’amministrazione inadempiente[17]. In adesione a questa “bivalenza” della figura del commissario, parte della giurisprudenza ha affermato che il commissario sarebbe organo ausiliario del giudice oppure organo straordinario dell’amministrazione a seconda dell’ampiezza (minore o maggiore) dello spazio che il giudicato lascia alla sua azione: qualora il giudice demandi al commissario il compito generale di sostituirsi alla pubblica amministrazione inadempiente, il commissario dovrebbe considerarsi come organo straordinario della stessa; laddove, invece, il giudice gli attribuisca un compito ben preciso e delimitato, esso dovrà ritenersi come un suo ausiliario[18].
Il codice del processo amministrativo, con gli articoli 21 e 114, ha recepito esplicitamente la tesi (già prevalente) del commissario ad acta quale organo ausiliario del giudice[19]. A riprova di un tanto, dopo l’entrata in vigore del codice, il giudice amministrativo ha confermato in numerose pronunce come il commissario ad acta debba essere considerato un ausiliario del giudice e che lo stesso sia titolare di un potere che trova un fondamento diretto nella pronuncia del giudice dell’ottemperanza[20].
Nonostante tale espressa presa di posizione del codice sulla natura del commissario, non si può dire che l’impianto normativo sia risultato idoneo a sgombrare il campo da tutti i dubbi relativi all’attività compiuta dallo stesso e ai mezzi esperibili per contestare i suoi atti.
Infatti, il codice prevede un duplice regime di rimedi avverso gli atti del commissario a seconda di quale sia il soggetto che intenda impugnarli[21]: qualora siano le parti a voler contestare il provvedimento commissariale è ammesso il reclamo dinanzi al giudice dell’ottemperanza; qualora, invece, si tratti di terzi estranei al giudicato, gli atti commissariali sono impugnabili con il ricorso al giudice amministrativo secondo il rito ordinario[22]. Laddove si fosse imposto anche ai terzi estranei lesi dalle determinazioni commissariali l’obbligo di rivolgersi al giudice dell’ottemperanza, si sarebbe rischiato di infrangere il principio del (tendenziale) rispetto del doppio grado di giudizio (ove il giudice competente per l’ottemperanza fosse stato il Consiglio di Stato) ma, più ancora, di ledere il loro diritto di difesa, poiché per loro l’attività commissariale è “res inter alios”[23].
È lecito, quindi, chiedersi se l’impugnabilità degli atti del commissario da parte dei terzi estranei al giudicato li trasforma in atti di natura amministrativa, ossia se dalla duplicità di rimedi possa discendere una duplicità di natura giuridica (amministrativa e giudiziale) degli atti commissariali[24].
3. Il ruolo e i poteri del commissario ad acta nell’ambito del giudizio avverso il silenzio.
La questione della natura del commissario ad acta e dei suoi rapporti con il giudice che lo nomina e con l’amministrazione sostituita assume una connotazione diversa con riferimento al commissario nominato in sede di giudizio avverso l’inerzia della pubblica amministrazione[25].
Con la nomina del commissario ad acta nel rito del silenzio, infatti, non si ha un vero e proprio giudizio di ottemperanza ma piuttosto un’ottemperanza “anomala” o “speciale”, dove la specialità risiede nella circostanza che si prescinde dall’attuazione di un provvedimento giudiziale[26].
La giurisprudenza e la dottrina si interrogano se al commissario ad acta nominato nell’ambito del rito avverso il silenzio vadano attribuiti poteri e natura differenti dal commissario dell’ottemperanza o se l’istituto vada inteso in termini di unitarietà nella sua disciplina codicistica che lo definisce come ausiliario del giudice[27].
Secondo alcune pronunce, mentre il commissario ad acta nominato in sede di giudizio di ottemperanza costituisce un organo ausiliario del giudice, diverso sarebbe il caso del commissario nominato nell’ambito del giudizio avverso l’inerzia dell’amministrazione, non avendosi in tal caso un vero e proprio giudizio di ottemperanza, tant'è che il codice del processo amministrativo non rinvia alle norme su tale tipo di giudizio, limitandosi a prevedere la nomina di un commissario ad acta[28]. Seguendo questa impostazione l’attività del commissario nominato nel giudizio sul silenzio non si limiterebbe al completamento e all’attuazione del dictum giudiziale recante direttive conformative dell’attività amministrativa, ma si tradurrebbe in un’attività di pura sostituzione nell’esercizio del potere proprio dell’amministrazione soccombente, collegata alla pronuncia giudiziale solo per quanto attiene al presupposto della prolungata inerzia dell’amministrazione medesima. L’attività del commissario ad acta sarebbe, dunque, qualificabile come sostitutiva rispetto a quella dell’amministrazione, piuttosto che di stretto ausilio al potere esecutivo del giudice[29].
Sul punto, però, c’è da registrare anche una recente posizione contraria del Consiglio di Stato secondo la quale la qualificazione del commissario ad acta come sostituto della pubblica amministrazione non sarebbe sostenibile alla luce dell’art. 117, comma 4, c.p.a. che attribuisce alla cognizione del giudice tutte le questioni relative all’esatta adozione del provvedimento richiesto. Il commissario, pertanto, è costretto a muoversi in un “contesto governato dal giudice”, dovendosi escludere che esso vada a sostituire l’amministrazione[30].
Tale dibattito rileva anche nel caso di specie laddove la qualificazione del commissario come organo sostituto dell’amministrazione è propugnata dall’amministrazione appellante, secondo la quale vi è una distinzione ontologica tra il giudizio di ottemperanza “classico” di cui agli artt. 112 e ss. c.p.a. e la ottemperanza “atipica” di cui all’art. 117, comma 6, c.p.a. Soltanto nel caso dell’ottemperanza vera e propria il commissario assumerebbe il ruolo di mandatario del giudice, in quanto da quest’ultimo chiamato all’attuazione di un proprio decisum a monte deliberato. Nella diversa ipotesi del giudizio avverso il silenzio inadempimento ex art. 117 c.p.a., invece, l’organo commissariale sarebbe chiamato a pronunziarsi per la prima volta sull’istanza rimasta inevasa dalla pubblica amministrazione, sulla base di un comando giudiziario finalizzato a superarne l’inerzia. Vi sarebbe, perciò, una profonda differenza strutturale tra il ruolo che il commissario riveste nei due tipi di giudizio: ossia, sarebbe ausiliario del giudice nell’ottemperanza classica e organo sostituto all’amministrazione nell’ottemperanza atipica. In quest’ultimo caso gli atti commissariali emanati sarebbero ordinariamente annullabili in autotutela in quanto atti imputabili all’ente comunale e in quanto costituenti l’espressione del primo esercizio del potere amministrativo da parte dell’amministrazione (rectius da parte del commissario per conto dell’amministrazione).
Il Collegio, però, richiamando un proprio recente precedente[31], dichiara di non condividere tale impostazione sostenendo che, qualora il giudice abbia stigmatizzato come illegittimo (rectius antigiuridico) il silenzio-inadempimento serbato dall’amministrazione, esso ben può provvedere, a mezzo del commissario ad acta, alla ponderazione comparativa, anche discrezionale, illegittimamente omessa dall’amministrazione in violazione del generale dovere di concludere il procedimento.
4. Il decisum della sentenza: l’assenza del potere di autotutela della pubblica amministrazione sui provvedimenti commissariali.
La possibilità o meno per l’amministrazione di agire in autotutela sugli atti commissariali è una questione particolarmente attuale, soprattutto con riferimento al giudizio avverso il silenzio dove il commissario ad acta si trova a dover provvedere per la prima volta (in sostituzione dell’amministrazione) sull’istanza del privato rimasta inevasa.
La giurisprudenza prevalente è propensa a negare detto potere di autotutela, poiché la pubblica amministrazione si trova, rispetto ai provvedimenti commissariali, in una sorta di posizione di sovranità limitata[32] e poiché la natura intersoggettiva tra commissario e amministrazione sostituita impedisce che quest’ultima possa rimuovere in autotutela un atto commissariale[33].
Anche in dottrina è stata esclusa la possibilità di rimuovere in autotutela i provvedimenti commissariali poiché l’amministrazione, così facendo, realizzerebbe uno “straripamento di potere” nei confronti dell’autorità giudiziaria, vanificando la tutela ottenuta dal ricorrente vittorioso in sede giurisdizionale[34]. Infatti, ammettere il potere di rimozione degli atti commissariali da parte del soggetto pubblico risultato soccombente in un giudizio pregresso finirebbe per svuotare di valore l’adottata decisione giudiziale a lui favorevole[35].
La sentenza in commento si sofferma sulle ragioni che depongono per l’assenza, in capo alla pubblica amministrazione sostituita, del potere di rimuovere in autotutela i provvedimenti del commissario ad acta nominato nell’ambito del giudizio avverso il silenzio inadempimento.
L’analizzata natura del commissario come ausiliario del giudice è il primo argomento in base al quale viene negato detto potere di autotutela all’amministrazione. A parere del Collegio tale ragionamento non può essere messo in dubbio neanche dalla diversità funzionale del giudizio avverso il silenzio nel quale il commissario eserciterebbe per la prima volta un potere amministrativo in maniera libera o, meglio, svincolata dall’attuazione di un giudicato. Nel caso del giudizio avverso il silenzio, infatti, l’illegittima inerzia dell’autorità amministrativa costituisce il presupposto per l’intervento del giudice che può sostituirsi alla pubblica amministrazione rimasta inerte attraverso il commissario ad actache, per il fatto di pronunciarsi in prima battuta in luogo dell’amministrazione rimasta silente, non perderà la sua natura di organo ausiliario del giudice. Infatti, è al giudice stesso (per mezzo del commissario) che compete, dopo aver stigmatizzato come illegittimo il silenzio inadempimento dell’amministrazione, il potere di provvedere a quella ponderazione comparativa, anche discrezionale, illegittimamente omessa dall’amministrazione, in violazione del generale dovere di conclusione del procedimento[36].
Un altro elemento che depone per l’assenza del potere di autotutela è il rapporto tra commissario e amministrazione sostituita che viene declinato in termini inter-soggettivi più che inter-organici. La natura inter-soggettiva del rapporto, infatti, esclude che l’atto impugnato possa essere imputato all’ente sostituito e, conseguentemente, che possa essere inciso dal potere di autotutela della pubblica amministrazione. Infatti, quantomeno il potere di annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies, l. n. 241/1990, che rileva nel caso di specie, è generalmente spendibile solo nei confronti di atti emessi dalla stessa pubblica amministrazione ovvero da altro soggetto sotto-ordinato. L’amministrazione sostituita, quindi, non viene espropriata dal potere di autotutela perché detto potere non le compete in radice, essendovi un rapporto inter-soggettivo e non inter-organico tra l’amministrazione sostituita e il commissario[37].
Analogamente a quanto affermato da autorevole dottrina[38], il Collegio afferma che ammettere l’autotutela avverso i provvedimenti commissariali determinerebbe “da un lato la mortificazione del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost. e ribadito dal c.p.a. proprio nella disposizione di apertura, dall’altro la violazione del principio di separazione dei poteri, consentendosi altrimenti la sterilizzazione amministrativa dell’intervento giurisdizionale”.
A supporto di tale impostazione viene richiamato anche il dettato dell’art. 117, comma 4, c.p.a.[39] in base al quale sarebbe evidente la ratio legis di concentrare in capo al giudice la cognizione di tutte le vicende conseguenti alla pronuncia avverso il silenzio inadempimento, ivi incluso il sindacato sugli atti commissariali eventualmente emanati[40].
Tale espressa scelta legislativa, inoltre, sarebbe confermata dalla “strutturale natura giuridica del commissario”, figura che promana dal giudice, che svolge funzioni ausiliarie allo stesso e di cui costituisce la longa manus.
Infatti, il Collegio ritiene che il dato decisivo per dirimere questione relativa alla sussistenza o meno del potere di autotutela in capo alla pubblica amministrazione non vada indagato nel tipo di attività (ampiezza della valutazione discrezionale) che il commissario è chiamato a svolgere a seconda che lo stesso sia nominato nel giudizio di ottemperanza o in quello avverso il silenzio; quello che rileva è che i suoi atti non sono mai geneticamente riconducibili all’ordinario esercizio dell’attività amministrativa essendo, invece, espressione dell’attività giurisdizionale. Il commissario ad actadeve considerarsi sempre una figura distinta dall’amministrazione e la sua attività deve essere qualificata in ogni caso come “attività soggettivamente giurisdizionale pur se calata in una forma amministrativa”.
5. La permanenza del potere di provvedere della pubblica amministrazione dopo la nomina del commissario.
Una questione diversa, ma che presenta indubbi punti di contatto con l’annullabilità in autotutela dei provvedimenti commissariali, è quella relativa alla persistenza del potere di provvedere in capo all’amministrazione dopo la nomina del commissario ad acta nell’ambito del rito avverso il silenzio, questione che attualmente risulta al vaglio dell’Adunanza Plenaria[41].
L’ordinanza con cui la Sezione IV del Consiglio di Stato ha rimesso la questione alla Plenaria da adeguatamente conto dei diversi orientamenti formatisi sul punto nella giurisprudenza[42].
Secondo una prima risalente impostazione il potere-dovere dell’amministrazione di dare esecuzione alla pronuncia giurisdizionale verrebbe meno già dopo la nomina del commissario ad acta[43].
Per un secondo orientamento, divenuto maggioritario nella giurisprudenza più recente, il c.d. esautoramento dell’organo inottemperante (rectius inadempiente) si verificherebbe solo con l’operatività dell’investitura commissariale (o, per dirla diversamente, dopo il suo insediamento) che attuerebbe il definitivo trasferimento del munus pubblico dall’ente, che ne è titolare per legge, a quello che ne diviene titolare in ragione della sentenza del giudice amministrativo[44].
Seguendo un terzo orientamento, meno diffuso nella giurisprudenza più recente, la competenza commissariale rimarrebbe concorrente con quella dell’amministrazione che continuerebbe ad operare nell’ambito delle attribuzioni che la legge le riconosce e che verrebbero estinte con l’insediamento del commissario[45].
Esposti i termini della questione, la Sezione IV prende motivatamente posizione a favore della tesi della competenza concorrente dell’amministrazione e del commissario, tesi che troverebbe conferma in una serie di principi (anche di rilievo costituzionale), tra cui il principio di legalità in connessione con l’art. 97 cost., il principio di certezza dei rapporti giuridici e il principio di responsabilità dei titolari dei pubblici uffici in connessione con l’art. 28 cost.[46].
È ben vero che nell’ordinanza di remissione il quesito riguarda l’interrogativo “se l’amministrazione possa provvedere tardivamente rispetto al termine fissato dal giudice amministrativo, fino a quando il commissario ad acta eserciti il potere conferitogli”. Il potere concorrente di commissario ad acta e pubblica amministrazione riguarderebbe il momento antecedente e non successivo all’adozione dell’atto commissariale come nel caso di specie. Ed è altrettanto vero che il potere di provvedere in prima istanza non è assimilabile al potere di provvedere in autotutela: il potere di autotutela, per esempio, può essere esercitato nei confronti del silenzio assenso, situazione in cui il potere della pubblica amministrazione di agire è spirato, ma in tal caso la possibilità di agire in autotutela è espressamente attribuita alla pubblica amministrazione dalla legge[47].
Quindi, pur nella consapevolezza della profonda differenza tra le due questioni (permanenza del potere di provvedere della pubblica amministrazione dopo la nomina del commissario e annullabilità in autotutela degli atti commissariali) pare di poter affermare che, qualora fosse accolta l’impostazione della Sezione rimettente prevedente la competenza concorrente di commissario e amministrazione sostituita, tale circostanza potrebbe riaprire qualche dubbio a favore della sussistenza di un qualche potere da parte dell’amministrazione sostituita sugli atti commissariali. Infatti, il riconoscere la persistenza di un potere dell’amministrazione di agire anche dopo la nomina del commissario ad acta sembrerebbe “ritagliare” uno spazio di azione alla pubblica amministrazione sostituita i cui confini (estensibili fino all’annullamento in autotutela degli atti commissariali stessi?) non appaiono al momento di certa delimitazione.
6. Alcune brevi considerazioni conclusive.
La sentenza in commento, che si inserisce senza soluzione di continuità nel solco della più recente giurisprudenza sul tema, nega alla pubblica amministrazione sostituita il potere di autotutela sugli atti commissariali attraverso il seguente impianto concettuale: 1) il commissario ad acta nominato dal giudice è un organo ausiliario dello stresso e non un organo straordinario dell’amministrazione; 2) gli atti commissariali non sono geneticamente riconducibili all’ordinario esercizio della potestà amministrativa, ma all’attività del giudice amministrativo investito della questione; 3) l’amministrazione non può agire in autotutela avverso atti che non siano stati emessi da essa stessa almeno con riferimento all’esercizio del potere di annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies, l. n. 241/1990; 4) gli atti del commissario ad acta non possono che essere sindacati dal giudice amministrativo che ha nominato il commissario, come testualmente previsto dalle disposizioni codicistiche.
Pare opportuno evidenziare, però, come la sussistenza di poteri di secondo grado in capo all’amministrazione sostituita resti comunque legata (rectius condizionata) alla qualificazione che si ritenga di dare alla figura del commissario ad acta e al regime giuridico dei suoi atti. Infatti, pur essendo la più recente giurisprudenza orientata a riconoscere il carattere giurisdizionale all’attività del commissario, bisogna comunque segnalare che tale assioma non appare così granitico, soprattutto nell’ambito del giudizio avverso il silenzio[48].
In ragione di un tanto, sarebbe quantomai auspicabile che l’Adunanza plenaria, nel risolvere la appena sollevata questione sulla permanenza del potere di provvedere della pubblica amministrazione dopo la nomina del commissario, decidesse di incidentalmente di indagarne funditus la natura di quest’organo e il rapporto che lo lega all’amministrazione sostituita nell’ambito del giudizio avverso il silenzio, per poter risolvere “definitivamente” anche la questione dell’autotutela sui provvedimenti commissariali.
Ad ogni modo, pare potersi affermare che il potere di autotutela, anche a prescindere dal tipo di rapporto che lega il commissario all’amministrazione e dalla qualificazione giuridica da attribuire agli atti commissariali (quali atti amministrativi o giurisdizionali), sia un potere che mal si attaglia ad essere esercitato dalla pubblica amministrazione sostituita dal commissario ad acta. Questo poiché la ratio dei poteri di secondo grado ad esito eliminatorio è quella di consentire alla pubblica amministrazione titolare del potere di intervenire su di un proprio precedente provvedimento e non di contestare un provvedimento amministrativo aulinde adottato, anche se in propria vece. Per la contestazione degli atti commissariali, infatti, l’ordinamento prevede diversi strumenti di tutela giurisdizionale (reclamo o giudizio autonomo) a seconda dei soggetti potenzialmente pregiudicati dagli stessi (parti del giudizio o soggetti terzi), non venendosi a creare un vuoto di tutela per la pubblica amministrazione che voglia contestare i provvedimenti commissariali, dovendosi ritenere superata dal codice del processo amministrativo quella giurisprudenza (già minoritaria) che negava la legittimazione della pubblica amministrazione ad impugnare gli stessi in quanto atti propri.
***
[1] Cons. St., Sez. IV, 18 agosto 2021, n. 2335, in www.giustizia-amministrativa.it.
[2] T.A.R. Molise (Campobasso), Sez. I, 18 maggio 2017, n. 185, in www.giustizia-amministrativa.it.
[3] Il provvedimento del commissario ad acta aveva ad oggetto il rilascio di un permesso di costruire mai concesso dall’amministrazione rimasta inerte e avverso la quale era stato presentato ricorso avverso il silenzio. Detto commissario è stato nominato dal medesimo T.A.R. con sentenza non definitiva T.A.R. Molise (Campobasso), Sez. I, 4 dicembre 2015, n. 452, in www.giustizia-amministrativa.it.
[4] Cons. St., Sez. IV, 15 settembre 2017, n. 3860, in www.giustizia-amministrativa.it.
[5] Sulla figura del commissario ad acta si rinvia ai contributi di: D. VAIANO, Il commissario ad acta nel sistema dei giudizi di ottemperanza, Roma, 1996; G. ORSONI, Il commissario ad acta, Padova, 2001; A. CIOFFI, Sul regime degli atti del commissario ad acta nominato dal giudice dell’ottemperanza, in I Tribunali Amministrativi Regionali, 2001, 1, II, p. 1 ss.; V. CAPUTI JAMBRENGHI, Commissario ad acta, in Enc. giur., Agg., Vol. VI, Milano, 2002, p. 284 ss.; S. D’ANTONIO, Il commissario ad acta nel processo amministrativo: qualificazione dell’organo e regime processuale, Napoli, 2012; S. PIGNATARO, Il commissario ad acta nel quadro del processo amministrativo, Bari, 2019.
[6] Sul giudizio di ottemperanza in generale, tra i moltissimi contributi, si segnalano senza alcuna pretesa di esaustività: F.G. SCOCA, Aspetti processuali del giudizio di ottemperanza, in AA.VV, Il giudizio di ottemperanza (Atti del XXVII Convegno di Scienza dell’amministrazione di Varenna), Milano, 1983; R. VILLATA, Riflessioni in tema di giudizio di ottemperanza ed attività successiva alla sentenza di annullamento, in Dir. proc. amm., n. 3/1989, p. 369 ss.; A. TRAVI, L’esecuzione della sentenza, in S. CASSESE (a cura di), Trattato di diritto amministrativo - Diritto amministrativo speciale, Vol. V, Milano, 2003, p. 4605 ss.; C.E. GALLO, Ottemperanza (giudizio di), in Enc. giur., Milano, 2008, Annali, II, p. 818 ss.; G. MARI, Giudice amministrativo ed effettività della tutela, Napoli, 2013; M. SANINO, Il giudizio di ottemperanza, Torino 2014; S. TARULLO, Ottemperanza (giudizio di), in Dig. disc. pubbl., Agg., Torino, 2017, p. 559 ss.; F. MANGANARO, Il giudizio di ottemperanza come rimedio alle lacune dell’accertamento, in F. FRANCARIO - M.A. SANDULLI (a cura di), La sentenza amministrativa ingiusta ed i suoi rimedi, Napoli, 2018, p. 119 ss.; F. FRANCARIO, Il giudizio di ottemperanza. Origini e prospettive, in Il Processo, n. 3/2018, p. 171 ss.
[7] A. DAIDONE - F. PATRONI GRIFFI, Artt. 112-115, in G. MORBIDELLI (a cura di), Codice della giustizia amministrativa, Milano, 2015, p. 1072.
[8] M. CLARICH, Il giudicato e l’esecuzione, in A. SANDULLI (a cura di), Diritto processuale amministrativo, Vol. 7, in S. CASSESE (diretto da), Corso di diritto amministrativo, Milano, 2007, p. 313.
[9] Per un’approfondita ricostruzione del dibattito si rinvia a S. PIGNATARO, op. cit., p. 65 ss.
[10] Corte cost., 12 maggio 1977, n. 75, in Giur. it., 1978, I, p. 980 ss.
[11] Cons. St., Ad. Plen., 14 luglio 1978, n. 23, in Giur. it., 1979, III, p. 26 ss. Per un commento alla pronuncia si segnala F.G. SCOCA, Sentenze di ottemperanza e loro appellabilità, in Foro it., 1979, III, p. 4 ss.
[12] In tal senso in dottrina si sono pronunciati tanti autorevoli studiosi tra i quali si segnala M. NIGRO, Il giudicato amministrativo e il processo d'ottemperanza, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1981, p. 115.
[13] Tale orientamento è stato sostenuto da Cass. civ., SS.UU., 19 marzo 1999, n. 9709, in Giust. civ., 199, I, p. 3347 ss., con nota di M.A. VISCA, Giurisdizione della Corte dei conti in tema di responsabilità amministrativo-contabile del commissario ad acta, ivi. Tra le sentenze amministrative (non numerosissime) che hanno seguito tale impostazione vedasi: C.G.A.R.S., 17 giugno 1982, n. 24, in Riv. amm., 1982, III, p. 644 ss.; Cons. St., Sez. V, 3 marzo 1988, n. 125, in Foro amm., 1988, p. 1464; e, più di recente, T.A.R. Campania (Napoli), 10 marzo 2009, n. 1363, in Foro amm. - T.A.R., 2009, p. 830. In dottrina, a favore di questa tesi, si sono schierati: G. VACIRGA, L’impugnazione dei provvedimenti adottati dal commissario giudiziale ad acta, in Foro amm., 1982, I, p. 258-259; A. IANNOTTA, La natura giuridica del commissario ad acta e il regime di impugnazione dei suoi atti, in I Tribunali amministrativi regionali, 1993, II, p. 414; G. ORSONI, op. cit., p. 99.
[14] Come si dirà poi, il codice del processo amministrativo, all’art. 114, comma 6, ha esplicitamente riconosciuto il potere di presentare reclamo alle “parti nei cui confronti si è formato il giudicato” e, quindi, anche alla pubblica amministrazione sostituita dal commissario ad acta.
[15] Sul riconoscimento del potere di autotutela dell’amministrazione nei confronti degli atti commissariali vedasi T.A.R. Campania (Napoli), 10 marzo 2009, n. 1363, cit.
[16] L’elaborazione di tale teoria si deve in primis alla giurisprudenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, con le sentenze C.G.A.R.S., 25 febbraio 1981, n. 1, in Cons. di St., 1981, I, p. 188 e C.G.A.R.S., 21 dicembre 1982, n. 92, in Foro amm., 1983, p. 372. Tra la dottrina che ha condiviso tale ricostruzione si segnalano: S. GIACCHETTI, Il giudizio d'ottemperanza nella giurisprudenza del Consiglio di giustizia amministrativa, in Giur. amm. sic., 1988, II, p. 36 ss. e in www.lexitalia.it (par. 6); L. MAZZAROLLI, Il giudizio di ottemperanza oggi: risultati concreti, in Dir. proc. amm., 1990, p. 253; C.E. GALLO, op. cit., p. 835.
[17] M. CLARICH, L’effettività della tutela nell’esecuzione delle sentenze del giudice amministrativo, in Dir. proc. amm., n. 3/2018, p. 540.
[18] In questi termini si segnalano: Cons. St., Sez. VI, 30 dicembre 2004, n. 8275, in Foro amm. - C.d.S., 2004, p. 3607; Cons. St., Sez. V, 28 dicembre 2011, n. 6953, in Urb. e app., n. 5/2012, p. 561 ss., con commento di M. ANDREIS, Commissario ad acta, regime dei suoi atti e nuovo codice del processo amministrativo, ivi, p. 565 ss.
[19] L’art. 21 c.p.a., rubricato “Commissario ad acta” prevede che “Nell’ambito della propria giurisdizione, il giudice amministrativo, se deve sostituirsi all’amministrazione, può nominare come proprio ausiliario un commissario ad acta. Si applica l'articolo 20, comma 2”. Per un commento a tale norma si rinvia a F.G. SCOCA, Commento all’art. 21, V. LOPILATO - A. QUARANTA (a cura di), Il processo amministrativo, Milano, 2011, p. 231 ss. Inoltre, l’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a. ha prescritto che “Il giudice [dell’ottemperanza], in caso di accoglimento del ricorso: … d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta”.
[20] In tal senso, tra le tante, si segnalano: Cons. St., Sez. IV, 13 gennaio 2015, n. 52, Cons. St., Sez. VI, 15 settembre 2015, n. 4299, Cons. St. Sez. IV, 4 dicembre 2017, n. 5667, Cons. St., Sez. V, 27 novembre 2018, n. 6724, Cons. St., Sez. V, 21 maggio 2018, n. 3039, tutte in www.giustizia-amministrativa.it.
[21] Tale dicotomia è delineata in maniera chiara da P.M. VIPIANA, L’ottemperanza al giudicato amministrativo fra l’attività del commissario ad acta e quella dell’amministrazione “commissariata”, in Urb. e app., n. 10/2015, p. 1055.
[22] Secondo l’art. 114, comma 6, c.p.a. “Il giudice conosce di tutte le questioni relative all’ottemperanza, nonché, tra le parti nei cui confronti si è formato il giudicato, di quelle inerenti agli atti del commissario ad acta. Avverso gli atti del commissario ad acta le stesse parti possono proporre, dinanzi al giudice dell’ottemperanza, reclamo, che è depositato, previa notifica ai controinteressati, nel termine di sessanta giorni. Gli atti emanati dal giudice dell’ottemperanza o dal suo ausiliario sono impugnabili dai terzi estranei al giudicato ai sensi dell’articolo 29, con il rito ordinario”.
[23] In questi termini Cons. St., Sez. V, 13 gennaio 2015, n. 52, in Urb. e app., n. 5/2015, p. 1049 ss, con nota di P.M. VIPIANA, op. cit., ivi, p. 1053 ss.
[24] P.M. VIPIANA, op.cit., p. 1055, risponde negativamente a tale quesito affermando che “l’impugnabilità di un atto davanti al giudice amministrativo non ne implica necessariamente la natura di atto amministrativo” e che “non pare sostenibile la duplice natura degli atti commissariali”.
[25] Sul tema si segnalano i contributi di: L. BERTONAZZI, Il giudizio sul silenzio, in B. SASSANI – R. VILLATA (a cura di), Il codice del processo amministrativo. Dalla giustizia amministrativa al diritto processuale amministrativo, Torino, 2012, p. 986 ss.; G. MARI, L’azione avverso il silenzio, in M.A. SANDULLI (a cura di), Il nuovo processo amministrativo, Vol. I, Milano, 2013, p. 250 ss.; M. RAMAJOLI, Forme e limiti della tutela giurisdizionale contro il silenzio inadempimento, in Dir. proc. amm., n. 3/2014, p. 709 e ss.; A. CIOFFI, Il dovere di provvedere nella legge sull’azione amministrativa, in A. ROMANO (a cura di), L’Azione amministrativa, Torino, 2016, p. 134 ss.; F. SCALIA, Profili problematici del rito sul silenzio dell’amministrazione nella prospettiva dell’effettività e pienezza della tutela, in federalismi.it, n. 10/2016; S. CAREGGI, L’esecuzione della pronuncia silenziosa, in Giustizia insieme, 1° luglio 2020.
[26] In questi termini si esprime S. CAREGGI, op. cit. Secondo Cons. St. Sez. VI, 25 giugno 2007, n. 3602, in www.giustizia-amministrativa.it, si parla di un’ottemperanza “anomala o speciale” in quanto “si prescinde dal passaggio in giudicato della sentenza, e, soprattutto si ammette l’intervento del commissario nell’ambito del medesimo processo, senza più bisogno di un ricorso ad hoc, essendo sufficiente una semplice istanza al giudice che ha dichiarato l’illegittimità del silenzio” e in quanto l’attività del commissario “può atteggiarsi come attività di pura sostituzione, in un ambito di piena discrezionalità, non collegata alla decisione se non per quanto attiene al presupposto dell’accertamento della prolungata inerzia dell’amministrazione”. Il Consiglio di Stato evidenzia anche che “se per il commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato, prevale la tesi secondo cui si tratta di un organo ausiliario del giudice (tesi che ha ricevuto anche l’importante avallo dell’Adunanza plenaria n. 23 del 1978), il dibattito è, invece, tutt’ora aperto per quella speciale figura di commissario ad acta nominato per porre rimedio alla persistente inerzia dell’Amministrazione”.
[27] Non è questa la sede per darne un’adeguata ricostruzione delle diverse posizioni della giurisprudenza e della dottrina, per la quale si rinvia al contributo di F. SCALIA, op. cit.
[28] In questi termini si esprime Cons. di St., Sez. VI, 28 gennaio 2016, n. 338, in www.giustizia-amministrativa.it. Secondo tale pronuncia il commissario ad acta sarebbe un organo sostitutivo dell’amministrazione e non un mero ausiliario del giudice in quanto “l’attività del commissario ad acta, posta in essere in esecuzione della sentenza che rimuova la situazione di inerzia imputabile alla pubblica amministrazione, non si limita - come nel vero e proprio giudizio di ottemperanza - al completamento e all’attuazione del dictum giudiziale recante direttive conformative dell’attività amministrativa, ma si atteggia come attività di pura sostituzione nell’esercizio del potere proprio dell’amministrazione soccombente ed è collegata alla pronuncia giudiziale solo per quanto attiene al presupposto della prolungata inerzia dell’amministrazione medesima; … l’attività del commissario ad acta, munito di piena autonomia decisoria, appare, dunque, qualificabile come sostitutiva rispetto a quella dell’amministrazione, piuttosto che di stretto ausilio al potere esecutivo del giudice, il quale potrà esclusivamente vagliare l’effettivo adempimento finale da parte del commissario in relazione all’ordine contenuto nella pronuncia giudiziale”.
[29] T.A.R. Calabria (Catanzaro), Sez. I, 26 gennaio 2017, n. 82, in www.giustizia-amministrativa.it. In senso sostanzialmente analogo si esprime anche la recente sentenza T.A.R. Puglia (Bari), Sez. III, 18 settembre 2020, n. 1180, in www.giustizia-amministrativa.it.
[30] Cons. St., Sez. IV, 22 ottobre 2019, n. 7172, in www.giustizia-amministrativa.it. Secondo tale pronuncia deve escludersi che il commissario ad acta, nominato nell’ambito del giudizio avverso il silenzio, possa essere legato all’ente da una relazione inter-organica; quindi, le parti “possono, e debbono, contestare gli atti del commissario ad acta soltanto attraverso il rimedio processuale disciplinato dal citato art. 114, comma 6, secondo periodo, mentre l’attivazione di un giudizio secondo il rito ordinario è riservata esclusivamente ai terzi estranei al giudicato”.
[31] Cons. St., Sez. VI, 11 agosto 2020, n. 5006, in www.giustizia-amministrativa.it.
[32] T.A.R. Campania (Napoli), Sez. VI, 13 settembre 2006, n. 8072, in www.giustizia-amministrativa.it. In senso sostanzialmente analogo vedasi anche T.A.R. Veneto (Venezia), Sez. I, 1° febbraio 2011, n. 188, in www.giustizia-amministrativa.it.
[33] In tal senso vedasi anche la recente Cons. St., Sez. VI, 11 agosto, 2020, n. 5006, cit. Depone, invece per l’annullabilità dei provvedimenti commissariali T.A.R. Campania (Napoli), 10 marzo 2009, n. 1363, cit.
[34] V. CAIANIELLO, Manuale di diritto processuale amministrativo, Torino, 2013, p. 1010.
[35] S. PIGNATARO, op. cit., p. 234-235.
[36] Sul tema si rinvia su tutti al contributo di A. POLICE, Il dovere di concludere il procedimento e il silenzio inadempimento, in M.A. SANDULLI (a cura di), Codice dell’azione amministrativa, 2017, p. 273 ss.
[37] In sostanza non c’è un atto amministrativo emanato dallo stesso ente (o da un ente sotto-ordinato) su cui la pubblica amministrazione possa esercitare il potere di annullamento d’ufficio secondo il paradigma normativamente previsto per tale potere di secondo grado dall’art. 21-nonies, l. n. 241/1990. Per un inquadramento sui poteri di autotutela si segnala M. IMMORDINO, I provvedimenti amministrativi di secondo grado, in F.G. SCOCA (a cura di), Diritto amministrativo, Torino, 2019, p. 301 ss. Sul potere di annullamento d’ufficio, che rileva nel caso di specie, si rinvia a C. DEODATO, L’annullamento d’ufficio, in M.A. SANDULLI (a cura di), Codice dell’azione amministrativa, 2017, p. 1173 ss.
[38] In tal senso V. CAIANIELLO, op. cit., p. 1010.
[39] Secondo l’art. 117, comma 4, c.p.a. “Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'esatta adozione del provvedimento richiesto, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario”.
[40] Il Collegio precisa che lo strumento del reclamo, previsto dall’art. 117, comma 4, c.p.a., evita che si venga a creare un vuoto di tutela per la pubblica amministrazione sostituita, la quale potrà sempre contestare gli atti commissariali presentando apposito reclamo al giudice competente.
[41] Per un approfondimento del dibattito sulla questione antecedente alla recente rimessione della questione all’Adunanza Plenaria si rinvia a S. PIGNATARO, op. cit., p. 223 ss.
[42] Cons. St., Sez. IV, 10 novembre 2020, n. 6925, in www.giustizia-amministrativa.it. Per un commento all’ordinanza di rimessione si vedano A. SCOGNAMIGLIO, Silenzio della PA e regime giuridico del provvedimento sopravvenuto alla nomina del commissario ad acta, in Giustizia insieme, 19 gennaio 2021 e G. BROLLO, Gli effetti della nomina del commissario ad acta nel giudizio sul silenzio: permane o si consuma il potere di provvedere dell’Amministrazione silente?, in www.giustamm.it, n. 12/2020.
[43] In relazione a tale orientamento il Collegio precisa che “Andrebbe verificato comunque se tale tesi, espressa con riferimento al commissario nominato all’esito del giudizio di ottemperanza, si potrebbe applicare anche all’ipotesi del commissario nominato per provvedere in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione”. In tal senso viene richiamata la sentenza Cons. St., Sez. V, 10 marzo 1989, n. 165, in www.giustizia-amministrativa.it.
[44] Vedasi ex multis: Cons. St., Sez. V, 5 giugno 2018, n. 3378, Cons. St., Sez. IV, 22 marzo 2017, n. 1300 e Cons. St., Sez. IV, 9 novembre 2015, n. 5081, tutte in www.giustizia-amministrativa.it. Nell’ambito di questo secondo orientamento viene anche citata la pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 7 del 9 maggio 2019 la quale (pur non occupandosi funditus della questione) al par. 5.6 ha previsto che “L’insediamento del commissario ad acta … nella sua duplice veste di ausiliario del giudice e di organo straordinario dell'amministrazione inadempiente surrogata, priva quest’ultima della potestà di provvedere”.
[45] Per questo orientamento vengono richiamate le pronunce: Cons. St., Sez. IV, 10 maggio 2011, n. 2764, Cons. St., Sez. V, 21 novembre 2003, n. 7617, Cons. St., Sez. V, 8 luglio 1995, n. 1041, tutte in www.giustizia-amministrativa.it.
[46] A. SCOGNAMIGLIO, op. cit., par. 2. Si rinvia poi anche al par. 5 del medesimo contributo per un’interessante (e condivisibile) analisi sul metodo e sulle conclusioni dell’ordinanza di rimessione.
[47] L’art. 20, comma 3, l. n. 241/1990 prevede espressamente che “Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l’amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies”.
[48] Al paragrafo n. 24.3 dell’ordinanza di rimessione Cons. St., 10 novembre 2020, n. 6925, cit. viene posto il dubbio se l’impostazione dell’Adunanza plenaria n. 1/2002, prevedente l’imputabilità degli atti commissariali all’amministrazione sostituita (e non al giudice), sia da intendersi (o meno) superata dall’entrata in vigore dell’art. 117, comma 4, c.p.a. Sul punto, in questa sede, ci si limita a precisare che la sentenza Cons. St., Ad. Plen., 9 gennaio 2002, n. 1, in Dir. e giust., n. 7/2002, p. 54 ss., è stata emanata in un contesto normativo in cui i poteri cognitori e decisori del giudice nel giudizio avverso il silenzio erano diversi rispetto a quelli attualmente previsti dal codice del processo amministrativo.