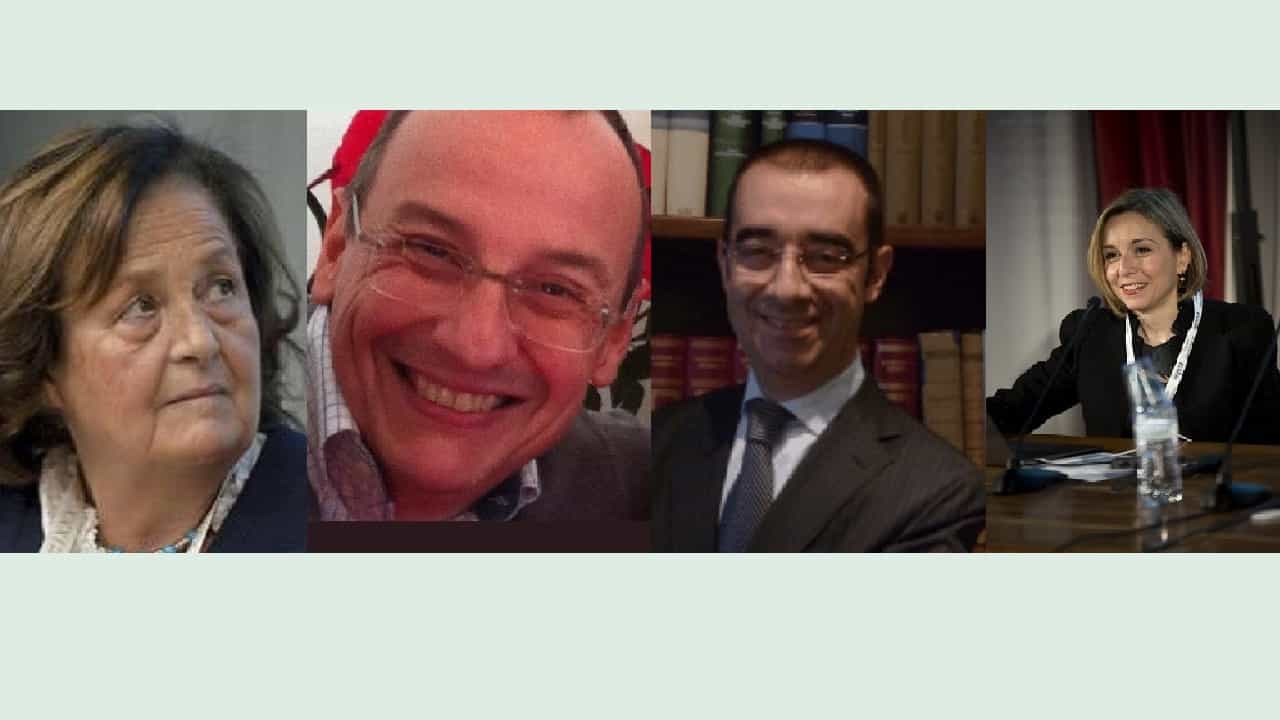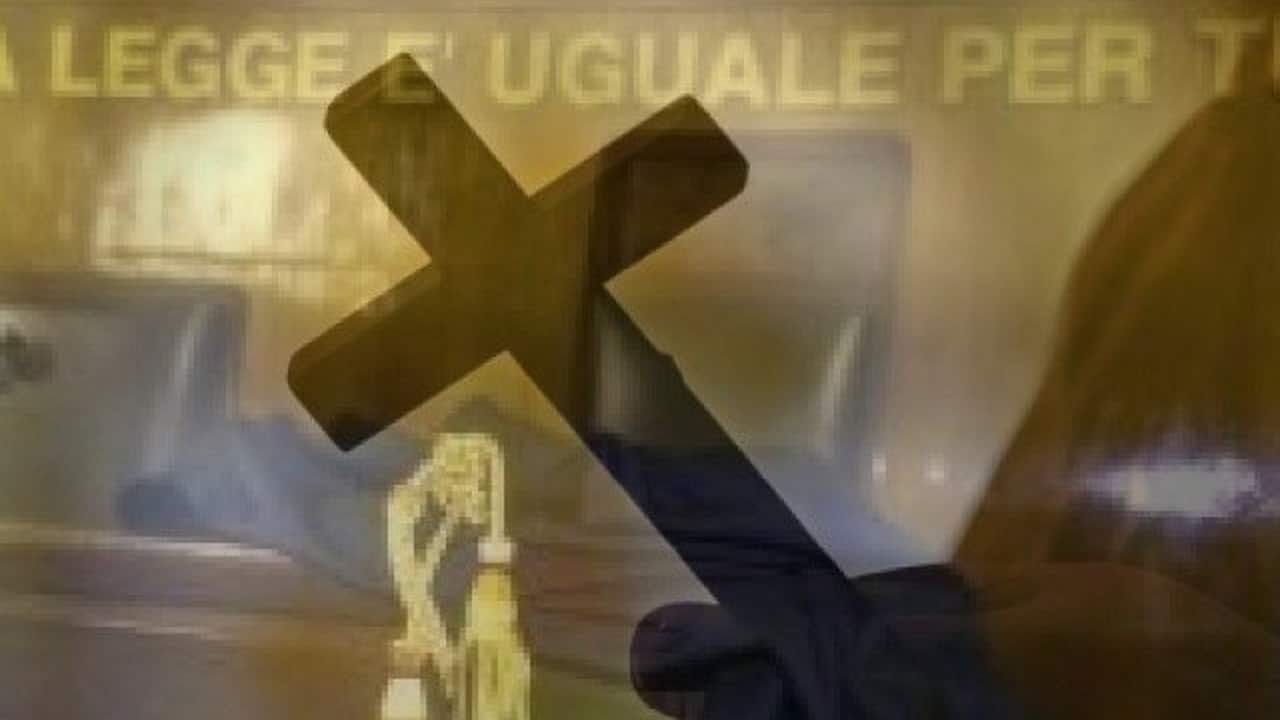Sommario: 1. La sentenza della Corte costituzionale n. 132 del 2025 e l’ordinanza del Tribunale di Firenze del 15 ottobre 2025 - 2. Esiste il diritto all’aiuto al suicidio? - 3. Conclusioni.
1. La sentenza della Corte costituzionale n. 132 del 2025 e l’ordinanza del Tribunale di Firenze del 15 ottobre 2025
Il Tribunale di Firenze, nell’ambito di un procedimento promosso in via d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c. con il quale si era chiesto dalla ricorrente accertarsi il proprio diritto alla autodeterminazione terapeutica mediante la somministrazione di un farmaco da parte di un terzo, con ordinanza del 30 aprile 2025 sollevava l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 579 c.p. nella parte in cui non esclude la punibilità di colui che, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017, attui materialmente la volontà suicidaria liberamente formatasi di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ritenga intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, quando la stessa persona, per impossibilità fisica in quanto priva dell’uso degli arti e per l’assenza di strumentazione idonea, non sia in grado di procedervi autonomamente o quando comunque le modalità alternative di autosomministrazione disponibili non siano dalla medesima accettate sulla base di una scelta motivata e non irragionevole. Evidenziava il giudice rimettente che il divieto posto dall’art. 579 c.p., nei casi in cui sussistessero tutte le garanzie previste per l’aiuto al suicidio, per l’assolutezza della sua portata, analogamente alla fattispecie di cui all’art. 580 c.p. vigente prima della sentenza n. 242 del 2019, comprimeva in modo sproporzionato il diritto di autodeterminazione del paziente e generava un’irragionevole disparità di trattamento giuridico tra le persone che siano fisicamente in grado di autosomministrarsi il farmaco e quelle deprivate di tale possibilità, e quindi in condizioni cliniche peggiori rispetto alle prime.
Con sentenza n. 132 del 2025[1] la Corte costituzionale dichiarava l’inammissibilità delle proposte questioni di costituzionalità dell’art. 579 c.p. per non avere il giudice a quo adeguatamente motivato circa la non reperibilità di strumenti di autosomministrazione del farmaco letale per persone affette, come la ricorrente, da sclerosi multipla primaria progressiva, così rendendo imprecisa la descrizione della fattispecie e quindi insufficiente la motivazione sulla rilevanza delle questioni poste. La Consulta riteneva insufficienti le indagini svolte da detto giudice, il quale si era limitato a prendere atto delle ricerche di mercato operate da una struttura operativa del Servizio sanitario regionale, ed evidenziava che le verifiche concernenti l’esistenza della strumentazione idonea e, in caso affermativo, la concreta disponibilità della stessa avrebbero richiesto il coinvolgimento di organismi specializzati operanti, col necessario grado di autorevolezza, a livello centrale, come, quanto meno, l’Istituto superiore di sanità, organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale. Solo l’accertamento, a seguito di più approfondite indagini, della indisponibilità di una strumentazione compatibile con le condizioni di salute della ricorrente avrebbe consentito di scrutinare la legittimità costituzionale dell’art. 579 c.p., sulla base dei parametri indicati dalla stessa Corte nelle sentenze n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024.
Dopo la riassunzione del giudizio il Tribunale, in esito al supplemento di istruttoria sollecitato dalla Consulta, con ordinanza del 15 ottobre 2025[2] accertava la reperibilità di strumentazioni con puntamento oculare utilizzabili in combinazione con una pompa infusionale, che sebbene non espressamente ideate per l’autosomministrazione del farmaco letale potevano essere adattate allo scopo, consentendo alle persone con gravi disabilità motorie di darsi la morte autoiniettandosi per via endovenosa detto farmaco. Rilevava altresì che la competente Commissione medica aveva verificato la sussistenza nella specie di tutte le condizioni prescritte dalle precedenti pronunzie della Corte costituzionale per dare luogo al suicidio assistito ed ordinava alla competente ASL di concludere entro 15 giorni la fase esecutiva della procedura di suicidio medicalmente assistito in conformità alle prescrizioni contenute nelle sentenze della Corte costituzionale n. 242 del 2019 e n. 132 del 2025 e quindi di mettere a disposizione della ricorrente i farmaci per la somministrazione per via endovenosa individuati dalla Commissione medica multisciplinare, di fornire la strumentazione utile alla autosomministrazione ovvero di mettere a disposizione, previa verifica della funzionalità, interazione e compatibilità dei dispositivi rispetto alle finalità della procedura e alle condizioni cliniche della paziente, una pompa infusionale con un sensore di comando attivabile mediante uno strumento di comunicazione per paziente tetraplegica, infine di mettere il farmaco e la strumentazione così individuata a disposizione del medico di fiducia, il quale avrebbe prestato la propria assistenza se e quando la ricorrente avesse deciso di procedere in tal senso.
È evidente l’impegno del giudicante nell’aderire alle indicazioni della Consulta, aprendosi alla sperimentazione di tecniche del tutto innovative, consistenti nell’utilizzazione di dispositivi diversi combinabili tra loro, ritenuti in grado di garantire l’autosomministrazione del farmaco ad un soggetto assolutamente privo della capacità di movimento, e quindi sollecitando soluzioni ancora inesplorate collegate agli sviluppi della scienza medica e della tecnologia.
Come risulta dall’esposizione che precede, la decisione di inammissibilità per difetto di motivazione della questione proposta con riguardo alla verifica della reperibilità della necessaria strumentazione aveva comportato che la Corte delle leggi evitasse di pronunciare sul merito della conformità a Costituzione dell’art. 579 c.p., della quale il giudice rimettente aveva dubitato. Dunque nessuna apertura o chiusura sul punto della punibilità senza eccezioni dell’omicidio del consenziente , ma ancora una volta una messa a fuoco delle condizioni previste per accedere al suicidio assistito, salva restando la possibilità di proporre nuovamente la questione di costituzionalità della norma disciplinante l’eutanasia attiva.
È evidente la torsione operata dalla Corte costituzionale nel ricondurre la questione all’art. 580 c.p. attraverso la sollecitazione ad approfondire la ricerca di soluzioni idonee a consentire il suicidio, piuttosto che l’omicidio della donna, e quindi la propensione a non uscire dall’area dell’aiuto al suicidio riportando la condotta del terzo nella sfera della non punibilità alle condizioni di cui alla propria sentenza n. 242 del 2019, piuttosto che entrare nel perimetro del più grave reato di omicidio del consenziente ed introdurre una analoga deroga all’applicazione dell’art. 579 c.p., dandosi carico del vulnus già emendato per l’aiuto al suicidio.
2. Esiste un diritto all’aiuto a morire?
Come è noto, una delle questioni più delicate, non chiarite in passato dalla Corte costituzionale, riguardava la configurabilità o meno del diritto, azionabile giudizialmente, ad essere aiutati a morire. Di un diritto siffatto nelle motivazioni del giudice delle leggi di cui alle pronunce n. 242 del 2019, 235 del 2024 e n. 66 del 2025 non vi è menzione, ed anzi pare doversi escludere l’esistenza, parlando esse solo di richiesta di aiuto e lasciando al medico la facoltà di esaudirla, così riducendo la possibilità di morire in modo conforme alle proprie scelte individuali tramite l’aiuto di terzi a mera libertà di esprimere una istanza non vincolante. Estremamente chiaro sul punto è il passaggio della sentenza n. 242 del 2019 in cui si afferma che la presente declaratoria di illegittimità costituzionale si limita a escludere la punibilità dell’aiuto al suicidio nei casi considerati, senza creare alcun obbligo di procedere a tale aiuto da parte dei medici.
È appena il caso di notare che l’esclusione di un diritto di tale contenuto si contrappone nettamente al reiterato riconoscimento (già espresso nella sentenza della Corte di Cassazione n. 21748 del 2007 sul caso Englaro) del diritto del malato a rifiutare o interrompere tutte le cure, anche quando da tale rifiuto o da tale interruzione possa derivare la morte.
Peraltro nella specie la ricorrente aveva dato per scontata l’esistenza di un diritto siffatto, atteso che aveva chiesto in via cautelare che fosse accertato il proprio diritto fondamentale ad autodeterminarsi nelle scelte terapeutiche in materia di fine vita, nella sua declinazione del diritto di scegliere in modo libero, consapevole e informato, di procedere alla somministrazione del farmaco letale in modalità eteronoma e dunque da parte del personale sanitario, mentre la sua contestuale richiesta di sollevare la questione di costituzionalità dell’art. 579 c.p. era diretta ad ottenere l’affermazione di non punibilità del medico che la sostituisse nell’esercizio del suo diritto di porre termine alla propria vita.
Tenuto conto che la fattispecie in esame è ben diversa da quelle esaminate dal giudice delle leggi con le richiamate decisioni, in quanto non si tratta qui di un processo penale avente ad oggetto l’accertamento della responsabilità dell’autore della condotta di aiuto, ma di un giudizio civile diretto a far valere un diritto di una persona in vita, è evidente che soltanto impostando la domanda ai sensi dell’art. 700 c.p.c. in termini di diritto a morire poteva ravvisarsi non solo la percorribilità della tutela cautelare urgente, ma anche l’incidentalità della questione di costituzionalità relativa alla norma penale ritenuta applicabile.
La Corte costituzionale ha sostanzialmente recepito tale impostazione, facendo in più punti riferimento al diritto di accedere alla procedura ed affermando nella parte conclusiva della motivazione che la persona rispetto alla quale sia stata positivamente verificata la sussistenza di tutte le condizioni indicate nella sentenza n. 242 del 2019 e precisate nella sentenza n. 135 del 2024 ha una situazione soggettiva tutelata, quale consequenziale proiezione della sua libertà di autodeterminazione, e segnatamente ha diritto di essere accompagnata dal Servizio sanitario nazionale nella procedura di suicidio medicalmente assistito, diritto che, secondo i principi che regolano il servizio, include il reperimento dei dispositivi idonei, laddove esistenti, e l’ausilio nel relativo impiego.
È evidente la rilevanza di tale enunciazione, che pur formulata nell’ambito di una pronuncia di inammissibilità per difetto di motivazione, e quindi estranea alla ratio decidendi, tende chiaramente a superare le precedenti posizioni in cui la Corte, ponendosi in una prospettiva esclusivamente penalistica, aveva depenalizzato a determinate condizioni la condotta di chi aiuta al suicidio, senza mai riconoscere un generale diritto di morire: si afferma qui per la prima volta il diritto giudizialmente azionabile di procedere al suicidio assistito, quale espressione della libertà di autodeterminazione, e si ha cura di garantirne l’effettività sancendo l’obbligo del SSN di operare per soddisfarlo.
È importante al riguardo puntualizzare che la Consulta ha affermato l’esistenza del diritto all’aiuto quale consequenziale proiezione della libertà di autodeterminazione, e non già il diritto di autodeterminazione assoluta nelle scelte di fine vita: appaiono pertanto non puntuali le critiche avanzate dai primi commentatori[3] per avere la stessa Corte prodotto uno “scivolamento” verso la violazione della dignità umana in nome dell’autodeterminazione.
Il riconoscimento di un diritto siffatto nel giudizio della Corte appare implicitamente confermato nei passaggi della motivazione in cui sono state rigettate le varie eccezioni di inammissibilità proposte dalle amministrazioni resistenti: il loro rigetto infatti muove dall’implicito presupposto che non fosse più in discussione l’esistenza di un diritto costituzionalmente garantito, ma solo le modalità di esplicazione di esso, e quindi la sua effettività.
Si era anche eccepita l’inammissibilità dell’azione cautelare in quanto funzionale unicamente alla proposizione della questione di costituzionalità, così da risolversi in una ficta lis: la Corte ha sul punto correttamente osservato che l’accertamento chiesto al Tribunale aveva ad oggetto il ruolo causale della condotta del terzo, ricondotto alla fattispecie di cui all’art. 579 c.p., norma censurata nell’incidente di costituzionalità, ma non si limitava ad esso, estendendosi a tutti gli altri requisiti di esercizio del diritto di autodeterminarsi, onde andava negato che l’oggetto del giudizio principale si esaurisse in quello dell’incidentale, con conseguente esclusione della natura fittizia dell’azione cautelare. Ha rilevato inoltre che solo per il tramite della declaratoria di incostituzionalità l’oggetto della domanda civile proposta avrebbe potuto essere conseguito: l’accertamento della illiceità penale o meno della condotta del terzo costituiva pertanto passaggio obbligato per la risoluzione della controversia di cui al giudizio principale.
E tuttavia la declaratoria della Corte sul diritto all’aiuto al suicidio, espressa nei termini innanzi riportati, offre non poche ragioni di perplessità: essa sembra tra l’altro confliggere con quanto nelle precedenti decisioni affermato dalla stessa Consulta in tema di cure palliative, lì dove aveva osservato che il coinvolgimento in un percorso di cure palliative deve costituire un prerequisito della scelta, in seguito, di qualsiasi percorso alternativo da parte del paziente (ordinanza n. 207 del 2018 e sentenza n. 242 del 2019).
Le osservazioni che precedono non esimono dal rilievo, che anzi sollecitano, che ben più lineare sarebbe stato il percorso argomentativo della Corte se la medesima avesse preso atto dell’accertamento in fatto del giudice di merito circa la non disponibilità di strumentazioni utilizzabili dalla ricorrente ed avesse centrato il suo esame sulla conformità a Costituzione dell’art. 579 c.p., valutandone la legittimità sulla base degli stessi parametri che avevano condotto alla decisione di incostituzionalità dell’art. 580 c.p. Per questa via non solo si sarebbe evitata l’accusa di trasformare la natura del giudizio costituzionale come giudizio sulla legittimità di una norma in qualcosa di diverso[4], ma si sarebbe anche posto rimedio a quella disparità di trattamento tra chi è in grado di darsi la morte con l’aiuto di terzi e chi, pur trovandosi nelle stesse condizioni richieste dal giudice delle leggi per rendere non punibile l’aiuto al suicidio, sia privo anche di quel minimo di autonomia che gli consentirebbe, premendo quel pulsante o iniettandosi quel farmaco, di percorrere l’ultimo tratto del cammino verso la fine.
3. Conclusioni
Da quanto innanzi esposto appare in evidenza la necessità e l’urgenza che il Parlamento definisca in termini chiari la situazione giuridica del soggetto che chiede di essere aiutato a morire, dandosi anche carico, in tesi, di garantire l’effettività della tutela e l’esigibilità del diritto attraverso una puntuale disciplina dell’obiezione di coscienza da parte del personale sanitario, istituto sommariamente evocato dalla Corte costituzionale nelle precedenti decisioni. Sono invero evidenti le ricadute che una generalizzata utilizzazione di essa, senza alcuna indicazione sui soggetti, sui tempi e le modalità della sua manifestazione e sulla necessità di predisporre alternative all’interno della struttura sanitaria, potrebbe produrre, rimettendo sostanzialmente nelle mani dei medici l’esercizio del diritto. Purtroppo il testo unificato dei vari disegni di legge attualmente all’esame delle Commissioni Giustizia e Sanità del Senato si distingue per le sue scelte al ribasso rispetto alle indicazioni della Corte delle leggi: esso non solo si muove su un piano incompatibile con il riconoscimento del diritto ad essere aiutato a morire, ma finisce anche per escludere il SSN dal procedimento per accedere al suicidio medicalmente assistito, così lasciando al settore privato la gestione di un settore così delicato.
Eppure la Corte costituzionale aveva riconosciuto al SSN il compito di accertare la sussistenza delle condizioni sostanziali di liceità dell’accesso alla procedura, oltre che di verificare le relative modalità di esecuzione, le quali dovranno essere evidentemente tali da evitare abusi in danno di persone vulnerabili, da garantire la dignità del paziente e da evitare al medesimo sofferenze (così la sentenza n. 242 del 2019), in tal modo attribuendo alla struttura pubblica un ruolo primario e indefettibile.
[1] Annotata da BECCHI, Un commento alla sentenza n. 132 della Corte costituzionale nel giudizio di legittimità dell’art. 579 del Codice penale e una proposta alternativa, in forumcostituzionale.it, 20 agosto 2025; FARRI e AIROMA, Fine vita: la Corte costituzionale smentisce se stessa? in centrostudilivatino.it, 13 agosto 2025.
[2] Per una prima analisi del provvedimento v. GALLO, Fine vita, competenze e Costituzione: nota all’ordinanza del tribunale di Firenze nel caso “ Libera”, in giurisprudenzapenale.com, 22 ottobre 2025.
[3] Cfr. PIERGENTILI, RUGGERI e VARI, Verso l’introduzione dell’eutanasia ope iudicis? (Note minime a margine di un ‘abnorme questione di legittimità costituzionale) , in dirittifondamentali.it, 29 maggio 2025.
[4] Così FARRI e AIROMA, loc.cit.