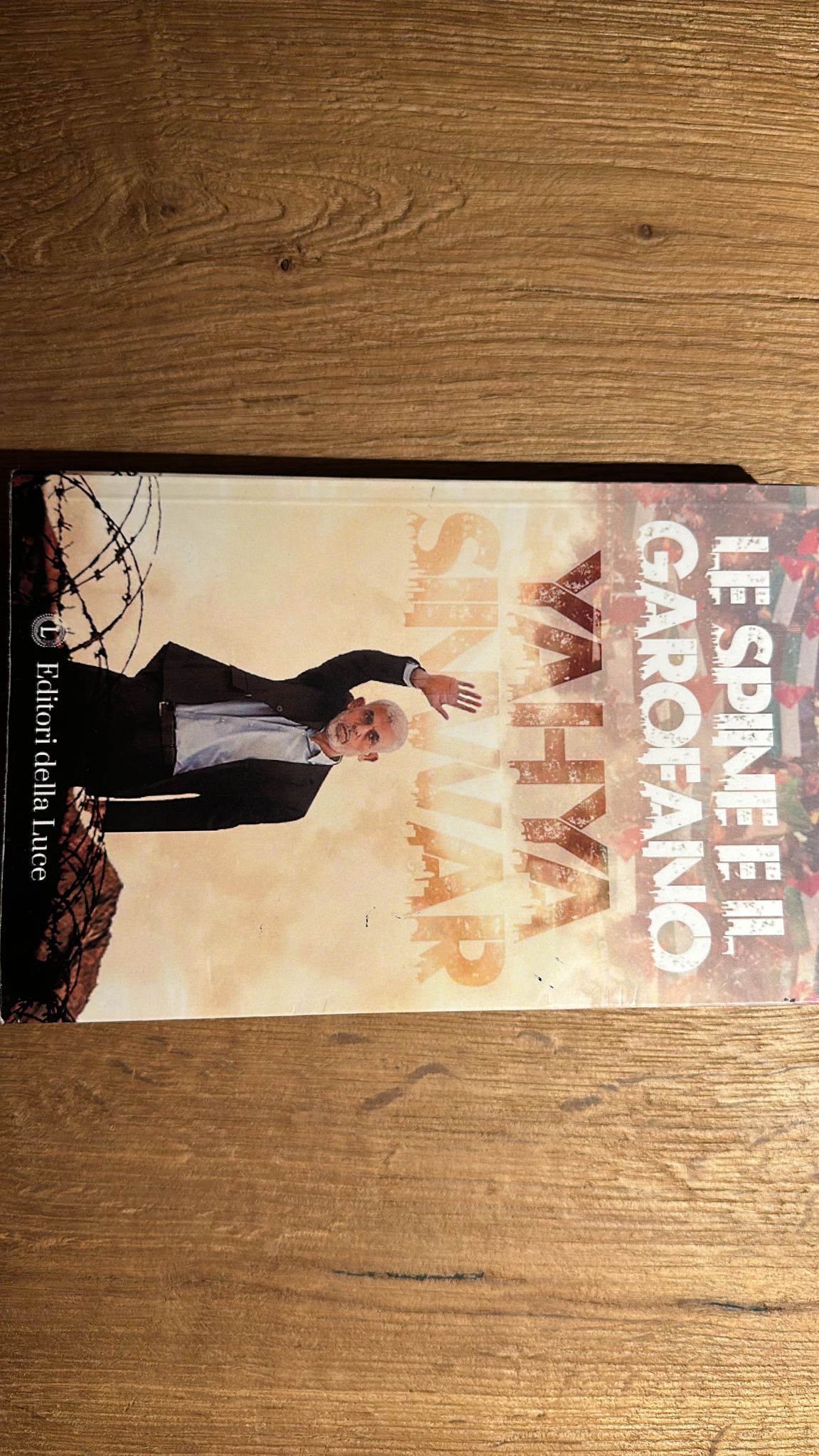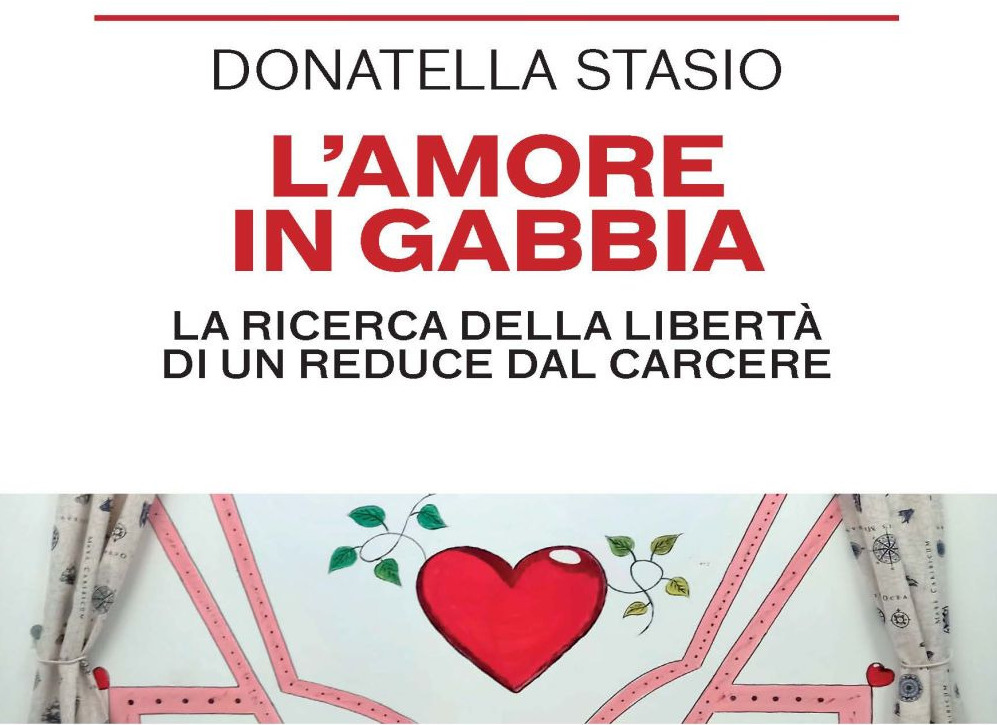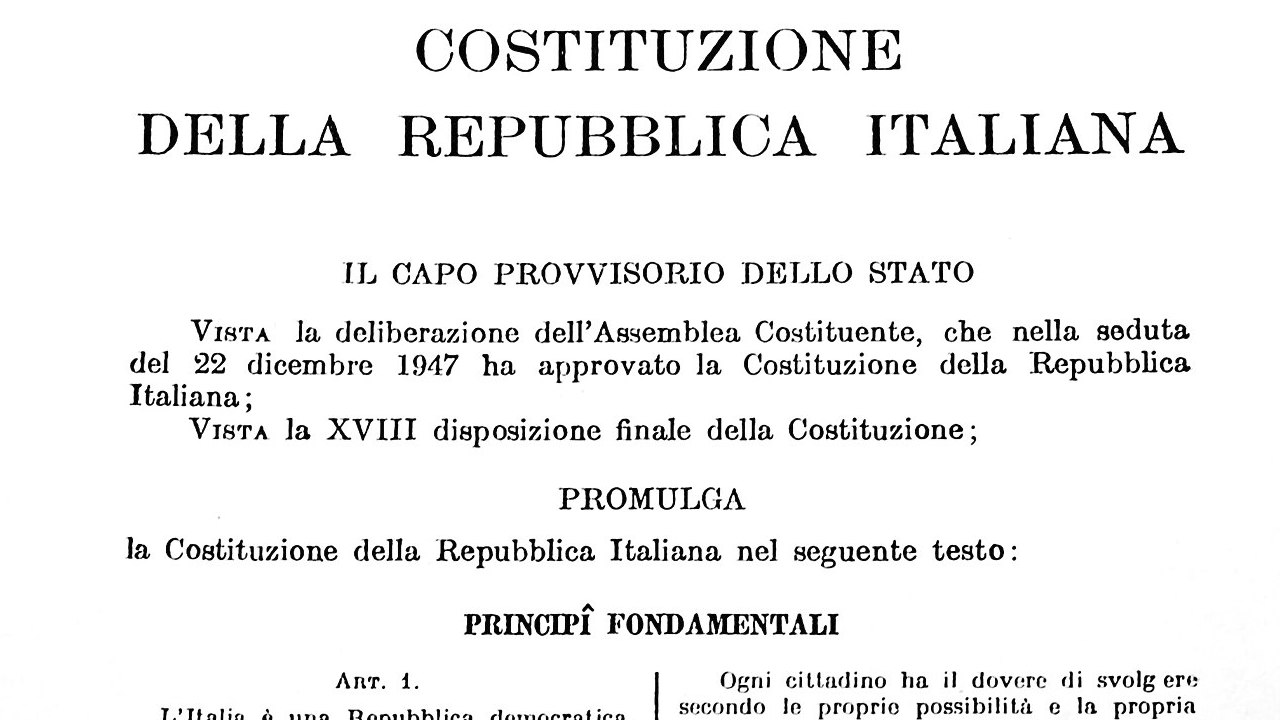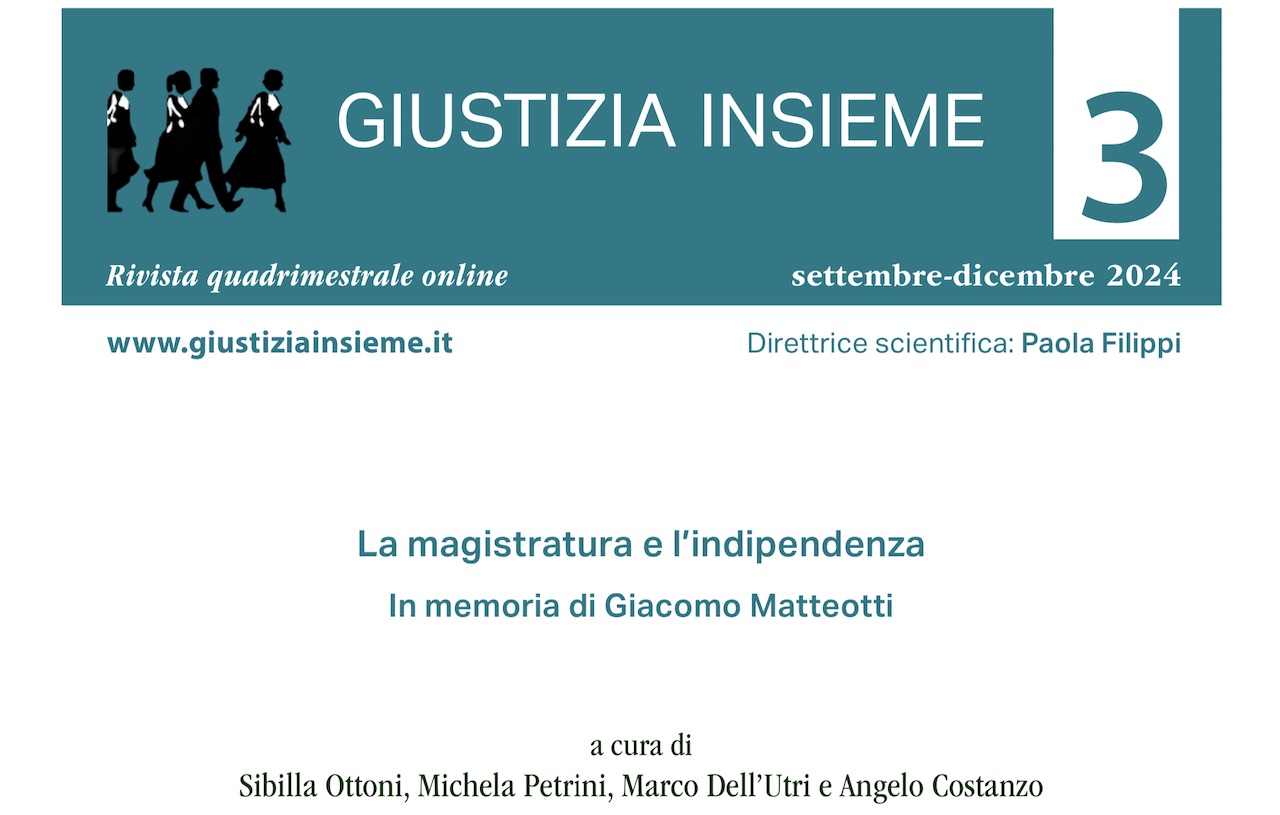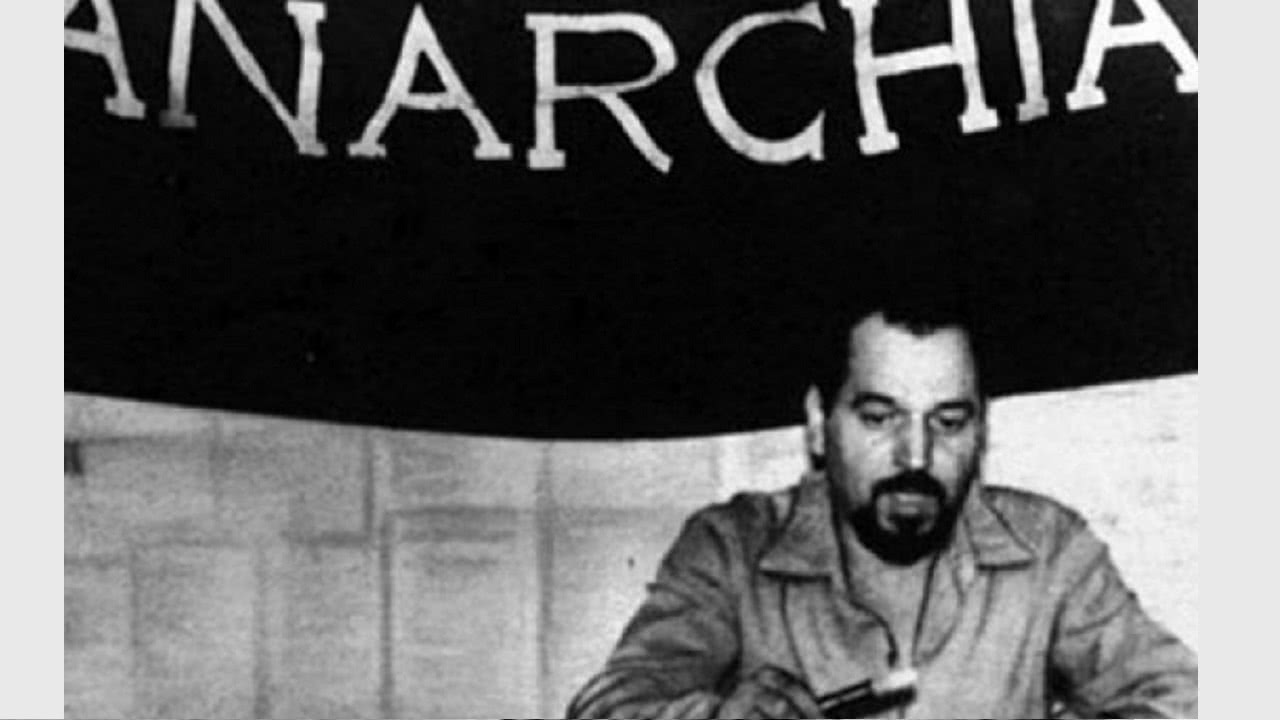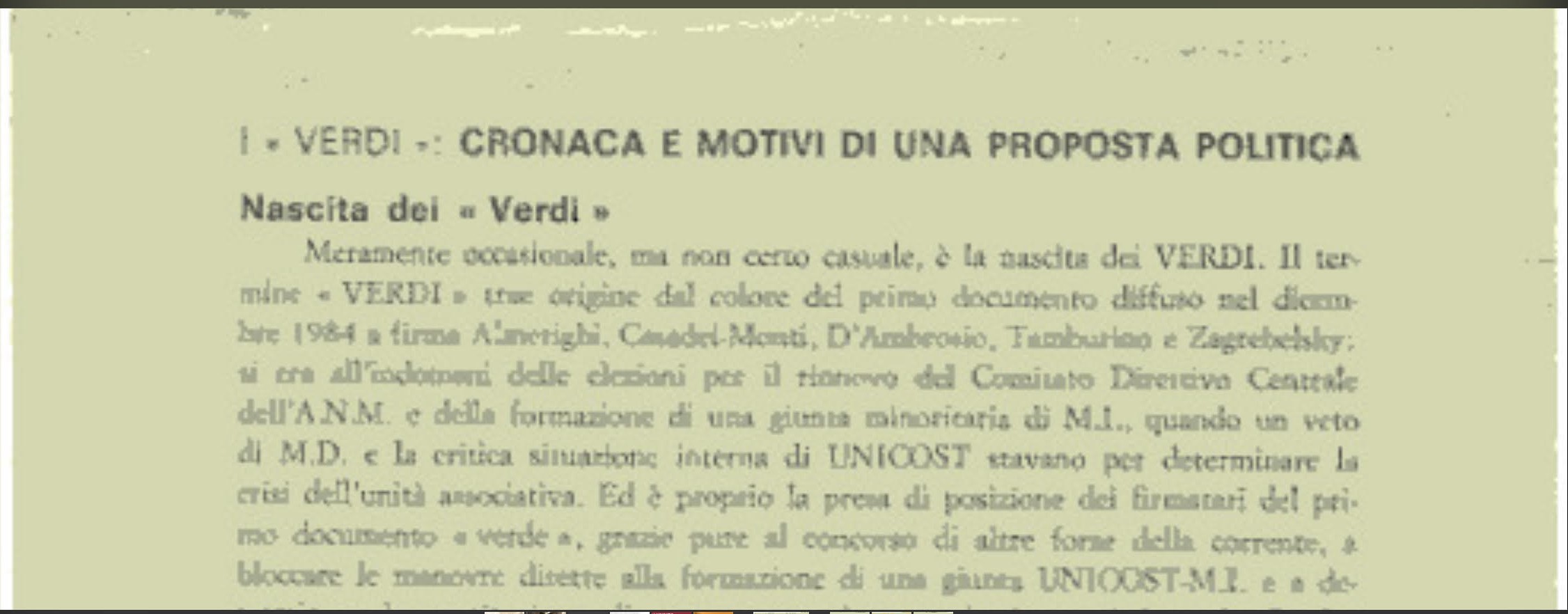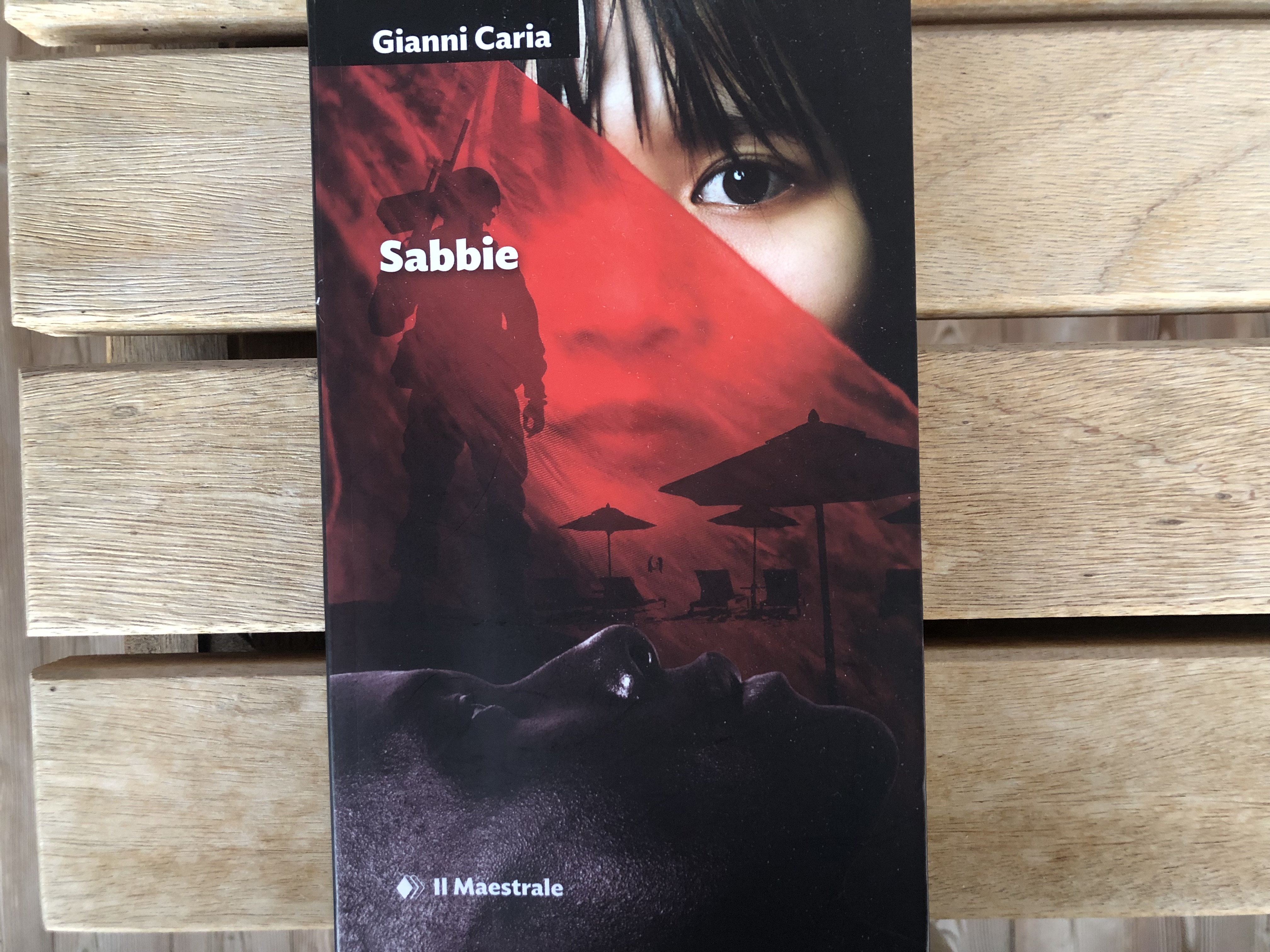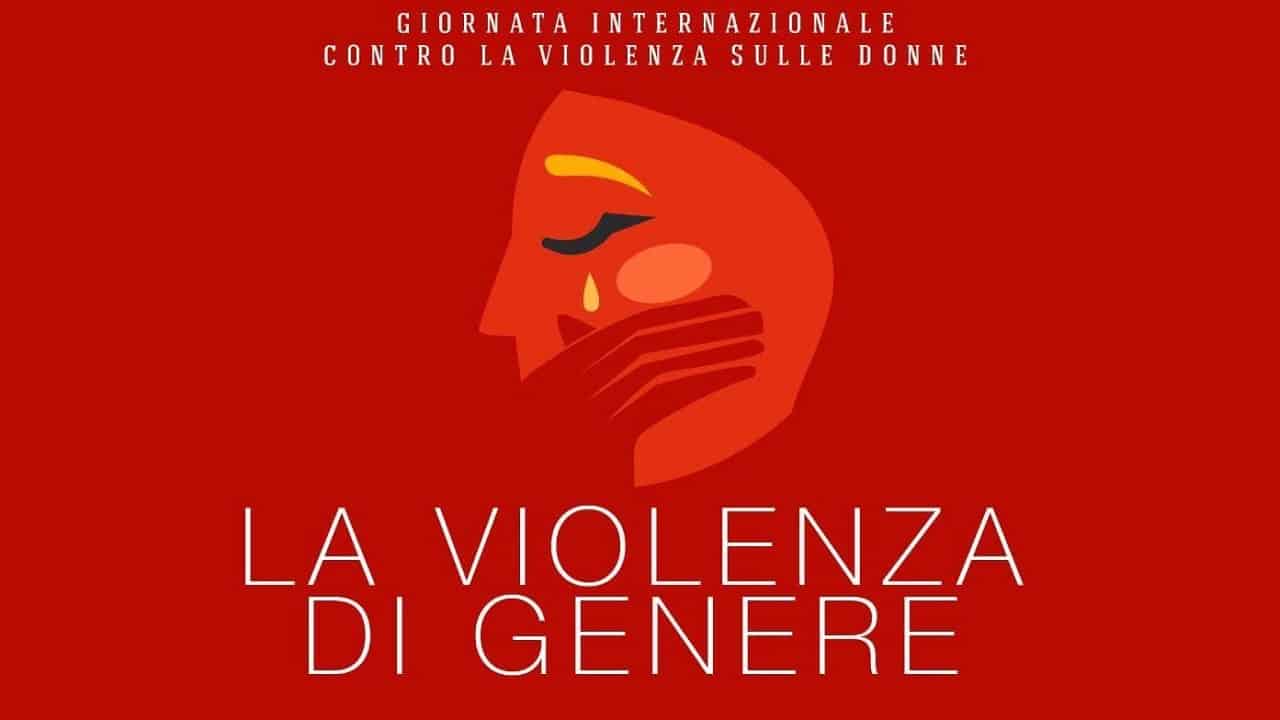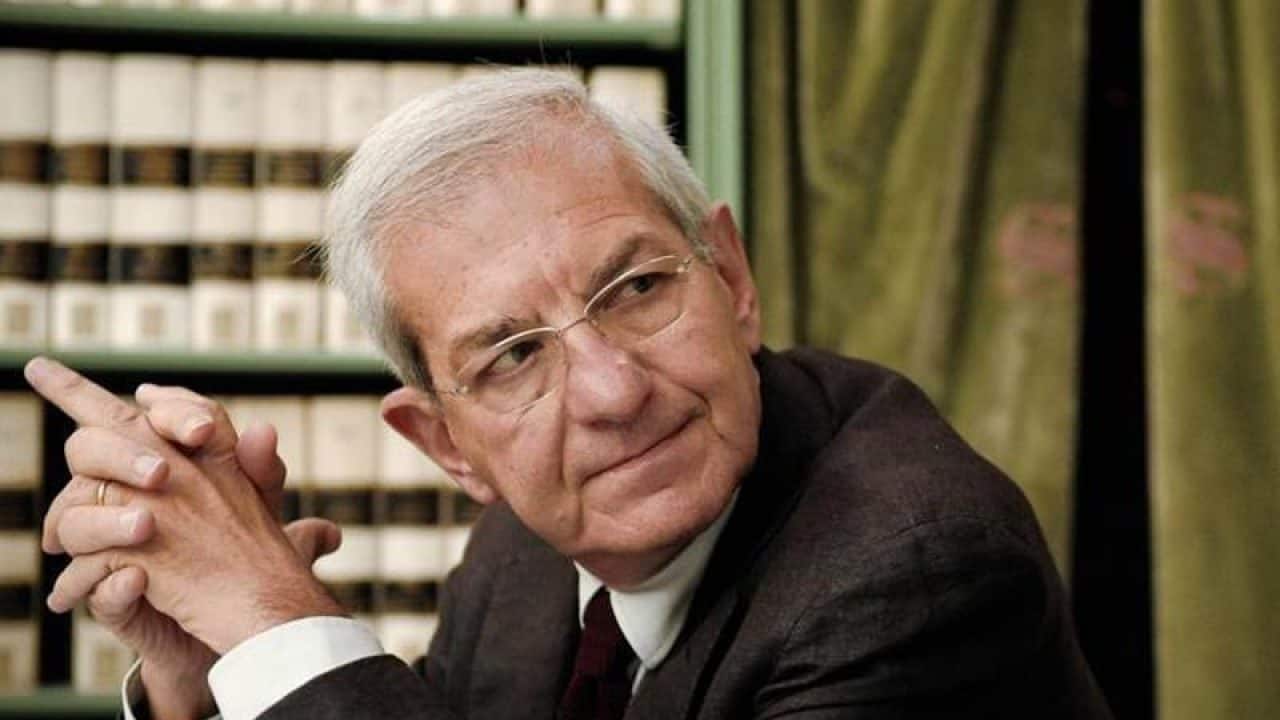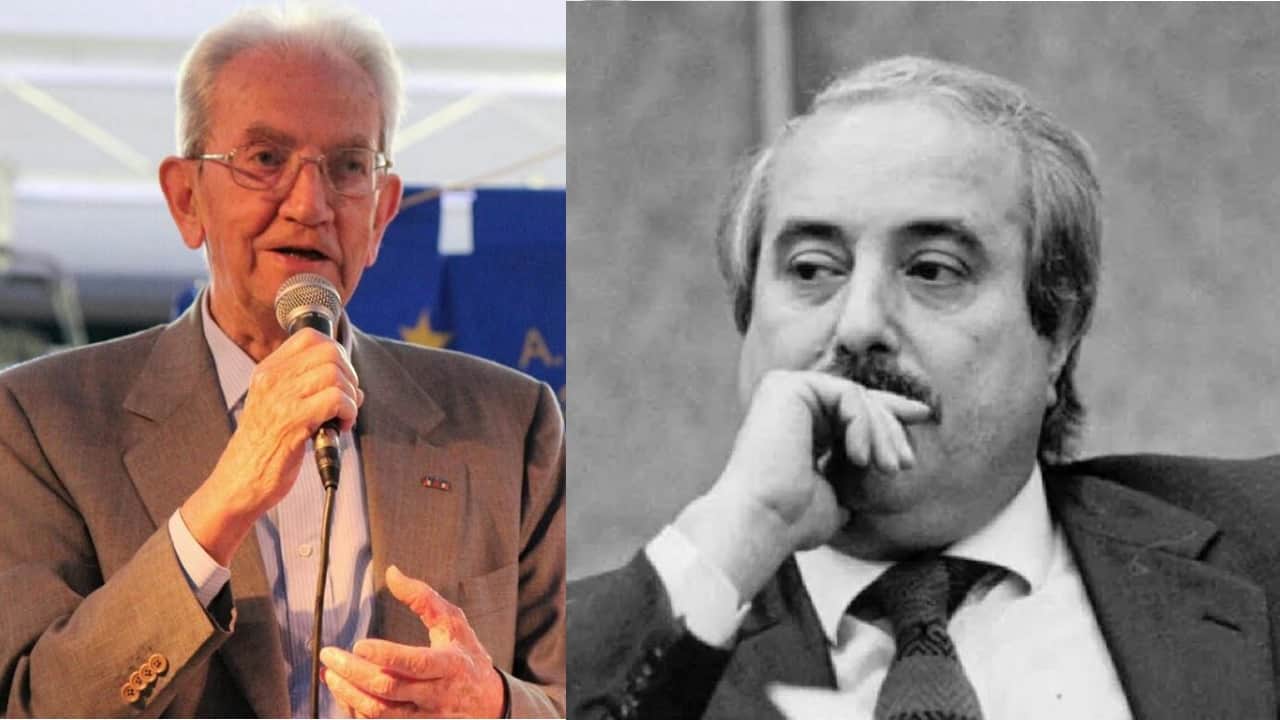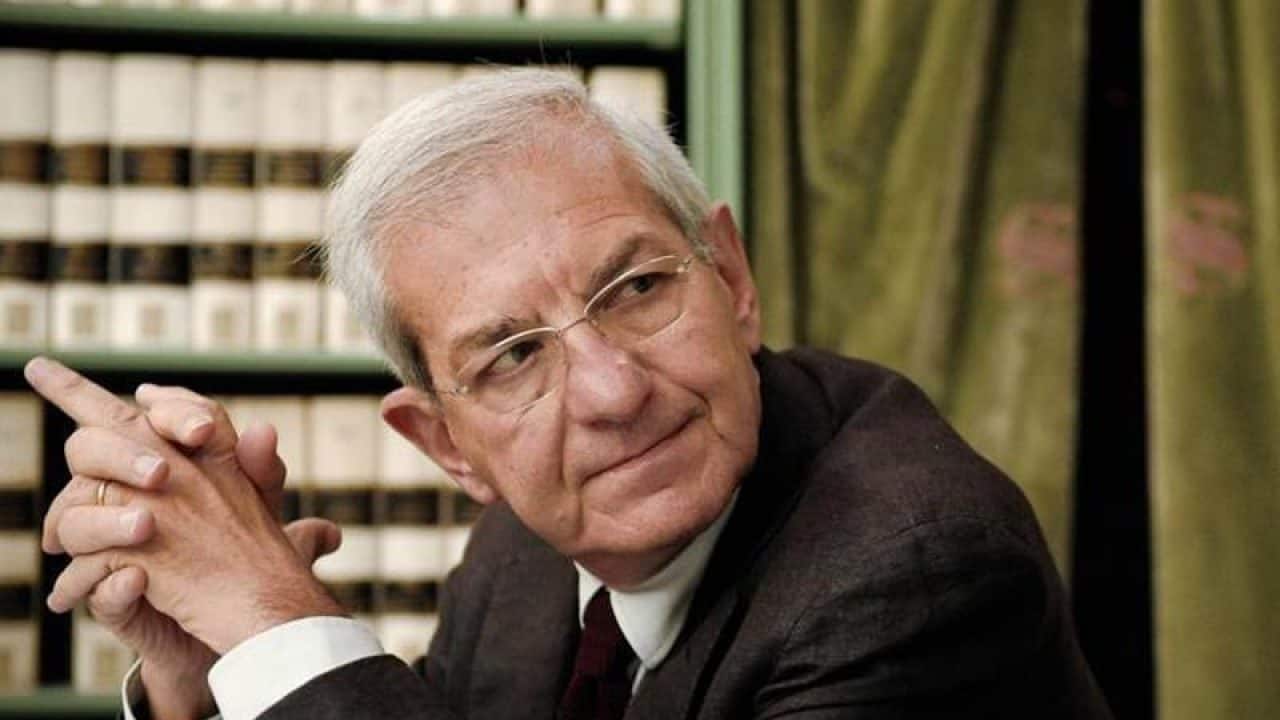Immigrazione, rimpatri e incolumità del richiedente asilo. Intervista a Rita Russo
di Paola Filippi
L’intervista a Rita Russo, consigliera della Corte di Cassazione, Prima Sezione civile, e formatrice decentrata della Scuola Superiore della Magistratura in tema di protezione internazionale e procedure di rimpatrio, è finalizzata a far conoscere alle lettrici e ai lettori della Rivista, anche non giuristi, le questioni sottese alle procedure di rimpatrio dei cittadini di Paesi extra unione.
I provvedimenti giurisdizionali di non convalida dei provvedimenti di trattenimento balzano agli onori delle cronache appena vengono depositati, ma spesso le notizie giornalistiche si concentrano più sugli effetti indiretti di questi provvedimenti e sui commenti che vengono espressi al riguardo da personalità di pubblico rilievo, a volte anche da esponenti del Governo. Con la particolarità che i mezzi di comunicazione, quali la stampa ed i social media hanno dato largo spazio a notizie sulle persone dei giudici che hanno adottato i provvedimenti, alle loro opinioni personali e persino alle loro vicende private o familiari, ma molto meno spazio ai contenuti dei provvedimenti stessi ed al sistema normativo, invero complesso, che ne sta alla base.
L’insieme normativo che regola la “questione migranti” è effettivamente complesso, intrecciandosi norme europee e norme nazionali, tuttavia alcuni passaggi fondamentali possono essere spiegati in modo semplice, in modo che tutti possano acquisire una conoscenza sufficiente della questione per formarsi una propria opinione personale sul contenuto dei provvedimenti; anche al fine di criticarli, come è diritto di ciascun cittadino di un paese democratico, ma su base oggettiva e a ragion veduta.
Una considerazione preliminare: è seriamente preoccupante che poche voci parlino della necessità di bilanciare il diritto dello Stato di controllare i flussi migratori con il diritto di chi afferma di essere esposto a rischio di persecuzioni o di trattamenti inumani e degradanti nel suo paese di origine di trovare un giudice che lo ascolti, in piena indipendenza e con il tempo necessario ad esaminare diligentemente la sua domanda. Anche per respingerla, se infondata, ma con la limpida consapevolezza di avere trattato i diritti umani con l’attenzione che meritano e di avere assicurato a tutti l’accesso ad un ricorso effettivo. Si dice, e a ragione, che queste decisioni devono essere rapide, quanto più possibile, ma rapidità non significa superficialità di giudizio; trovare la formula di un giusto processo che concili queste le esigenze di rapidità ed efficacia è anch’essa una operazione di bilanciamento che spetta indubbiamente al legislatore, nell’ambito della sua discrezionalità, ma seguendo il solco tracciato dalle norme costituzionali ed europee.
In definitiva, tutti parlano di clandestini e di trattenimenti ma essendo una materia estremante specialistica solo gli addetti ai lavori comprendono a fondo le ragioni dei decreti emessi in questi ultimi mesi sia con riferimento ai molteplici rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia sia con riferimento alla decisione di “non convalida del trattenimento” e l’implicazione sottesa alla definizione di paesi sicuri; tutti però possono comprenderne i passaggi fondamentali.
Riteniamo che l’intervista alla consigliera della Corte di Cassazione Rita Russo per la sua conoscenza della materia e la sua particolare attitudine a spiegare e semplificare sarà estremante utile per tutti coloro che vogliono capire cosa significa “trattenimento” dello straniero, e qual è la posta in gioco nel giudizio di convalida e infine l’incidenza complessiva dei decreti di non convalida del trattenimento.
1. Se il cittadino di uno Stato, non compreso tra quelli dell’Unione, entra in Italia senza permesso qual è il procedimento da adottare ai fini del suo rimpatrio nel paese di origine?
R.R. Il cittadino di uno Stato non appartenente alla UE, se non ha titolo di soggiorno, deve essere allontanato dal territorio nazionale. I provvedimenti di allontanamento si dividono in due categorie: i respingimenti, nei confronti di chi sta tentando di entrare, e le espulsioni, nei confronti di chi è ormai entrato sul territorio nazionale, ma non ha titolo per restarvi. Le espulsioni spesso riguardano cittadini stranieri che nel passato avevano regolare permesso di soggiorno poi scaduto e non rinnovato, oppure persone che si sono dimostrate pericolose; molti sono stranieri che hanno fatto domanda di asilo, che fino a quando la loro richiesta non viene decisa, possono soggiornare regolarmente; ma se la richiesta viene definitivamente respinta sono espulsi. I provvedimenti sono adottati dal Questore del luogo (o anche dalla polizia di frontiera) e sono esecutivi. Il rimpatrio avviene con l’accompagnamento alla frontiera, ma se non può farsi immediatamente lo straniero può essere trattenuto in un apposito centro. Il trattenimento dello straniero è un provvedimento amministrativo che priva l’interessato della libertà personale e quindi deve essere assistito dalle garanzie di cui all’art. 13 della Costituzione italiana, vale a dire: essere previsto per legge, essere convalidato dal giudice competente entro 48 ore dalla sua trasmissione, e avere una durata massima prevista per legge. Dicendo “legge” si intende un atto del Parlamento e non del Governo. Il Governo può adottare atti aventi forza di legge (i decreti legge) in casi di urgenza, ma devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni, altrimenti decadono. Le scelte di fondo spettano sempre al Parlamento. Ci sono poi specifici accordi di rimpatrio con i singoli paesi extra UE per facilitare il rientro del cittadino nel suo paese. La cooperazione con i paesi d'origine in tutte le fasi della procedura di rimpatrio è una condizione preliminare per un rimpatrio efficace e sostenibile.
2. Cosa accade se viene formulata richiesta di protezione internazionale?
R.R. Il cittadino straniero che fa richiesta di protezione internazionale (asilo) non può essere rimpatriato se prima la sua domanda non viene esaminata e ritenuta infondata; in prima battuta la decisione spetta a un organo amministrativo che si chiama Commissione territoriale; contro questa decisione si può fare ricorso al Tribunale (sezione specializzata immigrazione) e contro la decisione del Tribunale si può proporre ricorso in Cassazione.
Di regola lo straniero ha diritto di restare sul territorio nazionale fino alla decisione definitiva, tranne nel caso delle c.d. procedure accelerate dove il diritto è limitato alla fase di esame amministrativo, e non anche se si ricorre al Tribunale e in Cassazione. Inoltre il cittadino straniero non può essere respinto o espulso se è esposto a rischio di persecuzioni (come definite dalla Convenzione di Ginevra), oppure a serio rischio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura oppure ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti (come definiti dalla Carta dei diritti fondamentali della Unione europea e dalla Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo). Le persecuzioni riguardano le persone che fanno parte di gruppi specifici che in determinati luoghi sono minoritari, discriminati o in posizione di debolezza economica e sociale rispetto al gruppo più forte, ad esempio comunità religiose, etniche, genere femminile o infanzia, oppositori politici, comunità LGBTQUIA+. A volte le persecuzioni riguardano anche persone che pur non essendo in senso stretto appartenenti a questi gruppi, vengono identificati come tali, ad esempio i familiari stretti dell’oppositore politico o colui che manifesta per i diritti delle persone omosessuali. Il rischio di trattamenti inumani e degradanti invece si valuta con riferimento a specifiche posizioni individuali: per esempio una persona detenuta, anche legittimamente, ma in condizioni disumane, senza cibo sufficiente o di che ripararsi dal freddo. Inoltre, non si possono respingere le persone che provengono dai paesi interessati da conflitto armato, cioè la guerra, quando il conflitto genera violenza indiscriminata e quindi espone a rischio una persona, anche un semplice civile, per il solo fatto di essere presente sul territorio interessato dal conflitto. In questo caso, ai fini del diritto alla accoglienza e all’asilo, è sufficiente accertare che la persona venga dal paese in guerra, senza necessità che questa spieghi le ragioni individuali della migrazione. Tutti gli altri invece devono spiegare le ragioni della migrazione, raccontando la loro storia individuale nei dettagli, in modo che le autorità amministrative prima e i giudici dopo possano verificare se effettivamente hanno diritto alla protezione internazionale. Ma c’è una particolarità: prima di invitare la persona a spiegare le ragioni della migrazione, lo Stato, tramite i suoi funzionari, deve informare queste persone che hanno diritto di presentare la richiesta di asilo. Ciò è previsto per legge ed è stato chiaramente affermato dalla Corte di Cassazione, anche sulla base della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo.
3. La procedura previste dalle leggi italiane sono analoghe a quelli di altri paesi dell’Unione? Nei paesi dell’Unione sono previsti procedimenti di convalida e procedure accelerate?
R.R. Qui occorre fare una premessa. Asilo, immigrazione e controlli delle frontiere sono di materie di competenza dalla Unione Europea (artt. 77-80 del Trattato sul funzionamento della Unione) e gli Stati membri della UE si sono vincolati ad una politica comune in queste materie. Ciò vuol dire che ci sono norme minime comuni per il trattamento di tutti i richiedenti asilo e delle loro domande e per la gestione dei flussi migratori. L’UE ha potestà legislativa in queste materie che esercita tramite le Direttive (che devono essere recepite in una legge nazionale) e i Regolamenti (direttamente efficaci); le norme UE prevalgono sulle norme nazionali. In alcuni settori specifici (ad es. il permesso di soggiorno per motivi umanitari) la stessa normativa europea riconosce spazi di discrezionalità ai legislatori nazionali, ma l’idea di fondo è quella di uniformare il trattamento dei migranti e richiedenti asilo, non solo in tema di diritti sostanziali, che peraltro sono assicurati anche da Convenzioni internazionali, ma anche in materia di procedure. In tema di procedure per il riconoscimento dell’asilo e di rimpatri vi sono specifiche norme della Unione europea che vincolano lo Stato italiano e i suoi giudici. Se un giudice dubita della compatibilità tra una norma italiana e una norma europea può rivolgersi (la Corte di Cassazione deve) alla Corte di giustizia della Unione europea, con sede a Lussemburgo, per avere una interpretazione certa del diritto europeo da applicare al caso (questione pregiudiziale). Se è invece è già certo che una norma di legge italiana è in contrasto con una norma europea, ad esempio perché la Corte UE si è già pronunciata, il giudice italiano disapplica la prima perché prevale la seconda. Il giudice italiano che non applica una norma europea è sottoposto a procedimento disciplinare. Infine, per garantire la uniformità di trattamento, si applica il principio del mutual trust (reciproca fiducia). Se il giudice di un paese europeo competente a decidere la domanda di asilo di un migrante ha accolto o negato la protezione internazionale, il giudice italiano deve riconoscere questa decisione, e viceversa.
In tema di trattenimento vi sono più Direttive: la Direttiva rimpatri (2008/115/CE) prevede casi e modi del trattenimento del cittadino di un paese terzo, non richiedente asilo, sottoposto a procedure di rimpatrio; la Direttiva procedure e la Direttiva accoglienza e rifusione (2013/32/UE e 2013/33/UE) disciplinano il trattenimento del richiedente asilo. Il cittadino straniero in attesa di rimpatrio (non richiedente asilo) può essere trattenuto se c’è rischio di fuga oppure se evita od ostacola la preparazione del rimpatrio. Il cittadino straniero richiedente asilo può essere trattenuto solo in circostanze eccezionali, ad esempio se ha presentato la domanda quando era già stato raggiunto da provvedimento di espulsione e la sua domanda appare strumentale (nondimeno sarà esaminata, anche se con la procedura accelerata) oppure se proviene da un “paese sicuro”; anche in questo caso la sua domanda sarà esaminata, sia pure con la procedura accelerata. In ogni caso, si prevede che il trattenimento amministrativo debba essere sottoposto a “un pronto riesame giudiziario della legittimità del trattenimento su cui decidere entro il più breve tempo possibile dall'inizio del trattenimento stesso”. In Italia questo riesame si chiama convalida e deve avvenire entro 48 ore dalla trasmissione al giudice del provvedimento di trattenimento che a sua volta va trasmesso entro 48 ore dalla sua adozione (96 ore complessive, come dispone l’art. 13 della Costituzione). Il riesame giudiziario in tempi brevi del provvedimento di trattenimento è comunque una garanzia comune in tutti i paesi europei, anche se i dettagli dipendono dal diritto nazionale. Procedure accelerate e trattenimento sono quindi due istituti collegati.
In parole semplici: in certi casi si presume che la domanda di asilo sia infondata e quindi la si esamina con una procedura più veloce, non c’è diritto a restare in Italia dopo la decisione della Commissione territoriale anche se si è fatto ricorso al Tribunale (che può però dare una sospensiva) e lo straniero può essere trattenuto in vista del (probabile) rimpatrio. Le procedure si possono anche svolgere alla frontiera e questa è una ipotesi che interessa l’Italia che ha le frontiere accessibili da terra e da mare (i cd. sbarchi); naturalmente lo straniero è ammesso a dare la prova del contrario e cioè che nonostante provenga da un paese sicuro o ha presentato la domanda solo dopo l’espulsione ha comunque diritto all’asilo.
4. Alla luce del ricorso per cassazione avverso provvedimenti in materia di decreti di trattenimento quanti sono i casi di non convalida?
R.R. Non conosco le statistiche generali delle “non convalide”; posso dire però che si vedono raramente in Corte di Cassazione, perché più frequentemente i ricorsi sono presentati da cittadini stranieri che si lamentano della avvenuta convalida e deducono che non è stato fatto un adeguato controllo di legalità. Per quanto riguarda le “non convalide” e per quanto a mia conoscenza, di recente vi è stato il ricorso del Ministero sulle non convalide dei trattenimenti da parte del Tribunale di Catania, per omesso versamento da parte del migrante delle garanzie finanziarie, processi ove le sezioni unite della Corte di Cassazione in data 8 febbraio 2024 hanno sollevato una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia della UE e dove il Ministero ha poi rinunciato ai ricorsi, per cui i relativi procedimenti sono stati dichiarati estinti (decreti del 17 luglio 2024). Di recente vi sono stati i ricorsi del Ministero sulle non convalide dei trattenimenti in Albania, sulla questione dei “paesi sicuri” trattati alla udienza del 4 dicembre 2024 e rinviati a nuova data in attesa che si pronunci la Corte di Giustizia dell’UE, perché vi sono molte questioni pregiudiziali sollevate non solo da giudici italiani ma anche da un giudice tedesco; pur rinviando la Corte di Cassazione ha voluto offrire ai giudici europei alcune riflessioni sulla questione di c.d. “paesi sicuri”.
4.1. Di quali riflessioni si tratta?
R.R. Il Ministero dell’interno si è opposto alla non convalide, da parte del Tribunale di Roma, dei trattenimenti in un centro sito in Albania (ma gestito da autorità italiane, in virtù di un accordo col governo albanese) di cittadini a egiziani e del Bangladesh ritenuti provenienti da “paesi sicuri”.
Esiste infatti un elenco dei paesi sicuri, che in passato era contenuto in un decreto ministeriale, attualmente invece è contenuto in una norma di legge. Sulla base di informazioni raccolte da affidabili agenzie internazionali (ad es. UNHCR) si valuta se un certo paese si può considerare sicuro e lo si inserisce nell’elenco. Se si proviene da un paese sicuro si presume che la domanda di asilo non sia fondata, salvo prova contraria.
La questione attuale è se si può designare un paese come sicuro se ci sono delle eccezioni soggettive e cioè eccezioni individuali o per categorie di persone: cioè se si può dire che il paese è sicuro eccetto, ad esempio, per gli oppositori politici, o per certe comunità religiose. Il punto dubbio è se in questo caso l’interessato, deve necessariamente affermare di appartenere a quella categoria che fa eccezione oppure basta anche affermare che per il fatto di non tutelare una certa categoria o più categorie il paese non possa considerarsi “sicuro” in generale e cioè anche per chi non appartiene a quel gruppo o categoria.
La questione è alla attenzione della Corte di Giustizia UE, ma la Corte di Cassazione pur rinviando i processi, ha rilevato che la designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro potrebbe essere legittimante effettuata con eccezioni soggettive, però con due limiti: il primo è che la persona può sempre invocare gravi motivi per i quali quel paese pur sicuro in via generale non lo è nel suo caso specifico; il secondo è che le eccezioni non possono essere così estese, costanti o endemiche da divenire generalizzate, né possono essere di tale intensità, pervasività e gravità, da mettere a repentaglio la dignità umana, dal momento che gli Stati democratici devono tutelare anche le minoranze.
Inoltre, in un separato ma collegato e contemporaneo processo, la Corte di Cassazione ha affermato che l’elenco dei paesi sicuri è sempre soggetto a controllo da parte del giudice, ma con effetti limitati al caso concreto quando la designazione operata dall’autorità governativa contrasti con i criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa europea o nazionale. Il giudice opera un controllo di legittimità dell’attività amministrativa legata al caso concreto.
Questo però vale per il passato, quando l’elenco paesi sicuri era contenuto in un decreto ministeriale e cioè un atto del Governo non avente forza di legge. Al momento attuale invece l’elenco, almeno in Italia, è contenuto in una norma di legge (decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158, poi assorbito dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187 che ha convertito anche il c.d. decreto flussi). Ciò ha portato alcuni giudici italiani ad interrogare nuovamente la Corte europea chiedendo se sia compatibile con il diritto europeo che questi elenchi siano fatti con un atto avente forza di legge.
5. Esiste una definizione Unionale di Paese Sicuro?
R.R. In atto non esiste un elenco unico dei paesi sicuri, ma solo dei criteri generali comuni, dati dalle Direttive europee, in base ai quali ogni Stato forma il proprio elenco. L’Unione europea ha però approvato un insieme di norme (c.d. Patto europeo sull’asilo) che entreranno in vigore a far data dal febbraio 2026 che prevedono, tra l’altro, che l’elenco dei paesi sicuri divenga unico e redatto a livello centrale europeo. La Corte di giustizia UE ha già precisato alcuni criteri di esclusione e cioè che un paese non può definirsi sicuro se parti del suo territorio non lo sono. Per adeguarsi a questa sentenza (4 ottobre 2024) lo Stato italiano ha eliminato dall’elenco alcuni paesi, come la Nigeria, che hanno parti del territorio insicure. Bisogna però chiarire che la provenienza da un paese “non sicuro” non garantisce l’accoglimento della domanda di asilo, così come la provenienza da un paese sicuro non è ostativa all’accoglimento della domanda stessa. La valutazione delle domande di asilo avviene sempre su base individuale, ed anche questa è una regola europea. La differenza è che nel caso di provenienza da paese sicuro l’esame della domanda si svolgerà con la procedura accelerata, sulla base di presunzioni che il ricorrente può smentire, e il richiedente può essere trattenuto. Inoltre, il ricorso al Tribunale non ha effetto sospensivo automatico del rimpatrio se la domanda di asilo è stata respinta in via amministrativa. Su questo però la Corte di Cassazione a sezioni unite si è pronunciata in modo rigoroso. Se una persona proviene da pase sicuro e la sua domanda viene esaminata e respinta con la procedura accelerata, ma la Commissione territoriale non ha rispettato i termini, la impugnazione di questo provvedimento davanti al Tribunale si terrà con la procedura ordinaria e quindi si avrà il diritto a restare sul territorio (effetto sospensivo automatico del ricorso al Tribunale).
6. Cosa accade in caso di non convalida del trattenimento? Il richiedente protezione internazionale è autorizzato a rimanere in Italia?
R.R. Se il trattenimento non è convalidato il richiedente viene immediatamente liberato, ma si può disporre un nuovo trattenimento se ci sono i presupposti. Dipende dalle ragioni per cui non si è convalidato il trattenimento. Facciamo un esempio: il trattenimento non viene convalidato perché è stato fondato sulla provenienza da paese sicuro e il giudice accerta che quel paese non è sull’elenco o è stato eliminato dall’elenco (ad esempio si tratta della Nigeria, da poco eliminata) e quindi rifiuta la convalida. In questo caso non si può più disporre un nuovo trattenimento per questa stessa ragione, ma eventualmente per altre, se ve ne sono. Invece se il trattenimento non è stato convalidato per ragioni contingenti, ad esempio perché è scaduto il termine di 48 ore per la trasmissione o per la convalida, si può riproporre il trattenimento rispettando i termini di trasmissione e il giudice può convalidarlo purché rispetti anch’egli i termini. Il richiedente non è però “autorizzato” a restare in Italia solo perché il trattenimento non è convalidato: è sempre necessario che ottenga un permesso di soggiorno e ciò avviene se la sua domanda è accolta o durante il tempo necessario ad esaminarla.
7. Il procedimento di convalida è compatibile con il rinvio pregiudiziale?
R.R. Se il giudice della convalida solleva il rinvio pregiudiziale alla Corte UE deve sospendere il giudizio, procedimento che è incompatibile con i termini di convalida; ciò significa che l’interessato viene liberato, come in tutti i casi in cui non si può rispettare il termine complessivo di 96 ore.
8. Chi è il giudice competente alla convalida del trattenimento?
R.R. Prima delle recenti modifiche normative (ottobre -dicembre 2024) la competenza sulla convalida del trattenimento si divideva tra il giudice di pace -che era e resta competente per convalidare i trattenimenti degli stranieri che non richiedono asilo – e la sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale, competente a convalidare i trattenimenti di quegli stranieri che richiedono asilo. Per effetto del decreto-legge n. 145 dell’11 ottobre 2024 convertito in legge n. 187 del 9 dicembre 2024, la competenza a convalidare i trattenimenti dei richiedenti asilo è stata spostata alle Corti d'appello. Ciò significa il passaggio da un giudice specializzato, nella cui formazione la Scuola Superiore della Magistratura ha già investito molte risorse, ad un giudice non specializzato. Per i magistrati la formazione è comunque un impegno importante e sicuramente anche i giudici della Corte di appello seguiranno percorsi di formazione, che verranno predisposti per loro, ma che richiedono tempo e impiego di altre risorse. Vi è da dire inoltre che riguardo le nuove competenze delle Corte d’appello (estese anche al reclamo avverso la sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento amministrativo di rigetto della domanda di asilo) tutti i presidenti delle Corti d'appello italiane hanno espresso preoccupazione per questi nuovi carichi di lavoro che potrebbero interferire con il raggiungimento degli obiettivi del PNRR.
9. Possono farsi previsioni per il futuro in merito alla questione dei paesi sicuri?
R.R. Non è semplice fare previsioni per il futuro perché da un lato l’Unione europea ha già approvato un nuovo Regolamento (facente parte del c.d. Patto europeo) applicabile dal 12 giugno 2026, secondo cui la designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro, a livello sia dell’Unione che nazionale, può essere effettuata con eccezioni per categorie di persone chiaramente identificabili e in base a una lista unica. Dall’altro però si deve tenere presente che i paesi europei sono vincolati non solo dalle rispettive Costituzioni nazionali, ma anche dalla c.d. Costituzione europea (Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea o Carta di Nizza) e dalle varie Convenzioni internazionali che abbiamo firmato tra cui la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la convenzione di Ginevra.
Queste “Carte” riconoscono l'esistenza di principi fondamentali ai quali non si può derogare e definiscono anche la struttura di uno Stato democratico, e ciò che all'interno di uno Stato democratico si può fare o non si può fare. A questo riguardo si può ricordare che nella recente ordinanza sui paesi sicuri la Corte di Cassazione ha voluto mettere in chiaro un concetto, così esprimendosi: “La democrazia, infatti, non si esaurisce nel procedimento elettorale. Un paese democratico, basato sulla rule of law, assicura anche, con un adeguato meccanismo di contrappesi, che i diritti fondamentali espressione della dignità della persona umana siano rispettati”.
Si ritiene utile allegare all'intervista l'ordinanza interlocutoria della Prima Sezione civile della Corte di Cassazione n. 34898/2024, di rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione della Corte di giustizia sul rinvio pregiudiziale disposto, nell’ambito di altro giudizio principale, nelle cause C-758/24 e C759/24, Alace e altri, dal Tribunale di Roma; la sentenza della Prima Sezione civile della Corte di Cassazione n. 33398/2024, che sul rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Roma, ha enunciato il principio di diritto secondo il quale: "Nell’ambiente normativo anteriore al decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158, e alla legge 9 dicembre 2024, n. 187, se è investito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale di richiedente proveniente da paese designato come sicuro, il giudice ordinario, nell’ambito dell’esame completo ed ex nunc, può valutare, sulla base delle fonti istituzionali e qualificate di cui all’art. 37 della direttiva 2013/32/UE, la sussistenza dei presupposti di legittimità di tale designazione, ed eventualmente disapplicare in via incidentale, in parte qua, il decreto ministeriale recante la lista dei paesi di origine sicuri (secondo la disciplina ratione temporis), allorché la designazione operata dall’autorità governativa contrasti in modo manifesto con i criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa europea o nazionale. Inoltre, a garanzia dell’effettività del ricorso e della tutela, il giudice conserva l’istituzionale potere cognitorio, ispirato al principio di cooperazione istruttoria, là dove il richiedente abbia adeguatamente dedotto l’insicurezza nelle circostanze specifiche in cui egli si trova. In quest’ultimo caso, pertanto, la valutazione governativa circa la natura sicura del paese di origine non è decisiva, sicché non si pone un problema di disapplicazione del decreto ministeriale” e la Relazione del Servizio novità del Massimario a cura di Alessandro Farolfi.
Sul tema si vedano anche Corte di giustizia: l’Egitto non è un paese sicuro, Paesi sicuri e categorie di persone “insicure”: un binomio possibile? Il Tribunale di Firenze propone rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE di Cecilia Siccardi, Il Tribunale di Bologna chiede alla Corte di Giustizia di pronunciarsi sul DL paesi sicuri, La sentenza della Corte di Giustizia del 4 ottobre 2024, causa C-406/22, secondo una prospettiva “interna” e di diritto dell’Unione Europea di Marcella Cometti, Un giudice a Roma. Gli immigrati, il governo e la protezione dello stato di diritto di Cataldo Intrieri.