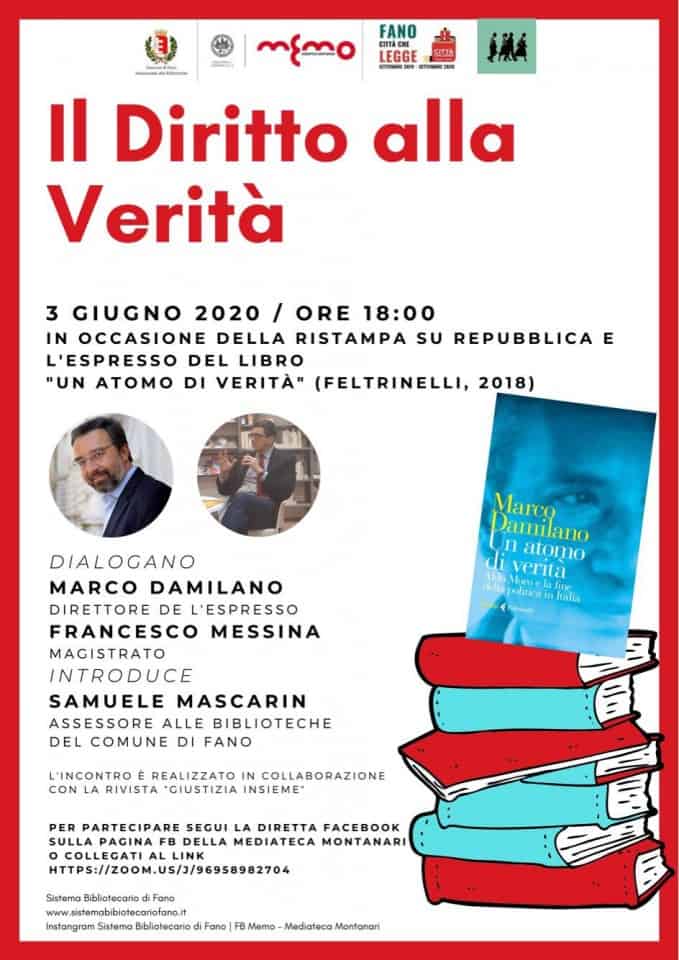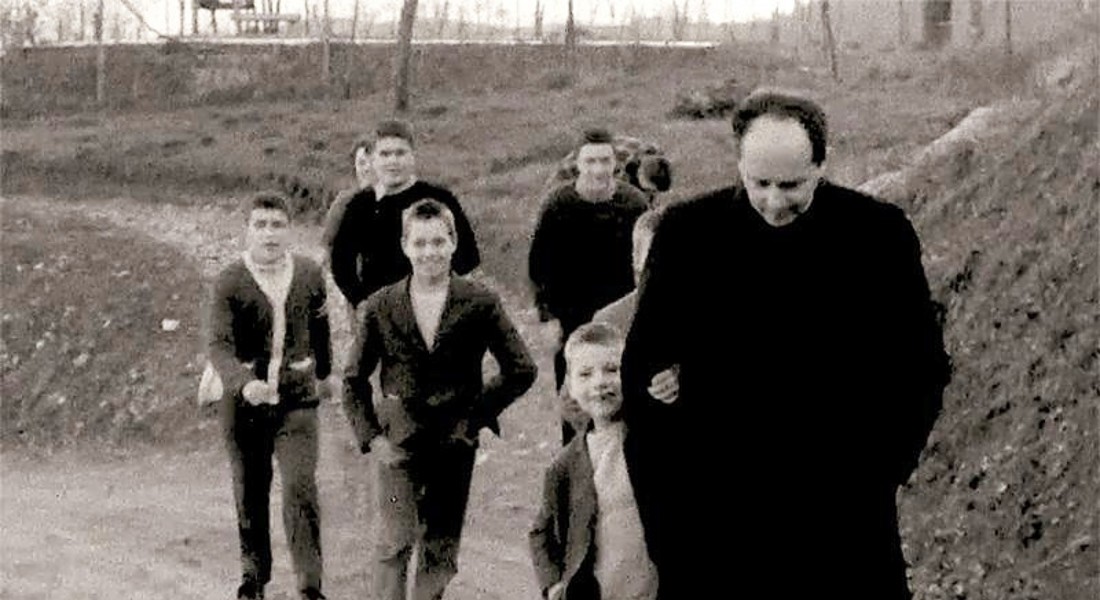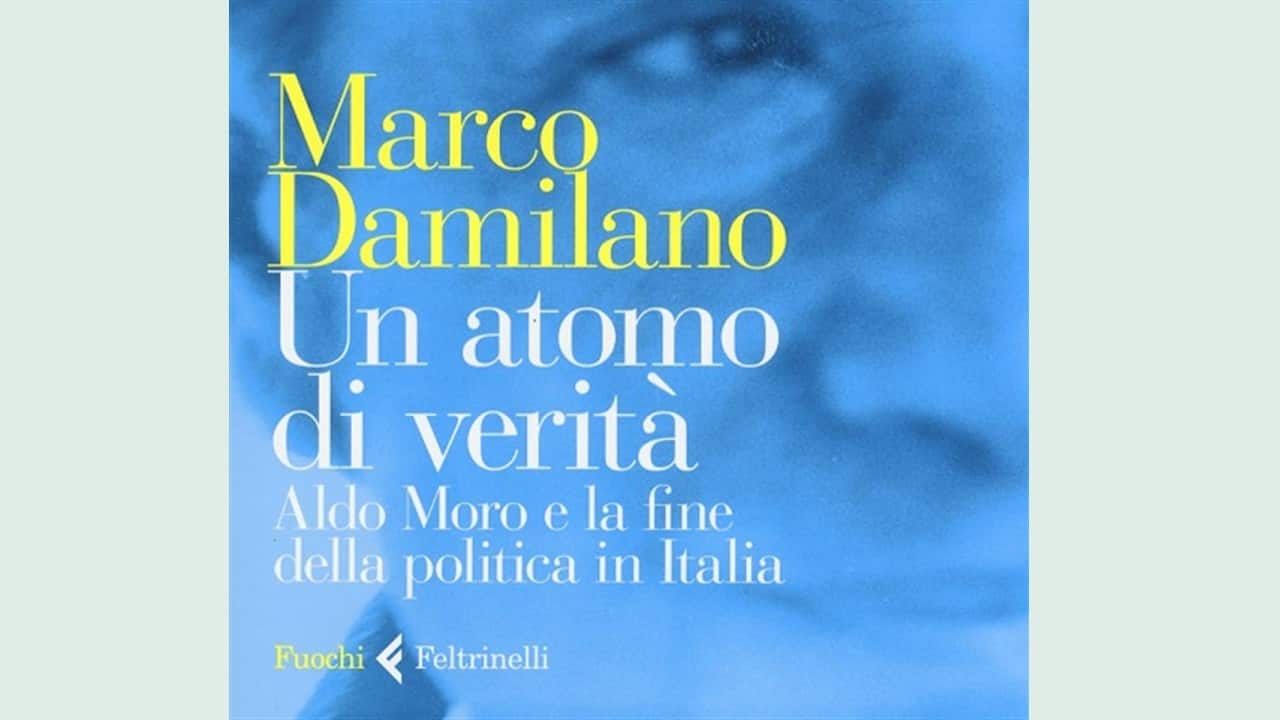
Il diritto alla verità
Presentazione dell’incontro con Marco Damilano – 3 giugno ore 18.00 – diretta su “zoom” e bacheca Facebook “Memoteca Montanari” di Francesco Messina
La ricostruzione del passato è stata spesso manipolata al fine di fornire ai cittadini una interpretazione dei fatti che è funzionale alla tutela di determinati interessi, alterando così i processi cognitivi della scelta consapevole. Il dialogo organizzato per mercoledì 3 giugno, in occasione della ristampa del libro di Marco Damilano “Un atomo di verità”, ha lo scopo di discutere su un tema fondamentale, quello della verità nascosta o non completamente svelata, esaminandolo da esperienze e angolazioni culturali diverse, ma convergenti nella finalità. Si tratta di esaminare l’ampiezza di un fondamentale diritto della persona umana (quello a una conoscenza, il più possibile piena, della storia e della politica), i meccanismi distorsivi della realtà e i mezzi per cercare di restarne immuni.
E, infine, di comprendere cosa abbiamo perso nei "percorsi spezzati" della vicenda democratica italiana e cosa possiamo ancora guadagnare dall’analisi rigorosa di essi. La vicenda di Aldo Moro - tragica nel suo esito sia umano, ma decisiva sul piano politico - è paradigmatica dei tanti eventi cruciali e cupi degli ultimi decenni storia del nostro Paese, e del modo con cui essi sono stati rappresentati alla maggioranza dei cittadini. Il tema dell’incontro - il “diritto alla verità, inteso come pretesa soggettiva concreta - pone un problema non tanto della quantità dell'informazione a disposizione di ognuno, ma della sua qualità e della sua correttezza su fatti epocali. Da tempo, le tradizionali agenzie formative della collettività italiana (scuola, partiti politici, associazioni culturali) confliggono, o sono state sostituite, dal sistema mediatico-comunicativo della semplificazione e dell’immediatezza, con l’effetto di creare immagini distorte della realtà, anche di quella storica, instillando il concetto tanto suadente, quanto falso, del cittadino che “sa già tutto” e non ha bisogno della ricerca e della riflessione quale momento indispensabile per un giudizio.
L'ignoranza della storia, l'inutilità di reperire la ragione profonda delle cose sono teorizzate come nuovo stile esistenziale per ottenere un gratificante riscontro privato e, soprattutto, pubblico. Tutto questo non accade per caso o in conseguenza di un ineluttabile destino collettivo, ma per una sempre più diffusa e organizzata mancanza di principi etici e di senso critico.
Un deficit che sedimenta e cristallizza l’esistente, e inibisce la dialettica del cambiamento.
**********
Riprendendo Moro e la lezione storico-politica del decennio italiano che va dal 1968-1978, si può dire che la conoscenza è sempre una questione di metodo. Italo Calvino avvertiva che coloro che vogliono semplificare a tutti i costi ciò che, per sua natura, è complesso, in realtà preparano solo menzogne; diversamente, chi dà risposte precise a questioni complesse dimostra l'unico atteggiamento utile e onesto.
“Onesta” e “verità” sono concetti profondamente legati sul piano teorico e conseguenziali su quello pragmatico. Il diritto alla verità rappresenta un "luogo della conoscenza" in cui la personalità umana, che è archetipo della Costituzione Repubblicana, si manifesta nel modo più dinamico e, si badi bene, anche con il maggior bisogno di solidarietà culturale. La ristampa del libro di Marco Damilano offre, quindi, un’opportunità precisa, quella di riesaminare una parte decisiva del nostro passato (ma poi è davvero passato? oppure vi è una coazione a ripetere?), e di farlo in modo attento e rigoroso, acquisendo anticorpi culturali contro la perdita della memoria e il possibile verificarsi di derive autoritarie.
Il dialogo del prossimo 3 giugno vuol quindi significare la necessità delle prospettive differenti, quelle del giornalista e del magistrato, per esaminare fenomeni che, per la loro natura, hanno bisogno della cultura delle competenze nel ricomporre il puzzle della complessità della Storia.
Il filo di questo sforzo comune, che vuol essere l’espressione del pensare e dell’agire democratico nella comunità, lo si trova nel significato più autentico della parola di “politica”; e cioè, per dirla con Isaiah Berlin, nell’arte del vivere nella “polis”, un’attività della quale anche coloro che preferiscono la vita privata non possono fare a meno. Significa sforzarsi di mettere in equilibrio scrupoloso e complementare i risultati giudiziari e quelli dell’analisi giornalistica.
D’altra parte, è solo elevando la pretesa culturale dei cittadini che si può affinare la qualità della risposta delle Istituzioni.
***
Viviamo un tempo in cui, rispetto al futuro inquieto che ci aspetta, “nulla sarà come prima”. Sull’espressione, sempre più abusata, grava il pericolo che essa possa divenire l’ennesimo stereotipo linguistico di una gattopardesca riproposizione dell’esistente.
Di certo, la grave crisi etica ed economica con la quale tutti ci confrontiamo dovrebbe – anche - portarci a cogliere il dato positivo che ci viene imposto dalla Storia, e cioè quello di ri-pensare gli scopi soggettivi e quelli societari attraverso i quali, come avvertiva Alessandro Duranti, qualsiasi società - capitalistica, feudale o egualitaria – evolve oppure perisce.
E’ quando le difficoltà sono più dure che bisogna essere razionali, capaci empatia con il passato che ci “precede”, ci identifica, solo a saperlo e volerlo riconoscere.
Spesso nel dibattito pubblico si fa riferimento - quasi a fornire la soluzione ultima di ogni discussione - alle scelte del popolo, alla sua tradizionale, intrinseca saggezza.
Ma questo dovrebbe essere un punto di partenza, e non di arrivo, di una riflessione.
Dovrebbe porre interrogativi più che essere, come quasi sempre accade, un’opzione per blandire il cittadino, facendogli credere di possedere una conoscenza che, invece, non ha, perché gli è stata accuratamente nascosta.
C’è da recuperare, a mio avviso, il significato e il valore della parola più pregnante dei Costituenti della Repubblica- e Moro lo è stato - e cioè quella di “compito”, etimologicamente inteso come azione che completa, colma i vuoti, in una faticosa ma incessante “rimozione degli ostacoli”.
Scriveva Elio Basso che “la democrazia, cioè la sovranità del popolo, sarà più o meno effettiva a seconda che il popolo sarà più o meno in grado di avere e di formulare una propria volontà libera e cosciente e di controllarne l'adempimento. Ciò che dipenderà dalle condizioni economiche sociali e culturali della popolazione”.
Preporsi un “compito”, al di là della sua realizzazione, all’insegna della “verità” sono i presupposti e le ragioni di ogni responsabile impegno.