Pubblichiamo un'anticipazione degli Atti del Convegno La magistratura e l’indipendenza promosso da Questa Rivista che si è tenuto a Roma il 12 aprile 2024 e che saranno pubblicati prossimamente in un fascicolo a cura di Sibilla Ottoni, Michela Petrini, Marco Dell'Utri e Angelo Costanzo.
Introduzione
di Paola Filippi
Questo fascicolo contiene gli atti del Quarto convegno della Rivista Giustizia Insieme dal titolo La magistratura e l’indipendenza, dedicato a Giacomo Matteotti a 100 anni dal suo omicidio per mano di sicari di Benito Mussolini.
Il convegno si è svolto nella magnifica biblioteca di Sant’Ivo alla Sapienza, in un luogo ove sono conservati gli atti dei più importanti processi svoltisi durante il ventennio fascista. Omicidi e pestaggi a opera dell’Ovra e della milizia fascista rimasti impuniti anche per la mancanza di indipendenza della magistratura del ventennio.
L’omicidio di Giacomo Matteotti – delitto politico, snodo dell’avvento del fascismo – è strettamente collegato all’indipendenza della magistratura.
È importante ricordare i magistrati coinvolti nelle vicende processuali. E questo è necessario farlo anche perché, come ha scritto Primo Levi, bisogna ricordare «perché quello che accaduto una volta può accedere ancora». Tutto ciò che è accaduto può ripetersi, perché i meccanismi del genere umano non mutano con il passare del tempo.
Il processo richiama prepotentemente la questione dell’indipendenza della magistratura.
La storia dell’omicidio di Giacomo Matteotti è anche la storia dell’indipendenza di magistrati come Mauro Del Giudice e Guglielmo Tancredi, ovvero della diversa declinazione della dipendenza di magistrati come Niccodemo Del Vasto, procuratore che sostituì Tancredi e Fagella, Presidente del Tribunale di Roma, Vincenzo Crisafulli, Procuratore Capo dell’Ufficio di Procura di Roma, Giuseppe Francesco Danza, presidente del collegio giudicante di Chieti e Alberto Salucci, procuratore d’accusa.
È evocativa del valore dell’indipendenza la frase del memoriale di Mauro Del Giudice – conservato presso l’Archivio di Stato – consegnato alla corte di assise di appello di Roma che procedette a carico dei sicari a seguito del decreto luogotenenziale che dichiarò inesistente, tra gli altri, la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Chieti il 24 marzo 1926.
«Ripeto che parlo per vero dire, non già perché mosso da alcun sentimento di rancore o per vendicarmi della persecuzione ventennale subita per avere fatto allora il mio dovere di magistrato indipendente. Sono sull’orlo della tomba ed assai prossimo a render conto a Dio della mia vita trascorsa negli uffici giudiziari. Debbo perciò essere creduto.»
L’esperienza della magistratura degli anni ’20, come ricorda il prof. Scarselli«costituisce per noi un indispensabile spunto per riflettere sulle nostre attuali questioni, e ciò anche perché, nella storia, come molti filosofi ci hanno insegnato, tutto ciò che è accaduto può ripetersi, e i meccanismi del genere umano non mutano con il passare del tempo».
«In primo luogo, in questo ricordo della magistratura, si riesce a rinvenire tutti i tratti dell’essere umano: si va dal senso del dovere di Mauro Del Giudice al lassismo opportunista di Giuseppe Francesco Danza, dall’orgogliosa consapevolezza della funzione giudicante di Lodovico Mortara allo scandaloso esercizio della funzione requirente di Alberto Salucci, dalla sete di indipendenza e giustizia di Vincenzo Chieppa agli atteggiamenti privi di rigore quali quelli tenuti dai magistrati del processo a Benito Mussolini tra il 1919 e il 1922, fino alla smoderata ambizione e al trasformismo di giudici quali Michele Isgrò e Giuseppe Montalto, disposti a dirigere un Tribunale Speciale a servizio di un dittatore per motivi personali di tipo carrieristico.»
L’indipendenza della magistratura è un bene prezioso.
La definizione di Stato di diritto presuppone un sistema di norme chiare, giustificate quanto alla loro obbligatorietà dai principi costituzionali e unionali, e che in qualche modo ne siano la realizzazione, esige la sottoposizione indifferenziata alla legge di tutti i cittadini e tutti gli enti e presuppone l’autonomia e la separatezza dei poteri e dunque l’indipendenza del potere giurisdizionale.
Non a caso, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento 2020/2092 del 16 dicembre 2020 del Parlamento europeo, come primo elemento sintomatico di una situazione di violazioni delle Stato di diritto, al primo punto ovvero alla lett. a), sono indicate «le minacce all'indipendenza della magistratura».
La nozione di stato di diritto è strettamente collegata a quella di società democratica che trova il suo necessario contrafforte in un sistema giudiziario efficiente, imparziale e indipendente.
L’indipendenza del potere giurisdizionale, di coloro che emettono la decisione, ma pure della magistratura requirente costituisce un diritto del cittadino.
La parità di tutti i cittadini davanti alla legge pretende l’indipendenza del potere giurisdizionale così come pretende l’indipendenza del magistrato e l’imparzialità delle sue decisioni.
Se l’indipendenza del corpo magistratuale e del singolo magistrato che lo compone è un diritto irrinunciabile dei cittadini e della collettività, per il magistrato più che un dovere è un dover essere.
Non a caso l’indipendenza e l’imparzialità, sin dalla prima regolamentazione delle valutazioni di professionalità dopo l’abolizione, negli anni Sessanta, dei concorsi e degli scrutini in cui si articolava il sistema dei c.d. ruoli chiusi – mi riferisco alla circolare Tamburino del 1985 – sono stati individuati – successivamente è stato aggiunto l’equilibrio – come pre-requisiti, ai fini dell’esercizio della funzione giurisdizionale.
La violazione di tali doveri da parte di un singolo magistrato si riverbera negativamente sull’intero corpo magistratuale.
D’altro canto, come ci ha ricordato Zagrebelsky, «Indipendenza e imparzialità sono doveri fondamentali riguardanti i singoli magistrati e la magistratura nel suo insieme. Vi è un nesso stretto tra ciò che riguarda il singolo magistrato che si esprime e le ricadute sulla magistratura tutta. Quando si dice – e si pretende che abbia portata generale – che la magistratura è “potere diffuso”, si deve poi considerare che il potere giudiziario tutto è coinvolto nel comportamento dei singoli magistrati» (La libertà di espressione e l’imparzialità di Vladimiro Zagrebelsky, pubblicato il 2 gennaio 2024 su questa Rivista, sotto la voce Costituzione e carte dei diritti fondamentali).
Abbiamo individuato come argomento del quarto convegno di Giustizia insieme: “l’indipendenza della magistratura” per tre ordini di ragioni.
La prima: in quanto riteniamo che l’indipendenza della magistratura debba essere costantemente oggetto di attenzione e noi vorremmo dare un senso alla necessità di attenzione perché dall’indipendenza dipende il sistema democratico.
Come ha scritto Licia Fierro nel bel saggio intitolato Giacomo Matteotti: il suo e il nostro tempo, «I sistemi democratici non nascono una volta e per sempre, vanno costruiti e ricostruiti ogni giorno».
La seconda ragione è che occorre essere consapevoli dell’esistenza di situazioni potenzialmente idonee a turbare l’indipendenza, situazioni spesso sottovalutate se non addirittura ignorate. Occorre mettere sotto osservazioni le potenziali situazioni di rischio.
La terza ragione è che occorre iniziare a ragionare attorno alla questione dell’indipendenza delle decisioni in relazione all’intelligenza artificiale; a riflettere in tema di indipendenza, prevedibilità e algoritmo.
La prima sessione del convegno è stata dedicata all’indipendenza del magistrato europeo.
Dalla Corte di Strasburgo arrivano segnali che ci rassegnano una allarmante tendenza verso la retrocessione dello stato di diritto in alcuni paesi dell’Unione, come peraltro in paesi occidentali nell’orbita di influenza con l’Unione – penso a Israele.
La Presidente della Corte di Strasburgo, al seminario presso l’Accademia dei Lincei – come richiamato da Simone Pitto nel suo articolo “Unpacking the courts”: prevenzione e reazione agli attacchi all’indipendenza dei giudici. Brevi riflessioni a partire dal Convegno “Giudice e stato di diritto”, pubblicato il 9 aprile 2024 sulla Rivista – ha segnalato che quanto osservato a Strasburgo in questi ultimi anni non è una mera “retrocessione” dello Stato di diritto ma un chiaro segnale dell’esistenza di un fenomeno di degenerazione ed erosione della democrazia.
Si registra una ampia giurisprudenza della Corte di Strasburgo che segnala interventi diretti a minare l’indipendenza dei magistrati attraverso provvedimenti che modificano la disciplina in settori nevralgici quali la carriera, i trasferimenti, le sospensioni, i procedimenti disciplinari. Si tratta di interventi normativi idonei a influenzare nei paesi sotto osservazione quali Polonia, Ungheria, Bulgaria, Malta, Romania, Slovacchia. Tanto per fare un esempio pendono 450 ricorsi che sollevano dubbi sull’indipendenza della magistratura in Polonia.
Con riferimento all’Ungheria, in relazione al caso Salis, la giudice Ungherese Anna Madarasi ha scritto un interessante articolo che evidenzia l’altra faccia della medaglia ovvero quella della pressione di governi esteri sui magistrati nazionali.
Le sue riflessioni portano a pensare che lì dove è in dubbio l’indipendenza c’è meno rispetto dell’imparzialità nelle decisioni (Quis Custodiet Ipsos Custodes? Note al margine di un processo penale ungheresepubblicato il 24 marzo 2024 – voce diritti stranieri).
È indispensabile la ricerca collettiva degli anticorpi per le criticità che rilevanti in tema di condizionamento dei giudizi e quali i rimedi.
(Si rinvia alla lettura dell’articolo del titolo L’Unione Europea e lo Stato di diritto. Fondamento, problemi, crisidi Vladimiro Zagrebelsky del 28 maggio 2021 - voce diritto UE).
La coordinatrice della tavola rotonda è stata Sibilla Ottoni, giudice del Tribunale di Tivoli. Hanno partecipato Simone Benvenuti, professore di diritto pubblico presso l’Università Roma TRE, Leonardo Pierdominici, ricercatore di diritto pubblico presso l’Università di Bologna e Simone Pitto, assegnista di ricerca presso l’Università di Genova.
La seconda sessione è stata dedicata all’indipendenza della magistratura in Italia. Ci siamo interrogati in ordine ai pericoli per l’indipendenza ricollegabili, anche solo in via indiretta, a talune riforme in itinere. Pensiamo alla valutazione professionale fondata sulle valutazioni dei provvedimenti; si tratta di una previsione potenzialmente lesiva dell’indipendenza del giudice per il metus che può condurre il giudice a non emettere la decisione giusta, scevra da condizionamenti, per paura di valutazioni non positive.
Come ha scritto Nello Nappi: «Il conformismo è il vero rischio professionale dei magistrati, perché li esonera da quella “responsabilità empatica” che è indispensabile per riconoscere l’effettivo significato dei comportamenti altrui nel contesto di una comune costellazione di valori» (su questa Rivista in “Equilibri ed equilibrismi” pubblicato il 4 aprile 2024 - voce ordinamento giudiziario)
Premesso che l’ottimismo del cuore ci induce a ritenere che i test psicoattitudinali, come in più sedi ha evidenziato il Presidente Santalucia e come scrive Nappi, non siano altro che “l’ennesima operazione di equilibrismo propagandistico” i test, in astratto, potrebbero divenire uno strumento non utile al servizio giustizia bensì un strumento a disposizione di chi volesse selezionare i vincitori di concorso in base alle idee e al pensiero politico. Non è con i test che si valuta l’equilibrio e, d’altro canto, la valutazione di detto pre-requisito deve essere costante come lo è in base alle valutazioni periodiche alle quali negli organi di governo autonomo decentrato partecipano pure gli avvocati.
Una operazione che pure mette a repentaglio l’indipendenza della decisione, con condizionamenti intenzionali provenienti dall’esterno, è l’attività di dossieraggio e l’attività denigratoria diretta e personale contro magistrati in ragione di provvedimenti emessi. A questo riguardo viene in mente l’attacco del 15 ottobre 200 9al collega Raimondo Mesiano, che il giorno prima aveva condannato la Fininvest a pagare una multa milionaria per danni alla Cir di Carlo de Benedetti, ma anche i recenti dossieraggi, anche successivi al convegno – si pensi alle notizie personali divulgate dalla Stampa riguardo al Presidente Marco Gattuso per rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia -.
È di questi giorni il tweet di Elon Musk del tenore “These judges need to go” riferito ai giudici che si sono occupati delle richieste di convalida del trattenimento di cittadini dell’Egitto e del Bangladesh, ovvero che hanno deciso con riferimento a questioni riguardante la procedura da adottare e quindi scelta squisitamente giurisdizionale.
Le “schedature” realizzate in danno dei magistrati dimostrano plasticamente come anche la privacy sia condizione di libertà e, a un tempo, di democrazia. L’utilizzo distorto dell’informazione può determinare condizionamenti e incidere su scelte decisionali che presuppongono l’indipendenza e così determinare rischi rilevanti per la tenuta delle garanzie democratiche.
A questo proposito occorre richiamare la ricorrente affermazione della Corte di Strasburgo secondo la quale: deve essere costantemente protetto «il ruolo speciale ricoperto nella società dal potere giudiziario che, in quanto garante della giustizia — valore fondamentale in uno Stato di diritto —, deve godere della fiducia della collettività se deve poter svolgere le proprie funzioni».
La sessione è stata coordinata da Michela Petrini, sostituta procuratrice a Spoleto. Alla tavola rotonda hanno partecipano Giuliano Scarselli, professore di procedura civile presso l’università di Siena, l’avv. Cataldo Intrieri del foro di Roma e Giuseppe Santalucia, Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati.
La terza sessione ha riguardato le influenze “ambientali”. La riflessione dalla quale siamo partiti e che abbiamo deciso di esaminare con questa tavola rotonda è strettamente collegata alle enormi trasformazioni che hanno interessato la nostra società negli ultimi vent’anni.
Ci sono fattori ambientali destinati a influenzare surrettiziamente le decisioni giurisdizionali delle quali è necessario acquisire coscienza per elaborare schermi di protezione dell’indipendenza.
La riflessione dalla quale siamo partiti è che con la trasformazione da homo politicus a homo economicus anche lo iurius dicere si trova a fare i conti con gli effetti economici delle decisioni.
Su altro terreno, il PNRR, con la celerità delle decisioni che impone per fini economici, potrebbe limitare la riflessione sottesa alla soluzione dei conflitti. La rapidità nell’assunzione delle decisioni in quest’ottica potrebbe ledere l’indipendenza per la limitazione dei tempi che impone ab esterno, a scapito del cittadino. La celerità, d’altro canto, conduce al conformismo, con i danni ai quali abbiamo fatto riferimento, richiamando le parole di Nello Nappi e all’automatismo a scapito della ponderazione. I condizionamenti a scapito dell’indipendenza si registrano con riferimento al fenomeno del processo mediatico e a tutte le pulsioni populistiche che ne derivano. Spinte che portano il giudice a decidere come Pilato per accondiscendere il popolo.
Ha coordinato la terza sessione Marco Dell’Utri, consigliere della Corte di Cassazione. Hanno partecipato alla tavola rotonda Gabriella Luccioli, Presidente emerita della Prima sezione della Corte di Cassazione, Bruno Montanari, professore di filosofia del diritto presso l’Università di Catania e la Cattolica di Milano, Geminello Preterossi, professore di filosofia del diritto dell’università di Salerno e direttore scientifico dell’Istituto Italiano per gli studi filosofici di Napoli.
Infine la quarta sessione è stata pensata per analizzare l’indipendenza e l’intelligenza artificiale. Un terreno tutto da esplorare nel quale è nostra intenzione declinare il profilo dell’indipendenza in un ambito del tutto nuovo. “L’intelligenza artificiale garantisce l’assenza di condizionamenti?”
Ha coordinato l’ultima sessione Angelo Costanzo, consigliere della Corte di Cassazione e hanno partecipato alla tavola rotonda Nicola Zamperini, giornalista esperto di culture digitali, Giancarlo Montedoro, presidente di sezione del Consiglio di Stato, Ombretta di Giovine, consigliera della Corte di Cassazione.

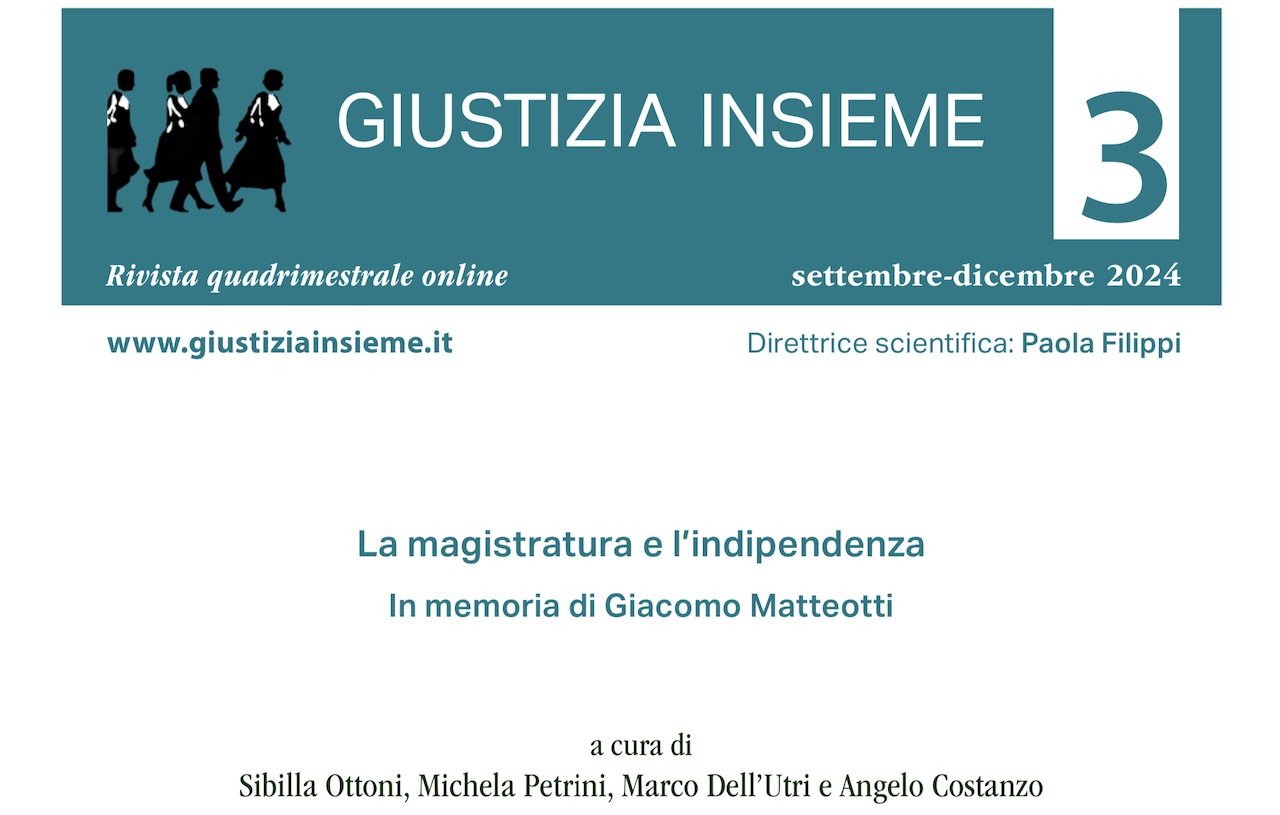

 And then Add to Home Screen.
And then Add to Home Screen.