
GIUSTIZIA INSIEME
ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma
ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma
Sommario: 1. Introduzione – 2. L’ingiustizia e la prospettiva dei diritti – 3. La sentenza della Corte di Giustizia del 22 dicembre 2022 nella causa C-61/21 – 3.1. Le conclusioni dell’Avvocato Generale Kokott – 3.2. Le conclusioni della CGUE – 4. Conclusione: le ricadute concrete della sentenza sulla causa C-61/21.
1. Introduzione
Sotto la spinta dei numerosi contributi scientifici che si sono dedicati ad approfondire il tema dell’inquinamento[1], la consapevolezza sulle conseguenze nocive per la salute umana e per l’ambiente e sui corrispondenti costi economici si è progressivamente diffusa ed è ormai ampiamente consolidata nell’opinione pubblica, a livello sia nazionale che globale[2]. Per comprendere fino in fondo i rischi connessi all’inquinamento, tuttavia, è necessaria un’impostazione sistemica che percepisca e valorizzi anche agli impatti dell’inquinamento sulla vita umana nel suo complesso, guardando, dunque, anche al di là della dimensione puramente sanitaria[3].
In questa prospettiva, il Principio 1 della Dichiarazione, adottata a conclusione della Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente umano[4], che afferma l’esistenza di “un diritto fondamentale alla libertà, eguaglianza e adeguate condizioni di vita, in un ambiente di qualità che permetta una vita di dignità e benessere”, ha rappresentato la base concettuale su cui fondare, negli anni, il riconoscimento dell’interdipendenza e dell’interrelazione esistente tra diritti umani e ambiente. Nel 2009[5], poi, si è riconosciuta ufficialmente la connessione esistente tra il contrasto all’inquinamento e la promozione dei diritti umani, mettendo in evidenza come il primo[6] inevitabilmente produca implicazioni dirette sul godimento dei secondi[7]. Nel 2021, inoltre, con la Risoluzione 48/13 del Human Rights Council, si è giunti all’espresso riconoscimento del diritto ad un ambiente salubre, inteso come il diritto umano ad un ambiente pulito, sano e sostenibile. È essenziale sottolineare, peraltro, che il riferimento esplicito, nel testo della Risoluzione, ad un “riconoscimento” del diritto, piuttosto che ad un’attribuzione o ad un’enunciazione, ha un effetto implicito cruciale, poiché include il diritto in questione nel novero di quelli che sono ontologicamente tali in quando connessi al concetto condiviso di dignità umana[8].
Se, dunque, la correlazione esistente tra inquinamento e godimento dei diritti umani appare, oggi giorno, chiara ed innegabile, è decisamente più complesso stabilire quali siano le conseguenze di questa correlazione sotto il profilo strettamente giuridico. Da un lato, infatti, occorre verificare se, ed eventualmente in che misura, gli effetti nocivi dell’inquinamento possano essere qualificati come violazioni dei diritti umani da sanzionare e risarcire. Dall’altro lato, poi, è necessario chiarire se, ed eventualmente in che misura, gli effetti nocivi dell’inquinamento, in quanto qualificati come violazioni dei diritti umani, possano essere imputati allo Stato o ad altri enti pubblici che abbiano mancato di adottare piani adeguati alle esigenze di contenimento dell’inquinamento o siano stati incapaci di rispettare i limiti alla dispersione di inquinanti imposti dalla normativa a tutela dell’ambiente. Conseguentemente, è necessario acclarare se ciò può far sorgere, in capo allo Stato o all’amministrazione, una responsabilità per lesione di una posizione giuridica tutelata riconducibile direttamente al cittadino, in modo tale da legittimare quest’ultimo ad avanzare, in sede giurisdizionale, una richiesta di risarcimento del danno.[9]
2. L’ingiustizia e la prospettiva dei diritti
Dal punto di vista giuridico, il progressivo consolidarsi della certezza scientifica circa i rischi concreti dell’inquinamento per la salute umana e la tutela dell’ambiente non si è tradotto nell’adozione di un approccio legislativo univoco alla questione né, tanto meno, ha chiarito l’attribuzione di eventuali responsabilità giuridiche alle amministrazioni pubbliche inerti o inadempienti.
Come emerge dall’analisi della legislazione nazionale ed internazionale, infatti, il panorama normativo è sempre stato caratterizzato da una forte frammentazione, contraddistinta dal susseguirsi di disposizioni finalizzate alla risoluzione di problematiche specifiche, e non si è mai arrivati concretamente all’introduzione di un regime sistemico di protezione dell’ambiente come risorsa naturale in sé. Inoltre, se è vero che, sin dalla Conferenza di Copenaghen del 2009, l'approccio restrittivo (fondato unicamente sull’introduzione di divieti e tradizionalmente tipico delle fonti normative internazionali destinate a contrastare e contenere l’inquinamento nelle sue varie forme) è stato progressivamente abbandonato in favore di un approccio proattivo (fondato invece sull’introduzione di obblighi gravanti sugli Stati di procedere all’adozione di piani nazionali e normative ad hoc), i diritti dei singoli e delle comunità sono rimasti comunque relegati a margine.
Nonostante l’approccio proattivo sia senza dubbio più apprezzabile rispetto a quello puramente restrittivo, peraltro, anche questa strategia non risulta particolarmente efficace se si considera che il contenuto delle misure adottate dagli Stati risulta spesso insufficiente e scarsamente contestualizzato poiché, generalmente, ampiamente in ritardo rispetto all'accelerazione del cambiamento climatico ed all’aggravarsi dell’inquinamento. Anche questa impostazione, dunque, mostra alcuni evidenti limiti ed ha urgente bisogno di un rinnovamento che garantisca, tra l’altro, il giusto riconoscimento e la tutela diretta ai diritti dei singoli e delle comunità.
A fronte di un tale quadro giuridico, la sensazione che si è gradualmente diffusa nell’opinione pubblica è stata quella di una generale malcelata insoddisfazione per l’inefficacia delle politiche pubbliche in questo particolare ambito, che a sua volta determina un senso di ingiustizia eco-sociale su un piano tanto globale quanto locale. E’ tuttavia da evidenziare, però, che, storicamente, l’esperienza umana dell’ingiustizia è un elemento essenziale del cambiamento, poiché rappresenta, in molti casi, il punto di partenza del tumultuoso percorso bottom up che porta all’affermazione dei diritti[10]. Sin dalla metà dei primi anni 2000, quindi, il progressivo innesto della prospettiva dei diritti nella discussione sul cambiamento climatico ha avuto l'effetto di vera e propria “chiamata alle armi”[11] per vari stakeholder, che si sono fatti carico di promuovere una progressiva traslazione della questione dal piano politico al piano giudiziario, utilizzando il linguaggio normativo dei diritti.
Nell'ultimo decennio, infatti, ha preso sempre più piede il fenomeno del “contenzioso climatico”[12], finalizzato a sostenere un mutamento di prospettiva: dalla mera protesta civile e politica circa l’ineffettività dell’azione legislativa ed amministrativa nazionale ed internazionale, al riconoscimento ed alla valorizzazione del piano soggettivo dei diritti umani e fondamentali[13].
Il “contenzioso climatico” è senza dubbio un fenomeno proteiforme, capace di raccogliere sotto un’unica formula situazioni tra loro molto diverse il cui elemento di comunanza, però, è rappresentato dall’obbiettivo perseguito: porre al centro del dibattito pubblico sulla questione climatica e la salubrità ambientale, non solo a livello politico ma a livello propriamente giuridico, i diritti degli individui e delle comunità, demandando al giudice il compito di verificare le ragioni della pretesa vantata in giudizio e, una volta accertato che essa configura una lesione dei diritti riconosciuti dall’ordinamento, quantificare un risarcimento.
Le ragioni in fatto e in diritto che, alla luce della norma di legge invocata, hanno l’effetto di costituire il diritto soggettivo da far valere in giudizio con la domanda proposta possono comprendere, ad esempio, le inadempienze degli Stati o delle multinazionali in merito ad obblighi climatici e di tutela ambientale derivanti da un combinato di norme nazionali e internazionali, ed in questi casi, la connessa domanda di tutela giurisdizionale rivolta al giudice nei confronti della parte convenuta generalmente comprende una richiesta di risarcimento del danno subito. Tuttavia, trattandosi di un fenomeno estremamente variegato, la causa petendi e il petitum delle azioni legali promosse possono essere anche estremamente vari.
Naturalmente, questa strategia, che è possibile riconoscere in tutti i contenziosi instaurati in Europa[14] innanzi a giudici nazionali o innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), si àncora all’essenza stessa del concetto di diritto, poiché è pacifico che i diritti richiedano all’apparato statale ed amministrativo di porre in essere comportamenti attivamente finalizzati a garantirne sia la tutela sia la concreta realizzazione[15]. È inoltre altrettanto condiviso che i diritti siano concetti in costante evoluzione, interpretabili ed adattabili, per consentire all’ordinamento di reagire adeguatamente alle nuove ingiustizie che l’inesauribile dinamismo sociale produce, contribuendo incessantemente all’inesorabile e perpetuo avanzamento della comunità[16].
Tuttavia, proprio quando la controparte resistente è la pubblica amministrazione, questa logica incontra, nell’ordinamento italiano, difficoltà di tipo squisitamente giuridico nel momento in cui sono dubbi: 1) l’individuazione della norma attributiva del diritto; 2) l’inquadramento della posizione giuridica vantata dal ricorrente nel novero dei diritti soggettivi o degli interessi legittimi; 3) la definizione chiara del nesso causale univoco tra condotta omissiva o commissiva dell’amministrazione e danno per il privato, cui ancorare la richiesta di risarcimento.
3. La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 22 dicembre 2022 sulla causa C-61/21
Tra le decisioni giurisprudenziali che sono destinate ad avere un forte impatto sulle politiche ambientali future dell’Unione, sull’affermazione dei diritti individuali dei singoli e sull’affermazione del diritto al risarcimento del danno da parte del privato subito a seguito di azione od omissione della pubblica amministrazione, si inserisce senza dubbio la sentenza del 22 dicembre 2022 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE)[17] che ha deciso la causa C-61/21 avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE)[18], dal giudice francese della Cour administrative d'appel de Versailles.
La domanda promossa dal giudice francese alla CGUE, nello specifico, prende le mosse da una controversia avviata in sede statale tra un privato e l’amministrazione pubblica francese nell’ambito della quale il primo ha convenuto in giudizio il Ministre de la Transition écologique (ndr. Ministro della transizione ecologica, Francia) e il Premier ministre (ndr. Primo ministro, Francia) per ottenere l'annullamento di quella che viene qualificata come una decisione implicita di diniego del Prefetto del Val-d'Oise (Francia) relativamente all’adozione delle misure necessarie alla mitigazione degli effetti dell’inquinamento atmosferico[19] nella zona di sua competenza, come invece dovrebbe avvenire in ottemperanza a quanto richiesto dalla normativa europea in tema di tutela della qualità dell’aria[20].
Tale omissione, secondo la ricostruzione del ricorrente, fa sì che il livello dell’inquinamento persista inalterato e, poiché ciò ha l’effetto di esacerbare i problemi di salute di cui questi già soffre, peggiorandone la qualità della vita, lo legittima a chiedere all’amministrazione francese il risarcimento dei danni subiti. Il ricorrente fonda la propria pretesa sul contenuto della direttiva 2008/50/CE[21] del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente[22] in Europa, facendo riferimento, in particolare, al disposto degli articoli 13, paragrafo 1[23], e 23, paragrafo 1[24] che introducono, da un lato, il concetto di valore limite e, dall’altro, l’obbligo di adottare piani per contenere l’inquinamento e garantire che i valori soglia non siano superati.
Di fronte ad una pretesa così articolata, che è già stata respinta in primo grado dal Tribunal administratif de Cergy-Pontoise (ndr. Tribunale amministrativo di Cergy-Pontoise, Francia) e per la cui risoluzione è imprescindibile una corretta interpretazione della normativa euro-unitaria, il giudice amministrativo nazionale francese di secondo grado ha quindi ritenuto di proporre un rinvio pregiudiziale direttamente alla CGUE, che è il soggetto giuridico deputato all’interpretazione delle norme europee, proponendo i seguenti quesiti: “1) Se le norme applicabili del diritto dell'Unione europea derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1 e all'articolo 23, paragrafo 1 della direttiva[2008/50], debbano essere interpretate nel senso che attribuiscono ai singoli, in caso di violazione sufficientemente qualificata da parte di uno Stato membro dell'Unione europea degli obblighi che ne derivano, un diritto a ottenere dallo Stato membro in questione il risarcimento dei danni causati alla loro salute che presentano un nesso di causalità diretto e certo con il deterioramento della qualità dell'aria. 2) Ammesso che le disposizioni sopra menzionate siano effettivamente idonee a far sorgere un siffatto diritto al risarcimento dei danni alla salute, a quali condizioni sia subordinato il riconoscimento di tale diritto, per quanto riguarda in particolare il momento in cui si deve ritenere avvenuto l'inadempimento imputabile allo Stato membro di cui trattasi.”[25]
3.1. Le conclusioni dell’Avvocato Generale Kokott
L’Avvocato Generale (AG) presso la CGUE, Juliane Kokott, investita della causa, ha proposto alla Corte, nelle sue conclusioni, il proprio parere tecnico sulla vicenda ed ha sostenuto, con limpida chiarezza argomentativa e nella piena consapevolezza della portata potenzialmente dirompente della questione oggetto della causa C-61/21, una tesi favorevole al privato ricorrente[26].
Considerate le tre condizioni che legittimano il diritto al risarcimento del danno per violazione della normativa comunitaria da parte dell’amministrazione statale (ovvero la presenza di una disciplina direttamente applicabile in favore dei privati, la presenza di una violazione qualificata imputabile allo Stato membro e la presenza di un nesso causale diretto tra violazione qualificata e danno patito dal privato[27]), infatti, l’AG articola un ragionamento lineare e dettagliato che si sofferma, dapprima, sulla questione della diretta applicabilità della direttiva 2008/50/CE e delle altre norme europee applicabili ratione temporis e, successivamente, sulla determinazione degli elementi che connotano una violazione qualificata da parte dello Stato francese e l’attivazione del nesso causale diretto.
Sotto il profilo della diretta applicabilità delle norme europee richiamate, l’AG mette in evidenza come sia assolutamente legittimo ritenere che la violazione dei valori limite per la tutela della qualità dell'aria previsti dal diritto dell'Unione faccia sorgere, in capo al privato, un diritto al risarcimento del danno patito, dal momento che tali norme sono caratterizzate da sufficiente chiarezza.[28] E’ infatti necessario, ad opinione dell’AG, valorizzare la ratio che sta alla base delle norme sulla qualità dell’aria, concepite per tutelare in modo adeguato determinate categorie di abitanti degli Stati membri che vivono o lavorano in zone particolarmente inquinate e che, dunque, sono direttamente interessati dal superamento dei valori limite o dal rischio di superamento dello stesso[29], evitando banalizzazioni che rimandano ad un concetto di salute umana generalista, privo di un contenuto non effettivamente individuato o individuabile.
Quanto, poi, alla determinazione dell’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione, l’AG richiama gli elementi che il giudice nazionale deve valutare per formare il suo convincimento[30] e conclude, sulla base dell’analisi delle disposizioni della direttiva 2008/50/CE e delle direttive che l’hanno preceduta, che un superamento dei valori limite per la qualità dell’aria ambiente, in assenza di un adeguato piano per porvi rimedio, costituisce una violazione qualificata del diritto dell’Unione, idonea a dar luogo a risarcimento. In proposito, inoltre, l’AG specifica anche che, pur nel caso in cui le autorità amministrative competenti dei singoli Stati avessero provveduto a adottare un piano in ottemperanza alle norme comunitarie, potrebbe comunque integrarsi una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione qualora il piano in questione fosse viziato da un uso scorretto della discrezionalità finalizzato ad aggirare, sotto il profilo sostanziale, gli obblighi imposti dalla normativa. Tale evenienza potrebbe verificarsi, ad esempio, quando, nel prevedere un periodo di tolleranza del superamento dei limiti degli inquinanti nell’aria, non si vincoli l’amministrazione ad agire nel più breve tempo possibile, oppure in tutti quei casi in cui i mezzi predisposti dai piani per rimediare al superamento dei limiti abbiano carattere manifestamente inadeguato; altri casi esemplari di un esercizio scorretto della discrezionalità da parte dell’amministrazione, inoltre, potrebbero verificarsi nei casi in cui i punti di campionamento su cui si basano i piani siano palesemente mal posizionati o, ancora, laddove le tecniche di modellizzazione, su cui si basano i piani, contengano errori gravi che non permettono di comprendere l’effettiva entità del superamento dei valori limite.[31]
Da ultimo, per ciò che concerne il nesso causale diretto tra la violazione qualificata del diritto dell’Unione a tutela della qualità dell’aria ed i danni concreti alla salute dei privati, pur ricordando che anche questa valutazione spetta ai giudici nazionali che devono attenersi al livello probatorio richiesto dall’ordinamento di appartenenza, l’AG delinea tre elementi la cui contemporanea sussistenza avvalora la tesi dell’esistenza di un rilevante nesso causale diretto. Il soggetto leso, infatti, deve poter dimostrare: 1) di avere soggiornato, per un periodo di tempo apprezzabilmente lungo sotto il profilo medico-scientifico, in un ambiente in cui i valori limite sono stati violati in misura rilevante; 2) di soffrire di un danno alla salute ritenuto riconducibile, dal punto di vista medico-scientifico, all’inquinamento atmosferico di cui trattasi; 3) che, nel suo caso specifico, l’aver soggiornato per un periodo di tempo apprezzabilmente lungo in un ambiente malsano, poiché caratterizzato dall’elevata presenza di inquinanti nell’aria, ha determinato al ricorrente l’insorgere (o l’esacerbarsi) di una o più patologie riconducibili, sotto il profilo medico-scientifico, alla forma di inquinamento atmosferico presente. Inevitabilmente, segnala l’AG, “ciò richiederà perizie mediche periodiche, che dovranno certamente tenere conto anche delle basi scientifiche della fissazione dei valori limite e delle raccomandazioni, talvolta ancora più rigide, dell’Organizzazione Mondiale della Sanità”[32].
Da questa ricostruzione emerge con chiarezza che, tra le tre condizioni cumulative che devono sussistere perché i soggetti privati possano ottenere un risarcimento del danno causato da un’amministrazione statale che non ha rispettato (in modo omissivo o commissivo) le norme comunitarie, la più difficile da valutare è senza dubbio la terza, ovvero l’esistenza di un nesso causale diretto tra la grave violazione e lo specifico danno subito.
3.2. Le conclusioni della CGUE
A differenza delle conclusioni dell’Avvocato Generale, la sentenza della Corte, riunitasi in Grande Sezione in ragione della rilevanza della causa[33], propone una interpretazione del diritto dell’Unione sfavorevole alla pretesa del privato.
Sebbene, infatti, la Corte si allinei ai suoi precedenti nel riconoscere che il principio della responsabilità dello Stato per danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell'Unione ad esso imputabili è inerente al sistema dei Trattati[34], che questo principio si applica a qualsiasi caso di violazione del diritto dell'Unione da parte di uno Stato membro, indipendentemente dall'autorità pubblica responsabile di tale violazione[35], e che il diritto del privato al risarcimento del danno sorge non solo nei casi in cui una disposizione del diritto dell'Unione espressamente lo attribuisce, ma anche in relazione agli obblighi positivi o negativi che la medesima impone in maniera ben definita sia ai singoli sia gli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione[36], nel caso di specie la Corte ritiene che la richiesta di risarcimento del danno avanzata dal privato non abbia fondamento.
In particolare, pur riconoscendo che le norme della direttiva 2008/50/CE e delle direttive precedenti (1980/779/CEE, 1985/203/CEE, 1996/62/CE e 1999/30/CE) prevedono obblighi sufficientemente chiari e precisi nel definire il risultato che gli Stati membri devono raggiungere ed assicurare, ad avviso della Corte tali strumenti giuridici non hanno anche la funzione di attribuire un diritto ai singoli, essendo unicamente rivolti alla protezione della salute della comunità umana e dell'ambiente nel suo complesso.
Una tale ricostruzione, che fa evidentemente venir meno la prima delle tre condizioni cumulative necessarie per poter affermare la legittimità della richiesta di risarcimento del danno vantata da un soggetto privato, sostanzialmente azzera qualunque possibilità di argomentare sul merito della richiesta di risarcimento. Al massimo, chiosa la Corte, le persone fisiche o giuridiche direttamente interessate da un rischio di superamento di valori limite o di soglie di allarme potranno sfruttare la facoltà che è loro riconosciuta di rivolgersi ai giudici nazionali competenti per ottenere un provvedimento che imponga all’autorità amministrativa di adempiere all’obbligo di facere introdotto dalla direttiva europea, predisponendo così un apposito piano d'azione per la tutela della qualità dell’aria conforme a quanto richiesto dall’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma.
4. Conclusione: le ricadute concrete della sentenza sulla causa C-61/21
La sentenza della Corte di Giustizia sulla causa C-61/21, sebbene non decida nel merito la controversia (la cui soluzione, chiusasi la parentesi del rinvio pregiudiziale, spetta comunque al giudice nazionale), avrà senza dubbio una serie di conseguenze significative sulle cause ambientali e climatiche già in corso e su quelle future, qualificandosi come un precedente favorevole alla posizione degli Stati membri resistenti con effetto vincolante non soltanto per il giudice del rinvio, ma anche per gli altri giudici nazionali investiti di questioni analoghe.
La sensazione che prevale ad una prima lettura della sentenza, tuttavia, è quella di un’occasione persa per la giurisprudenza euro-unitaria, che rinuncia a cogliere e valorizzare le esigenze di evoluzione del livello di tutela dei diritti fondamentali che caratterizza ormai, da molti anni, il panorama internazionale ed europeo.
Nell’ambito delle politiche dell’Unione Europea, infatti, la questione del miglioramento della qualità dell'aria è all'ordine del giorno da decenni e, nonostante una strategia normativa disorganica, le discipline europee in materia hanno comunque avuto l’apprezzabile merito di introdurre valori limite vincolanti per numerosi inquinanti connessi ad obblighi proattivi gravanti sugli Stati membri.
Non è, perciò, al passo con i tempi ritenere verosimile quell’interpretazione della normativa a tutela della qualità dell’aria che concepisce unicamente un interesse alla salute umana di carattere collettivo, senza ammettere alcuna possibilità di individuazione concreta di soggetti potenzialmente in condizione di subire una lesione riconducibile direttamente alla mancata attuazione, a livello nazionale, della normativa comunitaria.
Per di più, è già da lungo tempo che la giurisprudenza e la dottrina[37] hanno chiarito che la tutela della salute pubblica è ben lungi dall’essere un concetto astratto, e dipende, al contrario, dalla tutela concreta della salute dei singoli individui che fanno parte della comunità. È recentissima, ad esempio, l’ennesima pronuncia della Corte di Cassazione che, a Sezioni Unite, ribadisce che il diritto alla salute è un diritto fondamentale, nel senso che, “non tollerando compressioni neppure da parte dei pubblici poteri, mantiene sempre la sua natura di diritto soggettivo, non degradabile ad interesse legittimo”.[38] Ed è parimenti doveroso richiamare quella giurisprudenza costante della stessa CGUE[39] ove si afferma che la piena efficacia delle norme del diritto dell’Unione sarebbe messa a repentaglio, e la tutela dei diritti da esse riconosciuti sarebbe impossibile, se i singoli non avessero la possibilità di ottenere un risarcimento in tutti quei casi in cui i loro diritti siano lesi da una violazione del diritto dell’Unione imputabile a uno Stato membro.
La gravità della situazione ambientale e l’urgenza di cambiare impostazione focalizzandosi non solo sugli obblighi e i divieti ma, propriamente, sui diritti, sono inoltre testimoniate dai dieci procedimenti d’infrazione avviati dalla Commissione Europea già decisi dalla stessa CGUE[40] (nei quali si è dimostrato che i diversi Stati membri coinvolti non rispettano le norme di qualità dell’aria ambiente e, in ben nove casi su dieci, si è accertato che la violazione della normativa comunitaria era sistematica e persistente), cui si aggiungono altri sette procedimenti d’infrazione avviati dalla Commissione Europea ed attualmente ancora pendenti[41].
A ciò che accade a livello europeo, infine, fa eco il livello nazionale, ove le norme in materia di qualità dell’aria sono oggetto di controversie anche dinanzi ai giudici nazionali[42].
Certo, è indubbio che, se la Corte riconoscesse ai privati un diritto soggettivo vantabile in giudizio, il numero delle richieste di risarcimento del danno subito per violazione da parte delle amministrazioni nazionali delle norme in materia di qualità dell’aria lieviterebbe quasi istantaneamente e, come rileva l’AG nelle sue conclusioni, “a prescindere dagli associati rischi finanziari, il contenzioso relativo a siffatte rivendicazioni potrebbe costituire un onere considerevole per i giudici degli Stati membri”[43]. Tuttavia, è sempre l’AG Kokott a mettere in chiaro che, in nessun caso, nell’ordinamento europeo retto dai principi dello Stato di diritto e fondato sui Trattati istitutivi e sulla Carta di Nizza, è ammissibile limitare il riconoscimento di diritti che possono dar luogo a richieste di risarcimento solo per prevenire un aumento del contenzioso.
Il gran numero di persone potenzialmente interessate a adire le Corti per ottenere un risarcimento, semmai, dimostra l’importanza e l’improcrastinabilità di un intervento della Corte che, attraverso la sua funzione nomofilattica, sia in grado di garantire un’adeguata tutela al diritto alla salute dei cittadini europei.
Scegliendo di escludere qualunque pretesa risarcitoria, in conclusione, la Corte si sta sostanzialmente allontanando dalla sua precedente giurisprudenza sul principio della responsabilità dello Stato per danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione ad esso imputabili.
Non resta che auspicare che il legislatore euro-unitario, il quale ha già avviato la procedura per rinnovare la disciplina normativa in materia entro il 2030[44], intervenga sulla questione, per un verso rielaborando la formulazione delle norme in modo da eliminare ogni dubbio circa la possibilità di enucleare dei diritti individuali e, per altro verso, alleggerendo l’onere della prova del nesso causale tra la violazione qualificata dello Stato e la lesione subita dal privato, attraverso l’introduzione, ad esempio, di una presunzione “relativa”, in base alla quale, nel caso di un soggiorno di durata sufficientemente lunga in una zona in cui è stato superato un valore limite, il danno alla salute si possa considerare imputabile a tale superamento.[45]
[1] Tra i principali studi scientifici italiani che si sono occupati, ad esempio, del tema dell’inquinamento atmosferico si ricordano il progetto VIIAS e lo studio EpiAir2, promossi dal Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) del Ministero della Salute, nonché l’indagine longitudinale sul Delta del Po e l’indagine longitudinale nell’area urbana e sub-urbana di Pisa promossi dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).
[2] Per una ricognizione degli effetti principali dell’inquinamento sulla salute si rinvia, ex multis, a Global burden of 87 risk factors in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019, in Lancet, 17 ottobre 2020, vol. 396, n. 10258, 1223 ss.
[3] Cfr. Human Rights Council, Resolution 7/23, Human rights and climate change, 28 marzo 2008. Per un approfondimento sulla necessaria adozione di un approccio sistemico nella tutela ambientale si veda M. Ramajoli, Il cambiamento climatico tra green deal e climate change litigation, in Rivista giuridica dell’ambiente, n. 1/2021, 56, ove l’Autrice mette in evidenza che “attualmente è in corso un processo di grande fermento volto al passaggio dall’affermazione di obiettivi generali all’individuazione di strumenti giuridici per la loro attuazione. Ciò richiede primariamente la comprensione approfondita della natura degli obiettivi climatici, secondo un approccio necessariamente interdisciplinare che utilizzi i risultati ottenuti dagli scienziati del clima. In secondo luogo, in questa fase ancora embrionale è importante distinguere le policy nella lotta al cambiamento climatico dalle misure giuridiche, mantenendo sullo sfondo gli obbiettivi macro da perseguire. […] Di diverso rispetto al passato è che all’interno dell’Unione Europea ogni singola attività economica e ogni singolo settore che ha impatto diretto o indiretto sul cambiamento climatico dovranno essere rivisti alla luce del nuovo imperativo dell’emergenza climatica.” Nello stesso senso, poi, si vedano anche D. Bevilacqua, La normativa europea sul clima e il Green New Deal. Una regolazione strategica di indirizzo, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 2/2022, 297 ss., M. Delsignore, La tutela o le tutele pubbliche dell'ambiente? una risposta negli scritti di Amorth, in Diritto amministrativo, n. 2/2021, 313 ss.
[4] Svoltasi a Stoccolma dal 5 al 16 giugno 1972.
[5] In particolare, ciò è avvenuto con la pubblicazione del Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the relationship between climate change and human rights (A/HRC/10/61) elaborato dal Human Rights Council e presentato il 15 gennaio 2009.
[6] In combinazione con numerosi altri fattori, tra cui si annoverano, a titolo esemplificativo, la geografia, il livello economico-sociale, la disabilità e l’età.
[7] La connessione esistente tra inquinamento, cambiamento climatico e diritti umani è stata ribadita, di recente, anche dal Report of the Secretary-General. The impacts of climate change on the human rights of people in vulnerable situations (A/HRC/50/57), elaborato dal Human Rights Council e presentato il 6 maggio 2022.
[8] Per un approfondimento sul tema si rinvia a D. Pauciulo, Il diritto umano a un ambiente salubre nella risoluzione 76/300 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in Rivista di Diritto Internazionale, n. 4/2022, 118 ss., che commenta la risoluzione 76/300 (A/RES/76/300, par. 1) del 28 luglio 2022 con la quale l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nel contesto della 76° sessione plenaria, si è allineata alla Risoluzione 48/13 del Human Rights Council ed ha riconosciuto il diritto ad un ambiente pulito, salubre e sostenibile quale diritto umano.
[9] Cfr. G. Ghinelli, Le condizioni dell’azione nel contenzioso climatico: c’è un giudice per il clima?, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, n. 4/2021, 1273 ss.: A. Giordano, Climate change e strumenti di tutela. Verso la public interest litigation?, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, n. 6/2020, 763 ss.; E. Gabellini, Accesso alla giustizia in materia ambientale e climatica: le azioni di classe, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, n. 4/2022, 1105 ss.
[10] Cfr. E. Pariotti, I diritti umani: concetto, teoria, evoluzione, Padova, 2018; F. Viola, Il diritto come pratica sociale, Milano, 1990; F. Viola, I. Trujillo, What Human Rights are not (or not only). A negative path to Human Rights practice, New York, 2014.
[11] Cfr. M. Torre-Schaub, L. D’Ambrosio, B. Lormeteau (a cura di), Rapport final de Recherche. Les Dynamiques du Contentieux Climatique. Usages et mobilisations du droit pour la cause climatique, Mission de Recherche Droit & Justice, CNRS, CLIMALex, Institut des Sciences Juridiques & Philosophique de la Sorbonne, Parigi, 2019; M. Torre-Schaub, Justice et justiciabilité climatique: les apports de l’Accord de Paris, in Bilan et perspectives de l’Accord de Paris. Regards croisés, a cura di M. Torre-Schaub, Parigi, 2017, 107 ss.
[12] Sebbene non esista, ad oggi, una definizione universalmente accettata di “contenzioso climatico”, sono stati numerosi i tentativi definitori. Il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (United Nations Environment Programme - UNEP) ha elaborato una definizione di “contenzioso climatico” nel Report “The Status of Climate Change Litigation” del 2017: essa considera tali tutti i casi, indipendentemente dall’autorità innanzi alla quale sono discussi, che sollevano questioni di diritto o di fatto riguardanti la scienza del cambiamento climatico e gli sforzi di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico Si tratta di una definizione che si allinea alla visione proposta dalla dottrina nordamericana, secondo la quale con l’espressione “climate change litigation” si fa riferimento a “any piece of federal, state, tribal, or local administrative or judicial litigation in which the … tribunal decisions directly and expressly raise an issue of fact or law regarding the substance or policy of climate change causes and impacts.” (Cfr. D. Markell, J.B. Ruhl, An empirical assessment of climate change in the Courts: a new jurisprudence or business as usual?, in Florida Law Review, vol. 64, n. 1/2012, 15 ss.). La definizione dell’UNEP, tuttavia, esclude dal novero delle cause climatiche tutte quelle cause che, pur se destinate ad avere un impatto sulla tematica del cambiamento climatico, non vi fanno riferimento esplicito. Nel successivo Report dell’UNEP Global Climate Litigation Report: 2020 Status Review, inoltre, è stato chiarito che sono escluse dalla definizione proposta di “contenzioso climatico” tutte le cause in cui “the discussion of climate change is incidental or where a non-climate legal theory would guide the substantive outcome of the case. Thus, when climate change keywords are only used as a passing reference to the fact of climate change and those issues are not related to the laws, policies, or actions actually at issue, the case is excluded. Similarly, this report excludes cases that seek to accomplish goals arguably related to climate change adaptation or mitigation but that do not depend on the climate change dimensions of those goals. For example, lawsuits seeking to use human health regulations to limit air pollution from coal fired power plants may incidentally cause a court to compel that power plant to emit fewer greenhouse gases (GHGs). Such cases are not considered “climate change litigation” for the purposes of this study” (pag. 6). Altri autori, invece, hanno avanzato una definizione del concetto di “contenzioso climatico” che si discosta da quella proposta dall’UNEP nei suoi Report e mira a ricomprendere in questo insieme tutte le azioni legali intentate da privati, ONG e autorità locali, innanzi a tribunali nazionali o regionali e contro Stati e aziende del settore dell'energia fossile, finalizzati a contestare le politiche climatiche statali o aziendali attraverso rivendicazioni fondate sul diritto pubblico, sui diritti umani e sul diritto privato. Rispetto a quella dell’UNEP, questa seconda ricostruzione interpretativa appare maggiormente in linea con l’evoluzione che ha caratterizzato le cause dirette alla tutela dell’ambiente in senso più ampio, poiché non si limita a guardare alla questione del cambiamento climatico ma abbraccia una visione olistica improntata sul concetto di giustizia ambientale e garantisce il giusto riconoscimento al diritto dei singoli ad un ambiente salubre. (Cfr. M. Torre-Schaub, L. d’Ambrosio, B. Lormeteau (a cura di), Rapport final de recherche. Les Dynamiques du contentieux climatique, cit.)
[13] Per una ricostruzione delle tappe che hanno segnato punti fondamentali nell’evoluzione del contenzioso climatico si rinvia a M. Torre-Schaub, L. d’Ambrosio, B. Lormeteau (a cura di), Rapport final de recherche, cit.; A. Pisanò, Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei, Napoli, 2022; C. Higham, J. Setzer, E. Bradeen, Challenging government responses to climate change through framework litigation, Londra, 2022; S. Valguzza, Liti strategiche: il contenzioso climatico salverà il pianeta?, in Diritto processuale amministrativo, n. 2/202, 293 ss.; A. Giordano, Climate change e strumenti di tutela. Verso la public interest litigation?, op. cit.; F. de Leonardis, Verso un ampliamento della legittimazione per la tutela delle generazioni future, in Cittadinanza e diritti delle generazioni future, a cura di F. Astone, F. Manganaro, A. Romano Tassone, F. Saitta, Soveria Mennelli (CZ), 2010, 51 ss.
[14] Come evidenzia Pisanò, “nei contenziosi europei, gli attivisti climatici, favoriti dal fatto di convivere in uno spazio giuridico comune, quasi sempre utilizzano le stesse fonti (scientifiche e giuridiche), sviluppano le medesime strategie argomentative, si sostengono vicendevolmente, fanno riferimento ad una medesima ideologia (quella ambientalista) e hanno già condiviso esperienze pregresse di battaglie politiche, sociali, giudiziarie. Il risultato finale è l'emergere di un contenzioso climatico transnazionale dagli esiti non scontati perché potrebbero essere anche diversi da ordinamento a ordinamento, ma che attraversa tutto lo spazio giuridico europeo, utilizzando (spesso) l'argomento dei diritti come leva per spronare i governi ad assumere pienamente le loro responsabilità dinanzi all'emergenza climatica”. Cit. da A. Pisanò, Il diritto al clima, cit., 184.
[15] G. Pino, Il costituzionalismo dei diritti, Bologna, 2017.
[16] Tra le riflessioni più recenti in tema di discrezionalità interpretativa e argomentazione proposte dalla dottrina, si segnalano, per la ricchezza degli spunti, le suggestioni avanzate da P.L. Portaluri nella sua monografia La cambiale di Forsthoff. Creazionismo giurispudenziale e diritto amministrativo, Napoli, 2021, ove l’Autore, discutendo del controllo di meritevolezza ex art. 100 c.p.c. (interesse ad agire), mette in evidenza il carattere “progressivo” dei “valori” la cui evoluzione è inestricabilmente connessa all’avanzamento civile della società e si riflette positivamente sulla discrezionalità interpretativa dei diritti sanciti dall’ordinamento, consentendone (anzi, richiedendone) un ampliamento commisurato.
[17] Per un primo commento alla sentenza, elaborato nei giorni immediatamente successivi alla sua pubblicazione, si rinvia a H. van Eijken, J. Krommendijk, Does the Court of Justice clear the air: a Schutznorm in state liability after all?: JP v Ministre de la Transition écologique, in Eu law live, 10 gennaio 2023.
[18] La CGUE, nel suo parere del 18 dicembre 2014, 2/13, ha definito il rinvio pregiudiziale “la chiave di volta del sistema giurisdizionale”; esso, infatti, “instaurando un dialogo da giudice a giudice proprio tra la Corte e i giudici degli Stati membri, mira ad assicurare l’unità di interpretazione del diritto dell’Unione […], permettendo così di garantire la coerenza, la piena efficacia e l’autonomia di tale diritto nonché, in ultima istanza, il carattere peculiare dell’ordinamento istituito dai trattati” (punto 176). Per un approfondimento sul rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea si rinvia a F. Ferraro, C. Iannone (a cura di), Il rinvio pregiudiziale, Torino, 2020; A. Adinolfi, I fondamenti del diritto dell’UE nella giurisprudenza della Corte di giustizia: il rinvio pregiudiziale, in Diritto dell’Unione Europea, n.3/2019, 441 ss.; S. Foa, Giustizia amministrativa e rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in Ius Publicum, n. 2/2015, 1 ss.; R. Romboli, Corte di Giustizia e giudici nazionali: il rinvio pregiudiziale come strumento di dialogo, in Rivista AIC, n. 3/2014, 1 ss.
[19] L’inquinamento atmosferico è determinato dalla dispersione nell’atmosfera di sostanze non presenti in condizioni di aria pura (cioè costituita essenzialmente da concentrazioni definite di ossigeno O2, azoto N2, argon Ar, anidride carbonica CO2 e vapore acqueo H2O), che si distinguono in inquinanti primari emessi direttamente in atmosfera – monossido di carbonio (CO), anidride solforosa (SO2), biossido di azoto (NO2) e particolato – ed in inquinante secondario – l’ozono (O3) – prodotto principalmente da reazioni chimiche che coinvolgono NO2 e composti organici volatili (es. idrocarburi) in presenza di luce solare e di alte temperature. Sebbene tra le fonti di inquinamento atmosferico rientrino anche molti fenomeni naturali (come ad esempio le eruzioni vulcaniche e le tempeste di sabbia del deserto), è tuttavia indubbio che i più importanti inquinanti esterni derivino dall’utilizzo di combustibili fossili (utilizzati per la combustione di veicoli a motore, impianti termici ed impianti industriali), i quali generano particelle corpuscolate (presenti in concentrazioni più elevate nelle città e gravemente dannose per l’ambiente e per la salute umana. Le particelle corpuscolate possono essere suddivise in base al diametro aerodinamico medio: inferiore a 10 micron (PM10: particelle toraciche), a 2,5 micron (PM2,5: particelle fini o respirabili), a 0,1 micron (PM0,1: particelle ultrafini o nanoparticelle). Nel 2017, la European Respiratory Society (ERS) e la American Thoracic Society (ATS) hanno elaborato un documento che definisce ed individua i principali effetti avversi dell’inquinamento atmosferico (Cfr. G. D. Thurston, H. Kipen, I. Annesi-Maesano, J. Balmes, R. D. Brook, K. Cromar, S. De Matteis, F. Forastiere, B. Forsberg, M. W. Frampton, J. Grigg, D. Heederik, F. J. Kelly, N. Kuenzli, R. Laumbach, A. Peters, S. T. Rajagopalan, D. Rich, B. Ritz, J. M. Samet, T. Sandstrom, T. Sigsgaard, J. Sunyer, B. Brunekreef, A joint ERS/ATS policy statement: what constitutes an adverse health effect of air pollution? An analytical framework, in European Respiratory Journal, 11 gennaio 2017, vol. 49, (1):1600419.); un report altrettanto interessante sugli effetti sanitari principali dell’inquinamento atmosferico è stato pubblicato recentemente sulla prestigiosa rivista Lancet (Cfr. Global burden of 87 risk factors in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019, in Lancet, 17 ottobre 2020, vol. 396, n. 10258, 1223 ss).
[20] Per una ricostruzione dell’evoluzione normativa caratterizzante la progressiva introduzione di obblighi di tutela della qualità dell’aria, che metta anche in evidenza l’improcrastinabilità di un intervento legislativo per l’aggiornamento della disciplina europea, specialmente alla luce delle linee guida promosse dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2021, sia consentito rinviare a G. Torta, Spunti critici sull’aggiornamento della normativa europea in tema di qualità dell’aria, in giustamm.it, 2022.
[21] Direttiva 2008/50/CE (GU L 152 dell’11.6.2008, pag. 1-44) del Parlamento europeo e del Consiglio “relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, adottata il 21 maggio 2008 (e da ultimo modificata nel 2015). La Direttiva in questione, secondo quanto disposto dall’articolo 1, è finalizzata ad istituire misure volte a “definire e stabilire obiettivi di qualità dell’aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente nel suo complesso; valutare la qualità dell’aria ambiente negli Stati membri sulla base di metodi e criteri comuni; ottenere informazioni sulla qualità dell’aria ambiente per contribuire alla lotta contro l’inquinamento dell’aria e gli effetti nocivi e per monitorare le tendenze a lungo termine e i miglioramenti ottenuti con l’applicazione delle misure nazionali e comunitarie; garantire che le informazioni sulla qualità dell’aria ambiente siano messe a disposizione del pubblico; mantenere la qualità dell’aria ambiente, laddove sia buona, e migliorarla negli altri casi; promuovere una maggiore cooperazione tra gli Stati membri nella lotta contro l’inquinamento atmosferico.”
[22] Ai sensi dell’articolo 2 della Direttiva 2008/50/CE si intende per “«aria ambiente»: l’aria esterna presente nella troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro quali definiti dalla direttiva 89/654/CEE [ndr. Direttiva 89/654/CEE del Consiglio del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (GU L 393 del 30.12.1989, pag. 1), modificata dalla direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 21)], a cui si applichino le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e a cui il pubblico non ha accesso regolare”.
[23] All’articolo 13, (rubricato "Valori limite e soglie di allarme ai fini della protezione della salute umana") paragrafo 1, si stabilisce che "gli Stati membri provvedono affinché i livelli di biossido di zolfo, PM10, piombo e monossido di carbonio presenti nell'aria ambiente non superino, nell'insieme delle loro zone e dei loro agglomerati, i valori limite stabiliti nell'allegato XI. Per quanto riguarda il biossido di azoto e il benzene, i valori limite fissati nell'allegato XI non possono essere superati a decorrere dalle date indicate nel medesimo allegato. Il rispetto di tali requisiti è valutato a norma dell'allegato III. I margini di tolleranza fissati nell'allegato XI si applicano a norma dell'articolo 22, paragrafo 3 e dell'articolo 23, paragrafo 1".
[24] All’articolo 23 (intitolato "Piani per la qualità dell'aria"), paragrafo 1, si stabilisce, inoltre, che "Se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell'aria ambiente superano un valore limite o un valore-obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di tolleranza eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a predisporre piani per la qualità dell'aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il relativo valore limite o valore-obiettivo specificato negli allegati XI e XIV. In caso di superamento di tali valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i piani per la qualità dell'aria stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile. I piani per la qualità dell'aria possono inoltre includere misure specifiche volte a tutelare gruppi sensibili di popolazione, compresi i bambini. Tali piani per la qualità dell'aria contengono almeno le informazioni di cui all'allegato XV, punto A, e possono includere misure a norma dell'articolo 24. Detti piani sono comunicati alla Commissione senza indugio e al più tardi entro due anni dalla fine dell'anno in cui è stato rilevato il primo superamento. Qualora occorra predisporre o attuare piani per la qualità dell'aria relativi a diversi inquinanti, gli Stati membri, se del caso, predispongono e attuano piani integrati per la qualità dell'aria riguardanti tutti gli inquinanti interessati".
[25] Cit. da punto 33 della sentenza. Doveroso precisare, tuttavia, che, in realtà, dalla risposta del Giudice del rinvio alla richiesta di informazioni supplementari rivoltagli dalla Corte, risulta che il ricorrente, nel procedimento principale, chiede il risarcimento dei danni che gli sarebbero stati causati da superamenti dei valori limite di concentrazione in NO2 e in PM10 fissati all'allegato XI della direttiva2008/50/CE dal 2003: dunque, per la corretta definizione della questione, occorre prendere in considerazione non solo le disposizioni pertinenti della direttiva 2008/50/CE, ma anche quelle delle direttive 1980/779/CEE (articoli 3 e 7), 1985/203/CEE (articoli 3 e 7), 1996/62/CE (articoli 7 e 8) e 1999/30/CE (articolo 4, paragrafo 1 e articolo 5, paragrafo 1) nei periodi di rispettiva vigenza.
[26] Conclusioni dell’Avvocato Generale Juliane Kokott, presentate il 5 maggio 2022, Causa C‑61/21, JP contro Ministre de la Transition écologique e Premier ministre. Lingua originale: tedesco.
[27] Sul punto si vedano le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame (C‑46/93 e C‑48/93, EU:C:1996:79, punto 51), del 24 marzo 2009, Danske Slagterier (C‑445/06, EU:C:2009:178, punto 20), e del 10 dicembre 2020, Euromin Holdings (Cipro) (C‑735/19, EU:C:2020:1014, punto 79).
[28] Tali norme, argomenta l’AG, stabiliscono sia un obbligo, dal contenuto specifico e direttamente applicabile, gravante sugli Stati membri, di prevenire il superamento dei valori limite per gli inquinanti atmosferici considerati, sia un obbligo, altrettanto chiaro e autonomo, di predisporre piani per la qualità dell’aria che sorgono a seguito della violazione dei valori limite (punti da 33 a 71 delle conclusioni dell’AG Kokott).
[29] Si vedano, in particolare, i punti da 95 a 102 delle conclusioni dell’AG Kokott.
[30] Annoverando tra questi “l’ampiezza del potere discrezionale che tale norma riserva alle autorità, il carattere intenzionale o involontario dell’infrazione commessa o del danno causato, la scusabilità o inescusabilità di un eventuale errore di diritto e la circostanza che i comportamenti adottati da un’istituzione dell’Unione abbiano potuto concorrere all’omissione, all’adozione o al mantenimento in vigore di provvedimenti o di prassi nazionali contrari al diritto dell’Unione.” Cit. da punto 106 delle conclusioni dell’AG Kokott che richiama, in proposito, le sentenze della CGUE del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame (C‑46/93 e C‑48/93, EU:C:1996:79, punto 56), e del 29 luglio 2019, Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe (C‑620/17, EU:C:2019:630, punto 42).
[31] Inevitabilmente, un chiaro indizio che potrebbe guidare il giudice nazionale nella sua valutazione circa la validità o meno dei piani predisposti dai singoli Stati membri può essere rappresentato dalla presenza di procedure di infrazione aperte dalla Commissione nei confronti degli Stati per mancata o scorretta implementazione della direttiva 2008/50/CE. Avendo riguardo al periodo rilevante della violazione qualificata, peraltro, l’AG fa notare come “125. Una violazione qualificata delle norme relative alla protezione della qualità dell’aria ambiente per quanto riguarda il PM10 o il biossido di azoto ai sensi degli articoli 7 e 8 della direttiva 96/62, della direttiva 1999/30 nonché degli articoli 13 e 23 della direttiva 2008/50, comprende tutti i periodi durante i quali i valori limite applicabili sono stati superati in assenza di un piano di miglioramento della qualità dell’aria ambiente conforme ai requisiti di cui all’allegato IV della direttiva 96/62 o all’allegato XV, sezione A, della direttiva 2008/50, e a condizione che un piano non presentasse altre manifeste carenze.”
[32] Punto 137 delle conclusioni dell’AG Kokott.
[33] Nel corso della causa, infatti, sono pervenute alla Corte non solo le conclusioni dell’AG Kokott, ma anche le osservazioni presentate dal privato attore in sede nazionale, dal governo francese, dal governo irlandese, dal governo italiano, dal governo polacco, dal governo dei Paesi Bassi e dalla Commissione europea.
[34] Cfr. sentenza della CGUE del 18 gennaio 2022, Thelen Technopark Berlin, C‑261/20, EU:C:2022:33, punto 42 e giurisprudenza ivi citata.
[35] Cfr. sentenza della CGUE del 19 dicembre 2019, Deutsche Umwelthilfe, C‑752/18, EU:C:2019:1114, punto 55 e giurisprudenza ivi citata.
[36] Cfr. sentenze CGUE del 5 febbraio 1963, van Gend & Loos, 26/62, EU:C:1963:1, I‑5413, del 19 novembre 1991, Francovich e a., C‑6/90 e C‑9/90, EU:C:1991:428, punto 31, del 20 settembre 2001, Courage e Crehan, C‑453/99, EU:C:2001:465, punto 19, e dell'11novembre 2021, Stichting Cartel Compensation e Equilib Netherlands, C‑819/19, EU:C:2021:904, punto 47.
[37] Cfr. D. Morana, La salute come diritto costituzionale, Torino, 2021; L. Lamberti (a cura di), Diritto sanitario, Milano, 2019; B. Pezzini, Il diritto alla salute a quarant’anni dall’istituzione del servizio sanitario nazionale, in Rivista di BioDiritto, n. 2/2019, 121 ss.; G. Bianco, Persona e diritto alla salute, Padova, 2018; A. Morrone, F. Minni, Il diritto alla salute nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in Rivista AIC, n. 9/2013, 1 ss.
[38] Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza del 23 febbraio 2023 n. 5668, con la quale la Corte è stata chiamata a decidere su un ricorso per regolamento di giurisdizione proposto dal TAR Lombardia. La vicenda originava da un ricorso, presentato da un soggetto privato, che aveva convenuto in giudizio, inizialmente davanti al Tribunale di Milano, il Comune di Milano e la Regione Lombardia chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni da lui subiti in conseguenza del mancato rispetto, da parte dei convenuti, dei limiti fissati dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 155, a tutela della salute umana. Il giudice ordinario adito, tuttavia, aveva rilevato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, ritenendo che la causa fosse relativa ad un mancato esercizio, da parte del Comune e della Regione, dei poteri amministrativi finalizzati alla tutela dei cittadini dall’inquinamento atmosferico e che, dunque, la vicenda fosse da inquadrarsi come un caso di omessa adozione di provvedimenti amministrativi di carattere autoritativo a tutela della salute pubblica, perciò dalla chiara natura pubblicistica. Il privato aveva correttamente riassunto la causa davanti al Tar per la Lombardia ma anche questo giudice aveva sollevato conflitto negativo di giurisdizione ai sensi dell’art. 11, comma 3, cod. proc. amm., ritenendo che la controversia appartenesse invece alla giurisdizione del giudice ordinario; secondo il TAR, infatti, l’individuazione del giudice competente doveva essere effettuata in ottemperanza al criterio del petitum sostanziale che, nel caso di specie, era finalizzato a far valere il diritto alla salute del privato, ovvero un diritto che, per giurisprudenza costante della Corte di Cassazione non può essere affievolito o pregiudicato dall’esercizio dei poteri amministrativi. La Corte di Cassazione, riunita a Sezioni Unite, ha deciso il ricorso per regolamento di giurisdizione affermando la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle cause risarcitorie o inibitorie promosse da soggetti ai quali il fatto produttivo di danno ambientale abbia cagionato un pregiudizio alla salute o alla proprietà, secondo quanto previsto dall’art. 313, comma 7, dello stesso decreto legislativo. Al riguardo, la Corte ha affermato che “L’eventualità che l’attività nociva sia svolta in conformità a provvedimenti autorizzativi della P.A. non incide sul riparto di giurisdizione (atteso che ai predetti provvedimenti non può riconoscersi l’effetto di affievolire diritti fondamentali dei terzi) ma esclusivamente sui poteri del giudice ordinario, il quale, nell’ipotesi in cui l’attività lesiva derivi da un comportamento materiale non conforme ai provvedimenti amministrativi che ne rendono possibile l’esercizio, provvederà a sanzionare, inibendola o riportandola a conformità, l’attività rivelatasi nociva perché non conforme alla regolazione amministrativa, mentre, nell’ipotesi in cui risulti tale conformità, dovrà disapplicare la predetta regolazione ed imporre la cessazione o l’adeguamento dell’attività in modo da eliminarne le conseguenze dannose (ordinanza 23 aprile 2020, n. 8092). Allo stesso modo, è stato affermato che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia nella quale il privato, deducendo l’omessa adozione, da parte della P.A., degli opportuni provvedimenti a tutela del diritto alla salute, domandi nei confronti della stessa il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a immissioni intollerabili di odori e polveri provenienti da un’azienda agricola privata, venendo in rilievo, alla stregua del criterio del petitum sostanziale, un comportamento materiale di pura inerzia delle autorità pubbliche, suscettibile di compromettere il nucleo essenziale del diritto soggettivo inviolabile alla salute (così la recentissima sentenza 27 luglio 2022, n. 23436, in linea con la precedente ordinanza 12 novembre 2020, n. 25578).” Nel caso specifico, pertanto, la Corte non ha dubbi nell’affermare che a fondamento della domanda sta “una pretesa che si basa sulla tutela di un diritto fondamentale – quello, appunto, alla salute – che, non tollerando compressioni neppure da parte dei pubblici poteri, mantiene sempre la sua natura di diritto soggettivo, non degradabile ad interesse legittimo, con conseguente devoluzione della causa alla giurisdizione del giudice ordinario”.
[39] Cfr. sentenze CGUE del 19 novembre 1991, Francovich e a. (C‑6/90 e C‑9/90, EU:C:1991:428, punto 33); del 14 marzo 2013, Leth (C‑420/11, EU:C:2013:166, punto 40), del 24 giugno 2019, Popławski (C‑573/17, EU:C:2019:530, punto 56), e del 19 dicembre 2019, Deutsche Umwelthilfe (C‑752/18, EU:C:2019:1114, punto 54).
[40] Sentenze della CGUE del 10 maggio 2011, Commissione/Svezia (PM10) (C‑479/10, non pubblicata, EU:C:2011:287), del 15 novembre 2012, Commissione/Portogallo (PM10) (C‑34/11, EU:C:2012:712), del 19 dicembre 2012, Commissione/Italia (PM10) (C‑68/11, EU:C:2012:815), del 5 aprile 2017, Commissione/Bulgaria (PM10) (C‑488/15, EU:C:2017:267), del 22 febbraio 2018, Commissione/Polonia(PM10) (C‑336/16, EU:C:2018:94), del 24 ottobre 2019, Commissione/Francia (Superamento dei valori limite per il biossido di azoto) (C‑636/18, EU:C:2019:900), del 30 aprile 2020, Commissione/Romania (Superamento dei valori limite di PM10) (C‑638/18, non pubblicata, EU:C:2020:334), del 10 novembre2020, Commissione/Italia (Valori limite di PM10) (C‑644/18, EU:C:2020:895) del 3 febbraio 2021, Commissione/Ungheria (Valori limite di PM10) (C‑637/18, non pubblicata, EU:C:2021:92) del 4 marzo2021, Commissione/Regno Unito (Valori limite – biossido di azoto) (C‑664/18, non pubblicata,EU:C:2021:171), del 3 giugno 2021, Commissione/Germania (Valori limite di NO2) (C‑635/18, non pubblicata, EU:C:2021:437), e del 28 aprile 2022, Commissione/Francia (Valori limite di PM10)(C‑286/21,non pubblicata, EU:C:2022:319). Per un approfondimento commentato sulle sentenze che hanno sanzionato la Polonia, si rinvia a L. Busatta, Le politiche europee per la qualità dell’aria e le sfide di un concetto polisemico di salute. Corte di Giustizia dell’Unione Europea, terza sezione, C-336/16, Commissione c. Polonia, sentenza del 22 febbraio 2018, in Corti supreme e salute, n. 3/2018, 501 ss.; L. Busatta, Dal mancato rispetto delle politiche europee per la qualità dell’aria ai diritti delle generazioni future: come conciliare salute, economia e ambiente? [Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione, sentenza del 10 novembre 2020, Commissione v. Italia, C-644/18], in Corti supreme e salute, n. 1/2021, 21 ss. Per un approfondimento commentato sulle sentenze che hanno sanzionato l’Italia sia consentito rinviare a G. Torta, Spunti critici sull’aggiornamento della normativa europea in tema di qualità dell’aria, cit. Infine, per un approfondimento più generale sulle procedure d’infrazione, si vedano R. Adam, A. Tizzano, Manuale di diritto dell’Unione europea, III ed., Giappichelli, 2020; R. Adam, L’Italia e le procedure d’infrazione: ragioni e rimedi, in Il diritto dell’Unione europea, n. 2/2021, 371 ss.; M. Aranci, La procedura d’infrazione come strumento di tutela dei valori fondamentali dell’Unione europea. Note a margine della sentenza della Corte di giustizia nella causa Commissione/Polonia, in Eurojus.it, n. 3/2019, 49 ss.; M. Condinanzi, C. Amalfitano, La procedura di infrazione dieci anni dopo Lisbona, in Federalismi.it, n. 19/2020, 217 ss.
[41] Cause C‑573/19, Commissione/Italia (Biossido di azoto), C‑730/19, Commissione/Bulgaria (Biossido di zolfo), C‑125/20, Commissione/Spagna (Biossido di azoto), C‑70/21, Commissione/Grecia (PM10), C‑342/21, Commissione/Slovacchia (PM10), e C‑633/21, Commissione/Grecia (Biossido di azoto), eC‑220/22, Commissione/Portogallo (Biossido di azoto). E’ doveroso rimarcare, in proposito, che le procedure di infrazione (sia quelle già concluse con sentenza di condanna, sia quelle ancora aperte) si riferiscono a violazioni perpetrate dagli Stati di valori limite cristallizzati nella direttiva europea sulla qualità dell’aria che, rispetto ai valori limite indicati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nelle sue linee guida del 2008, erano decisamente più permissivi. Se si pensa che le linee guida più recenti adottate dall’OMS suggeriscono valori limite drasticamente più bassi rispetto a quelli proposti nel 2008 ci si rende immediatamente conto dell’urgenza di un intervento normativo in materia.
[42] A titolo esemplificativo valga richiamare la causa recentemente avviata da una coppia di genitori contro la Regione Piemonte per chiedere al Tribunale di Torino di riconoscere il diritto umano e fondamentale del proprio figlio minore (affetto da gravi malattie respiratorie) a respirare un’aria sana e pulita, come sancito dalla Direttiva UE n. 2008/50, recepita in Italia dal D. Lgs. n. 155/2010, quale espressione del diritto soggettivo costituzionalmente garantito alla vita, alla salute e ad un ambiente salubre, ai sensi degli Artt. 2, 9, 32 della Costituzione, 2 e 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e 2, 3, 37 e 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. N.r.g. 22282/2022.
[43] Punti 97 e 98 delle conclusioni dell’AG Kokott.
[44] A fine ottobre 2022 la Commissione Europea ha pubblicato una proposta per una nuova direttiva che individua norme provvisorie in materia di qualità dell'aria che, pur non recependo in toto le indicazioni fornite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel suo report del 2021, ne tengono conto e stabiliscono obiettivi di qualità dell’aria per il 2030. Il fine di tale proposta, peraltro, è il raggiungimento dell’obiettivo di un inquinamento atmosferico pari a zero, al più tardi, entro il 2050. Cfr. European Commission, Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on ambient air quality and cleaner air for Europe (recast), COM/2022/542 final, Bruxelles, 26.10.2022.
[45] L’idea di introdurre una presunzione relativa è stata proposta dall’AG Kokott nelle sue conclusioni (punto 138) e richiama la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Corte EDU) del 9 giugno 2005, Fadeyeva/Russia (55723/00, CE:ECHR:2005:0609JUD005572300, punti 87 e 88) che, in un caso di inquinamento atmosferico, ha dedotto una presunzione di danno da un superamento di valori limite e da altri importanti indizi.
Con il Convegno che si terrà il 12 Maggio 2023 a Firenze, Area Democratica per la Giustizia invita alla discussione sul futuro dell’Ufficio per il processo i protagonisti di questa innovativa e straordinaria esperienza .
Si tratta del quarto incontro promosso da Areadg sul tema.
Il primo, più di un anno fa, a ridosso dell’inserimento dei funzionari UPP nei nostri uffici, ha raccolto le aspettative ed i timori, le difficoltà, le criticità dello strumento. Sia sul piano della formazione professionale che delle condizioni materiali di lavoro, della dotazione delle risorse tecnologiche, della stessa collocazione fisica dei nuovi assunti.
Problematiche queste che hanno rallentato il pronto impiego della nuova risorsa.
Ma sin da subito abbiamo colto anche le potenzialità dello strumento unitamente ai rischi di una deriva produttivistica, coltivata anche attraverso altri interventi normativi, non orientata alla crescita della qualità della tutela giurisdizionale.
Perdipiù in una situazione di grave scopertura di organico sia dei funzionari, sia dei magistrati.
Il secondo ed il terzo incontro, a distanza di un anno dal primo, hanno messo a fuoco le diverse concrete modalità di attuazione dell’istituto, sia (nel primo dei due) con riferimento al cambiamento del modo di lavorare dei giudici (di merito e di legittimità, penali e civili) concentrando l’attenzione sulle attività di più diretto supporto alla decisione del singolo processo; sia (nel secondo) mettendo a fuoco le potenzialità organizzative a supporto della giurisdizione. Identificabili in quei servizi, trasversali rispetto al processo di definizione del singolo caso giudiziario, come quelli di monitoraggio dei flussi di lavoro, di tesaurizzazione del lavoro giurisdizionale attraverso le banche dati dei provvedimenti e degli altri strumenti del lavoro giudiziario; come anche i servizi di supporto al collegamento tra le attività dei Giudici e quelle di Cancelleria. Attività queste ultime di cui, sempre più nel recente passato, si è gravato il singolo giudice, a discapito del suo impegno nella trattazione e decisione dei processi.
Gli apprezzabili risultati sono stati il frutto dell’impegno di molti dirigenti amministrativi e magistrati, che hanno predisposto decine di progetti, nei più diversi ambiti e settori.
Ma sono stati soprattutto il frutto dell’impegno di centinaia di funzionari addetti all’ufficio per il processo, che sono cresciuti in questo anno accanto ai giudici ed agli amministrativi con cui hanno proficuamente collaborato.
In questo Convegno ascolteremo direttamente alcune loro voci.
Abbiamo anche commissionato una ricerca-sondaggio sulle aspettative dei nuovi assunti nel ruolo di funzionari Upp, sulla loro esperienza, sui loro orizzonti individuali, sulle loro proposte.
Hanno risposto al questionario oltre 2.200 funzionari, grazie all'impegno del Comitato funzionari Upp. Non possiamo non tener conto delle loro aspettative anche perché, nel frattempo, stiamo perdendo quelli di loro che optano per posizioni a tempo indeterminato in altre amministrazioni pubbliche.
È giunto ora il momento di dare un assetto ordinamentale stabile all’Ufficio per il processo, consapevoli che questo inserimento dovrà portare con sé altri interventi sul piano della riorganizzazione amministrativa.
Per sollecitare il confronto culturale, sindacale, associativo e politico ma anche per mettere a fuoco i passi sin da oggi necessari ed al contempo i ritardi del Governo abbiamo invitato esponenti dei Sindacati, dell’Avvocatura, dell’Università, dell’Anm, del CSM, Dirigenti amministrativi e dirigenti Magistrati a confrontarsi sul tema del prossimo futuro dell’UPP, consapevoli che oggi e non alla scadenza del PNRR devono esser fatte le scelte ed adottate le misure necessarie.
Su questa Rivista apri voce Ufficio del processo e organizzazione della Giustizia
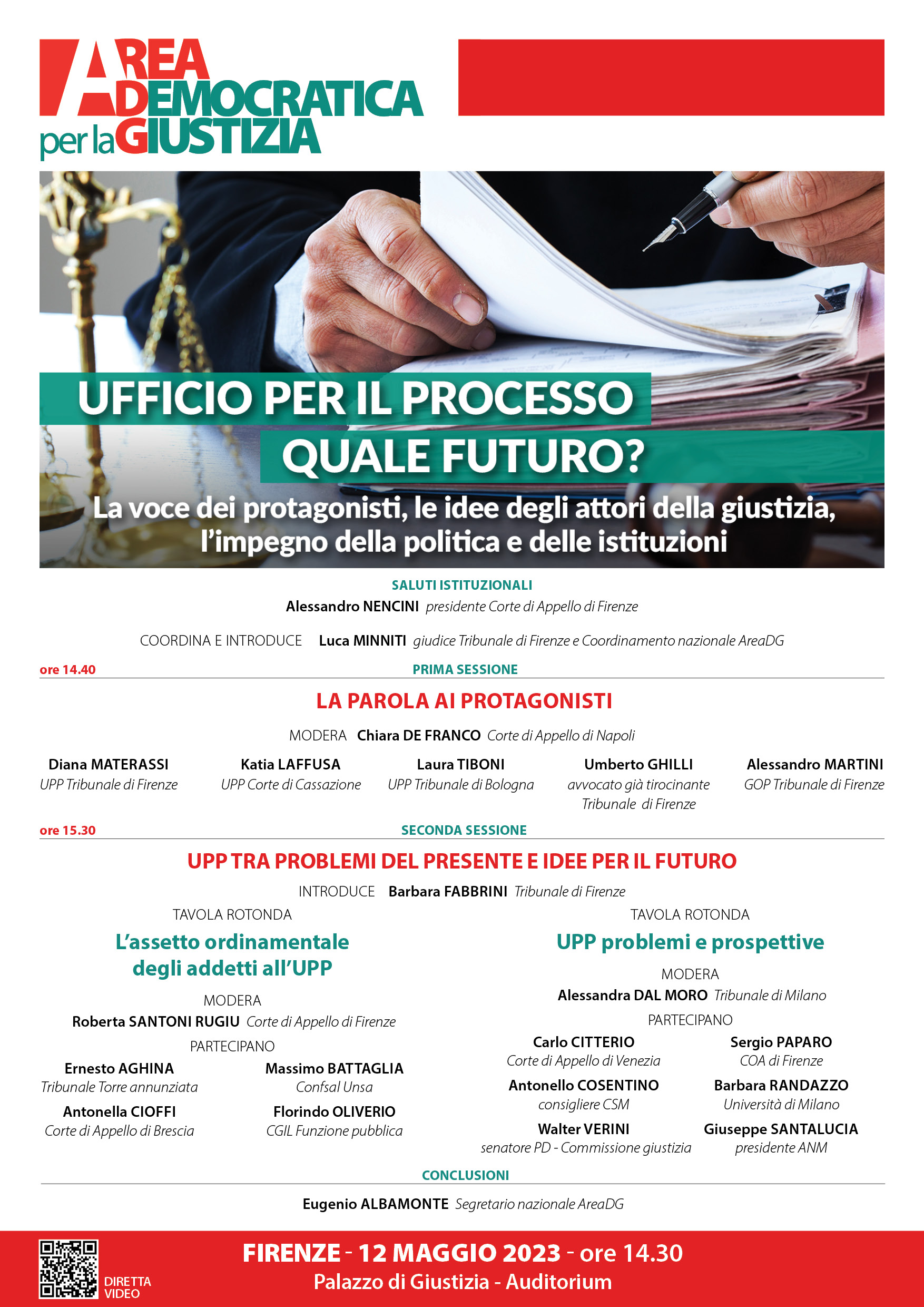
Sommario: 1. Introduzione: fondamentalista a chi? - 2. Breve storia di un termine - 3. La Finestra di Overton - 4. Conclusione: abbiamo bisogno dei fondamentalisti?
1. Introduzione: fondamentalista a chi?
Questa breve riflessione mi è stata suggerita da alcuni eventi recenti che offrono la sponda per riflettere sulla strana sorte di un termine, il quale in origine veniva portato con orgoglio, ma che oggi viene utilizzato per derubricare figure e movimenti spesso molto diversi tra loro. Come si evince dal titolo, il termine o meglio ancora l’etichetta in questione è quella di “fondamentalista”. Come altri “ismi”, questa parola viene spesso e volentieri impiegata “un tanto al chilo”: se sono di sinistra e qualcuno di destra non mi piace allora lo chiamerò “fascista”; se sono di destra e qualcuno di sinistra non mi piace allora lo chiamerò “comunista”; se qualcuno esprime opinioni di natura religiosa che eccedono il discorso normale della nostra società, allora lo chiamerò “fondamentalista”. Tutto ciò di solito avviene con particolare frequenza nel linguaggio dei mezzi di informazione e dei social media. Ovviamente, questo non significa che non vi sia chi si identifica esplicitamente con un discorso politico di stampo fascista o comunista. Come invece si vedrà, per quanto riguarda l’etichetta di fondamentalista, il discorso è più complesso. Ciò dipende in parte dal fatto che essa ha un uso quasi esclusivamente negativo al punto che anche chi è un fondamentalista nel senso storico del termine tende a non descriversi in questo modo.
Il fenomeno che descrivo è ben noto e consiste nell’usare in modo impoverito dei termini di per sé densi che vengono usati come la capote di un torero: ossia, gli si utilizza per compiere un movimento[1] (in questo caso un gesto verbale) che irriti un ricevente già maldisposto verso un certo bersaglio, al fine di prenderne il controllo e muoverlo laddove si voglia. Il torero così guadagna lo spazio per infilzare il cuore del toro, mentre l’abile comunicatore guadagna la presa sulle nostre menti, magari con l’intenzione di provocare una proverbiale levata di scudi, ondata di sdegno, manifestazione di protesta, etc. Di solito non ci accorgiamo della stregoneria ipnotica che viene esercitata su di noi perché, abituati a un linguaggio vago, semplice e piatto, abbiamo perso il gusto dei particolari. Sappiamo solo che, siccome siamo chi siamo, allora dobbiamo prendercela con il fascista/comunista/fondamentalista di turno e quindi, da bravi tori, sbuffiamo e scattiamo per incornare. Peraltro, se per caso fossimo dei tori che non vogliono morire, allora può aiutarci riflettere di più sulla storia di alcune parole, al fine di comprendere il perché e le implicazioni dell’uso semplificato che ne viene fatto. Questo potrebbe contribuire in parte a infrangere l’incantesimo di cui spesso siamo prigionieri.
Veniamo al dunque e alla questione del fondamentalismo. Come molti già sapranno, in data 15 febbraio la premier scozzese Nicola Sturgeon ha annunciato le sue dimissioni[2]. Come è naturale, a tale avvenimento ha fatto seguito un’elezione interna allo Scottish National Party (SNP), la formazione politica che attualmente governa la Scozia e a cui afferisce la ex-prima ministra, per selezionare il prossimo leader del paese. Alla fine, la vittoria ha arriso a Humza Yousaf che nel ballottaggio finale ha sconfitto con il 52% dei voti la seconda classificata Kate Forbes. Il 29 marzo di quest’anno Yousaf è quindi diventato primo ministro della Scozia con ciò realizzando due primati storici: è infatti il primo musulmano nonché la prima persona di origini asiatiche (i genitori sono pakistani) a ricoprire questo ruolo.
Arrivati a questo punto, vorrei spostare l’attenzione sulla suddetta Kate Forbes. Classe 1990, la nostra è ormai una veterana del parlamento scozzese, nel quale rappresenta dal 2016 il distretto delle Highlands di Skye, Lochaber e Badenoch di cui è anche una nativa (non a caso parla fluentemente il gaelico). Alumna delle università di Cambridge e di Edimburgo, formatasi nella sezione giovanile dell’SNP, Forbes si è distinta in particolare per aver servito dal 2018 al 2020 come Vice-Ministra alle Finanze e dal 2020 al 2023 come titolare del medesimo ministero. La sua campagna per la leadership è stata fin da subito ostacolata da un fatto che era già precedentemente noto al pubblico, ovverosia la sua appartenenza alla Free Church of Scotland. Quest’ultima è una chiesa evangelica di carattere presbiteriano e calvinista, la cui storia affonda le radici in uno scisma interno alla Chiesa di Scozia (allora chiesa di stato) avvenuto nel XIX secolo. Sebbene in crescita numerica negli ultimi anni, la Free Church of Scotland conta dei numeri alquanto esigui: circa 8000 membri a fronte di una popolazione di 5 milioni e mezzo di abitanti. Rispetto alla Chiesa di Scozia, questa compagine si distingue sia sul piano teologico che etico: pertanto, la Free Church of Scotland viene normalmente descritta come una chiesa “conservatrice” in merito a questioni quali, ad esempio, l’aborto, l’omosessualità, la transessualità, il suicidio assistito e il concepimento di figli fuori dal matrimonio.
A questo punto, devo stare molto attento a non attribuire a Forbes delle opinioni che non ha (lei stessa ha dichiarato in passato di non condividere ogni posizione ufficiale della propria chiesa[3] – fatto di per sé comune nelle tradizioni protestanti, dove non esiste un magistero vincolante). Cionondimeno, in più di un’occasione l’ex-ministra è stata cristallina in merito alla sua fede e alle sue opinioni in materia di etica. Per esempio, in un’intervista per la BBC avvenuta nel 2021 ebbe modo di affermare quanto segue: “io credo nella persona di Gesù Cristo. Credo che sia morto per me, che mi abbia salvato e che la mia vocazione sia quella di amarlo e servirlo e di servire e di amare il mio prossimo con tutto il mio cuore, la mia anima, la mia mente e la mia forza”; nel 2018 affermò che la “misura del vero progresso [di una società]” è il modo in cui vengono trattati “i non ancora nati e coloro che sono malati in modo terminale” (e ciò fu affermato articolando un’opinione che usualmente viene definita “pro-life”). Nonostante queste opinioni la mettano in chiara minoranza rispetto ai membri del suo partito (che è di centro-sinistra) e a buona parte della popolazione scozzese, Forbes ha sempre sostenuto che le sue convinzioni non fossero in conflitto con il suo compito di funzionario pubblico e con il suo dovere di servire e di rispettare i diritti di chiunque[4].
Non tutti sono della stessa opinione. Ad esempio, il suo collega John Nicholson, ex-giornalista e anch’egli membro del parlamento scozzese per l’SNP, pur affermando che in caso di vittoria di Forbes sarebbe rimasto nel partito (“it’s a democracy”, le sue parole), ha cionondimeno ritenuto che le sue convinzioni fossero sufficienti per definirla una “fondamentalista religiosa ossessionata dal sesso”[5]. Lo stesso Yousaf, discutendo le posizioni della rivale in merito alla legalizzazione del matrimonio per coppie dello stesso sesso avvenuta nel 2014 (Forbes ha affermato che se all’epoca fosse stata parlamentare non avrebbe sostenuto il disegno di legge), ha affermato che, pur essendo un musulmano orgoglioso della propria fede e che rispetta ossequiosamente il Ramadan, egli “non usa la sua fede come base della legislazione pubblica”[6]. A voler essere maliziosi si potrebbe dire che in pratica Yousaf abbia confessato di pensarla come la rivale, pur non rinunciando per questo ad adottare una posizione politicamente più vantaggiosa. Sia come sia, questo sembra avergli evitato di essere etichettato come “fondamentalista”.
C’è chi sostiene che l’onestà di Forbes le sia costata la posizione di primo ministro e forse la sua intera carriera politica (per ora quello che è certo è che Yousaf l’ha sostituita nel suo ruolo di ministra, il che però è una conseguenza abbastanza prevedibile del ricambio avvenuto nella leadership dell’SNP)[7]. Questo è difficile affermarlo con certezza: il suo impegno come parlamentare è ormai decennale e le sue posizioni non sono mutate all’improvviso, né erano state tenute segrete in precedenza; inoltre, la sconfitta a vantaggio di Yousaf è stata di 48 a 52 e quindi relativamente corta, il che sembra indicare che per molti le sue convinzioni non abbiano costituito un ostacolo a sostenerla. Sicuramente, nel momento in cui Kate Forbes ha scelto di candidarsi alla poltrona di primo ministro (ed essendo la sua una candidatura forte) è stata anche esposta a un’attenzione senza precedenti; altrettanto sicuramente, il suo parlare in modo chiaro ed esplicito in merito a questioni controverse non le ha giocato a favore.
Ciò detto, la questione su cui vorrei riflettere è la seguente: come è possibile che una figura quale quella della Forbes che, al netto di alcune posizioni minoritarie nel contesto del suo panorama sociale, è pienamente integrata nell’establishment (parlamentare, ministra di un partito di governo, laureata presso università illustri), sia stata cionondimeno classificata così rapidamente come “fondamentalista” e collocata quindi nella stessa categoria abitata da personaggi quali, ad esempio, Osama Bin Laden?
2. Breve storia di un termine
Per poter iniziare a rispondere a questa domanda e in un secondo momento cercare di trarne delle riflessioni che si spera siano utili, è necessario fare un passo indietro e indagare la storia di questa famigerata etichetta. Certo, nel farlo bisogna evitare di commettere quello che è un errore piuttosto comune, ovvero credere che la natura di qualcosa sia immediatamente identico alle sue origini. Perché questo sia un problema, lo si capisce se pensiamo al fatto che, sebbene sia corretto affermare che le mele provengono dagli alberi di mele, è però sbagliato affermare che la natura di una mela sia identica a quella dell’albero da cui proviene. Se non ci credete, provate a mordere un ramo di melo. Dunque, discutere la natura del termine “fondamentalista” non ci può fornire immediatamente la spiegazione del suo uso odierno, né ci può aiutare automaticamente a chiarire la natura della dinamica sociale che tende a mettere Kate Forbes e Osama Bin Laden nello stesso gregge. Cionondimeno, conoscere la natura dei meli è innegabilmente utile e necessario per capire la natura delle mele. D’altronde, quest’ultime non cadono dal cielo e, conoscendo la biologia del melo, possiamo tracciare il processo con il quale quest’albero produce i suoi frutti. Quindi, indagare la storia di un termine (o meglio, la storia dei suoi usi) ci può aiutare a comprendere come si sia arrivati alla situazione presente.
Per iniziare quest’indagine, vorrei fare riferimento a un secondo episodio avvenuto di recente e per la precisione nel maggio del 2021. In quella data la Saddleback Church, una congregazione battista evangelica che ha sede a Lake Forest, California, ha celebrato l’ordinazione al pastorato di tre dei suoi membri. Bisogna subito specificare, e tra un momento si capirà l’importanza di tale precisazione, che si trattava di tre persone di sesso femminile.
Quello di Saddleback è un nome molto importante all’interno del cristianesimo statunitense e mondiale. Fondata dal pastore Rick Warren e dalla moglie Kay nel 1980, quello che era nato come uno studio biblico a cui partecipavano 6 persone e che si teneva nell’appartamento dei Warren è cresciuto fino a diventare una chiesa che oggi conta una presenza media di 23mila persone ogni domenica. Warren è andato in pensione l’anno scorso ma la sua carriera alla guida di Saddleback non è stato solo un successo locale ma ha segnato la nascita di un certo stile di fare chiesa che, anche grazie alla pubblicazione di alcuni libri di successo, lo ha trasformato in una personalità pubblica di fama internazionale. Per capirci, nell’agosto del 2008 le strutture di questa comunità evangelica hanno ospitato un dibattito tra i candidati alla presidenza Barack Obama e John McCain (posti sold-out venduti per 1000 dollari l’uno) – si trattava in assoluto della loro prima apparizione congiunta in pubblico.
Nonostante il peso e la fama della comunità e della sua leadership, la famiglia di chiese di cui Saddleback faceva parte (ossia la Southern Baptist Convention, e quindi la più grande denominazione battista e più grande denominazione protestante degli USA) ha deciso di espellere la congregazione californiana a seguito dell’evento precedentemente ricordato. Il motivo di tale gesto è che secondo la comprensione delle Scritture della Southern Baptist Convention il ruolo di pastore dovrebbe essere riservato ai soli uomini (posizione questa che però non è condivisa da molte chiese evangeliche). Dunque, con democratico voto di maggioranza si è ritenuto che, in coerenza con la posizione ufficiale della SBC, chi non è d’accordo, anche se si chiama Rick Warren e la sua chiesa è la Saddleback, è pregato di recarsi all’uscita[8].
La cosa interessante è che fino a poco tempo fa le opinioni di Warren in materia erano in linea con la sua denominazione. Come lui stesso ha dichiarato, le sue posizioni sono mutate circa tre anni fa dopo aver studiato attentamente il tema. Recentemente intervistato da Russell Moore per Christianity Today[9], Warren ha descritto in questo modo la sua posizione teologica e l’opposizione che ha dovuto affrontare da parte di alcuni dei suoi co-religionari:
“questa è la stessa vecchia battaglia che dura da cent’anni all’interno della SBC tra battisti conservatori e battisti fondamentalisti. È importante sottolineare che il termine fondamentalismo è una parola che ha cambiato significato nel corso del tempo. Cent’anni fa, mi sarei definito anch’io un fondamentalista. Questo perché negli anni ’20 essere un fondamentalista significava semplicemente affermare le dottrine storicamente insegnate dalla chiesa come, ad esempio, la natura espiatoria del sacrificio di Cristo e l’autorità assoluta delle Scritture – insomma, tutte le dottrine fondamentali che definiscono il protestantesimo. Oggi usiamo questa parola in modo diverso e infatti si parla di musulmani fondamentalisti, buddisti fondamentalisti, atei fondamentalisti, comunisti fondamentalisti – bisogna quindi notare che chiamiamo fondamentalisti anche persone che hanno una visione del mondo completamente secolarizzata. Attualmente, in sostanza, l’unica cosa che si vuole indicare con questa parola è che sei una persona che ha smesso di ascoltare”[10].
Continua poi Warren:
“Io credo nell’inerranza delle Scritture. Io non credo però nell’inerranza di una qualche interpretazione delle Scritture – ivi inclusa la mia […] dobbiamo sempre approcciarci alla Bibbia con umiltà tenendo a mente che potremmo anche avere torto. Non sentirai mai un fondamentalista dire che potrebbe avere torto. Un battista conservatore crede nell’inerranza delle Scritture. Un battista fondamentalista crede nell’inerranza della sua interpretazione”[11].
Dunque, l’ex-pastore della Saddleback descrive con lucidità l’uso odierno del termine fondamentalista. Inoltre, secondo Warren, l’atteggiamento del fondamentalista si distingue da quello di chi, come lui, ha delle convinzioni ben definite e della cui superiorità è convinto, ma che allo stesso tempo rimane umile riconoscendo la propria fallibilità umana. In seconda battuta, l’altro elemento rilevante che emerge da questo stralcio di conversazione, è l’affermazione di Warren per la quale negli anni ’20 del secolo scorso egli non avrebbe avuto problemi a definirsi come un fondamentalista. Quest’affermazione ci consente di aprire il discorso sugli avvenimenti che portarono alla nascita di questo termine.
Normalmente nella letteratura si parla della “controversia fondamentalista-modernista” per indicare una disputa e il susseguente scisma avvenuto all’interno della Chiesa Presbiteriana statunitense[12]. Da una parte, i modernisti proponevano un adattamento del messaggio cristiano secondo le scoperte scientifiche e la morale dell’epoca; nei fatti, questo significava rinunciare a considerare la Bibbia come un testo ispirato, negare la storicità dei miracoli (ivi inclusi il parto virginale e la risurrezione di Cristo) e che la crocifissione di Gesù avesse in qualche modo fatto ammenda per i peccati dell’umanità. Dall’altra parte, i fondamentalisti erano coloro che, pur non presentando una posizione in sé antimoderna, ritenevano che le verità di fede tradizionalmente insegnate dalla Chiesa dovessero essere mantenute anche di fronte alla sfida delle ideologie contemporanee; per costoro, andare nella direzione indicata dai modernisti non significava sviluppare ma di fatto abbandonare la fede cristiana. In altri termini, il modernismo era da considerarsi a tutti gli effetti come l’anticamera dell’agnosticismo e dell’ateismo.
È quindi in quest’ambito che nacque l’uso del termine fondamentalista. Più nello specifico, per comprendere come ciò sia avvenuto bisogna risalire al 1909, data in il presbiterio di New York (ovverosia l’assemblea deputata, tra le altre cose, a promuovere all’ordinazione i candidati pastori della chiesa presbiteriana) decise di non accogliere tra individui che si erano rifiutati di sostenere pubblicamente la dottrina del parto virginale di Cristo. L’anno seguente, una commissione dell’assemblea generale della Chiesa Presbiteriana negli USA formulò un documento (poi accettato dall’assemblea) in cui si indicavano 5 dottrine come “necessarie ed essenziali” alla fede cristiana:
- L’ispirazione della Bibbia per opera dello Spirito Santo e pertanto la sua inerranza;
- Il parto virginale di Cristo;
- La morte di Cristo come fatto avvenuto per il perdono del peccato dell’umanità;
- La corporeità della risurrezione di Cristo;
- La realtà storica dei miracoli di Cristo[13];
In seguito a questo pronunciamento, dietro l’iniziativa di due facoltosi presbiteriani, Lyman e Milton Stewart (contraltari di John Rockfeller Jr., sponsor illustre dei modernisti), tra il 1910 e il 1915 vennero pubblicati una serie di pamphlets intitolati The Fundamentals: A Testimony to the Truth. Si trattava di una collezione di 90 testi composti da un gruppo di 64 accademici, selezionati nel panorama del protestantesimo non-modernista e rappresentanti ciascuna delle principali tradizioni componenti il panorama delle chiese evangeliche. Ognuno dei 90 Fundamentals aveva lo scopo di esporre in modo convincente una delle dottrine classiche della teologia cristiana, oppure di offrire una difesa apologetica contro alcune argomentazioni di taglio modernista, o infine di criticare il modernismo stesso e altri movimenti invisi agli autori (come, per esempio, i Mormoni e i Testimoni di Geova). Il termine “fondamentalista” sembra essere stato coniato in riferimento al titolo di questi testi e alla posizione propugnata dai loro autori pur tenendo conto del fatto che questi tra loro potevano avere opinioni alquanto diverse su determinati argomenti; i Fundamentals, infatti, servivano a definire e a difendere solamente quello che si riteneva essere l’essenziale di una visione cristiana del mondo[14].
Sviluppatosi in seno alla chiesa presbiteriana, il conflitto tra fondamentalisti e modernisti si estese a tutto il protestantesimo statunitense[15] facendo sì che figure appartenenti a tradizioni spirituali diverse facessero fronte comune per avversare la parte opposta. Un passaggio simbolico fu rappresentato dal famoso sermone “Shall the Fundamentalists Win?” predicato nel maggio del ’22 da Harry Emerson Fosdick, evento che spesso viene indicato dagli storici come l’inizio della controversia vera e propria. Costui, pur essendo di estrazione battista era in quel momento assegnato alla First Presbyterian Church di New York. Nella sua predica suddetta, Fosdick presentava i fondamentalisti come degli intolleranti che rifiutavano di fare i conti con la modernità e che avevano deciso, in maniera del tutto arbitraria, che determinati articoli di fede non potevano essere oggetto di dibattito. Da parte sua, il pastore presbiteriano di Philadelphia Clarence E. Macartney decise di rendere pane per focaccia ribattendo con un sermone, poi pubblicato, intitolato “Shall Unbelief Win?” Infatti, per Macartney la prospettiva di Fosdick era una pura e semplice negazione della fede cristiana che, se lasciata incontrastata, avrebbe secolarizzato il cristianesimo fino a svuotarlo di senso, trasformandolo in una sua versione priva di Dio e di Gesù Cristo. Al fine di evitare quest’eventualità il modernismo, secondo il pastore di Philadelphia, andava affrontato con “serietà, intelligenza e con spirito cristiano”[16].
Da qui in avanti il conflitto proseguì per due decenni. Alla fine degli anni ’30 i modernisti sembravano essere padroni del campo: i principali seminari teologici del paese erano sotto il loro controllo e così le case editrici e le posizioni di governo delle principali chiese evangeliche statunitensi. A ciò fece seguito un esodo di massa dei fondamentalisti che, fuoriusciti dalle loro comunità, fondarono nuove denominazioni, nuove congregazioni, nuove case editrici, nuove università e nuovi seminari[17]. La situazione cominciò a invertirsi a partire dagli anni ’70: oggi, il modernismo (anche se adesso si tende a preferire il termine “liberalismo”) sembra essere in via d’estinzione mentre le chiese nate dall’esodo fondamentalista, pur iniziando a mostrare di soffrire anch’esse gli effetti della secolarizzazione, sono in netta superiorità numerica e sembrano godere di una maggiore solidità. Quella che quindi era iniziata come una disputa locale a New York si estese a tutta la nazione americana e per la durata di un intero secolo.
Questo ci riporta al caso di Rick Warren (e come vedremo tra un attimo anche a quello di Kate Forbes). Ora possiamo infatti capire parte della sua affermazione: nell’intervista con Moore egli afferma di essere ben contento di schierarsi come successore spirituale di coloro che un secolo fa difesero l’ortodossia cristiana di fronte all’eresia modernista; allo stesso tempo, secondo l’uso contemporaneo, Warren applica il termine fondamentalista a chi, lungi dal volersi impegnare in un dibattito di idee come fecero gli autori dei Fundamentals, ha semplicemente elevato la propria dottrina a un rango di intoccabilità che per un buon cristiano dovrebbe appartenere soltanto alle Scritture. Secondo questa prospettiva, Kate Forbes, una donna che è ben felice di servire un paese e un partito che in larghissima parte non condividono la sua fede, sembrerebbe non meritarsi l’appellativo di “fondamentalista”, o quantomeno, non secondo l’accezione negativa che anche Warren rifiuta[18]. Emerge però un problema che è subito evidente: infatti, per un Fosdick già i fondamentalisti “buoni” erano dei fondamentalisti “cattivi”. Di converso, per un Warren, il fondamentalista “cattivo” potrebbe anche essere una persona non molto diversa da Fosdick, la quale, piegandosi in maniera acritica ai dogmi delle ideologie materialiste partorite dall’epoca moderna, non esita a negare ogni plausibile validità a un deposito di fede e saggezza tramandato per millenni. In effetti, secondo la definizione di Warren il fondamentalista “cattivo” potrebbe celarsi anche dietro le parole di quel collega di Forbes che non ha esitato a definirla una “fondamentalista religiosa ossessionata dal sesso”. Forse è lui la persona che non ha nessuna intenzione di ascoltare opinioni diverse dalle sue.
Ed è qui che torniamo ad Osama bin Laden. Perché è chiaro a questo punto un fatto piuttosto semplice: una diagnosi di fondamentalismo dipende almeno in parte dal punto di vista di chi la esprime; ma si tratta solo di una questione di punti di vista? Perché in effetti il leader di al-Qaeda sembra una figura alquanto diversa da tutte le altre personalità che sono state finora menzionate. Eppure, se esiste almeno un punto di vista per cui ciascuna di loro è definibile come un fondamentalista e per lo stesso punto di vista lo è anche bin Laden, allora esiste almeno un punto di vista secondo il quale Fosdick, Warren, Forbes etc. sono compagni di stanza del terrorista saudita. Questo sembra un risultato piuttosto sconcertante perché intuitivamente sembra che stiamo mischiando le mele con le pere e che lo facciamo mentre insistiamo sul fatto che in fondo anche le mele sono delle pere, se soltanto ci decidiamo a chiamarle pere. Quindi, o il termine fondamentalista (e analoghi) in realtà è soltanto un epiteto offensivo che appiccichiamo a persone con cui non siamo d’accordo e che vogliamo identificare come portatrici di opinioni inaccettabili (e che diventa poi il capote del torero) oppure serve un metro più oggettivo che consenta un uso discernente di quest’espressione.
Certo, potremmo decidere di smettere di usare questa parola e sceglierne una migliore. Questa però non sembra essere una possibilità concretamente disponibile alla luce del suo successo e della sua attuale diffusione. Allo stesso tempo, è importante riflettere su questo tema perché storie come quella del caso Forbes sono molto vicini a noi nel tempo e nella cultura, e, sebbene abbia evitato di fare riferimento diretto alla realtà italiana, abbiamo vissuto e vivremo ancora casi analoghi. Dobbiamo quindi accontentarci di usare un linguaggio vago per affrontare questioni di primaria importanza per la nostra vita pubblica (come, ad esempio, se una persona con determinate opinioni religiose sia per questo inadatta a svolgere incarichi politici)? Per questo, procediamo oltre e cerchiamo di capire se è possibile evitare questo destino che, personalmente, ritengo alquanto tragico (ma non inevitabile).
3. La Finestra di Overton
Arrivati a questo punto, per poter provare a sbloccare l’impasse in cui ci si è venuti a trovare, è necessario introdurre un concetto ulteriore. Questo è quello della ben nota “Overton Window” o “Finestra di Overton”, un’idea che prende il nome da un analista politico americano, Joseph Overton, che ebbe modo di svilupparla a metà degli anni ’90 del secolo scorso. La Finestra di Overton è un modello sviluppato per comprendere il modo in cui le scelte dei rappresentanti politici di un paese mutano e sono condizionate in base alle opinioni che vanno per la maggiore nella loro cultura di appartenenza. Fondamentalmente, esso si basa sul concetto che, al di là delle loro opinioni personali, i politici sono in grado di promuovere in modo efficace uno spettro limitato di proposte di legge[19]. A loro volta, queste sono viste come in linea di principio legittime in quanto riflettono un insieme di opinioni ritenute valide dalla maggioranza della popolazione. Politici che cercano di avanzare proposte che si collocano al di fuori della Finestra di Overton sono a rischio di subire un forte danno alla loro popolarità e di essere visti come degli estremisti, oppure come promotori di idee datate e/o bizzarre, etc. Da ciò deriva che i nostri politici sono più dei seguaci che dei leaders; ovviamente potrà darsi il caso in cui un’idea ai limiti del discorso pubblico si affaccia sul centro del dibattito ma questa sarà l’eccezione piuttosto che la regola[20]. Normalmente, i nostri rappresentanti tenderanno a orientarsi secondo le influenze maggioritarie espresse dalla società civile (che non significa necessariamente le influenze che provengono dalla maggioranza numerica della popolazione). Anche laddove un politico popolare propone delle idee ritenute radicali, è probabile che esso lo siano in senso molto relativo, ovvero che esse si collochino semplicemente un passo più in là di ciò che è considerato essere “buon senso”.
Di norma, la Finestra di Overton viene rappresentata tramite l’uso di una linea verticale divisa in sei livelli, ciascuno dei quali descrive il grado di accettabilità di una determinata posizione politica. Leggendo tali livelli in senso ascendente, la scala che ne risulta va da “impensabile” a “popolare”. Nel mezzo, si passa per le categorie di “radicale”, “accettabile” e “responsabile”[21]. Ovviamente, la distribuzione delle singole idee all’interno della Finestra di Overton cambia nel corso tempo. Pertanto, ciò che può essere impensabile in un certo periodo storico può invece diventare accettabile se non addirittura legge dello Stato in un periodo storico differente. Sulla base di quanto esposto è possibile dedurre che in linea di principio possono esistere nello stesso spazio sociale gruppi d’influenza che hanno idee molto diverse su cosa sia politicamente accettabile e cosa no.
Applicando la Finestra di Overton al tema di questo articolo è possibile affermare che per la Saddleback Church l’avere una donna come pastore è passato dall’essere “inaccettabile” a essere una prassi “accettabile” e poi concretamente adottata. Ciò è stato a sua volta ritenuto “inaccettabile” dalla Southern Baptist Convention. A loro volta, ci saranno sicuramente dei secolaristi militanti negli USA che ritengono di per sé “inaccettabile” il fatto che qualunque individuo, uomo o donna che sia, abbia un ruolo di leadership definito sulla base di un insegnamento religioso – e così via. Pertanto, si può ipotizzare che l’uso della parola fondamentalista ricalchi più o meno quello che in base alla Finestra di Overton si identifica come politicamente “inaccettabile”.
Sicuramente, sembra che i colleghi e rivali di Kate Forbes abbiano additato l’inaccettabilità di alcune delle sue idee (per quanto nel merito non si discutesse la possibilità di trasformarle in legge). Ciò si è affiancato, quantomeno per alcuni, con il designarla come una fondamentalista. Questo però ci riporta per l’ennesima volta allo stesso problema, che ora possiamo affrontare con un linguaggio più preciso: nel contesto della politica scozzese del 2023, Osama Bin Laden e Kate Forbes sono da considerarsi nello stesso modo inaccettabili (chiaro che Bin Laden ora non è più nelle condizioni di fare politica, ma lo si dice così per ipotesi)? Intuitivamente la risposta sembra essere “no” e ciò non solo perché Forbes ha comunque ricevuto il 48% dei voti nella corsa alla leadership dell’SNP ma anche perché la Free Church of Scotland non si pone rispetto alla Scozia nello stesso modo in cui lo fa Al-Qaeda. Anzi, nonostante il suo essere una minoranza portatrice di molte idee “inaccettabili” (nel senso della Finestra di Overton), si può affermare che il fatto che essa possa contribuire a far emergere una figura come quella di Kate Forbes sia una testimonianza della sua capacità di servire la società di cui fa parte.
Il problema, quindi, è duplice: da un lato, come è già emerso, il linguaggio del “fondamentalismo” (e analoghi) è impreciso e questa è già di per sé una pietra d’inciampo. A ciò si aggiunge il fatto che tale imprecisione contribuisce a confondere la distinzione tra diversi tipi di inaccettabilità politica, il che tende inevitabilmente a schiacciare verso il fondo le idee che non si collocano nella parte superiore della Finestra di Overton. Ciò significa che per effetto di questa imprecisione la vita politica di una società finirà probabilmente per impoverirsi in termini di biodiversità riproducendo solo un certo tipo di indirizzo, e ciò magari a fronte di una società civile che invece va diversificandosi.
4. Conclusione: abbiamo bisogno dei fondamentalisti?
Quest’articolo ha preso le mosse da alcuni eventi di cronaca recente, ed è proseguito con una breve storia del termine “fondamentalista”. Si è suggerito che la vaghezza con cui tale parola è stata utilizzata negli eventi riportati sia il sintomo di una prassi linguistica più ampia. Allo stesso tempo, sembra che il termine fondamentalista sia stato dalle sue origini carico di una certa ambiguità, oscillando tra un significato positivo (una sana fedeltà a una certa tradizione di fede) e un significato negativo (di intolleranza e rifiuto del confronto) che infine si è imposto come l’unico comunemente impiegato. Si è proseguito introducendo lo strumento analitico della Finestra di Overton, suggerendo che nel linguaggio comune si parli di fondamentalismo per descrivere idee e persone che sono o si ritengono debbano essere ritenute politicamente inaccettabili. Infine, si è suggerito che nel calderone del “fondamentalismo” potrebbero rischiare di finirci delle voci minoritarie che invece è interesse della società che vengano ascoltate, se non altro per non rendere il discorso politico sterile ed omogeneo.
Su questa nota, vorrei concludere con un ultimo riferimento storico, anche questa volta tratto dalla realtà americana. Si tratta nello specifico di un testo del 1988, la Williamsburg Charter, che ha come oggetto il tema della libertà di religione nella vita pubblica statunitense. Gli autori e i firmatari includevano sia personalità religiose che di orientamento secolarista; la redazione fu guidata da Os Guinness e tra i consulenti accademici spiccano nomi come quelli di Robert Bellah e Peter Berger. Tra i sostenitori che firmarono la Williamsburg Charter attirano l’attenzione gli ex-presidenti degli Stati Uniti Jimmy Carter e Gerald Ford e dei Chief Justices della corte suprema William Rehnquist (all’epoca in carica) e Warren Burger. Il testo venne presentato al pubblico a Williamsburg, Virginia il 25 giugno del 1988 e ciò per ricordare il 200° anniversario della richiesta da parte della Virginia al Congresso di una carta dei diritti (che diverrà poi il Bill of Rights e cioè i primi dieci emendamenti della costituzione degli Stati Uniti).
La Williamsburg Charter si poneva quattro obbiettivi: 1) celebrare l’importanza del primo emendamento della costituzione degli USA, e cioè quello riguardante la libertà di religione; 2) riaffermare l’importanza della libertà di religione – o libertà di coscienza – per i cittadini di ogni fede o di nessuna; identificare il ruolo di tale libertà nella vita pubblica statunitense rispetto alla quale tale diritto viene identificato come il primo e il più fondamentale dei diritti. A favore di questo punto la Charter sottolinea come tale diritto apra il Bill of Rights e come sia l’unico a cui la costituzione dedica due clausole (la prima proibisce al congresso di adottare una particolare fede come religione di stato, mentre la seconda gli proibisce di impedire il suo libero esercizio); inoltre, le libertà di parola, di stampa, di assemblea e di rivolgersi al Governo in caso di abusi (tutte trattate all’interno del primo emendamento) vengono considerate per analogia e per derivazione dalla libertà di coscienza[22].
Secondo gli autori della Williamsburg Charter:
“l’esistenza della società americana dipende dalla risposta che si dà a due domande. In base a quali verità ultime dovremmo vivere? In che modo queste verità dovrebbero entrare in relazione con la nostra vita pubblica?”
Essi aggiungono che la prima domanda ha un carattere personale ma che cionondimeno ha una ricaduta pubblica perché le convinzioni personali influenzano necessariamente la qualità della nostra vita pubblica. Proseguono poi affermando che “la risposta americana alla prima domanda è che il governo non può rispondervi. La seconda domanda, però, ha un carattere completamente pubblico ed è appropriato e necessario per il bene della società che essa riceva una risposta pubblica”. In sintesi, la risposta che viene proposta dagli autori della Williamsburg Charter (e che essi ritengono rifletta anche le intenzioni degli autori della Costituzione) è che, nei limiti della sicurezza dello Stato, i cittadini dovrebbero essere liberi non solo di coltivare privatamente ma anche di esprimere in pubblico (e quindi anche nell’arena politica) le proprie convinzioni. Anzi, secondo i suddetti una forma di governo democratico può sopravvivere solo se essa viene sostenuta da un popolo virtuoso e di forti convinzioni e solo se al suo interno si producono delle tensioni produttive tra gruppi che professano credenze che possono anche essere mutualmente esclusive.
In definitiva, secondo questo punto di vista, una certa forma di fondamentalismo non è solo accettabile nella vita pubblica di una democrazia moderna ma, anzi, sembra esserle persino essenziale. Sicuramente, la Williamsburg Charter sostiene che una democrazia è destinata a soccombere senza la presenza al suo interno di comunità che prendono sul serio le proprie convinzioni anche a costo di scontrarsi tra loro e che nel contempo sono capaci di formare cittadini attivi, partecipi, onesti e responsabili. In quest’ottica, contro Yousaf Hamza, non è solo accettabile che la fede di un politico stia alla base della sua attività legislativa, ma è addirittura necessario; se così non è, il politico in questione non sta facendo il suo lavoro. Questo però non è un “semaforo verde” per tutti perché legittima solo quelle forme di convinzioni che sono disposte a influenzare la vita di una società democratica ma anche di concedere alle altre comunità gli stessi diritti di cui esse godono. In questo modo, viene tracciato un chiaro divario tra il fondamentalismo (“cattivo”) di un Bin Laden e quello (supposto) (“buono”) di una Kate Forbes.
Non per questo si può però supporre di aver risolto una volta per tutte i problemi emersi. In primo luogo, la Williamsburg Charter fa riferimento a una situazione sociale e storica molto specifica, e in particolare fa riferimento a una determinata vicenda politica, ideale, giuridica e religiosa. Che cosa significherebbe cercare di sviluppare gli stessi concetti (ammesso che ciò sia possibile) in un ambiente differente, come per esempio nella nostra Italia che nel suo assetto attuale è il prodotto di un diverso processo culturale (banalmente, si può notare che il concetto di “laicità dello Stato” non appare nel Bill of Rights o nella Williamsburg Charter)? E che dire del fatto che la Charter sembra a tratti commettere l’errore di separare l’enunciazione di un diritto universale e inalienabile (quello della libertà di coscienza) dalla base materiale che ha consentito la sua scoperta, enunciazione e formulazione? Se infatti essa da un lato nota che il panorama della società statunitense è cambiato radicalmente rispetto ai tempi della Costituzione, essa ritiene comunque che anche il mutato scenario possa sostenere le stesse procedure e pratiche del passato. Eppure, è difficile che un diritto venga rispettato se le forze che storicamente lo hanno evidenziato si ritrovano indebolite o addirittura eliminate dalla vita pubblica.
Prescientemente, la Williamsburg Charter parla di una crescente proclività al conflitto e alla polarizzazione che si sta manifestando nella società americana e che potrà essere spenta solo mantenendo l’equilibrio tra libertà e convinzioni garantito formalmente dalla Costituzione. Di nuovo, se tale equilibrio è stato reso possibile da una composizione sociale che la stessa Charter ritiene essere profondamente mutata, come è possibile che tale tendenza venga contrastata, a meno che in qualche modo non si ritorni alla medesima situazione del passato o a una analoga? Quand’è l’ultima volta che chiedere ai talebani di trattare le donne al pari livello degli uomini ha incontrato il loro entusiasmo? E se viviamo in una società in cui i talebani o qualcosa loro equivalente (che sia di destra o di sinistra poco importa) ha in mano i microfoni, i soldi e le leve del potere, allora siamo costretti a vivere in una società gestita dai talebani e tanto peggio per i diritti democratici. D’altronde, si guardi agli USA di oggi, 35 anni dopo la Williamsburg Charter.
E dove siamo noi? Ho intenzionalmente evitato di fare riferimento a casi ed eventi della porta accanto perché ritengo che ciò che è lontano, ma simile, può fungere da specchio e ci può consentire di riflettere a mente più lucida, magari non così distratta dagli entusiasmi e dai coinvolgimenti che giustamente ci legano alla quotidianità locale. Chiudiamo con alcune domande. Chi sono i nostri talebani (se ve ne sono)? Chi sono i nostri fondamentalisti buoni e chi sono i nostri fondamentalisti cattivi (ancora, se ve ne sono)? E, quale è in definitiva lo stato di salute della nostra vita pubblica e in che misura abbiamo bisogno di una accresciuta tensione veramente produttiva al suo interno?
[1] I tori non vedono i colori; ciò che li fa “partire” verso la capote è l’irritazione causata dal movimento, non il fatto che è rossa – il colore rosso ha lo scopo di coprire le macchie di sangue.
[2] SNP in turmoil after Nicola Sturgeon resigns as first minister | Nicola Sturgeon | The Guardian.
[3] Free Church of Scotland: What are the beliefs of Kate Forbes's church? | The National.
[4] The favourite to lead the Scottish government faces an obstacle - her evangelical faith, Evangelical Focus.
[5] SNP MP calls Kate Forbes a 'sex-obsessed religious fundamentalist' as he admits party is 'in a mess' - Daily Record.
[6] Yousaf fires back at Forbes over gay marriage | The Spectator.
[7] Britons prefer Muslims to evangelical Christians in top political leadership, survey says, Evangelical Focus.
[8] Southern Baptist Convention Disfellowships Saddleback Chur...... | News & Reporting | Christianity Today.
[9] Il primo è uno dei teologhi evangelici pubblici più noti degli USA e dal 2022 editor-in-chief di Christianity Today, un’importante rivista americana di orientamento protestante che, secondo le intenzioni del fondatore – l’evangelista Billy Graham – avrebbe dovuto “piantare la bandiera evangelica nel mezzo della strada, assumendo una posizione teologica conservatrice ma allo stesso tempo promuovendo un approccio liberale ai problemi sociali”.
[10] Rick Warren: The Great Commission’s ‘Go and Teach’ Applies to Women | Christianity Today.
[11] Rick Warren: The Great Commission’s ‘Go and Teach’ Applies to Women | Christianity Today.
[12] Cfr. B. J. Longfield, «For Church and Country: The Fundamentalist-Modernist Conflict in the Presbyterian Church», in The Journal of Presbyterian History 78 (2000), pp. 35-50.
[13] Cfr. A. Loetscher, The Broadening Church: A Study of Theological Issues in the Presbyterian Church since 1869 (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1954), p. 50.
[14] G. Marsden, Fundamentalism and American Culture: The Shaping of Twentieth-Century Evangelicalism, 1870-1925 (New York: Oxford University Press, 1980), p. 119.
[15] Si noti che 20 anni prima anche la Chiesa Cattolica aveva avuto la sua crisi modernista e che nel corso del XIX discussioni analoghe si erano sviluppate nell’ambito del protestantesimo europeo (specie quello di lingua tedesca).
[16] C. E. Macartney, “Shall Unbelief Win? An Answer to Dr. Fosdick”, in Presbyterian, 13 luglio 1922, p. 8.
[17] Il già citato Christianity Today è uno dei frutti più noti di questo processo.
[18] Vale la pena di notare che, sebbene la nascita della Free Church of Scotland predati la controversia tra fondamentalisti e modernisti, la sua forma e direzione teologica attuale può senz’altro essere spiegata almeno in parte sulla base di questi eventi. Ad ogni buon conto, la Free Church of Scotland non ammette le donne al ruolo di pastore.
[19] Cfr. The Overton Window – Mackinac Center.
[20] Cfr. The Overton Window – Mackinac Center.
[21] Cfr. Why the Right-Wing Gets It--and Why Dems Don't [UPDATED] (dailykos.com).
[22] Cfr. THE-WILLIAMSBURG-CHARTER.pdf (osguinness.com); “Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances”.
Recensione di Gaetano De Amicis a P. Gianniti, Diritti fondamentali e giudice comune. Verso un sistema europeo di tutela integrata, Aracne, 2022, pp. 793; P. Gianniti, Corti supreme e diritti fondamentali. Verso una nomofilachia europea, Aracne, 2022, pp. 880.
Un vasto affresco dedicato ai grandi ed affascinanti temi del diritto europeo nelle sue varie declinazioni, all’analisi dei rapporti fra Corti nazionali e sovranazionali e all’individuazione delle più efficaci forme di protezione dei diritti fondamentali all’interno di un sistema europeo di tutela integrata, la cui edificazione in fieri necessita di uno sforzo di crescita culturale da parte dell’intera comunità dei giuristi europei: questo il filo conduttore delle numerose questioni problematiche condensate in due volumi, fra loro strettamente collegati, che l’Autore, Consigliere della Corte di Cassazione, ha offerto, con straordinaria ricchezza di contenuti e rara limpidezza espositiva, all’attenzione non solo degli specialisti del settore, ma anche dei giovani magistrati ed avvocati che intendano avvicinarsi ad uno studio approfondito di tematiche tanto complesse, quanto attuali nell’odierna esperienza delle vicende giuridiche e delle relazioni inter-giurisdizionali sullo scenario geopolitico europeo.
Nel primo lavoro monografico, ampiamente articolato nella sua rigorosa impostazione metodologica, l’Autore affronta con nitore argomentativo e dovizia di riflessioni critiche le tematiche, di centrale rilevanza, legate alla posizione dei giudici nazionali e al loro contributo di “garanzia” quali giudici “naturali” dei diritti tutelati in sede convenzionale o euro-unitaria.
L’opera è suddivisa in una parte generale e in una parte speciale.
Nei primi due capitoli della parte generale”, dedicata all’esame dei presupposti giuridico−politici dell’integrazione europea, vengono ampiamente richiamate le basi ideali e le attività dei movimenti europeisti, unitamente alle opere delle personalità e delle organizzazioni cui è stata legata l’evoluzione storica della “grande” e della “piccola” Europa.
Nel terzo, quarto e quinto capitolo della parte generale vengono esaminati i rapporti fra i diversi ambiti dell’integrazione europea e la tutela dei diritti fondamentali nel quadro dell’attuale assetto istituzionale dell’Unione, evidenziando i nessi di collegamento con il ruolo di garanzia svolto dalle corti nazionali ed europee.
La parte speciale è dedicata ad una organica ed approfondita trattazione espositiva dei singoli livelli di tutela dei diritti fondamentali (quello nazionale, quello convenzionale e quello comunitario), con particolare attenzione al ruolo assunto oggi dal giudice comune, quale “motore” del vigente sistema europeo di tutela integrata, nell’ambito di un “costituzionalismo multilivello” che vede la compresenza negli ordinamenti interni dei singoli Paesi membri dell’Unione di tre – diversi, ma strettamente connessi - sistemi di salvaguardia dell’ormai ampio catalogo dei diritti fondamentali.
La diversa tipologia di strumenti interpretativi a disposizione del giudice comune gli permette di “collaborare” pienamente, in forma interattiva, al dialogo giudiziario intessuto nella dimensione dei rapporti euro-unitari e convenzionali, dando luogo ad una “comunità giuridica europea” orientata verso l’obiettivo della massima espansione dei livelli di garanzia del contenuto dei diritti fondamentali.
Nel secondo, ancor più ponderoso, studio monografico, dal titolo Corti supreme e diritti fondamentali. Verso una nomofilachia europea, pubblicato dall’Autore per i tipi della stessa casa editrice, si pone il tema centrale del contributo che la nomofilachia della Corte di cassazione, unitamente ad altre Corti, nazionali ed europee, potrebbe offrire alla crisi della certezza del diritto, quale elemento fondamentale dell’esperienza giuridica e principio cardine dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, con particolare riferimento al settore dei diritti fondamentali.
I due volumi, fra loro complementari, esplorano tematiche strettamente contigue, la cui analisi critica deve essere condotta necessariamente in forma incrociata, attraverso uno sguardo sinottico volto a comporne le diverse implicazioni operative in un quadro unitario.
In questo secondo lavoro monografico, in particolare, il ruolo nomofilattico della Corte di cassazione, con tutti i problemi legati alla gestione del suo enorme contenzioso, viene esaminato inquadrandone l’esercizio delle complesse funzioni – sia di definitiva risoluzione della questione oggetto del caso concreto nell’ultimo grado di giudizio (ius litigatoris), che di guida e orientamento nella elaborazione di un consolidato quadro di principii destinato ad orientare le future decisioni di merito a garanzia dell’unità del diritto nazionale (ius constitutionis) - al crocevia di un sistema multilivello di fonti, che innesca un dialogo ermeneutico circolare nel rapporto con le altre Corti supreme dei diversi ordinamenti nazionali e con le stesse Corte europee.
La parte generale viene dedicata ad un’ampia trattazione dei caratteri fondamentali e delle funzioni della moderna nomofilachia a livello nazionale, ponendone in rilievo i nessi con i grandi temi della ermeneutica contemporanea, della formazione del precedente negli ordinamenti di civil law e di common law e del mutamento del ruolo del giudice all’interno di un ordinamento multilivello a carattere, ormai, non più piramidale, bensì “reticolare”, a seguito del progressivo espandersi del diritto convenzionale e di quello euro-unitario.
Nella parte speciale, articolata in più sezioni, vengono esaminate, in particolare: a) le relazioni del giudice di legittimità con i giudici di merito e la Corte costituzionale; b) quelle con le altre Corti di ultima istanza a livello nazionale (Consiglio di Stato e Corte dei conti), evidenziando il problema della formazione di nomofilachie divergenti in materia di diritti fondamentali; c) il circuito dei rapporti con le altre Corti supreme di legittimità degli altri Paesi europei, con la Corte di giustizia e la Corte EDU, evidenziando i casi emblematici di dialogo e mancato dialogo, per mettere in luce, infine, la tensione dell’intero sistema di tutela dei diritti fondamentali verso la costruzione di una “nomofilachia europea”, con la conseguente trasformazione del contenuto delle funzioni svolte non solo dalla Corte di cassazione, ma da tutte le Corti di legittimità operanti nei diversi ordinamenti nazionali.
Utili riferimenti storici sull’unicità della Corte di cassazione nazionale e sull’evoluzione del ruolo esercitato dal supremo organo della nomofilachia si accompagnano, in una prospettiva diacronica, ad una vasta ed approfondita analisi della progressiva incidenza sul diritto interno delle Carte dei diritti fondamentali e dell’attività interpretativa delle Corti europee (Corte di giustizia e Corte EDU), nell’ambito di uno spazio territoriale europeo ove il giudice comune viene a porsi come organo giudiziario di riferimento sia per l’ordinamento euro-unitario che per quello convenzionale.
L’Autore mette in risalto la portata del fenomeno, sottolineando la possibilità che l’interpretazione della legge nel giudizio di legittimità venga rimessa in discussione, sotto vari profili, da organi giurisdizionali estranei all’assetto nazionale dell’ordine giudiziario, attraverso pronunce cui si riconosce una peculiare efficacia, non limitata all’ordinamento sovranazionale di riferimento, ma direttamente rilevante anche in quello interno, sì da determinare, in alcuni casi, l’eventuale superamento della intangibilità del giudicato, alla cui formazione anche la Corte di cassazione concorre, quale organo di vertice della giurisdizione, in conseguenza dell’esaurimento dei mezzi d’impugnazione.
Una nuova connotazione delle funzioni e del ruolo tradizionalmente assegnati alla Corte di legittimità inevitabilmente emerge, dunque, a fronte di un contesto ordinamentale esterno che in maniera pressante la sollecita ad assicurare l’uniforme interpretazione (ex art. 65 O.G) di un diritto positivo non più identificabile soltanto con le norme interne, ma anche con quelle derivanti dall’ordinamento comunitario (art. 11 Cost.) e dagli obblighi internazionali (art. 117, primo comma, Cost.), tracciando percorsi interpretativi che devono, auspicabilmente, risultare conformi alle rispettive elaborazioni giurisprudenziali, stabilmente orientati ed affidabili, nella loro oggettiva prevedibilità, pur a fronte di un accesso di massa alla giustizia che registra, ormai da tempo, un vertiginoso aumento della domanda.
La Corte di cassazione, come noto, è ormai da troppo tempo “assediata” nell’esercizio delle sue funzioni regolatrici dal quotidiano esame di centinaia di ricorsi, in presenza di un unicum rappresentato dall’adozione di oltre trentamila decisioni civili e cinquantamila decisioni penali all’anno, con il conseguente rischio di non riuscire a garantire un sufficiente livello di uniformità e coerenza, interna ed esterna, delle proprie linee di indirizzo giurisprudenziale.
La contestuale crisi della politica e della certezza del diritto si accompagna ad un profondo mutamento del rapporto fra legge e giurisdizione, la cui progressiva evoluzione tende ad affidare un ruolo centrale alle Corti supreme, per le loro ineliminabili funzioni di garanzia della prevedibilità, della coerenza e della qualità delle decisioni nel processo di integrazione europea.
Una nomofilachia sempre più declinata non come un antistorico ed inutile esercizio di autorità, ma nella diversa prospettiva della sua capacità di ricondurre ad unità la complessità del nuovo sistema multilivello, da un lato, fungendo da raccordo fra tutte le componenti della comunità dei giuristi, dall’altro, bilanciando la tutela del principio del libero convincimento del giudice con le esigenze di certezza e di stabilità delle decisioni, all’interno di una visione “unitaria”, che sappia tener conto sia dei nuovi indirizzi assunti dalla giurisprudenza di merito, sia delle “correnti” profonde che orientano le “rotte” seguite dalle elaborazioni giurisprudenziali delle Corti europee.
Un contesto, dunque, radicalmente mutato sia rispetto alla centralizzazione della giurisdizione di legittimità a seguito della proclamazione del Regno d’Italia, sia rispetto alla visione fatta propria dalla Costituzione repubblicana del 1948, che non intaccò la duplicità di prospettive emergenti dalla fondamentale disposizione contenuta nell’art. 65 dell’ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 10, là dove la garanzia dell’esatta osservanza delle leggi, con la cassazione dell’atto del giudice che non le avesse rispettate, si accompagnava al diverso profilo di garanzia della uniformità dell’interpretazione giurisprudenziale al fine di assicurare l’unità e l’uguaglianza del diritto positivo.
Di qui l’analisi critica dell’Autore, che prende le mosse dalla pressante esigenza, sociale ancor prima che giuridica, di recupero dei valori della certezza del diritto e della prevedibilità delle decisioni giudiziarie, per valorizzare le implicazioni del necessario confronto istituzionale del sindacato di legittimità affidato alla Corte di cassazione rispetto a quello esercitato, a vario titolo, sia dalla Corte costituzionale e dagli organi apicali delle giurisdizioni speciali, che dalle Alte Corti europee, nella duplice prospettiva di una nomofilachia “dialogante”, volta ad evitare la formazione di contrasti sia nell’ambito dell’ordinamento interno, sia con riferimento alle indicazioni provenienti da quello sovranazionale.
Se la legittimazione costituzionale della Corte di cassazione deve ancor oggi rinvenirsi nella sua capacità di costruzione di un “diritto vivente”, in grado di orientare con un sufficiente grado di affidabilità i comportamenti dei cittadini e ricondurre ad unità sistematica il confuso intreccio di leggi, norme esterne e correlative elaborazioni giurisprudenziali, la nomofilachia che essa è chiamata a rendere, al pari delle altre Corti supreme nazionali, dovrebbe sempre più orientarsi nel senso della tutela dello ius constitutionis, al fine di garantire la tendenziale uniformità degli indirizzi giurisprudenziali, e sempre meno in quello della tutela dello ius litigatoris.
La natura di “vertice ambiguo” della Corte di cassazione, secondo la immaginifica definizione datane da Michele Taruffo, è rinvenibile peraltro nello stesso codice genetico del giudice della legittimità, trattandosi di funzioni coessenziali, che devono comunque trovare, come spiegato da Giorgio Lattanzi (Cassazione o terza istanza, in Cass. pen., 2007, p. 1370 ss.), un opportuno punto di equilibrio, la cui mancanza renderebbe problematica l’opera di uniforme elaborazione del diritto giurisprudenziale.
Nella prospettiva interna, se da un lato pare irrealistico, per l’Autore, ipotizzare un ritorno al sistema della giurisdizione unica ordinaria – pur teoricamente auspicabile nella dimensione evolutiva del diritto europeo –, dall’altro lato, il pericolo correlato al possibile formarsi di nomofilachie divergenti a causa dei numerosi plessi giurisdizionali che compongono a “mosaico” l’ordinamento nazionale deve spingere l’intera comunità dei giuristi e il legislatore ad interrogarsi sulle possibili soluzioni da offrire al problema.
Certamente opportuno, anche se non risolutivo, potrebbe rivelarsi, al riguardo, uno sforzo di coordinamento istituzionale volto a promuovere la ricerca di canali di costante dialogo – sul piano scientifico ed organizzativo – tra giudici ordinari, amministrativi e contabili su temi che richiedono la declinazione di forme e meccanismi di tutela di valori fondamentali comuni (ad es., attraverso una più intensa e stretta collaborazione tra l’Ufficio del Ruolo e del Massimario della Corte di cassazione e gli Uffici studi delle altre Corti).
Sotto altro, ma connesso profilo, occorre tuttavia considerare che l’ordinamento costituzionale ha già individuato nella sola Corte di cassazione l’organo supremo della giustizia (ex art. 65 ord. giud.), attribuendole una funzione regolatrice della giurisdizione (art. 111, comma ottavo, Cost.) che di per sé esclude una divaricazione delle nomofilachie sulle questioni di giurisdizione, devolute unicamente al giudice di legittimità: seguendo tale linea di orientamento l’Autore suggerisce di estendere la nozione di “limite esterno della funzione giurisdizionale” per riconoscere al ruolo nomofilattico, da sempre esercitato dalla Corte di cassazione in materia di diritti soggettivi, una rilevanza esterna, non circoscritta ai soli giudici ordinari, ma estesa a tutti i giudici – nessuno escluso – in modo da valorizzare l’orientamento consolidato della Corte in tema di norme attributive di diritti soggettivi e ridurre, in caso di diverse determinazioni, l’area delle decisioni inficiate, in materia amministrativa o contabile, da un difetto di giurisdizione relativa, in quanto tale impugnabile mediante ricorso per cassazione.
Su altro versante, maggiormente legato allo sviluppo del dialogo con le Corti europee, si impone, ad avviso dell’Autore, e il rilievo non può che essere condiviso, un deciso rafforzamento del ruolo della Corte di cassazione come Corte del precedente.
Non si tratta, ovviamente, di spingersi sul piano dell’attribuzione di un’efficacia vincolante alle decisioni di legittimità, che l’inevitabile pluralismo nella elaborazione della giurisprudenza di merito e i tratti di una moderna nomofilachia – non certo piramidale, né gerarchica, ma basata su un metodo partecipativo orientato a garantire la stabilità nel cambiamento e il cambiamento nella stabilità – non consentirebbero affatto di percorrere.
Si tratta, invece, di definire un quadro di interventi normativi che affidi alla Corte il potere di stabilire, sulla base di criteri oggettivi e predefiniti, quali siano i ricorsi da ammettere e, dunque, da decidere nella prospettiva del sindacato di legittimità che la Costituzione tipicamente le affida.
Un ampio spettro di soluzioni, a tal fine, potrebbe essere oggetto di adeguato approfondimento in linea con la disposizione di cui all’art. 111, settimo comma, Cost.: dalla perimetrazione della violazione di legge come unico motivo di ricorso per cassazione nella prospettiva di una prevalente tutela della nomofilachia che l’Autore definisce “positiva” (ossia rivolta al contenuto delle future decisioni giudiziali, e non alla valutazione della decisione già emessa ed impugnata), alla previsione del vincolo della Corte di legittimità all’accertamento del fatto contenuto nella sentenza pronunciata dal giudice di merito; dalla configurazione del ricorso in cassazione come mezzo straordinario di impugnazione, volto a sindacare il solo profilo in iure della sentenza impugnata (in coerenza con il principio del doppio grado di giurisdizione e con la natura del giudizio di sola legittimità svolto dalla Corte), alla introduzione di efficaci filtri alla possibilità di impugnare la sentenza di secondo grado.
Pur prescindendo da una possibile revisione dell’assetto normativo costituzionale, già oggi la disposizione dettata nell’art. 111, settimo comma, Cost. potrebbe essere letta, secondo l’Autore, nella più razionale prospettiva della garanzia del diritto a proporre il ricorso per cassazione, non in quella che tutela il diritto all’ammissione del ricorso.
Un efficace vaglio preliminare sull’ammissibilità del ricorso risulta dunque coerente non solo con la norma costituzionale che limita la garanzia del ricorso per cassazione alla sola violazione di legge, ma anche con gli orientamenti tracciati dalla Corte EDU sulla compatibilità convenzionale dei “sistemi di filtraggio” adottati nei diversi ordinamenti europei in relazione al merito o alla tipologia delle questioni poste all’attenzione delle Corti di legittimità.
Nella medesima prospettiva, effetti “decisamente positivi” potrebbero derivare da interventi legislativi finalizzati, nell’ambito dell’attuale assetto costituzionale, a disporre una separazione categoriale tra difensori legittimati a difendere nei giudizi di merito e nel solo giudizio di legittimità, ove sono richieste una preparazione ed una esperienza particolari, in modo da limitare il numero degli abilitati a proporre ricorso per cassazione (secondo il modello francese), creando un corpo di difensori altamente specializzati, idonei pertanto a compiere un filtro esterno all’accesso alla Corte di legittimità, con l’effetto ulteriore di selezionare i ricorsi realmente meritevoli di essere trattati e di migliorarne il livello qualitativo (v. la Prefazione di E. LUPO, secondo cui l’esperienza della introduzione di filtri meramente interni alla Corte, attraverso la previsione di strumenti giuridici di volta in volta diversi, si è dimostrata sostanzialmente inutile, quando non è stata fonte di ulteriori complicazioni e difficoltà per le attività della Corte).
Del resto, non si pone in contrasto con le regole dell’equo processo, come ricordato dalla stessa Corte EDU in una pronunzia del 26 luglio 2002, la possibilità di riservare ad un ristretto numero di difensori la rappresentanza del ricorrente dinanzi ad una Corte suprema.
Una Corte del precedente, collocata in una posizione distante dalla configurazione di una Corte di terza istanza volta ad assicurare anche la giustizia del caso concreto, che si trovi in piena consonanza di poteri e funzioni con le linee di tendenza rilevabili negli altri ordinamenti nazionali europei, in grado di garantire effettivamente l’unificazione della interpretazione del diritto sul territorio dello Stato e l’eguale trattamento dei cittadini in una società democratica fondata sul principio della rule of law, senza però abbandonare la prospettiva di una nomofilachia che, in linea con le moderne acquisizioni della teoria dell’ermeneutica, sappia enunciare il principio di diritto nel contesto della concretezza della singola vicenda storica oggetto del giudizio: questo, secondo l’Autore, dovrebbe essere il modello di una Corte di legittimità al passo con i tempi, ormai lontani dalle scelte che il legislatore costituzionale ebbe ad operare – con la formulazione dell’art. 111 - in un momento storico (il 1948) in cui il numero annuale dei ricorsi – almeno quelli civili - era stato quasi sempre inferiore a 4.000, laddove dal 2002 ad oggi è risultato superiore, per lo più, ai 30.000.
Pare difficilmente giustificabile oggi, nello scenario europeo, l’anomalia di una Corte suprema come quella italiana, dinanzi alla quale possano proporre ricorso circa 50.000 difensori, sollecitandola ad esercitare - attraverso l’abnorme pianta organica di circa 400 magistrati che emettono migliaia di sentenze ed ordinanze a fronte di una sterminata massa di ricorsi - una funzione nomofilattica la cui declinazione avviene ormai all’interno di una sempre più ampia rete di rapporti sovranazionali, attraverso una voce “dialogante” il cui dictum dovrebbe essere necessariamente percepito in termini di certezza e uniformità, così da interloquire efficacemente con le altre Corti supreme nazionali e con le stesse Corti europee, in un contesto normativo sempre più eterogeneo ed articolato, che richiede un’immediata capacità di stabilizzare la formulazione del principio di diritto, garantendo la prevedibilità delle decisioni al fine di governare gli effetti magmatici di un sistema policentrico, e non solo multilivello, delle fonti di produzione del diritto.
Va ricordato, peraltro, che il legislatore non si è mostrato indifferente alle esigenze di una moderna nomofilachia, avendo rafforzato – con le novelle del 2 febbraio 2006, n. 40, e del 23 giugno 2017, n. 103 – gli obiettivi di tendenziale stabilità e uniformità dei principii di diritto espressi dall’organo di vertice della legittimità attraverso l’ampliamento della portata del vincolo di coerenza con il precedente costituito dalla decisione che le Sezioni unite civili e penali hanno pronunciato al fine di dirimere i contrasti interpretativi emersi tra le sezioni semplici o per risolvere questioni giuridiche di particolare importanza.
Sono state infatti disciplinate sia l’enunciazione del principio di diritto «nell’interesse della legge» (art. 618, comma 1-ter, c.p.p.), anche d’ufficio, quando il ricorso è dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta, sia la regola di raccordo fra le Sezioni semplici e le Sezioni unite (comma 1-bis: «Se una sezione della corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso»), in coerenza con quanto analogamente previsto sia per il giudizio civile di cassazione (artt. 363, comma 3, e 374, comma 3, c.p.c., sost. dagli artt. 4 e 8 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), che per il giudizio amministrativo (art. 99, comma 3, d.lgs. n. 104 del 2010: codice del processo amministrativo) e contabile (artt. 42, comma 2, legge n. 69 del 2009 e 117 d.lgs. n. 174 del 2016: codice del processo contabile), con riguardo alle decisioni rispettivamente assunte dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato e dalle Sezioni riunite della Corte dei conti.
Ulteriori innovazioni di rilievo, anche se non decisive nella prospettiva indicata dall’Autore, vanno individuate nelle modifiche degli artt. 360, primo comma, n. 5, 360-bis, 384 e 420-bis c.p.c.
Ragioni di “pacato ottimismo” possono trarsi, soprattutto, dall’analisi degli interventi normativi operati con le recenti riforme processuali (d.lgs. nn. 149 e 150 del 2022), varate in attuazione delle leggi delega per la riforma della giustizia civile e penale (leggi nn. 134 e 206 del 2021), in vista del raggiungimento degli obiettivi fissati dal P.N.R.R.
Vanno segnalate, in tal senso, l’introduzione del rimedio finalizzato alla revocazione della sentenza civile il cui contenuto sia stato successivamente dichiarato contrario alla CEDU (legge delega n. 206 del 2021, art.1, comma 10, attuato con l’art. 3, comma 28, lett. o), d. lgs. n.149 del 2022, che ha inserito nel codice di rito civile il nuovo art.391-quater) e la previsione, all’interno del processo penale, di “un mezzo di impugnazione straordinario davanti alla Corte di cassazione al fine di dare esecuzione alla sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo”, con l’attribuzione alla Corte di legittimità del “potere di adottare i provvedimenti necessari” (legge delega n.134 del 2021, art.1, comma 13, lett. o), attuato con l’art. 36 d.lgs. n. 150 del 2022, che ha inserito nel codice di rito penale la nuova disposizione dell’art. 628-bis).
Strumenti processuali nuovi, che mirano a realizzare le fondamenta di un circolo ermeneutico biunivoco rispetto agli orientamenti interpretativi assunti dalla Corte EDU, le cui implicazioni operative, tuttavia, dovrebbero essere necessariamente saggiate all’esito dell’auspicabile ratifica del Protocollo n. 16 CEDU, ponendo la Suprema Corte di cassazione e le Alte Corti nazionali nella condizione di attivare opportunamente, anche in una logica di deflazione della massa dei ricorsi, un dialogo preventivo in funzione consultiva, non certo vincolante, utile soprattutto nella fase “ascendente” della formazione del giudicato interno.
Disposizioni di analogo rilievo, ai fini che vengono qui in considerazione, sono quelle cristallizzate dal legislatore nelle nuove disposizioni di cui agli artt. 380-bis c.p.c. (procedimento accelerato per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati) e 363-bis c.p.c. (che introduce l’istituto del rinvio pregiudiziale degli atti dal giudice di merito alla Corte di cassazione per risolvere una questione di diritto, nella prospettiva di prevenire la formazione di contrasti giurisprudenziali o di contenziosi seriali).
Dati incoraggianti emergono, peraltro, dall’analisi statistica della lenta, ma costante, riduzione del contenzioso civile e penale di cui si dà conto nell’ultima Relazione del Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2022 (leggibile sul sito www.cortedicassazione.it).
Sia nel settore civile che in quello penale, infatti, il numero delle decisioni assunte dalla Corte è sensibilmente cresciuto rispetto all’inizio del 2021, consentendo di ridurre in misura sensibile il peso delle pendenze.
Analoghi risultati positivi sono registrabili con riferimento alla durata dei processi celebrati dinanzi al Giudice di legittimità, poiché rispetto agli obiettivi fissati dall’Unione europea per la riduzione dei tempi di decisione entro il 2026, il criterio basato sul cd. disposition time, il cui target rispetto alla base di partenza dei dati relativi al 2019 è pari al 40% nel settore civile ed al 25% nel settore penale, consente di ritenere già raggiunto e superato il traguardo in quest’ultimo ambito (ove si è giunti al risultato di 132 giorni a fronte di un limite stimato in 166 giorni) ed in via di progressivo avvicinamento anche nel settore civile, il cui limite massimo è di 976 giorni a fronte di un baseline per il 2019 di 1302 giorni.
Linee di tendenza, quelle illustrate nella richiamata Relazione, che appaiono estremamente confortanti, specie se poste in relazione ai positivi effetti - allo stato non ancora obiettivamente verificabili nella loro entità - della prossima attuazione del quadro delle riforme normative varate dal legislatore nella seconda metà del 2022.
In definitiva, l’auspicio dell’apertura di una “nuova stagione” per il funzionamento e la realizzazione degli obiettivi costituzionali propri di un’istituzione plurisecolare e gloriosa come la Corte di cassazione si coniuga, nella prospettiva dell’Autore, alla rinnovata e condivisa consapevolezza della grave responsabilità che su di essa incombe, quella, cioè, “di tracciare la rotta dell’interprete, non con la ragione dell’autorità, ma con l’autorità della ragione”.
Sommario: 1. La selettività del concorso in magistratura e la nascita di una specifica domanda di formazione. - 2. Il monopolio dei corsi privati: semplice dato di fatto o necessità? - 3. La riforma Cartabia e le modifiche in tema di corsi di preparazione al concorso in magistratura. - 4. I compiti attuali della Scuola Superiore della Magistratura e le forze a disposizione. - 5. L’ipotetica attuazione della riforma Cartabia a risorse invariate. - 6. La possibile soluzione: cambiare passo.
* Il contributo si inserisce nell'approfondimento del tema Accesso in magistratura, precedenti contributi Accesso alla magistratura - 1. Pensieri sparsi sul concorso in magistratura di Giacomo Fumu, Riflessioni sul concorso in magistratura di Mario Cigna Il tirocinio formativo ex art. 73 d.l. n. 69/2013 di Ernesto Aghina, Il procedimento per la nomina e selezione dei giudici e pubblici ministeri nella Repubblica Federale Tedesca di Cristiano Valle, Percorsi di accesso alla magistratura in Ungheria di Anna Madarasi, L’accesso alla magistratura francese di Antonio Musella[*] Spunti per una nuova formazione comune per le professioni legali di Angelo Costanzo sotto la voce della rivista Ordinamento giudiziario.
1. La selettività del concorso in magistratura e la nascita di una specifica domanda di formazione.
Poco più di due mesi fa hanno preso servizio 202 nuovi magistrati: sono i vincitori dell’ultimo concorso bandito dal Ministro della Giustizia circa tre anni prima.
I posti a concorso erano in realtà 310, sicché più di un terzo dei posti disponibili non è stato coperto, nonostante i candidati che si sono presentati alle prove scritte siano stati ben 5827. Di questi, infatti, solo 220 (circa il 5% dei partecipanti) sono stati ammessi all’orale, ed un’altra ventina sono stati dichiarati inidonei all’esito delle interrogazioni.
Si tratta di un divario tra aspiranti e vincitori impressionante e senza precedenti, anche se normalmente i posti a concorso non vengono mai coperti nonostante l’altissimo numero di partecipanti, sicché si può agevolmente comprendere il motivo per cui il concorso in magistratura sia considerato uno dei più impervi tentativi di accedere al mondo del lavoro per un laureato in giurisprudenza.
Anche se la commissione che giudica i candidati varia nella sua composizione per ciascuno dei concorsi che periodicamente si succedono, il criterio di selezione improntato a massima severità sembra una costante, frutto consapevole di una scelta di non derogare al criterio della qualità, anche a costo di contribuire a non sanare i vuoti di organico che notoriamente affliggono i ranghi della magistratura.
L’alto numero dei candidati è, per altro verso, conseguenza del fatto che il posto a concorso è uno dei posti più appetibili per un laureato in giurisprudenza, per numerosi e concorrenti motivi: prestigio della funzione, idealismo, soddisfazione intellettuale, lo stipendio (fisso e più che adeguato a soddisfare le esigenze di un buon tenore di vita).
L’estrema selettività del concorso, unita alla sua appetibilità, ha generato negli anni una specifica domanda di formazione: si sono moltiplicati manuali di diritto dedicati espressamente allo sviluppo degli argomenti ritenuti papabili per le tracce scritte e sono sorti in tutta Italia corsi di preparazione al concorso in magistratura, soprattutto per colmare il gap tra una formazione universitaria totalmente declinata in esami orali e un concorso la cui selezione viene svolta, come si è visto in precedenza, in via pressoché esclusiva attraverso l’espletamento di prove scritte.
L’utilità di questi corsi è dimostrata da un dato empirico: la quasi totalità dei magistrati italiani attualmente in servizio ha partecipato ad uno di questi corsi e indirettamente deve a questa esperienza almeno una parte della specifica preparazione giuridica utilizzata per l’accesso all’impiego desiderato.
2. Il monopolio dei corsi privati: semplice dato di fatto o necessità?
Di fatto, non è praticamente ipotizzabile diventare magistrati in Italia senza avere partecipato ad un corso di preparazione al concorso.
È quindi evidente che si tratta di uno degli snodi fondamentali dell’accesso alla magistratura.
Non può pertanto non destare preoccupazione il fatto che esso non sia allo stato regolamentato in alcun modo: l’organizzazione di questi corsi è del tutto estranea sia al mondo della magistratura che a quello universitario ed affidata interamente a privati.
Non esistono requisiti soggettivi per aprire una scuola di preparazione al concorso, non vi sono controlli sulla didattica o sulla selezione dei docenti né sulle metolodogie formative scelte.
Le uniche norme che stabiliscono chi può far parte di questo delicatissimo settore o come deve starci sono le regole del mercato, che dovrebbero premiare l’offerta formativa migliore. Ma dove non interviene provvidenzialmente la “mano invisibile” di Adam Smith …. vale tutto.
Recenti episodi di cronaca giudiziaria, troppo noti anche per essere menzionati incidentalmente, hanno mostrato quanto possa essere pericolosa questa situazione di assoluta deregulation.
La situazione attuale presenta un ulteriore profilo di singolarità, perché una regola in verità esiste: è quella che impedisce ai magistrati ordinari di organizzare e far parte, anche in via occasionale, dei corsi in esame.
In particolare, l’articolo 3, 3° comma della circolare del C.S.M. sugli incarichi extragiudiziari 22581/2015 del 9 dicembre 2015 statuisce che “sono vietate l’organizzazione di scuole private di preparazione e concorsi o esami per l’accesso al pubblico impiego alle magistrature e alle altre professioni legali nonché la partecipazione, sotto qualsiasi forma ed indipendentemente dalle caratteristiche dimensionali, alla gestione economica, organizzativa e scientifica di tali scuole ovvero lo svolgimento presso di esse di attività di docenza, anche in via occasionale”.
La violazione di questo precetto costituisce illecito disciplinare a norma del d.l.vo 23 febbraio 2006, n. 109 aart. 3 comma 1 lettera d) secondo cui “costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell’esercizio delle funzioni:
(…) d) lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria di cui all’articolo 16, comma 1 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, o di attività tali da recare concreto pregiudizio all’assolvimento dei doveri disciplinati dall’articolo 1”.
In altri termini, attualmente, chiunque può insegnare ai laureati in giurisprudenza come prepararsi al concorso per diventare magistrati, persino (in ipotesi) un non laureato in legge, tranne i magistrati, cioè i futuri colleghi dei vincitori dei concorsi, che avrebbero ovviamente più di altri competenze giuridiche e potrebbero portare un dato di esperienza non surrogabile da parte di chi questo lavoro non svolge.
La ratio di questo divieto risiede nella necessità di impedire il proliferare di incarichi extragiudiziari, peraltro di carattere particolarmente remunerativo ed impegnativo e dunque la tutela lato sensu del prestigio e della funzionalità della magistratura.
Ma l’effetto è paradossale: è impedito ogni contatto tra chi chiede formazione per diventare magistrato e i maggiori esperti della materia, ovvero i magistrati medesimi.
Né può essere trascurato che si è consegnato in questo modo l’accesso alla magistratura a privati estranei alla stessa, affidando al caso o alla buona volontà dei singoli la tenuta dell’offerta formativa, che ricomprende non solo la competenza giuridica in senso stretto ma anche l’insegnamento della cultura della giurisdizione e la trasmissione della sensibilità istituzionale che sono invece connaturati – salve dolorose eccezioni - all’essere magistrato.
C’è da dire che molti di questi corsi sono gestiti da magistrati amministrativi o da ex magistrati ordinari, sicché di fatto il rischio ora paventato viene ad essere escluso, ma si tratta comunque di un effetto del tutto casuale.
Desta preoccupazione il fatto che non esista alcuna regola che impedisca deviazioni da un percorso virtuoso lasciato alla singola iniziativa o alle leggi di mercato né alcuna previsione che bilanci l’esclusione dall’offerta formativa in questa fase dei naturali depositari della cultura della giurisdizione con la imposizione di regole per imporre una metodologia formativa in un settore formativo intrinsecamente connesso all’accesso alla magistratura.
3. La riforma Cartabia e le modifiche in tema di corsi di preparazione al concorso in magistratura.
Da questa riflessione prende dunque le mosse la preannunciata riforma del sistema di accesso al concorso contenuta nella legge delega di riforma dell’ordinamento giudiziario, che fa parte del complesso di disposizioni legislative noto come “riforma Cartabia”.
In particolare, l’articolo 4 della legge numero 71 del 2022, rubricata “Deleghe al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura”, nell’indicare al Governo i principi cui i decreti legislativi dovranno attenersi per il riassetto dell’accesso in magistratura, prescrive che essi debbano “prevedere che la Scuola superiore della magistratura organizzi, anche in sede decentrata, corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario per laureati”.
Con lo stesso provvedimento normativo è stato abolito l’obbligo di frequentazione di corsi presso una scuola di specializzazione (oltre al tirocinio presso gli uffici giudiziari), recidendo l’unico legame previsto tra mondo accademico ed accesso alla magistratura.
La ratio della norma esaminata è, ad avviso di chi scrive, condivisibile.
La Scuola Superiore della Magistratura è l’espressione più alta della formazione dei magistrati e costituisce dalla sua istituzione un baluardo della indipendenza della magistratura non solo a livello culturale e formativo in senso stretto ma ontologico, essendo formazione e legittimazione democratica dei magistrati concetti intimamente legati.
Sembra più che opportuno che la Scuola partecipi alla formazione dei magistrati sin dall’inizio del loro approccio al loro futuro impiego.
Prevedere un coinvolgimento dell’organo di formazione dei magistrati nella fase di preparazione al concorso in magistratura consentirebbe dunque di eliminare il divieto per i magistrati di fare formazione agli aspiranti colleghi ma canalizzerebbe questo intervento attraverso il filtro dell’istituzione addetta professionalmente alla formazione anziché lasciare l’iniziativa ai singoli magistrati.
Verrebbero in tal modo neutralizzati i rischi (esorbitanti guadagni, estranei alla funzione giudiziaria e compromissioni dell’efficienza degli uffici per sottrazione di importanti risorse) sopra evidenziati.
Tuttavia, se esercitata nei termini indicati dalla norma descritta, la delega porterebbe ad effetti esiziali non solo per la preparazione al concorso in magistratura, ma per la stessa Scuola Superiore della Magistratura e conseguentemente per la formazione dei magistrati in servizio.
È infatti sufficiente comparare i compiti che ipoteticamente ricadrebbero sulla Scuola con le forze, materiali e umane, a disposizione per per evocare immediatamente l’immagine del cavallo tragicamente spirato sotto il carico insostenibile impostogli dal padrone in uno dei primi capitoli di “Delitto e castigo”.
4. I compiti attuali della Scuola Superiore della Magistratura e le forze a disposizione.
Il Comitato Direttivo della Scuola è composto da 12 persone. Quasi metà di loro – i cosiddetti “laici”, nominati tra professori universitari e esponenti del foro – non svolgono questo compito in via esclusiva, ma continuano l’attività precedente, che li assorbiva fino al momento della nomina a tempo pieno. Nei tre Comitati Direttivi che si sono succeduti dall’istituzione della Scuola ad oggi solo uno dei quindici componenti laici ha sospeso l’attività precedentemente svolta in costanza del mandato.
Su questi scarsi effettivi grava il compito di organizzare e gestire ogni anno circa 120 corsi di formazione permanente, il tirocinio di uno o due plotoni di MOT (la formazione dei colleghi vincitori di concorso prevede normalmente lo svolgimento presso la sede di Scandicci della Scuola di otto settimane di generico e nove di mirato, oltre alla preparazione ed alla gestione degli stages), numerosi corsi di formazione internazionale e di scambi EJTN, la formazione dei magistrati onorari, la formazione dei direttivi e semidirettivi (è in corso di svolgimento il primo corso post- riforma, che prevede una durata di tre settimane per quasi 250 aspiranti alle funzioni apicali), i corsi di riconversione, il coordinamento delle articolazioni territoriali dette “formazioni decentrate”, oltre a una gran quantità di attività collaterali, alcune delle quali di rilevante impegno (tra di esse la gestione e l’aggiornamento del sito, della newsletter, del canale Youtube, dei Quaderni, dell’archivio dei materiali, la gestione delle attività amministrative e contabili, et cetera).
La struttura amministrativa di supporto è costituita da un organico teorico di 50 unità, mai interamente coperto (il pensiero che la Scuola condivide questa condizione di cronica scopertura dell’organico con la totalità degli uffici giudiziari della penisola aiuta a sentirsi meno soli ma non risolve il problema).
Negli ultimi anni la situazione, già critica, si è aggravata con l’attribuzione alla Scuola di compiti aggiuntivi comportanti ulteriori carichi: oltre a quello, notevolmente più gravoso rispetto al passato, della formazione dei direttivi (la cui durata non era predeterminata e si esauriva in poche sessioni mentre ora è stata portata per disposizione legislativa ad “almeno tre settimane” ed estesa ai semidirettivi, platea assai più numerosa di quella dei direttivi) è stato previsto un coinvolgimento della Scuola nella formazione degli addetti all’Ufficio per il Processo, in collaborazione con il Ministero della Giustizia; un notevole aggravio di lavoro è inoltre pervenuto dalle modifiche in tema di formazione dei magistrati onorari.
5. L’ipotetica attuazione della riforma Cartabia a risorse invariate.
L’allestimento da parte della Scuola di un corso di preparazione al concorso in magistratura richiederebbe la predisposizione di un programma di lezione con cadenza almeno settimanale in via continuativa con argomenti differenti per almeno un anno, con attività collaterali di tutoraggio specifico e la gestione di esercitazioni scritte periodiche con conseguente necessità di correggere centinaia di elaborati ogni pochi giorni.
Servirebbero magistrati in grado di organizzare e gestire la parte didattica e personale per la parte amministrativa e contabile.
Si tratta di un surplus di attività, come dovrebbe risultare evidente da quanto detto in precedenza, che appare del tutto ingestibile con le attuali forze della Scuola, senza contare che mancherebbero le strutture ed il personale, già interamente impiegati per le attività già in essere.
Né può essere di alcun aiuto l’inciso, pure contenuto nella delega legislativa in esame, che “suggerisce” di prevedere come unità di supporto le strutture territoriali della Scuola dislocate presso ciascuna Corte di Appello (le già richiamate unità di “formazione decentrata”).
Anche queste sono infatti gravate da compiti in tutti i settori della formazione (permanente, iniziale, internazionale, onorari, ecc.) sia in proprio che come delegati dal Comitato Direttivo, potendo contare su forze ancora più esigue di quelle esistenti a livello centrale: buona parte delle strutture territoriali sono composte da pochissimi magistrati e quasi nessuna può avvalersi di personale amministrativo.
Nessuna di esse ha una struttura autonoma dove svolgere la propria attività né una vera e propria “sede”, sicché appare anche difficile ipotizzare come si possano articolare su base regionale i corsi di preparazione in esame.
I formatori decentrati, peraltro, non svolgono la loro delicata e importante funzione a tempo pieno ma sono magistrati impegnati nelle normali attività di ufficio, che godono di un parziale esonero, basato su parametri spesso incongrui.
La previsione di corsi di preparazione su base territoriale avrebbe il solo effetto, in definitiva, di moltiplicare il numero dei “cavalli” tragicamente schiacciati dal carico di dostoevskijana memoria.
6. La possibile soluzione: cambiare passo.
Le problematiche sopra descritte non devono indurre, a mio avviso, a rigettare come inattuabile la previsione contenuta nella delega legislativa, anche perché come già detto in precedenza, la ratio che ispira la norma commentata appare pienamente condivisibile.
Esiste un modo per attuare la previsione legislativa e “salvare” il cavallo: adeguare la struttura della Scuola ai nuovi compiti che via via si stanno aggiungendo a quelli tradizionali.
L’istituzione di formazione dei magistrati sembra matura, dopo un decennio dalla sua nascita, per il completo svezzamento e la trasformazione in una struttura di carattere più stabile, magari con distaccamento a tempo indeterminato di un numero congruo di magistrati, professori e personale amministrativo, come già sperimentato con successo in altre realtà omologhe (si pensi alla Francia).
Declinata in questo modo, la delega legislativa non solo non porterebbe svantaggi ma, nel realizzare la previsione di istituire presso la Scuola Superiore della Magistratura un corso di preparazione al concorso in magistratura, indirettamente farebbe compiere all’istituzione quel cambio di passo che appare ormai ineludibile.

To install this Web App in your iPhone/iPad press icon.
