- Angelo Costanzo
- Gli attori della giustizia
- Visite: 4904
Angelo Costanzo intervista Alessandro Corbino
“ Rigore è quando l’arbitro fischia. Il mito della legalità ” è il titolo del saggio appena pubblicato (per i tipi di Jovene) dove Alessandro Corbino tratta della difficoltà che gli ordinamenti europei incontrano nel governare il diritto con il modello della separazione dei poteri.
Alessandro Corbino ha insegnato diritto romano in diverse Università italiane (ha peraltro fondato la Facoltà di Giurisprudenza di Catanzaro di cui è stato preside) e dirige IVRA, una delle più prestigiose riviste internazionali del settore. Non si è sottratto all’impegno civile, svolgendo il ruolo di difensore civico nel Comune di Catania, e ha maturato una esperienza giudiziaria come giudice della Sezione giurisdizionale siciliana del Consiglio di Stato.
Angelo Costanzo, magistrato presso la Corte di Cassazione, gli ha rivolto alcune intriganti domande, ricevendone risposte utili ad alimentare approfondimenti emancipati dalle occasioni contingenti.
- Qual è la più importante differenza fra la rappresentanza politica nei sistemi antichi e quella contemporanea?
La comunità politica moderna non è più la piccola “città” (di poche decine di migliaia di “cives”, insediati in uno spazio geografico limitato), nella quale ebbe origini la cultura di autogoverno, alla quale ci richiama l’idea stessa della rappresentanza. Essa è una realtà complessa (uno “stato”, come ora diciamo) di milioni di cives, distribuiti in uno spazio, la cui estensione impedisce una “immediata” (tendenzialmente totalizzante come nella città antica) reciproca relazione degli stessi. Nella quale non sono possibili dunque pratiche di governo che prevedano un diretto esercizio delle relative funzioni.
Nell’esperienza antica, l’assemblea dei cives (che, anche nelle realtà più importanti, restava costituita da un numero relativamente ristretto di persone: nella Roma della fine del III secolo a.C., già potenza imperiale mediterranea, essi non superavano di molto quello di 200.000) votava le leggi, eleggeva i propri governanti e decideva le cause giudiziarie criminali di maggiore rilievo.
Negli stati moderni (costituiti da milioni di soggetti) la evenienza di un’assemblea analoga è stata (almeno fino alla rivoluzione tecnologica in atto) impossibile (e se ora lo divenisse non vorrebbe dire solo per questo che ne sarebbe anche auspicabile la pratica). E, dunque, il solo esercizio diretto concepibile di funzioni politiche è stato il voto (progressivamente sempre più universale), con il quale si è dato ai singoli di concorrere all’indirizzo delle attività di governo. In esso si è vista dunque l’essenza delle forme moderne di “autogoverno”. Si sono configurate forme assembleari elettive (parlamenti), costituite con criteri di “rappresentanza” (estrazione territoriale e numero dei componenti rapportati alla densità dei distretti e agli indirizzi ideologico-politici in concorrenza), alle quali sono state delegate le funzioni di ordinare (con leggi) sia la disciplina dei fatti, sia quella delle altre funzioni di governo (amministrazione e giurisdizione). E si è immaginato di avere disegnato così un governo “democratico” delle nostre collettività.
In questo modo di procedere si sono annidati due errori, che hanno finito con il minare alla lunga l’efficienza dei sistemi adottati.
Il primo di essi è stato credere che quelle disegnate dalle moderne costituzioni fossero pratiche riproduttive delle antiche logiche di autogoverno. Il secondo (in qualche modo conseguenziale) è stato quello di non comprendere che il “potere” politico (sovrano) è concepibile solo come un “insieme” (del quale una entità soltanto – collettiva o individuale, che si voglia: civitas insomma o princeps – abbia la titolarità) e non come una “somma” di funzioni distinte. Una divisione dei “poteri” (che ne presupponga la possibilità di distinta legittimazione e distinte modalità di controllo del loro esercizio) non è concepibile.
Dal primo punto di vista, credere che potessero funzionare come “rappresentativi” della volontà generale sistemi che fossero soltanto “disegnati” all’origine (e poi anche continuamente aggiornati) da rappresentanti di essa (parlamenti) è stata una illusione. I sistemi di regole non vivono solo di queste, ma anche della attuazione che di esse si fa. La quale ne ridisegna, nel concreto, la configurazione vivente, quella che incide visibilmente nella realtà fattuale.
Dal secondo punto di vista, si è trascurato che nei sistemi antichi (quelli appunto nei quali l’autogoverno era stato concepito e praticato, se anche con declinazioni diverse: quella di Roma non era la medesima che ne aveva attuato Atene) era stata data evidenza al fatto che poteva bene (doveva anzi) esservi distribuzione delle funzioni tra soggetti (istituzionali) diversi, ma non poteva esservi tuttavia “indipendenza” (nell’esercizio) di alcuna di quelle funzioni. Ciascuna delle quali è strumentale all’esercizio del potere politico. Ne costituisce esplicazione. E non può perciò – ove delegata – non rispondere al titolare di questo. Costruire un enunciato (legiferare), interpretarlo e tradurlo in un criterio di decisione (un comportamento amministrativo opportuno, la soluzione di una controversia pubblica o privata) sono azioni distinte ma (la prima e ciascuna delle seconde) tra loro (insuperabilmente) complementari. Concorrono all’obbiettivo pratico perseguito. Hanno ciascuna (e tutte) un rilievo “politico” non minore di quello che ha il disegno che se ne è fatto. Adottare l’enunciato (la legge) non è “governare”. Governare è utilizzare la stessa per assumere la decisione (amministrativa/giudiziale) del caso.
Ne viene con evidenza che, se le condizioni materiali (dimensioni sociali e territoriali della comunità) permettono solo pratiche “rappresentative” (e non dirette) di “autogoverno”, queste possono essere considerate espressione di quel principio solo se lo sono (come nei sistemi antichi) in ogni passaggio. Non può esservi “rappresentanza” (delega) nel disegno e non anche nell’attuazione di esso. Se insomma il “rappresentato” (collettività) ha un potere di controllo (in itinere e successivo) soltanto nell’esercizio di un segmento dell’azione di governo.
-
L'interpretazione del diritto e la soggettività dell'interprete. Perché è impossibile una certezza assoluta del diritto?
Perché il “diritto” è ciò che l’interprete desume dalla regola. Ne è ciò che se ne estrae. Il frutto di un’operazione logico-ricognitiva insuperabilmente soggettiva. La quale può essere “contenuta”, non “eliminata”. La sola “oggettività” pensabile è perciò, in materia, “spersonalizzare” nel massimo l’operazione. Fare coincidere il risultato virtuoso con lo storico libero convergere del pensiero dei più (meglio, naturalmente, se di tutti) su uno dei risultati possibili. E mantenendo ferma la coscienza che anche tale risultato non si sottrae alla opportunità di una revisione, ove cambino le condizioni di contesto. La regola nasce in un tempo, ma vive in un tempo successivo. Nel quale possono essere intervenute modificazioni della realtà che ne postulano una “nuova” lettura. Né la legge, né il diritto possono essere sottratti alla storia. Sono entrambi “artifici” (opera umana), esposti l’una e l’altro ad un processo dialettico molto complesso, per il quale ogni scorciatoia dovrebbe essere preclusa.
-
Perché sono in calo l'autorevolezza della Dottrina e delle Facoltà di Giurisprudenza?
A mio sommesso modo di vedere, a causa di un disegno costituzionale che (senza volerlo e confidando in un autocontrollo che, in parte, si è – fino ad alcuni decenni addietro – per altro, in buona misura, mantenuto) ha reso progressivamente nel tempo sempre più fattuale la coscienza della autoreferenzialità sostanziale dell’attività giurisdizionale e dunque della modesta incidenza di ogni possibilità esterna di condizionamento (anche autorevole). Il tutto condito da un “cedimento” delle università, che hanno abbandonato la funzione di educare alla “interpretazione” (dunque alla lettura critica delle regole) per privilegiare quella di addestrare alla conoscenza delle regole (dei dettati) e alla adesione alle interpretazioni di esse fattualmente correnti.
- Come vede la formazione odierna dei magistrati?
Fermo il contesto costituzionale vigente (che andrebbe tuttavia profondamente modificato), mi piacerebbe almeno che essa fosse quella di cultori di una scienza del “possibile” (di pratica del dubbio metodico a monte di ogni, pur necessaria, “decisione”) e non di una del “dovere essere”.
- Nel suo libro tratta della indivisibilità del Potere politico, che riflessi ha questa concezione sul sistema delle spinte e bilanciamenti fra Poteri ? E come si colloca la magistratura italiana nell'attuale assetto della divisione dei Poteri ?
La mancata coscienza della “indivisibilità” del potere politico, ha provocato, nel nostro ordinamento, una materiale articolazione della “divisione dei poteri”, che ha avuto (ed ha) le ricadute di debolezza fattuale sotto gli occhi di tutti. Nello schema adottato, i vari “poteri” sono stati (nell’ambito di un sistema ispirato al principio di autogoverno) immaginati tutti come da esercitare in forma “delegata”. Benché non in quella (dichiarata) della “rappresentanza”, ma in quella (più prossima) della “procura”. È il delegato che “decide”. Non su mandato (come si sottolinea, per altro, con riferimento al legislatore: art. 67), ma sulla base di una “preposizione” (investitura, variamente configurata) accompagnata da “istruzioni” generali (le regole costituzionali della funzione). Ora però, mentre per l’azione legislativa sono stati previsti meccanismi di controllo che rispettano (in qualche modo) lo schema adottato (periodicità dell’investitura e rinnovazione libera dei delegati), per quella amministrativa e, in particolare, giurisdizionale, non si è previsto (o, almeno, si sono lasciate scivolare le cose in tale direzione) alcunché di corrispondente. E si è così attribuito alla magistratura un grado di indipendenza, incompatibile con la natura delegata della funzione. Sia chiaro: non ne sto invocando modalità elettive. Sto solo sottolineando l’incoerenza del sistema corrente. Incoerenza che ha reso alla lunga inappropriato anche il sistema di “bilanciamenti” adottato. Questi si configurano infatti come interventi “correttivi” del constatato eccesso (commissivo/omissivo) di esercizio. Se la magistratura, nell’applicare la legge, la interpreta in una direzione ritenuta “eccessiva”, il legislatore cambia la legge. Se il legislatore si rivela inavveduto/eccedente, la magistratura interviene (direttamente o con il soccorso della Corte costituzionale) con un’azione correttiva, integrativa, supplente. Il che non è efficace e genera tensioni. Da un lato, non si elimina l’accaduto. Dall’altro, si possono solo comunque contrastare gli eccessi clamorosi. Non anche quelli striscianti (ben più frequenti ed incidenti). Sarebbe stato sicuramente più utile alla concordia civium (presupposto di ogni convivenza pacifica) “prevenire” l’eccesso (puntando sul coordinamento di esercizio). Non è facile suggerirne i modi. Possono richiedere un complesso gioco di mediazioni (che spetta alla scienza politica disegnare, in una forma appropriata ai contesti storici). Come avevano ben compreso i Romani e meno i Greci; e come, nella modernità, hanno ben compreso gli inglesi e meno gli americani. Anche qui: non sto invocando modelli (oltretutto intrasponibili), né sto esprimendo preferenze. Sto solo facendo constatazioni. La concordia non si ottiene adottando uno statuto politico che viva di competizione/prevalenza, nell’ambito di un quadro bloccato di regole (ve ne possono essere, ma solo se così poche e generali, da potere ricevere, e a lungo, estesa condivisione sociale). Si ottiene in una pratica di continue mediazioni. Nella quale convivano concertato coordinamento delle funzioni di governo (di tutte le funzioni di governo), collegialità della loro gestione e responsabilità “politica” del loro esercizio.



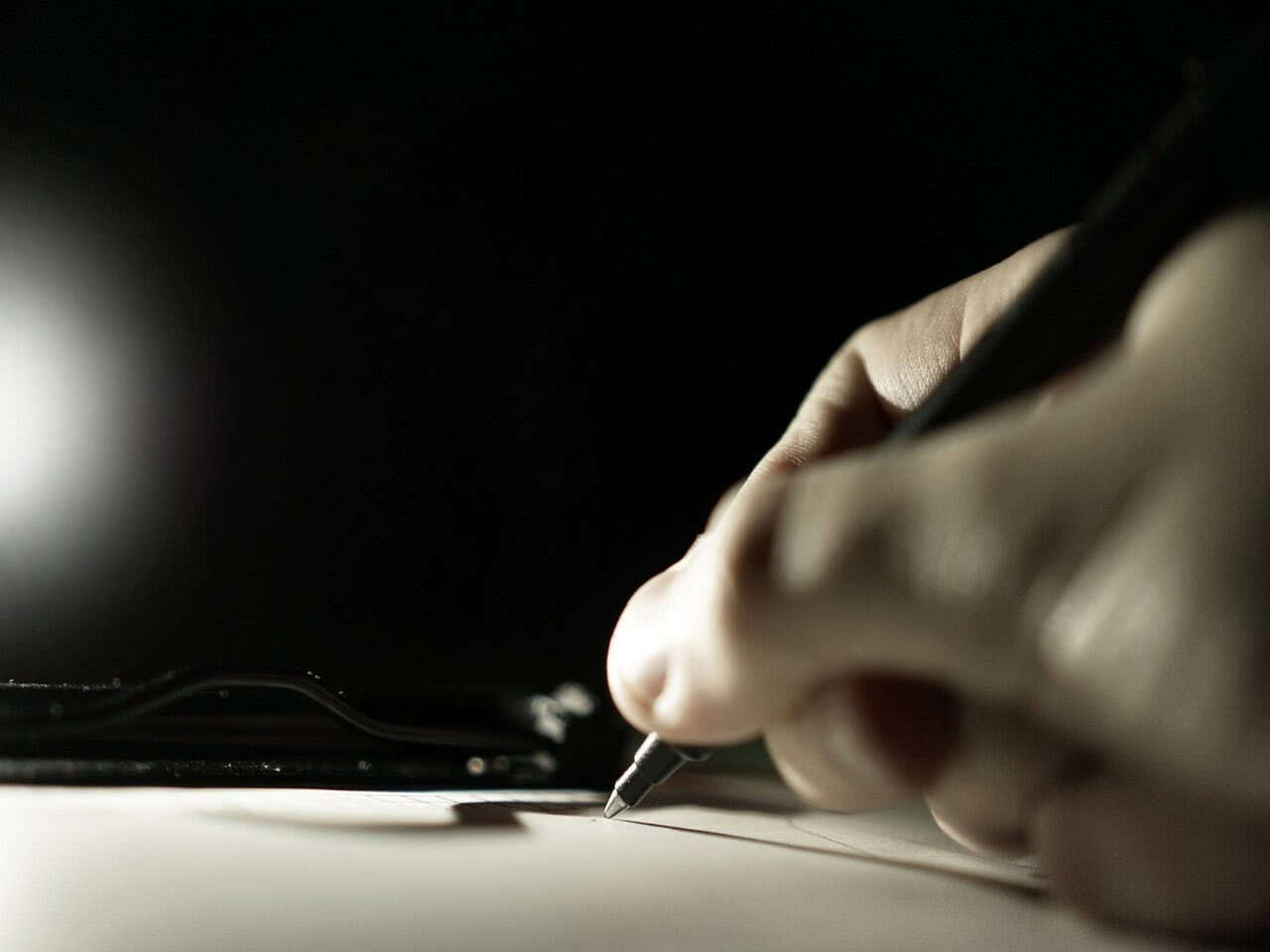

 E poi Aggiungi alla schermata principale.
E poi Aggiungi alla schermata principale.