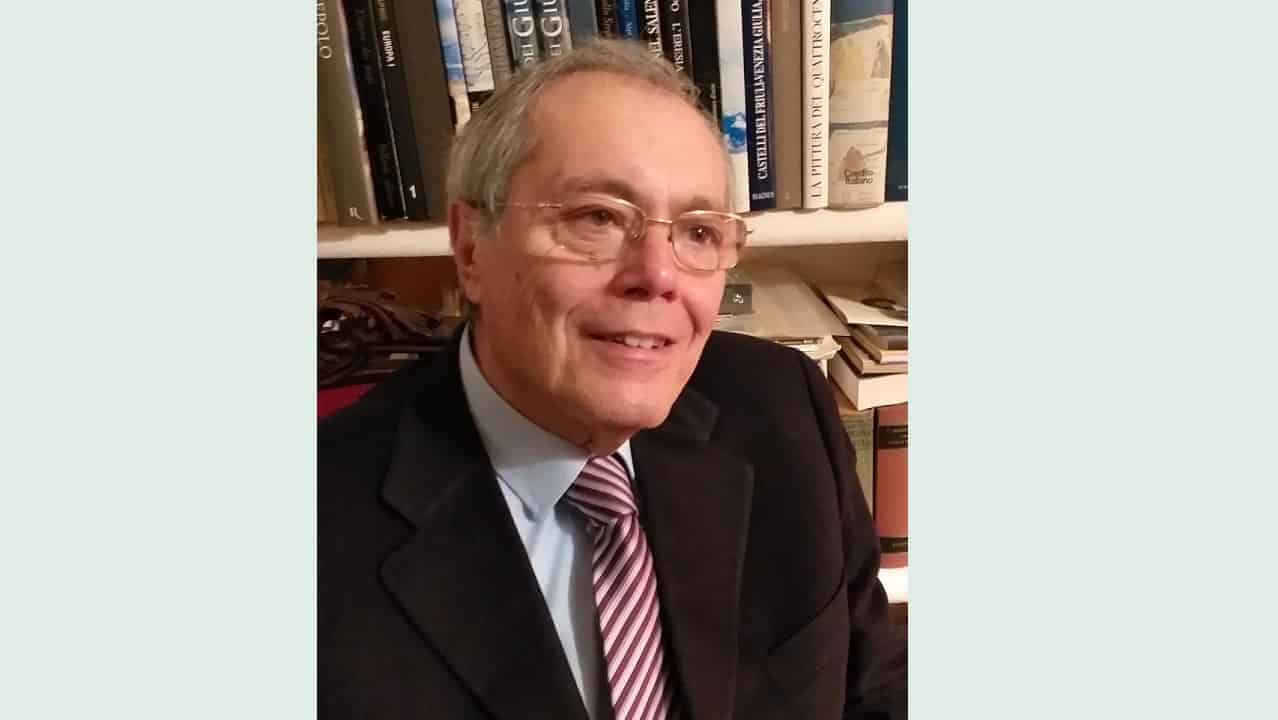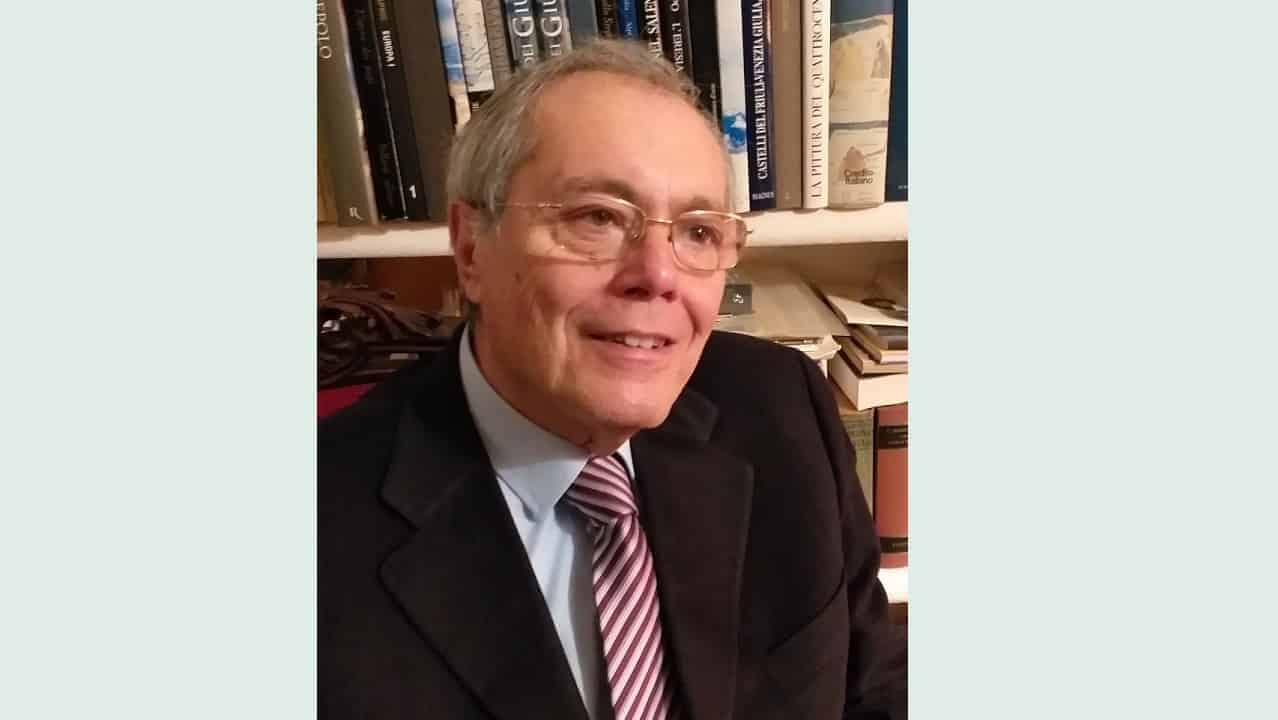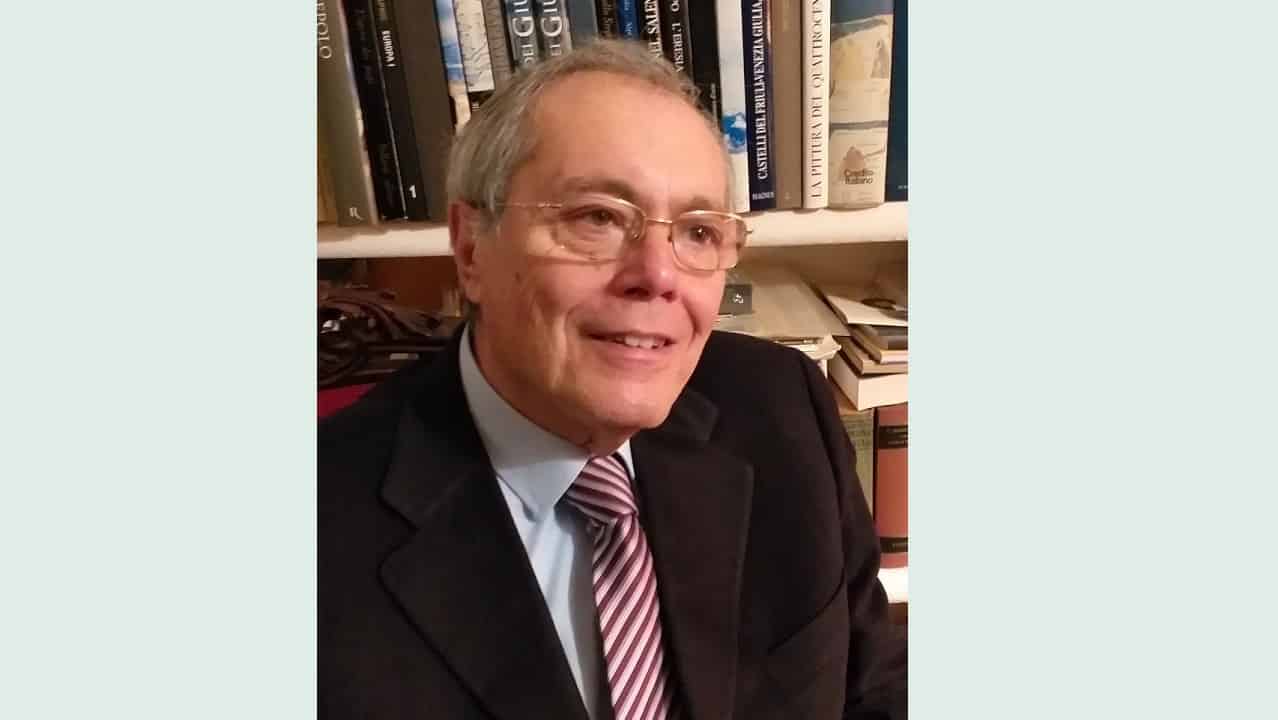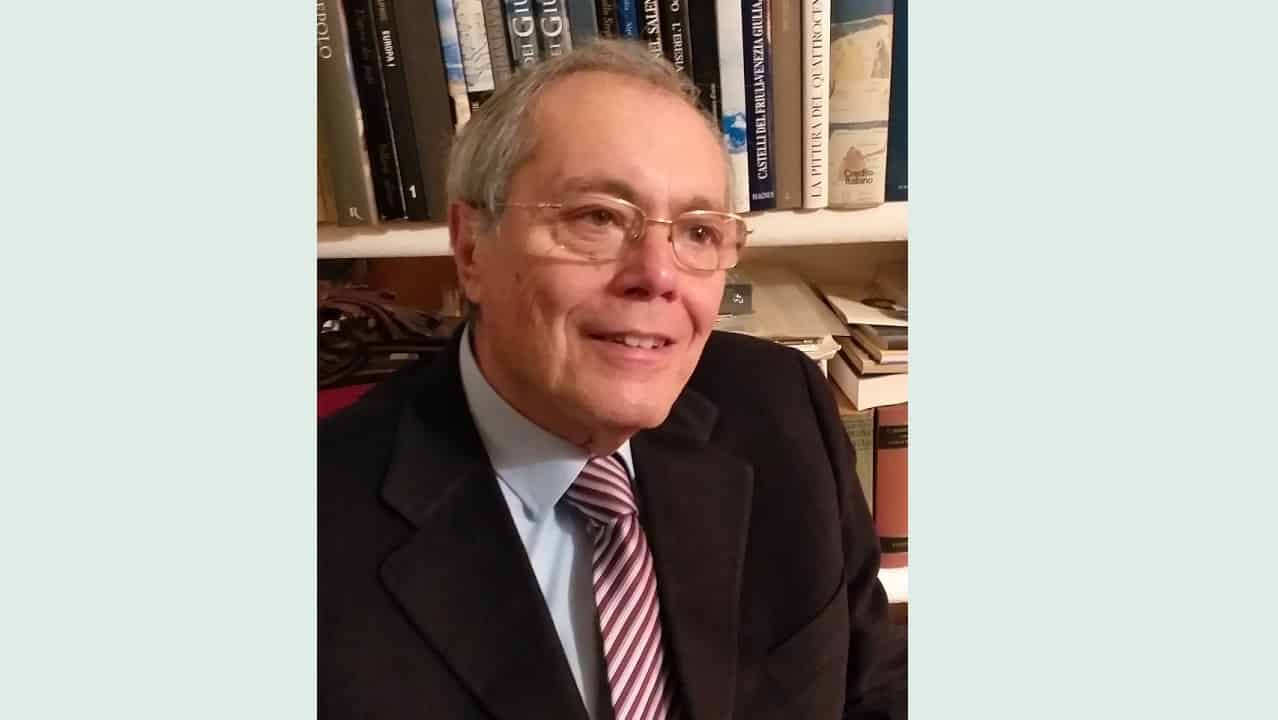Rimosso senza indugio il limite della discrezionalità del legislatore, la Consulta dà alla luce la preannunziata regolazione del suicidio assistito (a prima lettura di Corte cost. n. 242 del 2019) di Antonio Ruggeri
Ciò che si temeva è avvenuto. La nota dominante della pronunzia in commento è la conferma da essa resa della signoria che la Corte rivendica per sé nei riguardi di quella che fino ad oggi si chiamava la sfera riservata agli apprezzamenti discrezionali (o, diciamo pure, politici tout court) del legislatore.
Si badi. La Consulta aveva dato l’impressione nella decisione preparatoria di quella odierna, la discussa (e discutibile) ord. 207 del 2018, di voler preservare la sfera stessa, più e più volte avendovi fatto rimando, allo stesso tempo nondimeno lasciando intendere essere comunque indispensabile l’intervento delle Camere per far luogo ai “delicati bilanciamenti” richiesti dal caso (p. 10 del cons. in dir.).
Di contro, il messaggio che oggi ci viene indirizzato dal giudice delle leggi è che, laddove una disciplina normativa giudicata costituzionalmente necessaria non dovesse venire alla luce per mano del legislatore, sarà il giudice costituzionale a farsene carico, senza limite di sorta. Non si dà più, insomma, alcun confine sicuro ed invalicabile entro il quale la volontà del legislatore, e solo essa, potrà affermarsi e farsi valere; sarà, di contro, la Consulta a stabilire d’ora innanzi fin dove far espandere e dove invece contrarre la sfera rimessa alla regolazione da parte delle Camere, fino ad azzerarne del tutto il campo materiale da essa ricoperto.
Certo, deve pur trattarsi di vicende in cui siano in gioco beni della vita di cruciale rilievo, quale appunto quello di dar modo all’autodeterminazione del soggetto di spegnere (rectius, far spegnere da terzi) la propria vita: insomma, delle situazioni oggettivamente eccezionali, quelle al ricorrere delle quali la Corte caricherà su di sé l’onere, per vero gravosissimo, di riscrivere, inventandosela di sana pianta, una disciplina dallo stesso giudice dapprima giudicata non discendente “a rime obbligate” dalla Carta, desumendo da non meglio precisate “coordinate del sistema vigente i criteri di riempimento costituzionalmente necessari” (p. 4 del cons. in dir. della pronunzia in commento). Viene, dunque, da pensare che, laddove in futuro dovesse nuovamente assistersi all’adozione, in prima battuta, di una ordinanza di rinvio, analoga alla 207, nella quale peraltro saranno ridisegnati i lineamenti della futura normativa ovvero prefigurate alcune sue possibili soluzioni, allo scadere del termine al riguardo concesso al legislatore e perdurando la colpevole inerzia di quest’ultimo senza che peraltro si diano segni concreti di una possibile resipiscenza, sarà il giudice ad occupare il campo.
Si annida qui – come si è tentato di mostrare già in sede di primo commento della 207 – una contraddizione di fondo. Delle due, infatti, l’una: o è vero quanto dichiarato la prima volta dal giudice costituzionale, vale a dire che spetta davvero al legislatore (e solo ad esso) far luogo alla scelta tra le varie soluzioni normative astrattamente immaginabili, da compiersi entro un certo termine (del quale, peraltro, è oscuro il titolo in nome del quale è dal giudice fissato), ed allora non è chiaro cosa mai legittimi in un tempo successivo la Corte a sostituirsi al legislatore stesso; oppure il giudice può (e, anzi, deve) far luogo alla disciplina dalla stessa prefigurata, ed in tal caso non è chiaro perché non vi si possa (e debba) porre subito mano, senza indugio alcuno, tanto più che è poi pur sempre consentito al legislatore di apportarvi le innovazioni giudicate opportune, una volta che abbia deciso di tornare a rioccupare il campo di sua spettanza, sia pure nel rispetto dei “principi e criteri direttivi” somministratigli dal giudice costituzionale.
La contraddizione – come si viene dicendo – è insita nella nuova tecnica decisoria forgiata l’anno scorso: è un suo limite insuperabile, un vizio congenito (e non occulto…) della cosa, insomma. Né giova opporre – come fa la Corte nella decisione in commento (p. 4 del cons. in dir.) – che “decorso un congruo periodo di tempo, l’esigenza di garantire la legalità costituzionale deve, comunque sia, prevalere su quella di lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore per la compiuta regolazione della materia, alla quale spetta la priorità”. A portare fino ai suoi ultimi e conseguenti svolgimenti il ragionamento ora fatto, sarebbe come dire che il modello disegnato nella Carta in ordine alla tipizzazione dei ruoli istituzionali ha una forza non già autenticamente prescrittiva bensì meramente persuasiva e che gli stessi operatori possono factis discostarsene. Sarebbe, perciò, come sancire definitivamente il primato della politica, anche quella dei massimi garanti del sistema, sul primato della Costituzione.
Misterioso è poi il sortilegio che porta a commutare quelli che in un primo tempo sono, con studiata cautela, prospettati quali contenuti eventuali della disciplina sollecitata dalla Corte (eventuali, appunto, perché rimessi al discrezionale apprezzamento del legislatore) nei tratti caratterizzanti la stessa.
Così, ad es., per ciò che attiene al riconoscimento dell’obiezione di coscienza del personale sanitario chiamato a prestare la propria opera al fine di determinare la morte del soggetto: dapprima (p. 10 del cons. in dir. della 207) qualificato come meramente possibile ed ora (p. 6 del cons. in dir. della 242) invece ritenuto (per fortuna…) necessario. O, ancora, per ciò che concerne i luoghi nei quali potrà essere causata la morte, oggi individuati, “in attesa della declinazione che potrà darne il legislatore”, nelle strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale e con la garanzia dell’intervento di un organo collegiale terzo “munito delle adeguate competenze”, individuato nel comitato etico competente per territorio (p. 5).
Si dà, nondimeno, una differenza di non poco conto tra i due esempi appena fatti; ed è che, quanto al primo, non è più rimesso – perlomeno esplicitamente – alla scelta discrezionale del legislatore il riconoscimento del diritto all’obiezione di coscienza del personale coinvolto nelle “procedure” in questione (come sono – per vero, con una certa indelicatezza e freddezza di linguaggio, ripetutamente etichettate le azioni che causano la morte di esseri umani), mentre – come si è veduto – quanto alle sedi nelle quali le “procedure” stesse dovrebbero perfezionarsi la loro individuazione rimane nella disponibilità del legislatore. Viene perciò da pensare che, ove quest’ultimo dovesse un domani intervenire, non potrebbe non far luogo alla previsione del diritto suddetto (e, ove così dovesse invece essere, potrebbe, ancora una volta, rimediare la Corte avvalendosi della inusuale tecnica decisoria inaugurata lo scorso anno e perfezionata oggi).
Apparentemente, ad ogni buon conto, i margini di manovra del legislatore rimangono non poco estesi ma la Kompetenz-Kompetenz – come si viene dicendo – si appunta in capo alla Corte, e solo su di essa: sarà quest’ultima, dunque, a decidere se prendere la penna in mano e riscrivere ovvero scrivere per la prima volta la regolazione normativa di fattispecie nelle quali siano in gioco beni della vita meritevoli della massima considerazione; e sarà ancora la Corte a decidere in quale “luogo” normativo ciò potrà aversi. Nella 207, alle Camere si è indirizzato il “suggerimento” di operare non già sull’art. 580 c.p., sottoposto al giudizio della Consulta, bensì sulla legge 219 del 2017, al fine di riportare la futura regolamentazione alla “relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico”. Oggi, di contro, la Corte non se l’è sentita di spingersi fino al punto di far luogo ad una sì rilevante modifica del quadro legislativo in vigore e si è perciò “limitata” (si fa per dire, ovviamente…) ad avvalersi del solo materiale disponibile, quello portato alla sua cognizione, fatto oggetto di una corposa manipolazione. È comunque chiaro che un domani, qualora il legislatore dovesse decidersi finalmente ad intervenire, bene potrebbe (e a giudizio della Corte farebbe a) spostare il tiro mirando sulla 219.
Sta di fatto che, pur laddove la disciplina sottoposta al vaglio della Consulta dovesse in sé e per sé valutarsi come inadeguata all’intervento in parola, nulla farebbe da ostacolo a che esso possa ugualmente aversi per mano dello stesso giudice. Al tirar delle somme, quest’ultimo reputa di avere carta bianca praticamente su tutto: sul se, sul dove, su come intervenire.
È questa, a mio modo di vedere, la lezione che si ricava dalla complessiva manovra avviata lo scorso anno ed oggi portata a compimento: una lezione rilevante (e preoccupante) non soltanto – come si vede – al piano processuale, per ciò che attiene cioè all’ampliamento dell’area ricopribile dalle tecniche decisorie di cui la Corte dispone e per l’uso disinvolto che se ne fa, a mezzo di innaturali mescolamenti dei profili di ammissibilità con quelli di merito delle questioni portate alla cognizione della Corte, ma anche (e più ancora) al piano istituzionale, laddove si definiscono (e ridefiniscono) senza sosta, iussu iudicis, gli equilibri (e squilibri…) tra la stessa Corte e il legislatore.
Che dire, dunque, del principio della separazione dei poteri? Funere mersit acerbo… Non sono, dunque, solo i politici – come paventa R. Bin in un suo commento su www.laCostituzione.info del 22 novembre scorso – a lamentarsi della invasione di campo operata a loro danno ma anche qualche (forse ed auspicabilmente, non isolato) giurista.
Non consola, poi, la circostanza per cui anche nella decisione odierna insistito è l’appello al legislatore ad intervenire una buona volta sul campo facendo luogo a quei “delicati bilanciamenti” che sono sollecitati dal caso, dei quali si diceva. Il vero è che la regolazione oggi ope juris prudentiae prodotta e praticamente presa di peso (o quasi) dalla decisione interlocutoria dello scorso anno (a conferma dello scarto vistoso da essa esibito tra la forma e la sua sostanza) è comunque autosufficiente e si connota per un elevato tasso d’innovatività: è, cioè, una vera e propria legislazione rivestita delle candide forme della sentenza, che – come si diceva – fa luogo, in più punti, alla selezione di opzioni dapprima dallo stesso giudice presentate come meramente possibili e reciprocamente alternative. Si pensi solo, in aggiunta a quanto sopra detto, alla sorte dei casi analoghi a Cappato insorti prima della decisione di oggi, da quest’ultima parimenti riportati sotto l’“ombrello” protettivo della non punibilità dell’aiuto prestato al suicidio, sempre che siano allo scopo utilizzate modalità idonee “a offrire garanzie sostanzialmente equivalenti”; ed è facile previsione che non poche controversie al riguardo insorgeranno, tali da mettere a dura prova gli operatori chiamati a risolverle.
Particolarmente sottolineato – come si vede – è qui pure il ruolo dei medici cui sono rimesse verifiche di primario rilievo: un ruolo che – si tiene a precisare anche nella odierna decisione – dovrà essere comunque salvaguardato anche dalla futura disciplina legislativa (sempre che riuscirà finalmente a vedere la luce…).
Insomma, la “delega” è duplice: al legislatore, cui competono decisioni politiche nondimeno fortemente orientate dalla odierna “sentenza-legge” (e, risalendo, dalla “ordinanza-legge” dell’anno scorso), ed agli operatori sanitari. Nel frattempo, nondimeno, avrà pieno vigore la disciplina “sussidiariamente” prodotta dal giudice, dopo aver scientemente messo da canto il canone, pure connotato da strutturale vaghezza ed ambiguità, costituito dal rispetto della discrezionalità del legislatore, il cui vigore non era stato dalla stessa 207 revocato in dubbio.
La conversione di un giudice, sia pure del tutto peculiare, qual è la Corte, in un legislatore allo stato puro perviene così a compiuta maturazione, senza alcun mascheramento. Non si tratta più – come pure gli studiosi più prudenti ed avveduti hanno da tempo rilevato – di una mera prevalenza (o, diciamo pure, dominanza) della c.d. “anima” politica su quella giurisdizionale, nel mix cui esse danno vita in forza di una opportuna opzione operata già al tempo della Costituente; di più (e peggio), si tratta puramente e semplicemente dell’affermazione dell’una al posto dell’altra, svilita nella sua stessa essenza e risolutamente messa da parte.
Sia chiaro. Nessuno è così ingenuo e sprovveduto da non averne colto i segni premonitori, non soltanto nella pronunzia dello scorso anno su Cappato ma in molte altre adottate nei campi più varî di esperienza e con riguardo a vicende processuali pure assai diverse tra di loro: da quelle relative alle leggi elettorali ad altre ancora (come quella sulla Robin tax) in cui la Consulta si è parimenti discostata dai canoni stabiliti per l’esercizio della giurisdizione costituzionale (in ispecie, come si sa, da quelli relativi alla rilevanza ed agli effetti delle decisioni, specie di quelle ablative). In Cappato, tuttavia, si è forse raggiunto il punto più alto di questo trend che inquieta fortemente circa i suoi possibili sviluppi e gli esiti ad essi conseguenti. Ritardi e carenze dei decisori politici vanno – fin dove possibile e con gli strumenti al riguardo apprestati – combattuti con decisione e senza risparmio di energie. Il rimedio giusto non è tuttavia – a me pare – quello degli eccessi dei garanti che, non meno dei primi, concorrono a mettere sotto stress la Costituzione e lo Stato che da essa prende il nome.
Non vale obiettare – come pure talvolta si è fatto (e si fa) – che ciò che solo importa è che i diritti costituzionali ne abbiano, al tirar delle somme, un guadagno o, come che sia, quel pur parziale appagamento che senza l’intervento dei garanti stessi non potrebbe comunque aversi.
Ad un siffatto modo di vedere le cose possono, a mia opinione, opporsi almeno due argomenti, già in altri luoghi rappresentati, di metodo e di merito.
Per l’un verso, se il prezzo da pagare per vedere finalmente riconosciuto ed effettivamente salvaguardato un diritto costituzionale è quello riportabile alla inesorabile “logica” machiavellica del fine che giustifica il mezzo, si può obiettare che lo snaturamento dei ruoli istituzionali è un prezzo che l’ordinamento costituzionale non è in grado di pagare, dal momento che ne sarebbero fatalmente contagiati gli stessi diritti, secondo la ispirata intuizione dei rivoluzionari francesi, mirabilmente scolpita nell’art. 16 della Dichiarazione del 1789. Zoppo di una delle due gambe su cui si regge e con le quali soltanto può portarsi avanti nel suo non lineare, comunque sofferto, cammino, lo Stato costituzionale sarebbe infatti condannato a dissolversi e con esso, perciò, ad essere sacrificati proprio quei diritti per la cui salvaguardia è venuto ad esistenza.
Per l’altro verso, poi, è tutto da vedere se, in una vicenda processuale data, siano davvero in gioco diritti costituzionali pretermessi e bisognosi pertanto di essere finalmente protetti. Una questione che torna imperiosa a porsi proprio in merito al caso nostro, del quale nulla ora voglio dire dopo aver già manifestato in altri luoghi il mio punto di vista. Possiamo chiamare le cose come vogliamo, darne una edulcorata (e, in buona sostanza, deformata) rappresentazione ma resta il fatto che la Consulta, pur avendo in premessa (già nella 207) ribadito la insussistenza di un diritto a morire, in conclusione della vicenda approda alla sponda opposta, dandone il riconoscimento, sia pure a condizioni dalla stessa poste e – va detto senza infingimenti – non discendenti “a rime obbligate” dalla Carta costituzionale. Su ciò, desidero qui in chiusura ribadire il mio fermo, convinto dissenso e sollecitare un supplemento di severa, critica riflessione.
Un’ultima notazione che, per vero, meriterebbe una meno affrettata attenzione.
Ancora una volta, è qui lasciata in ombra la CEDU, la cui violazione pure era stata denunziata nell’atto introduttivo del giudizio di costituzionalità. Per vero, la decisione odierna (e già la 207 cui questa – come si diceva – largamente attinge avvalendosi della funzione “copia e incolla”) non trascura di fare richiami alla giurisprudenza convenzionale; e però, dal momento che si è fatto luogo all’accoglimento della questione (seppur nei limiti “normativamente” stabiliti dalla decisione stessa), si è ancora una volta fatto utilizzo della tecnica dell’assorbimento dei vizi, senza alcun riguardo per i parametri convenzionali (v. p. 8 del cons. in dir.). Insomma, ancora una testimonianza, quella oggi resa, del ruolo sostanzialmente ancillare e subalterno delle Carte dei diritti diverse dalla nostra legge fondamentale, alle quali perlopiù si fanno richiami ad pompam, senza davvero mettere in atto quella mutua integrazione delle stesse nei fatti interpretativi che è già da tempo predicata dalla Consulta (spec. sent. n. 388 del 1999) ma, a conti fatti, tranne qualche sporadica ed apprezzabile eccezione, non praticata. È un vero peccato che tardi a maturare la consapevolezza dei benefici che potrebbero averne i diritti ove quest’autentico metodo di giudizio, ispirato alla sostanziale parità delle Carte ed all’apporto risultante dal loro fecondarsi a vicenda, divenisse pratica quotidiana di amministrare giustizia, costituzionale e non. L’auspicio è che, anche grazie all’ingresso presso le Corti di studiosi ed operatori di provata sensibilità ed apertura culturale, anche questo passo prima o poi sia, in modo risoluto, fatto.