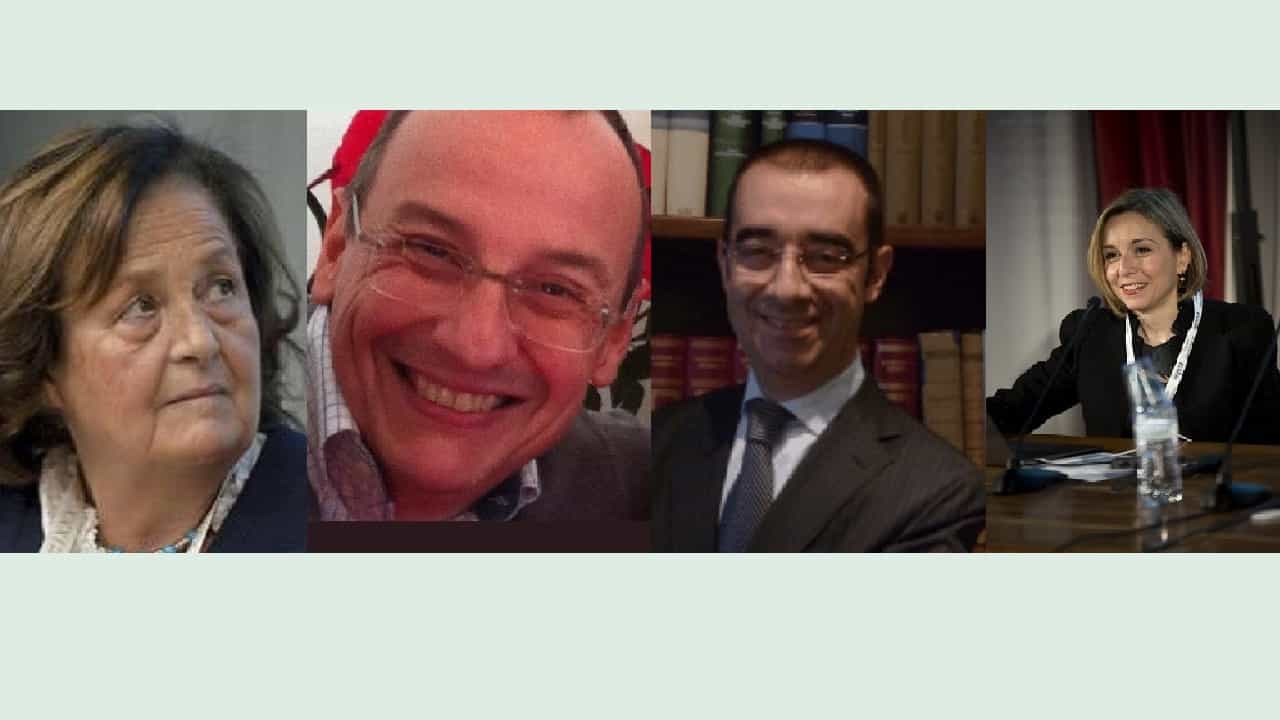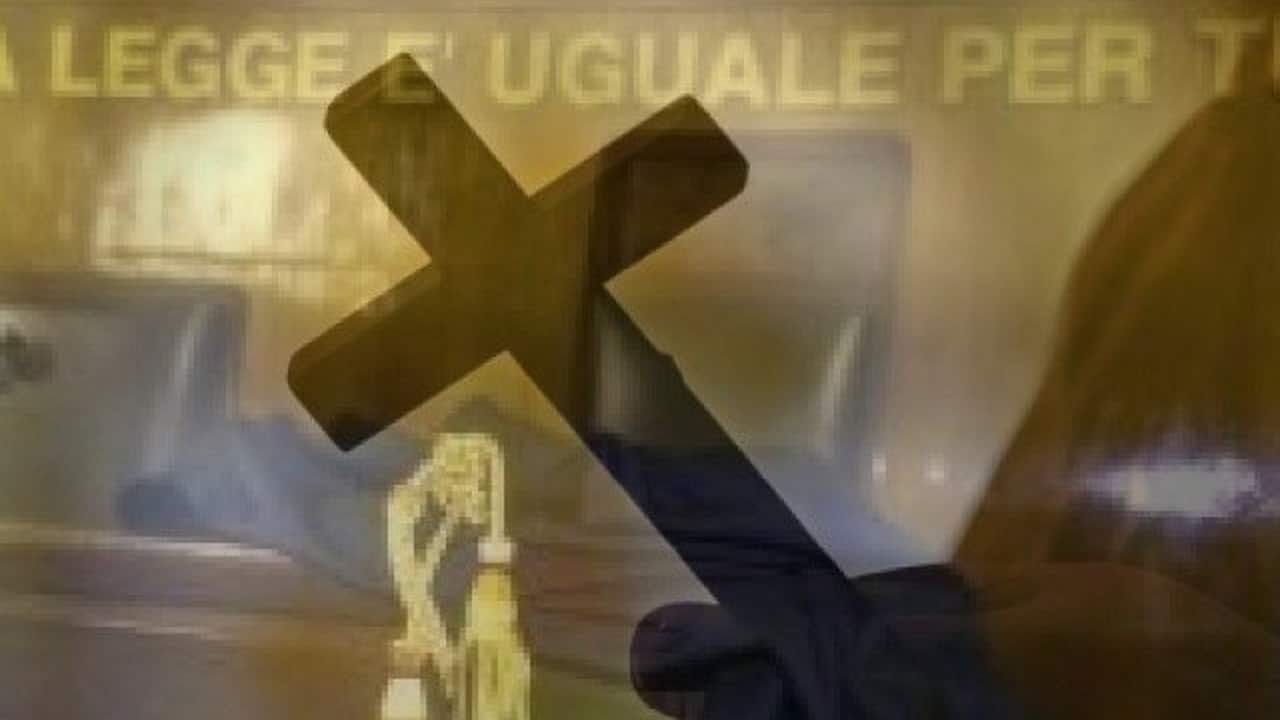Dedichiamo l’8 marzo alle Madri Costituenti
In questa stagione difficile, in cui è costante il richiamo alla Costituzione e ai valori in essa scolpiti, è d’obbligo dedicare la giornata dell’8 marzo alle Madri Costituenti, che svolsero un ruolo importante e forse poco noto nei lavori dell’Assemblea, dando il loro fondamentale contributo alla realizzazione di una Repubblica democratica ispirata al principio personalista. Erano soltanto 21 sul totale di 556 rappresentanti eletti; 5 di loro entrarono a far parte della Commissione dei 75; nessuna fu chiamata a comporre il “Comitato di redazione” che aveva il compito di elaborare il testo definitivo della Carta. Più specificamente, Nilde Iotti e Angela Gotelli fecero parte della I Sottocommissione incaricata di occuparsi dei diritti e doveri dei cittadini; Maria Federici, Lina Merlin e Teresa Mattei andarono a comporre la III Sottocommissione, designata a trattare la materia dei rapporti economici e sociali; nessuna donna fece parte della II Sottocommissione incaricata dell’organizzazione costituzionale dello Stato.
Esse appartenevano a schieramenti politici diversi: 9 erano comuniste, 9 democristiane, 2 socialiste, una del Fronte dell’Uomo Qualunque. Erano tutte giovani, alcune giovanissime, e provenivano da diverse regioni d’Italia, così da rappresentare l’intero territorio nazionale. Quasi tutte erano laureate, alcune insegnanti, alcune giornaliste, due sindacaliste. Molte di loro avevano condiviso la militanza nella Resistenza, pagando un prezzo alto per questa scelta di lotta; a tutte era comune un forte impegno nell’associazionismo femminile e poi nella campagna elettorale del 1946.
Non è difficile indovinare il clima di diffidenza, di scetticismo, di odioso paternalismo con il quale esse dovettero da subito confrontarsi: di tale clima è peraltro agevole cogliere numerosi riscontri nei resoconti ufficiali dei lavori.
Fu grande merito delle Costituenti percepire immediatamente la necessità di fare gioco di squadra, nonostante le diversità dello loro storie professionali e delle loro radici culturali, così da formare un sodalizio forte e compatto capace di dar voce con coerenza ed efficacia ad un pensiero femminile nuovo, teso a delineare un ordinamento democratico fondato sulla eguaglianza e sulla tutela dei diritti e della dignità di ogni persona e al tempo stesso a demolire i molti pregiudizi ancorati alla cultura del passato che tuttora allignavano, specie in ordine ad alcuni temi sensibili, nelle idee di molti appartenenti a quel consesso.
Nell’impegno immane di ricostruzione delle fondamenta giuridiche del Paese esse seppero rivendicare il posto che loro spettava, con la stessa quota di responsabilità e di fatica. Con la forza di argomentazioni serrate, con la passione ideale maturata nella loro storia politica e personale esse seppero interpretare e farsi portavoce della legittima aspirazione delle donne italiane di emancipazione, di cittadinanza piena, di rispetto nella famiglia, nella società e nei luoghi di lavoro, facendo così emergere una nuova visione della figura femminile.
Si deve alla determinazione di quelle donne il passaggio da una concezione meramente formale ad una sostanziale del principio di eguaglianza, così chiaramente scolpito in Costituzione: fu grazie ad un intervento di Lina Merlin che l’espressione “di sesso” fu inserita nel primo comma dell’art. 3, nella prospettiva di una piena eguaglianza formale tra tutti i cittadini e le cittadine e nel segno di una decisiva rottura con certi schemi del passato. E fu Teresa Mattei a sollecitare l’inserimento dell’espressione “di fatto” nel secondo comma dello stesso art. 3, così ampliando la natura e la portata degli ostacoli da rimuovere al fine di realizzare il principio di eguaglianza sostanziale.
Soccorrono al riguardo le parole di Teresa Mattei , la più giovane tra gli eletti e le elette, pronunciate nel suo primo bellissimo intervento in Assemblea: «…fra le più solenni dichiarazioni che rientrano nei 7 articoli di queste disposizioni generali, accanto alla formula che delinea il volto nuovo, fatto di democrazia, di lavoro, di progresso sociale, della nostra Repubblica, accanto alla solenne affermazione della nostra volontà di pace e di collaborazione internazionale, accanto alla riaffermata dignità della persona umana, trova posto, nell’ art. 7 (ora art. 3), la non meno solenne e necessaria affermazione della completa eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di condizioni sociali, di opinioni religiose e politiche. Questo basterebbe, onorevoli colleghi, a dare un preminente carattere antifascista a tutta la nostra Costituzione…»
Le Madri Costituenti furono determinanti nell’inserire nell’agenda politica dei lavori aspetti nuovi o fino a quel momento trascurati perché ritenuti marginali, come il valore supremo della persona e della dignità umana, la centralità della dimensione relazionale e delle formazioni sociali in cui si svolge la personalità dell’individuo.
Fondamentale fu l’apporto di Nilde Iotti sui temi della famiglia, sul principio della pari dignità della coppia, sulla protezione dei figli nati fuori del matrimonio, così come a Nilde Iotti si deve la nuova concezione del lavoro femminile come strumento essenziale per la crescita personale e l’autonomia non solo economica delle donne, anche se nella formulazione di alcuni articoli (artt. 29, 30, 37) fu necessario addivenire a faticosi compromessi tra le posizioni ideologiche dei costituenti, al bivio tra il pieno riconoscimento del principio di parità e l’esaltazione di un familismo fondato sul ruolo tradizionale delle donne nello spazio domestico.
Quanto all’impegno nella lotta contro i pregiudizi, è sufficiente la lettura dei verbali dei lavori della III Sottocommissione e dell’Assemblea generale relativi alla possibilità per le donne di accedere a tutti gli uffici pubblici, ed in particolare alla magistratura, per comprendere che i tanti interventi di segno negativo svolti da illustri giuristi non costituivano voci isolate, ma riflettevano orientamenti profondamente radicati nella società, nella classe politica e tra gli operatori del diritto. A fronte di coloro che definivano la partecipazione delle donne all’ordine giudiziario “una innovazione estremamente ardita” o che evocando le parole di San Paolo invitavano le donne a far silenzio nei tribunali si elevava l’ammonimento di Teresa Mattei: «nessuno sviluppo democratico, nessun progresso sostanziale si produce nella vita di un popolo se esso non sia accompagnato da una piena emancipazione femminile».
Grazie dunque alle Madri Costituenti per esserci state.
Immagine: Le 21 donne alla Costituente, in La Domenica del Corriere, 4 agosto 1946, 19, firmato “il cronista di Montecitorio”.