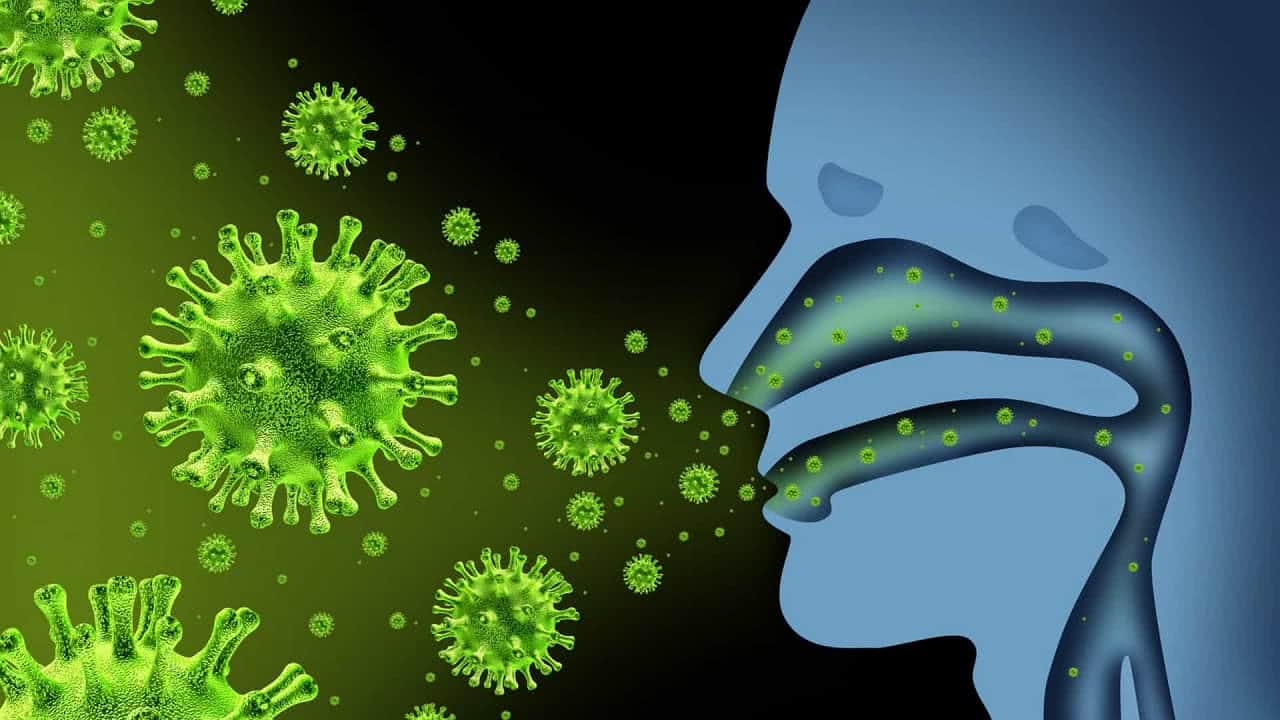
Coronavirus e carcere di Giovanni Maria Pavarin
Nella sezione delle aree tematiche della Gazzetta Ufficiale denominata “Coronavirus” figurano, dal 31 gennaio 2020 ad oggi, ben 12 tra decreti-legge, leggi e d.p.c.m. riguardanti le misure urgenti fin qui adottate.
Il carcere fa in essi capolino solo col d.p.c.m. 25 febbraio, che si è preoccupato che i nuovi ingressi in istituto non siano occasione di contagio [lett. m) dell’art. 1).
La preoccupazione è stata ribadita tal quale 5 giorni dopo [lett. h) dell’art. 4 d.p.c.m. 1 marzo 2020].
E’ solo il giorno successivo che il Governo interviene sopprimendo di fatto il diritto ai colloqui visivi (art. 18 legge n. 354/1975) col prevedere che gli stessi, negli istituti in allora appartenenti alla cd. “zona rossa”, fossero “svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria”, ovvero “surrogando” tale diritto con la possibilità di ottenere l’aumento del numero delle telefonate consentite ex art. 39 d.p.r. n. 230/2000 (art. 10, 14° comma d.l. 2 marzo 2020, n. 9) (le telefonate in esubero restano comunque assoggettate al potere discrezionale dl Direttore).
Immediata deve essere stata a mio giudizio la ricaduta pratica di tale disposizione sul fronte del penitenziario, se è vero che appena sei giorni dopo il d.p.c.m. 8 marzo 2020 innesta una parziale retromarcia con la previsione secondo cui “in casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri” [art. 2, lett. u)].
Molto interessante l’altra disposizione contenuta nella stessa lett. u), laddove - in relazione ai “casi sintomatici dei nuovi ingressi negli istituti penitenziari” - viene prevista la “condizione di isolamento” dagli altri detenuti “raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare”.
Si tratta, all’evidenza, di raccomandazione rivolta agli organi dell’Amministrazione penitenziaria, che sono legittimati a chiedere alla magistratura di sorveglianza i benefici penitenziari (art. 57 l.n. 354/1975): chiara la volontà di evitare che il virus entri in carcere e che, una volta entratovi, vi si propaghi.
L’ultima parte della stessa norma concerne la raccomandazione di “limitare i permessi e la libertà vigilata o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l’uscita e il rientro dalle carceri”: anche in questa ipotesi, evidente essendo che il Governo non può di certo “raccomandare” nulla alla giurisdizione, l’invito appare rivolto ai Direttori degli istituti, competenti a rilasciare il parere sulla concessione dei permessi premio ed a modulare il programma di trattamento dei semiliberi (art. 101 d.p.r. n. 230/2000), altro significato non potendo attribuirsi all’infelice ed atecnico richiamo alla libertà vigilata.
La sera dello stesso 8 marzo la Gazzetta Ufficiale pubblicava però il d.l. n. 11/2020, il cui art. 2, 8° comma interviene ad estendere a tutti gli istituti di pena (e prima ancora che l’intero paese divenisse “zona rossa”) la norma limitativa (rectius: soppressiva) del diritto ai colloqui, ignorando però la facoltà di deroga in casi eccezionali prevista qualche ora prima dal d.p.c.m. appena richiamato.
Dal che si dovrebbe far discendere, per incompatibilità del decreto-legge, fonte primaria di grado poziore e posteriore, rispetto a quella precedente e di grado inferiore (d.p.c.m.), il venir meno della facoltà concessa ai direttori degli istituti di pena di derogare in casi eccezionali alla norma impeditiva dei colloqui.
Il successivo 9° comma dello stesso art. 2 contiene poi una disposizione (per la verità alquanto eccentrica) che prevede che la magistratura di sorveglianza possa sospendere la concessione dei permessi premio e della semilibertà “tenuto conto delle evidenze rappresentate dall’autorità sanitaria”.
Qui si assiste ad una specie di tentativo (già leggibile in nuce nel d.p.c.m. 8 marzo 2020) del potere politico di “indirizzare” la giurisdizione: si tratta, infatti, di una norma del tutto pleonastica, evidente essendo che i magistrati di sorveglianza, facendo uso della discrezionalità loro concessa dalla più parte delle norme di ordinamento penitenziario, dispongono già del potere di sospendere la concessione dei permessi (o di non concedere la semilibertà) per motivi oggettivi (che non dipendono cioè da un giudizio di meritevolezza del condannato).
Inutile però negare la “suggestione” che la norma è destinata ad operare: ci saranno, e ci sono, magistrati di sorveglianza che sospenderanno in via generalizzata i permessi premio in corso di fruizione, altri che non ne concederanno di ulteriori, altri ancora che approveranno rimodulazioni dei programmi di trattamento della semilibertà in senso oltremodo restrittivo; altri magistrati effettueranno invece valutazioni caso per caso a seconda del tasso di rischio connesso al pericolo di importare il virus all’interno dell’istituto, ad esempio consentendo ai semiliberi di pernottare presso le loro abitazioni e computando le relative ore nel montante annuo delle licenze consentite dall’art. 52 l.n. 354/1975.
Va a tal proposito considerato che l’ambiente carcere non può essere considerato al riparo dal rischio epidemiologico solo perché si prevede una restrizione delle uscite: ogni giorno i detenuti, infatti, toccano cose (le merci, il cibo, i generi sopravittuari, ecc.) che vengono dall’esterno e vivono e respirano con persone (gli operatori penitenziari) che vengono dall’esterno.
Si deve dunque convenire che il rischio della propagazione all’interno degli istituti del coronavirus non è direttamente correlabile né all’abolizione dei colloqui né al giro di vite dei benefici penitenziari.
C’è di più: il detenuto non appare per definizione in grado di rispettare le norme comportamentali sul distanziamento sociale, essendo anzi obbligato a condividere numerose ore al giorno i propri spazi di vita con molte altre persone; del pari non è di certo applicabile ai detenuti il divieto di assembramento di cui all’art. 1, 2° comma del d.p.c.m. 9 marzo 2020, emanato quando tutta Italia è divenuta “zona rossa”.
Ma tant’è: il rebound nel pianeta carcere (non propriamente popolato da fini giuristi) di tali disposizioni, assommato a mille preesistenti motivi di tensione, è sfociato negli episodi di violenza, se non in vere e proprie sommosse ed evasioni di cui i media danno ogni giorno notizia e che ci restituiscono immagini del tutte inedite e non conosciute nemmeno all’epoca del terrorismo.
I preesistenti motivi di tensione sono noti a tutti: la sola parzialissima realizzazione delle riforme di sistema previste dalla legge Orlando, avendo i decreti legislativi delegati deluso le attese di molti detenuti; gli annunci “liberatori” seguiti ad alcune pronunce della Corte costituzionale e della Cedu in materia di ergastolo ostativo e di ammissibilità dell’istanza di permesso-premio anche in difetto di collaborazione con la giustizia da parte dei condannati per reati di cui all’art. 4 bis l.n. 35471975; l’inedito viaggio dei giudici della Corte costituzionale nelle carceri (con relativa regia di un film), che può aver creato un clima di fiducia nell’inizio di un costruttivo dialogo con le istituzioni; l’incremento, lento ma costante, del tasso di sovraffollamento; l’assenza di provvedimenti di clemenza da ben 14 anni; il clima sociale pervaso dallo slogan della pena effettiva e certa, che rende obiettivamente più difficoltosi i percorsi di reinserimento sociale e che disturba maledettamente tutti gli addetti al cammino rieducativo.
Non sta certamente a me dare consigli, fornire ricette o indicare le possibili vie d’uscita, né alimentare le polemiche insorte tra i colleghi sulla bontà e l’opportunità dei rimedi possibili.
Una sola cosa mi sembra chiara: quanto sta succedendo in questi giorni in carcere esige una risposta (quale che sia) caratterizzata dall’urgenza: solo una risposta celere e risolutiva sarà in grado di placare il clima di tensione e di far cessare definitivamente gli inauditi episodi di violenza e di morte.
Solo due osservazioni: quanto alla liberazione anticipata speciale (ipotesi avanzata dall’ottimo Riccardo De Vito, uno tra i più valenti ed apprezzati colleghi della sorveglianza), ricordo (solo a chi non ne avesse memoria) che è stato proprio questo istituto a consentire al nostro Paese di salvarsi da ulteriori pesanti condanne da parte della Cedu.
Quanto all’abolizione dei colloqui, il divieto ben potrebbe essere rivisto e rimodulato, prevedendo ad esempio gli opportuni controlli nei confronti di chi ha diritto di accedervi.
Come magistrato mi sento solo di ricordare che il compito che la legge affida alla giurisdizione di sorveglianza è quello di dare alla pena l’unico senso possibile, che è quello della rieducazione: castigo sì, retribuzione sì, ma anche speranza nella riabilitazione e nel riscatto attraverso la costante e spesso affannosa ricerca di percorsi di reinserimento.
Come magistrato mi sento solo di ricordare a me stesso che il principio della pena effettiva e certa non può essere usato come uno slogan.
Esso evoca semplicemente una delle principali conquiste del moderno Stato di diritto: esso altro non significa che il principio di legalità (art. 25, 2° comma Cost.), il quale implica il divieto di punire se non in base ad una legge certa (sul reato e sulla pena) entrata in vigore prima del fatto commesso.
Per questo il carcere, per chi ha la sorte di finirci, va concepito come un trampolino di partenza verso l’inizio di una nuova vita: si tratta di un obiettivo che va perseguito con l'apertura massima alle misure alternative alla detenzione, tutte le volte - beninteso - in cui ciò sia possibile senza ledere il diritto della collettività alla sua sicurezza.
Da ultimo, e sempre riguardo al sovraffollamento, si tratta solo di far alloggiare dignitosamente poco più di 60.000 persone: credo non sfugga a nessuno che l’impegno economico necessario alla risoluzione del problema pare quasi irrilevante se raffrontato alle cifre che sono state impiegate per affrontare le altre dolorose piaghe delle quali lo Stato è stato costretto ad occuparsi, impegnando importanti risorse finanziarie (penso ai terremotati, ai cassintegrati, ai malati, ai disabili, a tutti quei soggetti, insomma, nei cui confronti le parole come Stato sociale e welfare hanno ancora un senso).

