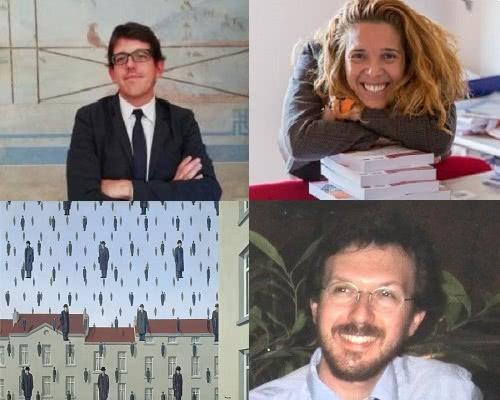Rivedere CILFIT? Riflessioni giuscomparatistiche sulle conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa Consorzio Italian management
di Giuseppe Martinico e Leonardo Pierdominici*
Sommario: 1. Introduzione e obiettivi dello scritto - 2. La genesi della teoria dell’acte clair e dei criteri CILFIT: inquadramento comparato - 3. Le conclusioni dell’avvocato generale Bobek nel caso Consorzio Italian Management - 4. Il contesto in cui si inseriscono le conclusioni dell’avvocato generale Bobek - 5. Conclusioni.
1. Introduzione e obiettivi dello scritto
In questo saggio si cercherà di contestualizzare e analizzare in maniera critica le conclusioni dell’avvocato generale Bobek al caso Consorzio Italian management[1], prestando particolare attenzione alle questioni che lo hanno indotto a suggerire alla Corte di giustizia dell’Unione europea un parziale superamento della nota giurisprudenza CILFIT[2].
Nel farlo, divideremo il saggio in quattro parti. Dopo la presente introduzione allo storico caso del 1982, nella seconda parte ripercorreremo le motivazioni che portarono la Corte a CILFIT, per poi, nella terza, esporre le ragioni insite nelle conclusioni dell’avvocato generale Bobek alla luce di considerazioni comparatistiche. Infine, inquadreremo queste conclusioni all’interno di una stagione (lunga) di ripensamento dei pilastri di quello che si potrebbe definire un diritto processuale “complesso”[3], frutto, cioè, dell’intreccio normativo prodotto, negli anni, dal processo di integrazione europea.
CILFIT è il prodotto di un’epoca di grande attivismo giudiziale in cui la Corte di Lussemburgo ha cercato, dopo aver posto le basi della specialità del diritto comunitario, di razionalizzare - vedremo in che modo - il rapporto con i giudici comuni. Nel farlo, la Corte ha in parte riscritto la disposizione dell’attuale art. 267 TFUE (a quel tempo art. 177 TCEE), ridisegnando le “regole d’ingaggio” che devono caratterizzare la cooperazione fra giudici nazionali e l’interprete qualificato del diritto dell’UE.
CILFIT appartiene all’Olimpo dei grands arrêts[4], una pronuncia analizzabile da vari punti di vista che ha il merito di aver aiutato la Corte a incanalare le energie giudiziali presenti in un ordinamento multilivello[5].
Nelle parole della Corte di giustizia, l’allora art. 177 TCEE, - e dunque l’attuale art. 267 TFUE -:
«Va interpretato nel senso che una giurisdizione le cui decisioni non sono impugnabili secondo l'ordinamento interno è tenuta, qualora una questione di diritto comunitario si ponga dinanzi ad essa, ad adempiere il suo obbligo di rinvio, salvo che non abbia constatato che la questione non è pertinente, o che la disposizione comunitaria di cui è causa ha già costituito oggetto di interpretazione da parte della Corte, ovvero che la corretta applicazione del diritto comunitario si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi; la configurabilità di tale eventualità va valutata in funzione delle caratteristiche proprie del diritto comunitario, delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta e del rischio di divergenze di giurisprudenza all'interno della Comunità».
Con CILFIT, quindi, la Corte di giustizia individuava alcune eccezioni a quanto stabilito dalla lettera della norma fondamentale in tema di procedimento pregiudiziale, vero e proprio pilastro dell’ordinamento dell’UE, come confermato, fra l’altro, anche nel Parere 2/13 della Corte di giustizia, ove se ne è sottolineata l’importanza nella «rete strutturata di principi, di norme e di rapporti giuridici mutualmente interdipendenti, che vincolano, in modo reciproco, l’Unione stessa e i suoi Stati membri, nonché, tra di loro, gli Stati membri»[6].
Proprio prendendo spunto da CILFIT e sulla scia di una copiosa letteratura processualistica[7], si è altrove sostenuto[8] che una delle più evidenti manifestazioni dell’efficacia erga omnes delle sentenze interpretative della Corte di giustizia consista proprio nella trasformazione della posizione del giudice nazionale di ultima istanza, in seguito alla presenza di una precedente pronuncia della Corte di giustizia: nel passaggio, quindi, da una situazione giuridica configurabile in termini di obbligo (una situazione di ăgĕre dēbēre, di necessità) ad una qualificabile in termini di discrezionalità[9]. CILFIT produce una situazione di possibilità limitata per il giudice che, nel caso in questione, può seguire la previa giurisprudenza o problematizzare la cooperazione, chiedendo una nuova interpretazione alla Corte di giustizia qualora non ne condivida una pregressa o creda che le circostanze del suo caso siano diverse. Più in generale si potrebbe dire che, in presenza di una pronuncia della Corte sul punto, le già limitate chance ermeneutiche dei giudici nazionali (anche quelli non di ultima istanza) si riducano ancora di più.
Le conclusioni dell’avvocato generale Bobek sono state già oggetto di attenti commenti da parte della dottrina italiana[10], ma in questo saggio cercheremo di leggerle in maniera sistematica, non soltanto dando conto di alcuni recenti sviluppi processuali, ma anche tenendo in considerazione circostanze di contesto - peraltro, come segnaleremo, già all’attenzione del Bobek studioso e comparatista -.
2. La genesi della teoria dell’acte clair e dei criteri CILFIT: inquadramento comparato
Come accennato, riteniamo necessario, per la migliore comprensione delle conclusioni dell’avvocato generale Bobek nel caso C-561/19, procedere con un inquadramento comparato: del resto - potrebbe dirsi quasi a mo’ di slogan - parliamo di conclusioni di un illustre comparatista[11], che invitano la Corte di giustizia dell’Unione a una profonda riconsiderazione di una dottrina storica, quella elaborata con la sentenza CILFIT[12], che è nata come reazione a dinamiche applicative sorte col sovrapporsi del sistema di giustizia sovranazionale con quelli peculiari degli stati membri, dottrina che è declinata mediante il richiamo rivolto ai giudici nazionali ad un’interpretazione che si nutra anche dell’indagine comparatistica, e che è finalizzata a disciplinare aspetti istituzionali di quel sistema che possono comprendersi appieno solo ampliando, per così dire, la prospettiva di analisi.
Come già s’è accennato, la sentenza CILFIT della Corte di giustizia verteva sul tema dell’interpretazione di quello che oggi è l’art. 267 comma III TFUE, ed in particolare sul tema del gradiente di obbligatorietà da riconoscersi in capo alla giurisdizione nazionale di ultima istanza rispetto all’effettuazione del rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di Lussemburgo, e di possibili eccezioni a quell’obbligatorietà per come disposta expressis verbis dal Trattato. La questione fu all’epoca posta dalla Corte di Cassazione italiana, che con ordinanza richiese se l’obbligo di rinvio pregiudiziale sancisse «un obbligo di rimessione che non consenta al giudice nazionale alcuna delibazione di fondatezza della questione sollevata ovvero subordini, ed in quali limiti, tale obbligo al preventivo riscontro di un ragionevole dubbio interpretativo»[13], traendo spunto da questione interpretativa invero assai semplice, tanto da essere qualche anno dopo delibata in camera ristretta e con sentenza lapidaria[14].
La Corte di giustizia intese disporre una certa attenuazione rispetto alla rigida obbligatorietà disposta dal Trattato: eccezioni potevano e possono porsi ove la giurisdizione nazionale di ultima istanza, che a ciò è chiamata, constati la non pertinenza della questione, la sua natura già esplorata dall’interprete qualificato del diritto sovranazionale, o la sua evidenza indubbia.
Nella vulgata, la Corte di giustizia è apparsa con ciò aderire alle teorie, di marca francese, dell’acte eclairé e dell’acte clair[15] (oltre che a un’opportuna costruzione del requisito della rilevanza tipica di tutti i sistemi fondati sul rinvio ad altra giurisdizione[16]): e dunque, parve aver colto l’occasione del rinvio da parte della Corte di Cassazione per statuire rilevanti eccezioni ad un obbligo troppo rigido imposto dal Trattato. Ciò, però, è vero solo in parte: e una ricostruzione delle circostanze che portarono alla decisione - secondo un’analisi storico-comparata nel solco di linee di ricerca oggi emergenti[17] - può raccontare una storia ben più variegata.
La Corte di giustizia, invero, colse la palla al balzo del rinvio italiano, ma non tanto per porre dirette eccezioni alla lettera del Trattato, quanto per arginare certe tendenze interpretative, perniciose per il sistema di controllo sovranazionale, provenienti dalle giurisdizioni nazionali. Già dal 1964, con il noto caso Shell-Berre[18], il Conseil d’État francese aveva infatti preteso di applicare la teoria dell’acte clair - originatasi dell’ordinamento francese quale eccezione al rinvio da parte del giudice al Ministère des affaires étrangères in punto di interpretazione dei trattati internazionali[19] - nell’ambito dei rapporti con la Corte di giustizia, pretendendo autonomamente di denegare in tal senso l’esistenza di una valida «questione» interpretativa ai sensi e per gli effetti dell’(allora) art. 177 TCEE e, pertanto, di un suo obbligo di rinvio. Analoga presa di posizione pervenne, nel 1970, dal Bundessozialgericht tedesco nel noto Widow’s pension case[20] - che la stessa dottrina locale ricondusse al trapianto delle teorie francesi[21] - ed ancora nel 1974 dalle giurisdizioni britanniche[22], già solo pochi mesi dopo l’accesso del Regno unito nelle Comunità. Sorse un dibattito accademico in materia che coinvolse esponenti illustri quali l’ex avvocato generale francese Lagrange su posizioni difensive delle prassi nazionali[23] e il già allora giudice della Corte Pierre Pescatore su posizioni critiche[24]. Fu persino presentata una interrogazione scritta al Parlamento europeo, cui la Commissione rispose con note simpatetiche rispetto all’autonomia delle giurisdizioni nazionali[25] (che poi replicò nelle osservazioni dinanzi alla Corte nel procedimento CILFIT, aderendo alle prese di posizione dei governi nazionali[26]).
Va considerato insomma che CILFIT fu decisa con riferimento a tale retroterra fattuale: e ve n’è traccia, a ben vedere, anzitutto nelle conclusioni dell’avvocato generale Capotorti, che perorò la causa di un rigetto pieno della teoria dell’acte clair non solo su basi teoriche, ma anche espressamente al fine di sconfessarne le abusive strumentalizzazioni fatte in sede nazionale, e al fine di un pieno effet utile delle fondamentali disposizioni sul rinvio pregiudiziale[27]. Ma ve n’è traccia, a ben intendere, anche nella storica sentenza, che non è certo un’adesione pedissequa alle teoriche francesi, ma una loro astuta declinazione rispetto alle specificità dell’architettura giurisdizionale sovranazionale.
Se l’adesione alla teoria dell’acte eclairé, peraltro confermativa delle statuizioni classiche di Da Costa[28], nasceva dalla consapevolezza dell’esistenza di un sostrato di giurisprudenza comunitaria ormai abbastanza robusto, e si traduceva nel mandato conferito ai giudici nazionali di conoscerlo e valutarlo, i c.d. criteri CILFIT relativi all’acte clair venivano tanto puntualizzati da circoscriverne fortemente, in realtà, l’applicazione. Demandare al giudice nazionale di ultima istanza la verifica della configurabilità di un acte clair «in funzione delle caratteristiche proprie del diritto comunitario, delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta e del rischio di divergenze di giurisprudenza all’interno della Comunità» voleva dire demandare - e qui arriviamo al secondo punto sopra accennato - un’indagine comparatistica piena sulla possibilità che l’interpretazione propalata non possa essere sconfessata in altri ordinamenti nazionali, per le loro specificità, e ciò anche rispetto alle caratteristiche proprie di un ordinamento giuridico composito come quello sovranazionale, tra cui l’esistenza di una peculiare terminologia non collimante con quella (già di per sé diversa) degli ordinamenti nazionali, l’esistenza di più versioni linguistiche di ogni normativa tutte egualmente autentiche (all’epoca della sentenza sei, oggi ventiquattro), la prassi tipica di un’interpretazione del diritto sovranazionale contestuale e teleologica, il possibile variabile stadio di evoluzione del diritto sovranazionale al momento in cui va data applicazione alla disposizione che viene in gioco[29]. Un mandato d’indagine comparatistica demandato al giudice nazionale di difficile se non improbo adempimento[30] (secondo una tecnica tipica, oggi rinvenibile anche in altri casi assai discussi in materia di rispetto della rule of law[31]), che già alcuni avvertiti commentatori dell’epoca ricondussero propriamente ad un fittizio mantenimento dello status quo[32], e che altri autori, tra cui proprio Bobek prima del suo mandato alla Corte, hanno stigmatizzato come ormai tecnicamente impossibile anche alla luce dei progressivi allargamenti geografici dell’Unione[33]. Per di più, a differenza che nel passato, un mandato oggi presidiato, per i casi di sua eventuale violazione, da più strumenti, quali il rimedio risarcitorio predisposto dalla giurisprudenza Köbler[34], il controllo politico da parte della Commissione mediante procedura di infrazione inaugurato col caso C-416/17[35] (contro la Francia, per violazione dell’art. 267 TFUE perpetrata proprio dal Conseil d’État), il rimedio dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo per violazione da parte dello stato della giurisdizione non referente dell’art. 6 CEDU, inaugurato con il caso Ullens de Schooten[36], oltre che, in certi ordinamenti nazionali, dalla possibilità di accesso diretto alla giurisdizione costituzionale per sancire la propria violazione dei diritti a un equo processo o al giudice natura precostituito per legge stante la mancata adizione della giurisdizione comunitaria[37].
Ma se dunque v’è prova storica del fatto che CILFIT sia arresto giurisprudenziale posto dalla Corte di giustizia al fine non tanto di limitare ex se, ma di regolare l’afflusso dei casi in Lussemburgo da parte delle giurisdizioni nazionali apicali, tenendo ben saldo il proprio ruolo di guardiana della corretta ed uniforme applicazione del diritto comunitario nei vari stati membri (la quale sarebbe pregiudicata laddove all’interno dei vari ordinamenti nazionali si consolidassero orientamenti ermeneutici difformi), è comunque certo vero che un’altra ratio coesiste con questa, ed è quella relativa, appunto, ad una più efficace gestione delle proprie risorse istituzionali rispetto alle richieste provenienti dalle giurisdizionali nazionali: una ratio che, nella letteratura in lingua inglese, va comunemente sotto il nome di docket control.
La Corte di giustizia oggi sovraintende la corretta ed uniforme applicazione del diritto dell’Unione in ventisette ordinamenti nazionali; è certo ampiamente mutata, come istituzione, nel corso dei decenni, ma rimane una giurisdizione con discrete ma limitate risorse. Essa pubblica annualmente le statistiche relative alla propria attività, da cui s’apprende che la giurisdizione che promana dai rinvii pregiudiziali da parte dei giudici nazionali è non solo quella ampiamente preponderante[38], ma anche quella foriera di attività sempre in crescita: permangono dubbi dei commentatori sull’utilizzo corretto ed effettivo del fondamentale strumento del rinvio pregiudiziale da parte di almeno un’ampia aliquota degli operatori nazionali, anche di nuova generazione[39], il che ha sinora portato alla Corte appunto a operare con molta cautela nel disincentivo ai giudici nazionali al rinvio; ma è certo vero che i rinvii pregiudiziali destinati in Lussemburgo sono stati (a far data dalle adesioni dei paesi dell’Est) ampiamente crescenti, ed ossia 265 nel 2007, 288 nel 2008, 302 nel 2009, 385 nel 2010, 423 nel 2011, 404 nel 2013, 450 nel 2013, 428 nel 2014, 436 nel 2015, 470 nel 2016, 533 nel 2017, 568 nel 2018, 641 nel 2019, 556 nel 2020[40].
L’idea di una Corte «vittima del proprio successo»[41] è antica, e persino caricaturale rispetto al grado di autonomia istituzionale di cui essa gode nel regolare le conseguenze di quel successo[42]. Sicuramente la gestione del flusso dei casi che riceve mediante posizione di proprie dottrine interpretative è parte importante di questa autonomia: essa ha fatto parlare, genericamente includendo CILFIT, anche in passato di una sua attività di docket control paragonata un po’ improvvidamente a quello di altre giurisdizioni ben diversamente organizzate[43]; ma, s’è accennato, quella gestione coinvolge la delicata questione dei rapporti con le corti nazionali e la fiducia che v’è implicita, va adoperata con cautela - e la Corte ne è consapevole - onde evitare nuove sacche di disobbedienza quali quelle che hanno condotto alla sentenza CILFIT, e coinvolge anche la varietà di rapporti che la Corte intrattiene con giurisdizioni di ordinamenti differenti, giacché è dimostrato che ben diversi sono i rinvii pregiudiziali posti, ad esempio, da giudici di common law e civil law in punto di ampiezza delle domande, permeabilità tra questioni di fatto e di diritto, intellegibilità del rinvio[44].
Questa questione - che pure nel passato ha specificamente interessato l’avvocato generale Bobek nei panni di studioso[45] - è sinora stata affrontata (proprio per non reprimere l’afflusso dei casi e non arretrare dinanzi al ruolo nomofilattico per la corretta ed uniforme applicazione del diritto dell’Unione) mediante soluzione tendenzialmente neutrali rispetto ai rapporti con i giudici nazionali e adoperate sul versante organizzativo-istituzionale: ad es., si è creato il Tribunale di prima istanza per sollevare la Corte di giustizia dall’ampia mole del contenzioso in via d’azione, s’è organizzata la Corte in camere anche minute per la gestione dei casi di minor spessore e s’è più recentemente dotata di un vicepresidente per la gestione più snella della composizione delle camere stesse[46], si sono previste procedure più snelle con possibilità di pronunzia mediante ordinanza motivata (in condizioni speculari a quelle dei criteri CILFIT, ossa in caso di acte clair o eclairé)[47], o ancora senza previa udienza pubblica[48], o senza previe conclusioni dell’avvocato generale[49]. Misure, come ha opinato un esperto membro della Corte come Christiaan Timmermans, tese sempre e solo allo scopo di «organize and maintain continuity»[50], senza arrischiarsi a disciplinare specificamente, come pure più volte anche autorevolmente suggerito[51], il delicato ma fondamentale sistema di comunicazione del rinvio pregiudiziale, mai nemmeno subappaltato al Tribunale di prima istanza nonostante la possibilità sia prevista dai Trattati[52]: i rapporti con le giurisdizioni nazionali, per non inibirne l’impiego, sono sempre stati affidati al più a linee guida, quali le «Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale» pubblicate dalla Corte[53], comunque non cogenti, o quali appunto i criteri CILFIT, anch’essi con tutti i limiti di pregnanza di cui s’è detto.
3. Le conclusioni dell’avvocato generale Bobek nel caso Consorzio Italian Management
Le conclusioni dell’avvocato generale Bobek si innestano sulle precedenti considerazioni, che vengono affrontate esplicitamente, quasi col piglio dell’accademico - in coerenza con le precedenti sue prese di posizione in ambito dottrinale, che abbiamo richiamato - e come del resto può essere considerato tipico della funzione[54].
Va del resto rimarcato che CILFIT è sentenza capostipite ma che ha conosciuto sviluppi singolari: più avvocati generali, e di ciò Bobek dà conto (par. 174), ne hanno proposto il superamento[55]; la Corte ne ha invece sempre propugnato la piena applicazione, anche recentemente ribadendola ed anzi persino rafforzandola mediante la richiesta di «prova circostanziata» di assenza di ragionevole dubbio sulla soluzione interpretativa propugnata senza accedere al rinvio[56]. D’altra parte, la Direzione ricerca e documentazione della Corte (vedremo che non è circostanza solo aneddotica) ha pubblicato nel 2019 un articolato studio comparatistico sull’applicazione dei criteri CILFIT da parte delle giurisdizioni nazionali d’ultima istanza, ed in particolare sull’interpretazione del concetto ivi esposto di «ragionevole dubbio» interpretativo (ossia in sostanza sull’applicazione della teoria dell’acte clair), con partita analisi di ogni ordinamento nazionale[57]: lo studio - uno dei primi pubblicati dalla Corte rispetto alle analisi della Direzione ricerca e documentazione tradizionalmente confinate ad uso interno - non solo testimonia di per sé l’esistenza di un dibattito mai sopito, ma espressamente conclude rilevando l’inesistenza di un impiego specifico ed espresso dei criteri CILFIT da parte delle giurisdizioni nazionali, le quali spesso parrebbero evitare il rinvio pregiudiziale laconicamente esplicitando l’assenza di ogni «ragionevole dubbio» che sia, ma senza argomentare ulteriormente a riguardo nelle proprie decisioni.
Forse non è un caso allora che il proposto cambio di paradigma dell’avvocato generale Bobek arrivi in questa temperie, e, per vero, cogliendo l’occasione di un rinvio pregiudiziale da parte del Consiglio di Stato italiano i cui confini sembravano peraltro ben più ridotti, coinvolgendo la limitata (ed invero pacifica) questione dei rapporti tra obbligatorietà del rinvio ex art. 267 comma III TFUE, eventuali preclusioni processuali nel giudizio a quo, eventuale configurabilità di fattispecie d’abuso del diritto nella possibilità delle parti in causa di eccepire a più riprese, anche successivamente a un primo rinvio pregiudiziale disposto, nuove questioni interpretative di diritto dell’Unione passibili di rinvio da parte del giudice d’ultima istanza[58].
L’avvocato generale nelle conclusioni liquida difatti velocemente la questione specifica fatta oggetto di rinvio da parte del Consiglio di Stato: richiama la pacifica competenza del giudice nazionale a sottoporre d’ufficio uno o più quesiti alla Corte di giustizia, per l’interpretazione o la validità di disposizioni sovranazionali, senza che la sollecitazione di una parte del giudizio, che pure è prassi, comporti un obbligo di rinvio (par. 23); rammenta la discrezionalità, pure pacifica, del giudice nazionale nel delibare sulla rilevanza e nel determinare il contenuto del quesiti da porre con l’ordinanza di rinvio, come anche la discrezionalità nel determinare la fase del processo in cui promuoverlo (con preferenza per una fase in cui s’è instaurato il contraddittorio tra le parti, anche al fine di agevolare l’intervento della Corte e promuoverne l’utilità, parr. 24-25); infine, evidenzia l’obbligo per il giudice remittente di disapplicare eventuali regole nazionali che limitino od ostacolino l’adempimento dell’obbligo ex art. 267 comma III TFUE, al fine di garantire la piena efficacia alle disposizioni sovranazionali (parr. 26-27). Applicando questi pacifici postulati, la soluzione al quesito effettivamente posto per il caso Consorzio Italian Management è presto offerta: un rinvio pregiudiziale può essere sottoposto alla Corte in qualsiasi momento e dunque in qualunque stato e grado del giudizio a quo, «indipendentemente da una precedente sentenza pregiudiziale della Corte pronunciata nell’ambito dello stesso procedimento, sempre che il giudice del rinvio ritenga che la risposta della Corte sia necessaria per consentirgli di pronunciare la propria sentenza»; ciò alla luce di una determinazione del giudice nazionale alla luce di «ogni ragionevole dubbio che esso possa ancora nutrire riguardo alla corretta applicazione del diritto dell’Unione nella causa di cui è investito» (par. 31).
Stabilito siffatto approdo mediante la sillogistica applicazione di noti precedenti arresti della Corte, le conclusioni dell’avvocato generale prendono poi ad analizzare un «livello più profondo» della questione, ed ossia se, sul piano normativo, «dovrebbe sussistere ancora un obbligo di rinvio pregiudiziale in casi come quello di specie» (par. 32): ciò anche alla luce delle sollecitazioni, rese espresse, dei governi nazionali intervenienti, in specie quello italiano e quello francese, che hanno chiamato con le loro osservazioni ad una rimeditazione dei criteri CILFIT (a differenza di Commissione e governo tedesco) alla luce dei presidi oggi esistenti in caso di violazione dell’art. 267 comma III TFUE, che già sopra abbiamo richiamato, ed anzi proprio alla luce della necessità di meglio definire quando si consumi una vera e propria violazione di quei disposti e quando ne consegua la possibilità di accedere a quei presidi.
È qui che il profilo dello studioso già critico sulla materia e dell’avvocato generale paiono fondersi: e Bobek invita, in sostanza, la Corte a gridare che il re è (ed è sempre stato) nudo, che i criteri CILFIT altro non incarnano che la fictio posta a presidio del suo ruolo che già sopra s’è descritta (in specie par. 99), e a meditare se quei criteri abbiano oggigiorno ancora senso, anche rispetto alle esigenze sempre più pressanti di controllo dell’afflusso dei casi (espressamente cennate, par. 122) e alla necessità di presidiare ragionevolmente un ruolo nomofilattico rispetto a giurisdizioni molteplici e con sensibilità ben disparate, ad es. in punto di differenziazione tra giurisdizioni di common law e civil law quanto al tema di precedente (par. 163, anche qui espressamente esponendo quando dottrinalmente s’era già arguito in proposito, v. supra).
La rimeditazione si svolge sui binari di una possibile “pubblicizzazione” del ruolo della Corte di giustizia nel sistema di controllo cooperativo svolto mediante la procedura di rinvio pregiudiziale interpretativo – a latere il sistema necessariamente centralizzato, e che tale dovrà rimanere, del rinvio pregiudiziale di validità[59] -. Una “pubblicizzazione” da leggersi come riparametrazione dei fini stessi dell’azione di supervisione della Corte attraverso la procedura interpretativa ex art. 267 TFUE, e da attuarsi mediante un ripensamento dei criteri di obbligatorietà del rinvio delle giurisdizioni nazionali d’ultima istanza nel solco di tre linee distintive: alcune già sostanzialmente tracciate dalla giurisprudenza pregressa, altre tutte da costruire. La prima: la distinzione tra «ragionevoli dubbi» interpretativi oggettivi o puramente soggettivi, e dunque tra necessità di intervento rispetto a rischi di strutturale radicarsi di giurisprudenze contrarie al diritto UE o solo rispetto a difformità del caso di specie (par. 133). La seconda, consonante: la distinzione tra supervisione sulla corretta e uniforme interpretazione del diritto UE e supervisione sull’applicazione minuta, case-by-case (par. 145). La terza: la distinzione tra possibili divergenze interpretative all’interno di un ordinamento nazionale membro e potenziali divergenze transnazionali, ossia che coinvolgano più globalmente l’intero ordinamento dell’Unione (par. 147).
Le conclusioni di Bobek - attraverso l’esplicitazione della natura sostanzialmente fittizia dei criteri CILFIT e delle effettive esigenze di docket control della Corte (che si riconoscono non essere certo garantite dalla capostipite sentenza del 1982) - propugnano una focalizzazione sulla finalità pubblicistica del rinvio pregiudiziale nel solco delle tre linee suddette. Mediante una riscoperta e valorizzazione della giurisprudenza Hoffmann-La Roche[60], la Corte dovrebbe indirizzare il proprio intervento e le proprie limitate risorse anzitutto nei confronti di ragionevoli dubbi interpretativi oggettivi - lasciando per il resto ai giudici nazionali d’ultima istanza la responsabilità del corretto adempimento al loro mandato europeo[61], e la distinzione tra dubbi oggettivi o meramente soggettivi, questi ultimi da potersi sanare mediante risorse interne[62]. Il tutto mentre ai criteri CILFIT, per loro natura, sarebbe connaturata «una buona dose di soggettivismo non accertabile e quini non riesaminabile» (par. 104). Sempre secondo l’impianto originario di Hoffmann-La Roche, pure la Corte dovrebbe concentrarsi, specie ove provengano da rinvii di giudici d’ultima istanza, su interventi diretti a sanare la corretta e uniforme interpretazione del diritto UE, dunque determinandone portato e scopo, e non tanto la corretta applicazione a fatti specifici. Ciò riscoprendo una distinzione tra questioni di fatto e di diritto immanente al sistema di rinvio pregiudiziale, ma spesso obliterata proprio dai giudici nazionali, con linee di demarcazione anche rispetto alle loro culture giuridiche d’appartenenza[63]; e dunque, anche in quest’ottica, lasciando ai giudici nazionali d’ultima istanza la responsabilità di tale actio finium regundorum. Da ultimo, e conseguentemente, concentrando le proprie risorse alla sanatoria di divergenze interpretative che interessino potenzialmente l’ordinamento dell’Unione in quanto tale, e non mere sacche interne di divergenza complementari, nel medesimo stato membro, ad indirizzi corretti, giacché quest’ultime comunque sanabili altrimenti rispetto ad un intervento autoritativo dal Lussemburgo.
Il tutto conducendo al suggerimento di una ricostruzione, in positivo anziché in negativo, dei criteri d’obbligatorietà del rinvio ex art. 267 comma III TFUE, passando dal vaglio dell’inesistenza di un «ragionevole dubbio soggettivo quanto alla corretta applicazione del diritto dell’Unione riguardo a una specifica controversia» al vaglio dell’esistenza di una «divergenza oggettiva individuata nella giurisprudenza a livello nazionale, che pone quindi in pericolo l’interpretazione uniforme del diritto dell’Unione all’interno dell’Unione europea» (par. 133); e richiamando altresì i giudici nazionali d’ultimo grado - rispetto alle grame risultanze dello studio della Direzione documentazione e ricerca della Corte già pubblicato e cui s’è cennato - all’obbligo di adeguata motivazione in materia, ricondotto al rispetto dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione (par. 171).
Un empito di ulteriore realismo chiude del resto le conclusioni, esplicitando la loro ratio di riconduzione dell’istituto processuale agli unici obbiettivi di sistema davvero perseguibili: ritenendo «che l’uniformità ex sentenza CILFIT quanto alla corretta applicazione del diritto dell’Unione in ciascun caso di specie sia un’utopia», ritenendo che «tenuto conto del carattere decentralizzato e diffuso del sistema giudiziario dell’Unione, il meglio che si possa mai raggiungere è una ragionevole uniformità nell’interpretazione del diritto dell’Unione, in quanto questo tipo di uniformità è già un compito piuttosto arduo», e arguendo che «quanto all’uniformità nell’applicazione e nei risultati, la risposta» ad ogni interrogativo scettico sia «piuttosto semplice: “nessuno può perdere ciò che non ha mai avuto”» (par. 180).
È forse proprio alla luce di tale chiarezza che può sciogliersi il dubbio - presente nei primi commenti della dottrina italiana - tra chi vede nelle proposte di Bobek una «proposta ribelle» capace di condurre ad una «revisione completa delle condizioni di esenzione dall’obbligo di rinvio, riformulate in modo da renderle - a detta dell’avvocato generale - più applicabili da parte del giudice nazionale e concettualmente più adatte a quello che sembra essere inteso come il “nuovo ruolo” del rinvio pregiudiziale nell’ordinamento dell’Unione»[64], e chi vi scorge solo una «finta rivoluzione» frutto di «un complesso esercizio dialettico, la cui portata non risulta però chiara»[65].
A chi scrive, la proposta pare potenzialmente dirompente - e per ciò, di non scontata accettazione da parte della Corte - giacché in più versi coinvolgente un vero e proprio cambio di paradigma, e una rimeditazione del rapporto tra centralizzazione e decentralizzazione del sistema giudiziario europeo che è immanente alla questione[66]. Essa è esplicitamente tesa a conformare non solo il nuovo ruolo dei giudici nazionali d’ultima istanza nell’architettura giudiziale (proto)federale europea[67], ma anche, in prospettiva, il ruolo della stessa Corte di giustizia in ogni rinvio pregiudiziale interpretativo ex art. 267 TFUE, e dunque, ancora, il rapporto di questa con tutti i giudici nazionali, indirettamente richiamati a più fattiva cooperazione. In tal senso, la proposta travalica non solo, come s’è detto, i limitati scopi dell’ordinanza di rinvio che l’ha originata, ma potenzialmente anche, a ben vedere, il limitato portato del comma III dell’art. 267 TFUE e della sua obbligatorietà: rivolgendosi certo direttamente ai giudici d’ultima istanza, quali fondamentali e sempre più frequenti contraddittori della Corte[68], affinché si facciano più attenti e responsabili guardiani, nell’adempimento del loro mandato europeo, della corretta e uniforme interpretazione ed applicazione del diritto UE (nella propria giurisdizione, ai casi di specie); ma rivolgendosi anche, seppur indirettamente, ad ogni giudice nazionale quale giudice europeo, giacché è tradizionalmente noto che statisticamente siano i giudici di prime cure quelli più propensi all’impiego del rinvio pregiudiziale[69].
Il vero interrogativo che si pone dinanzi a simili coraggiose proposte, cui anche la dottrina scettica accenna[70], è invero quello della concreta applicabilità di simili riconfigurati criteri applicativi, non tanto in punto di loro congenita astrattezza[71], quanto di sufficiente maturità del sistema giudiziario europeo, e dunque di solidità dell’apparato dei giudici nazionali quali giudici europei, per l’incamminarsi rispetto a tale riconfigurazione. Si tratta di un tema su cui, riconosciute le pressioni istituzionali quantitative sulla Corte che ne hanno fatto da una «bit of a family» ad una «bit of a factory»[72], anche illustri membri attuali del Kirchberg hanno criticamente riflettuto, ponendo in dubbio, ancora dopo decenni, la capacità dei giudici nazionali di trasformarsi in attori con più alto grado di autonomia rispetto alla supervisione sovranazionale,[73] e su cui lo stesso Bobek si interroga (par. 127).
Un timore sotteso, questo ultimo, che corre in parallelo e fa da contraltare a quello pressante relativo al docket control, nella cui ottica sarà di grande interesse conoscere le riflessioni della Corte, e che ci conduce, come ripromesso, a qualche ultima riflessione su certe linee di tendenza giurisprudenziali provenienti dal Lussemburgo rispetto alle quali può scorgersi una certa complessiva coerenza.
4. Il contesto in cui si inseriscono le conclusioni dell’avvocato generale Bobek
Le conclusioni del caso Consorzio Italian Management vanno, in effetti, opportunamente contestualizzate nell’ambito di linee di tendenza più ampie che, negli ultimi anni, hanno portato al ripensamento di altre giurisprudenze consolidate che hanno governato il rapporto fra giudici nazionali e Corte di giustizia, in un’opera continua di definizione e ridefinizione delle “regole di ingaggio” su cui si fonda la cooperazione giudiziale ex art. 267 TFUE.
Ci riferiamo in particolare a due veri e propri pilastri, con CILFIT, di quello che abbiamo denominato il diritto processuale “complesso”: Rheinmühlen I[74] e Simmenthal[75], due sentenze capostipite che hanno finito, però, per produrre sempre maggiori resistenze a livello interno, anche alla luce degli ultimi sviluppi del diritto costituzionale europeo.
Volendo partire da Simmenthal, è ovvio il richiamo alle recenti evoluzioni nel rapporto fra Corti costituzionali nazionali e Corte di giustizia dovute alla crescente importanza della Carta dei diritti fondamentali dell’UE nella giurisprudenza nazionale.
Oggi le stesse Corti costituzionali statali riconoscono la sostanza costituzionale del diritto europeo, in particolare della Carta dei diritti. Nel farlo, per altro, non hanno mai rinunciato a una sana dialettica con la Corte di giustizia, a dimostrazione di come il processo di integrazione possa essere sviluppato nel rispetto delle sovranità nazionali:
«Fermi restando i principi del primato e dell’effetto diretto del diritto dell’Unione europea come sin qui consolidatisi nella giurisprudenza europea e costituzionale, occorre prendere atto che la citata Carta dei diritti costituisce parte del diritto dell’Unione dotata di caratteri peculiari in ragione del suo contenuto di impronta tipicamente costituzionale. I principi e i diritti enunciati nella Carta intersecano in larga misura i principi e i diritti garantiti dalla Costituzione italiana (e dalle altre Costituzioni nazionali degli Stati membri)[76]».
Il passaggio della Corte costituzionale italiana citato proviene da una sentenza, la n. 269 del 2017, che ha fatto tanto discutere la dottrina nazionale[77] e che era caratterizzata da passaggi critici, poi (in parte, almeno) assorbiti dalla giurisprudenza seguente[78]. Il passaggio della 269 citato sopra contiene affermazioni importanti, che confermano la centralità del diritto europeo nella garanzia dei diritti; come dimostrato, del resto, anche dal ragionamento delle corti britanniche nella saga Miller[79] che hanno giustificato il necessario intervento del Parlamento inglese proprio sulla base del fatto che uscire dal Regno Unito implicava la sottrazione di diritti attribuiti da fonti europee.
In questo senso, la stessa Carta dei diritti fondamentali ha scontato il prezzo del proprio successo, scatenando persino episodi di concorrenza fra corti a proposito di chi debba avere l’ultima parola sull’interpretazione di quel testo, così simile e sovrapponibile alle disposizioni costituzionali nazionali.
In altre parole, la crescente importanza della Carta dei diritti fondamentali nella giurisprudenza nazionale ha portato alcune giurisdizioni, tra cui in primis le Corti costituzionali austriaca e italiana, a rivendicare maggiore centralità interpretativa quando a essere in gioco sia il possibile conflitto fra una disposizione nazionale e un bene costituzionale tutelato anche da una disposizione della Carta. Tutto ciò ha un evidente impatto sul mandato Simmenthal, già messo in discussione dal caso Melki[80] relativo al presunto contrasto del diritto UE con una legge organica francese (n. 58-1067, relativa al Conseil Constitutionnel francese, come modificata dalla legge organica n. 2009-1523)[81]. Secondo il modello disegnato dalla riforma sulla question prioritaire de constitutionnalité, un giudice comune francese che dubitasse dalla costituzionalità di una disposizione nazionale doveva sottoporre la questione alla Cour de cassation (se giudice ordinario) o al Conseil d’État (se giudice amministrativo), affinché queste valutassero la necessità di sollevare la questione al Conseil Constitutionnel, nell’ottica di un c.d. modello di controllo di costituzionalità incidentale “filtrato”. Il “punto” della riforma contestato, per quel che qui interessa, riguardava un aspetto puntuale della question prioritaire, quello per cui «in ogni caso il Conseil d’État o la Cour de cassation, quando sono dedotti motivi che contestano la conformità di una disposizione legislativa, da un lato, con i diritti e le libertà garantiti dalla Costituzione e, dall’altro, con gli obblighi internazionali della Francia, deve pronunciarsi in via prioritaria sul rinvio della questione di legittimità costituzionale al Conseil constitutionnel» (art. 23-5, L.O.N. 2009-1523). Tale meccanismo finiva, secondo la Corte di Cassazione francese - giudice a quo nel caso Melki - per minacciare il “mandato europeo” del giudice nazionale, e sulla base di queste considerazioni fu sollevata questione pregiudiziale alla Corte di giustizia. Poco prima dell’intervento della Corte di giustizia il Conseil Constitutionnel fornì un’interpretazione “adeguatrice” (in realtà sostanzialmente “abrogatrice”, come rilevato in dottrina[82]) del testo della riforma, che lo rese compatibile con il diritto dell’UE. Tale interpretazione si fondava sul potere cautelare di sospendere ogni effetto pregiudizievole della legislazione sospetta di contrarietà al diritto dell’Unione nell’attesa della delibazione dell’organo deputato del controllo di costituzionalità[83].
Prendendo atto di questa decisione, la Corte di giustizia si pronunciò successivamente, riaffermando nominalmente la validità della linea interpretativa Simmenthal, Rheinmühlen I e Foto Frost, ma pure concludendo, nella sostanza, per la non incompatibilità della questione prioritaria di costituzionalità (come interpretata dal Conseil Constitutionnel) con il diritto UE[84].
Si trattava di una pronuncia fondata su una sorta di appello lanciato ai giudici comuni per un maggiore e più incisivo controllo sulla corretta interpretazione ed applicazione del diritto sovranazionale, nella prospettiva di una sostanziale attenuazione delle rigidità di Simmenthal.
Un altro colpo a Simmenthal arrivò dalla giurisprudenza costituzionale austriaca che avrebbe dato origine al caso A c. B[85].
Questo caso ci ricorda che anche Corti costituzionali sicuramente aperte e cooperative, come quella austriaca - che da sempre ha dimostrato di concepire il rinvio pregiudiziale come strumento centrale del proprio operato - hanno recentemente assunto posizioni simili a quelle della nostra Corte costituzionale[86]. Non a caso la Corte costituzionale italiana, sempre nella sentenza n. 269/2017, scriveva a questo proposito di «trasformazioni che hanno riguardato il diritto dell’Unione europea e il sistema dei rapporti con gli ordinamenti nazionali». Si tratta di un cambiamento che, come si vede ancora più chiaramente nella sentenza n. 63/2019, ha anche dei risvolti positivi, che si concretizzano, per esempio, nel riconoscimento delle garanzie offerte da una pronuncia con efficacia erga omnes al diritto fondamentale equivalente tutelato.
Anche se il nucleo di Simmenthal è stato sempre confermato dalla Corte di giustizia, proprio in A c. B. si chiariva un punto importante, vero compromesso fra le esigenze di centralità delle Corti costituzionali e quelle di uniformità interpretativa e di primato del diritto UE:
«Per contro, il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 267 TFUE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una siffatta normativa nazionale se i suddetti giudici ordinari restano liberi di […] adottare qualsiasi misura necessaria per garantire la tutela giurisdizionale provvisoria dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione, e disapplicare, al termine di un siffatto procedimento incidentale, la disposizione legislativa nazionale in questione ove la ritengano contraria al diritto dell’Unione»[87].
Da questo passaggio, confermativo di Melki, si evince che l’unico modo di ammettere la non disapplicazione immediata prima del termine del procedimento incidentale è garantire al giudice l’esperibilità di una «misura necessaria per garantire la tutela giurisdizionale provvisoria dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione». Questo è quello che sembra suggerire anche la pratica francese all’indomani di Melki. Solo in questo modo il mandato Simmenthal può essere salvato. Simmenthal, del resto, non riguarda solo l’istituto della disapplicazione della norma interna contraria a quelle del diritto UE, ma indubbiamente verte sul più organico obbligo, per il giudice nazionale, di «garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all'occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale»[88].
Per cogliere il nesso esistente fra Simmenthal e Rheinmühlen I va richiamato un contesto forse ancora più complesso. In Rheinmühlen I la Corte di giustizia aveva stabilito che
«I giudici nazionali godono della più ampia facoltà di rinviare alla Corte di giustizia - sia d’ufficio che su domanda di parte - questioni sorte nell’ambito di una controversia dinanzi ad essi pendente, e vertenti sull’interpretazione o sulla validità di norme di diritto comunitario. Essi non possono esserne privati da norme di diritto interno che li vincolino al rispetto di valutazioni giuridiche espresse da un giudice di grado superiore»[89].
Per certi versi, si potrebbe dire che Simmenthal trovi un suo risvolto processuale in Rheinmühlen I che - nelle parole dell’avvocato generale Cruz Villalón nelle conclusioni al caso Elchinov - aveva «introdotto una sorta di controllo decentralizzato della “comunitarietà” non già delle norme, bensì delle decisioni giurisdizionali»[90].
Con Rheinmühlen I la Corte poneva le basi per la creazione di un rapporto davvero diretto con i giudici nazionali, in particolare con quelli di prima istanza che hanno avuto, si è già detto sopra, più delle corti apicali un ruolo centrale nello sviluppo della giurisprudenza della Corte di Lussemburgo.
In quest’ottica il diritto interno non può creare ostacoli che si frappongano a tale rapporto diretto. Su questa base la Corte di giustizia ha sviluppato altre sentenze storiche come Factortame, in cui si sanciva che «la piena efficacia del diritto comunitario sarebbe ridotta se una norma di diritto nazionale potesse impedire al giudice chiamato a dirimere una controversia disciplinata dal diritto comunitario di concedere provvedimenti provvisori allo scopo di garantire la piena efficacia della pronuncia giurisdizionale sull’esistenza dei diritti invocati in forza del diritto comunitario»[91].
Si noti che la Corte così finiva per riconoscere il ruolo dei poteri cautelari del giudice nazionale - la cui centralità abbiamo appena discusso analizzando Melki e A c. B - quale giudice di diritto dell’UE.
Rheinmühlen I è stata quindi la premessa che ha portato allo sviluppo di una giurisprudenza sempre più invasiva nei confronti delle dinamiche processualistiche nazionali – la cui autonomia può essere definita ormai un vero e proprio «paradiso perduto»[92] - fino ad arrivare a toccare territori che si supponevano invalicabili: quelli del giudicato nazionale.
Su questo sfondo, già nelle conclusioni al caso Elchinov[93] del 2010, l’avvocato generale Pedro Cruz Villalón aveva insistito sulla necessità di rivisitare Rheinmühlen I alla luce della querelle sull’intaccabilità del giudicato nazionale dopo sentenze come Köbler[94], Kühne & Heitz[95], Kempter[96] e Kapferer[97].
Il nocciolo del problema (rinviando ad altra sede per l’analisi estesa della questione[98]) era ed è il seguente: all’indomani di Köbler (e poi di Traghetti del Mediterraneo[99]), la dottrina si era posta il problema della possibile tangibilità del giudicato nazionale in seguito all’avvenuta condanna statale per violazione del diritto comunitario “perpetrata” attraverso un organo giudiziale nazionale.
La Corte di giustizia sul punto si è trovata dinanzi ad un dilemma: la lotta per l’uniformità del diritto europeo, così centrale anche nei criteri CILFIT, può spingersi fino al punto da minacciare il principio del giudicato nel diritto interno[100]?