
GIUSTIZIA INSIEME
ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma
ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma
I “tempi” dell’annullamento d’ufficio (nota a C.g.a.r.s., sez. I, 26 maggio 2020, n. 325)
di Giordana Strazza
Sommario: 1. Premessa - 2. L’annullamento (o gli annullamenti) “a più tempi” - 3. Conclusioni
1. Premessa
“Whether it’s the best of times or the worst of times, it’s the only time we’ve got”[1].
Allo stato attuale, la pubblica Amministrazione che intenda procedere all’annullamento d’ufficio[2] sembrerebbe dover muovere da questa consapevolezza.
Il potere posto a fondamento degli atti di ritiro non è immune dal fluire del tempo[3] che – tramite il veicolo della legge – lo regola, lo condiziona e lo limita.
L’inconfutabilità dell’assunto deve fare i conti, però, con il distinguo, tutt’altro che agevole, tra le “manifestazioni” diverse e le variabili di (uno stesso) annullamento e le eventuali ipotesi che celano (o sembrerebbero celare), invece, annullamenti in tutto o in parte differenti.
Del resto, la stessa disciplina generale dell’annullamento d’ufficio, contenuta nell’art. 21-nonies, l. 7 agosto 1990, n. 241, si biforca ormai in due modelli: quello sottoposto “solo” al limite temporale indeterminato ed elastico (comunque ancorato al canone della ragionevolezza), e quello ulteriormente circoscritto da un riferimento temporale massimo predeterminato in modo puntuale e rigoroso (che viene meno in caso di falso accertato con sentenza penale passata in giudicato[4]).
L’art. 6, l. 7 agosto 2015, n. 124[5] (c.d. legge Madia) ha previsto, infatti, un “nuovo paradigma”[6] nei rapporti tra privato e p.A. caratterizzato da un termine rigido, pari a diciotto mesi, accanto a quello “ragionevole”, per l’esercizio dell’annullamento d’ufficio sui “provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici”, nonché in caso di silenzio-assenso e di intervento tardivo sulla segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.)[7].
Senza dubbio l’introduzione del termine massimo di diciotto mesi per l’esercizio dell’annullamento d’ufficio (o dei poteri conformativi, inibitori e repressivi “posticipati” sulla s.c.i.a.) rafforza il vincolo sul “quando”, a salvaguardia della stabilità della situazione di vantaggio conseguita.
Le certezze si sgretolano, però, già sull’esatta portata dell’espressione “provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici”[8] (si pensi, ad esempio, alla querelle sulla possibilità di ricomprendervi anche l’aggiudicazione[9]) e si riducono ulteriormente a causa della lettura riduttiva dell’articolo 21-nonies, co. 2-bis, l. n. 241 del 1990, ormai invalsa nella giurisprudenza prevalente[10], che richiede il giudicato penale, per superare il limite dei diciotto mesi, solo in caso di dichiarazione falsa o mendace e non anche in caso di falsa rappresentazione.
Senza contare gli annullamenti “travestiti”, ossia le reazioni – di fatto – di autotutela caducatoria ex tunc al conseguimento ab origine illegittimo del vantaggio/del beneficio che, seppur non formalmente qualificate come “annullamento”, ne mutuano la sostanza (ma non i limiti).
A tale riguardo, il monito dei pareri del Consiglio di Stato[11] sull’uso improprio delle “etichette” “revoca”, “risoluzione” e “decadenza” (e sul conseguente divieto di aggirare la disciplina del 21-nonies) è stato “tranchant”, ma non sembra sia stato recepito con la fermezza adeguata[12].
Il tema si complica ulteriormente se si considerano i rapporti tra il citato art. 21-nonies e le altre fattispecie di annullamento (testualmente qualificate come tali) previste da discipline di settore o, più in generale, disseminate nell’ordinamento giuridico.
2. L’annullamento (o gli annullamenti) “a più tempi”
Ai fini che qui rilevano, valga l’esempio dell’annullamento regionale di cui all’art. 39, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (t.u. edilizia)[13].
Si tratta di un potere di annullamento straordinario, avente ad oggetto le deliberazioni e i provvedimenti comunali non conformi alle norme urbanistiche ed edilizie, sottoposto a un duplice termine perentorio, in quanto esercitabile entro dieci anni dalla loro adozione e comunque non oltre diciotto mesi dall’accertamento del vizio[14].
Premesso che il più risalente antecedente di tale disposizione, ossia l’articolo 27, l. 17 agosto 1942, n. 1150[15] (c.d. legge urbanistica) ammetteva tale potere caducatorio “in qualunque tempo” (cosicchè la successiva perimetrazione decennale ha realizzato un annullamento “a tempo” ante litteram), permangono ancora dubbi sulla sua qualificazione giuridica.
Di conseguenza, i presupposti e le condizioni che ne regolano l’esercizio sono, tuttora, incerti.
In alcuni casi, qualificato come strumento di controllo; in altri come meccanismo sostitutivo[16], secondo la tesi prevalente si tratterebbe di un potere da ricondurre all’art. 118 Cost., ai sensi del quale le Regioni hanno competenza amministrativa nelle materie a legislazione concorrente[17].
Ai fini che qui rilevano, occorre domandarsi se il potere caducatorio di cui al citato art. 39, che consente alla Regione di partecipare alla complessiva azione di “governo del territorio”[18] (art. 117, co. 3, Cost.) sia comunque assimilabile o riconducibile, in un rapporto di species a genus, a quello di cui all’art. 21-nonies, l. n. 241 del 1990.
La giurisprudenza più recente[19] sembrava orientata a negare l’ascrivibilità dell’art. 39 allo schema dell’autoannullamento, che, per espressa previsione di diritto positivo, è sottoposto – tra l’altro – al principio del bilanciamento dei contrapposti interessi[20], ma – da ultimo – il C.g.a. della Regione siciliana, con la sentenza del 26 maggio 2020, n. 325, resa dalla prima sezione, ne ha sostenuto la riconducibilità alla cornice del 21-nonies[21].
Secondo il Collegio, infatti, si tratta sempre di un potere di autoannullamento, seppur speciale, perché l’atto non è “dovuto” in caso di riscontrata illegittimità, ma resta rimesso a una valutazione discrezionale, come si desume dall’espressione “possono essere annullati”, e non è “coercibile” da parte del privato o da altro organo dell’Amministrazione.
L’art. 39 si riferisce, dunque, a un potere di amministrazione attiva, “di secondo grado, coerente con l’art. 21-novies l. n. 241/1990”, per cui l’annullamento dell’atto amministrativo illegittimo può essere esercitato non solo dall’Amministrazione che lo ha adottato, ma anche “da altro organo previsto dalla legge”[22].
Ad ogni modo, per il C.g.a., anche a voler classificare tale potere nel novero della “vigilanza-controllo”, rientrerebbe comunque all’ambito di applicazione dell’art. 21-nonies, l. n. 241 del 1990, che concerne “tutti i casi in cui la legge attribuisca ad un organo di amministrazione attiva il potere di annullamento di atti amministrativi, a prescindere dalla qualificazione della natura del potere”.
Di conseguenza, il Collegio ha prospettato una tendenziale reductio ad unum degli annullamenti di atti amministrativi (purchè adottati da organi di amministrazione attiva).
Con riguardo ai termini per l’esercizio del potere, tuttavia, la sentenza ha evidenziato che l’art. 39 si pone in rapporto di specialità e, pertanto, di prevalenza, rispetto all’art. 21-nonies, l. n. 241 del 1990[23], ad esso sopravvenuto.
La norma sull’annullamento regionale non risulta, infatti, espressamente abrogata né sussistono i presupposti esegetici per ravvisare una abrogazione tacita, in conformità del brocardo "lex posterior generalis non derogat priori speciali".
Del resto, la mancata abrogazione sembra confermata dal fatto che l’art. 6, co. 2, della c.d. legge Madia ha abrogato testualmente l’altra disposizione parimenti espressione di un annullamento d'ufficio “a tempo”, ossia l’art. 1, co. 136, l. 30 dicembre 2004 (c.d. legge finanziaria 2005)[24]. Ciò senza contare che in occasione del c.d. decreto s.c.i.a. 2 è stato compiuto un drafting del co. 5-bis[25] dell’art. 39, t.u. edilizia[26].
3. Conclusioni
Tale pronuncia sembra confermare, dunque, i dubbi sul difetto di coordinamento tra la nuova versione di cui all’art. 21-nonies e l’art. 39 già sollevati dalla dottrina.[27]
Senza considerare poi la sussistenza di leggi regionali che non solo hanno attribuito tale potere di annullamento ad altri enti sub-regionali (come la provincia[28]), ma ne hanno anche modificato i termini di esercizio (ad esempio, nel Veneto il termine è ridotto a due anni).[29]
L’individuazione del tempo dell’annullamento[30] risulta, così, non sempre agevole e immediata e sembra più opportuno constatare che si è al cospetto di ipotesi di annullamento (o di annullamenti) degli atti amministrativi “a più tempi”[31], con ripercussioni sulle prerogative delle p.A. e (soprattutto) sulla stabilità delle situazioni giuridiche dei privati.
I tempi dell’annullamento sembrano moltiplicarsi se si considera, peraltro, quanto stabilito dal nuovo art. 264, d.l. 19 maggio 2020, n. 34[32] (c.d. decreto Rilancio).
Al comma 1, la disposizione introduce, infatti, un “annullamento a tempo”, sia pure in via temporanea.[33]
L’art. 264, co. 1, lett. b), riduce, infatti, il termine massimo per l’annullamento d’ufficio a tre mesi dall’adozione/formazione del provvedimento o del silenzio-assenso; il co. 1, lett c), estende lo stesso limite temporale all’intervento “tardivo” sulla s.c.i.a.[34]
Si segnalano, però, alcune peculiarità rispetto al contenuto e alla formulazione dell’art. 21-nonies, l. n. 241 del 1990.
L’art. 264 ribadisce, infatti, la necessità della sussistenza delle ragioni di interesse pubblico ai fini dell’annullamento, ma manca un richiamo “agli interessi dei destinatari e dei controinteressati” (che, a scanso di equivoci, potrebbe essere aggiunto in sede di conversione).
Nella disciplina dell’emergenza, inoltre, l’“annullamento a tempo” non è testualmente riferito ai provvedimenti “di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici”, ma a quelli illegittimi ex art. 21-octies, l. n. 241 del 1990 (senza aggiungere l’esclusione espressa, probabilmente data per implicita, ai “casi di cui al medesimo articolo 21 octies, comma 2”, prevista dall’art. 21-nonies, co. 1) “adottati in relazione all’emergenza Covid-19”[35].
Da una lettura sistematica dell’art. 264, si ricava che, invece, il nuovo (e altrettanto temporaneo) limite al potere di revoca di cui all’art. 21-quinquies, l. n. 241 del 1990, è riferito testualmente ai procedimenti di cui all’art. 264, co. 1, lett. a)[36].
Il quadro si complica ulteriormente se si considera anche la nuova “revoca” dei “benefici già erogati”, prevista dall’art. 264, co. 2, del c.d. decreto Rilancio, in caso di dichiarazione mendace, che del potere di cui al citato art. 21-quinquies ha ben poco[37].
Si tratta, infatti, di un potere di rimozione del beneficio con effetto ex tunc, introdotto “a regime”[38] e senza limiti di tempo, in caso di dichiarazione mendace, che, insieme al divieto biennale di accesso a “contributi, finanziamenti e agevolazioni” e all’incremento della correlata sanzione “ordinariamente prevista dal codice penale”[39], si aggiunge alla “decadenza” dal beneficio (già) stabilita dall’art. 75, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
A ulteriore conferma, però, che l’aforisma indicato in premessa dovrebbe assumere, più propriamente, le sembianze di un’interrogativa: “Whether it’s the best of times or the worst of times, is it the only time we’ve got?”.
[1] Aforisma di A. Buchwald, riportato da R. Scott, I don’t have time, Filament Publishing, 2010, 26.
[2] Fra i tanti, si rinvia a F. Benvenuti, voce Autotutela (dir. amm.), in Enc. dir., vol. V, Milano, 1959, 537 ss.; E. Cannada Bartoli, voce Annullabilità e annullamento, in Enc. dir., vol. II, Milano, 1958, 484 ss. G. Codacci, Pisanelli, L’annullamento degli atti amministrativi, Milano, 1939. Per i riferimenti più recenti sull’autotutela, si v. infra, in particolare note 3, 5 e 6.
[3] A tal proposito, il Cons. Stato, Ad. plen., 17 ottobre 2017, n. 8, con commento di M.A. Sandulli, G. Strazza, L’autotutela tra vecchie e nuove incertezze: l’Adunanza Plenaria rilegge il testo originario dell’art. 21-nonies, l. n. 241 del 1990, in S. Toschei (a cura di), L’attività nomofilattica del Consiglio di Stato, Roma, 2019; E. Zampetti, Osservazioni a margine della Plenaria n. 8 del 2017 in materia di motivazione nell’annullamento d’ufficio, in Riv. giur. ed., 2, 2018, 404 ss.; C. Pagliaroli, La “storia infinita” dell'annullamento d'ufficio dei titoli edilizi: nessun revirement da parte dell'Adunanza plenaria, ivi, 1, 2018, 92 ss.; N. Posteraro, Annullamento d’ufficio e motivazione in re ipsa: osservazioni a primissima lettura dell’Adunanza Plenaria n. 8 del 2017, ivi, 5, 2017, 1103 ss.; G. Manfredi, La Plenaria sull’annullamento d’ufficio del permesso di costruire: fine dell’interesse pubblico in re ipsa?, in Urb. e app., 1, 2018, 52 ss., ha negato la "teoria dell'inconsumabilità del potere", altrimenti nota come "perennità della potestà amministrativa di annullare in via di autotutela gli atti invalidi", con la conseguenza che il decorso del tempo “onera l'amministrazione del compito di valutare motivatamente se l'annullamento risponda ancora a un effettivo e prevalente interesse pubblico di carattere concreto e attuale”. Per un approfondimento, si v., tra gli altri, M. Trimarchi, L’inesauribilità del potere amministrativo, Napoli, 2018, 277 ss.; F. Francario, Riesercizio del potere amministrativo e stabilità degli effetti giuridici, in Federalismi.it, 2017.
[4] Art. 21-nonies, co. 2-bis, l. n. 241 del 1990.
[5] “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”. Per un approfondimento, tra gli altri, si v. M.A. Sandulli, Gli effetti diretti della L. 7 agosto 2015 n. 124 sulle attività economiche: le novità in tema di s.c.i.a., silenzio-assenso e autotutela, in Federalismi.it, 17, 2015; Id., Postilla all’editoriale “Gli effetti diretti della L. 7 agosto 2015, n. 124 sulle attività economiche: le novità in tema di s.c.i.a., silenzio-assenso e autotutela, ivi, 20, 2015; F. Francario, Autotutela amministrativa e principio di legalità (nota a margine dell’art. 6 della l. 7 agosto 2015, n. 124), ivi; M. Lipari, La SCIA e l’autotutela nella legge n. 124/2015: primi dubbi interpretativi, ivi; M. Macchia, Sui poteri di autotutela: una riforma in senso giustiziale, in Giorn. dir. amm., 2015, 634 ss.; F. Volpe, L’annullamento del silenzio assenso e della s.c.i.a. Riflessioni di teoria generale a seguito dell’abrogazione dell’art. 21, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, in Giustamm.it, 10, 2015; S. D’Ancona, L’annullamento d’ufficio dopo la Riforma Madia, in Giur. it., 2015, 2748 ss.; V. Di Iorio, Osservazioni a prima lettura sull’autotutela dopo la l. n. 124/2015: profili di incertezza nell’intreccio tra diritto amministrativo e diritto penale, in Federalismi.it, 21, 2015; G. Manfredi, Il tempo è tiranno: l’autotutela nella legge Madia, in Urb. app., 2016, 5 ss.; P.L. Portaluri, Il nuovo diritto procedimentale nella riforma della p.A.: l’autotutela (profili interni e comunitari), in Federalismi.it, 20, 2016; F. Francario, Riesercizio del potere amministrativo e stabilità degli effetti giuridici, cit.; Id., Profili evolutivi dell’autotutela (decisoria) amministrativa, in A. Rallo, A. Scognamiglio (a cura di), I rimedi contro la cattiva amministrazione. Procedimento amministrativo ed attività produttive ed imprenditoriali, Napoli, 2016, 9 ss.; A. Rallo, L’inserimento del termine certo nell’esercizio dell’autotutela: appunti per una discussione, ivi, 53 ss.; A. Carbone, Il termine per esercitare l’annullamento d’ufficio e l’inannullabilità dell’atto amministrativo, in Giustamm.it, 11, 2016; M. Trimarchi, Decisione amministrativa di secondo grado ed esaurimento del potere, in Pers. e Amm., 2017, I, 189 ss.; Id., Stabilità del provvedimento e certezze dei mercati, in Dir. amm., 2016, 321 ss.; F. Costantino, L’annullamento d’ufficio del provvedimento, in A. Romano (a cura di), L’azione amministrativa, Torino, 2016, 869 ss.; L. Carbone, La riforma dell’autotutela come nuovo paradigma dei rapporti tra cittadino e amministrazione pubblica, in www.giustizia-amministrativa.it, 2017; C. Deodato, L’annullamento d’ufficio, in M.A. Sandulli (a cura di), Codice dell’azione amministrativa, Milano, 2017, 1173 ss.; Id., Il potere amministrativo di riesame per vizi originari di legittimità, in Federalismi.it, 7, 2017; A. Gualdani, Il tempo nell’autotutela, ivi, 12, 2017; R. Caponigro, Il potere amministrativo di autotutela, in Federalismi.it, 23, 2017; C.P. Santacroce, Tempo e potere di riesame: l’insofferenza del giudice amministrativo alle “briglie” del legislatore, ivi, 21, 2018; Id., Annullamento d’ufficio e tutela dell’affidamento dopo la legge n. 124 del 2015, in Dir. e proc. amm., 2017, 1145 ss.
[6] La locuzione è tratta dal parere del Cons. Stato, 30 marzo 2016, n. 839. Per un approfondimento, si rinvia ad A. Carbone, La riforma dell’autotutela come nuovo paradigma dei rapporti tra cittadino e amministrazione pubblica, Relazione al convegno “La legge generale sul procedimento amministrativo: attualità e prospettive nei rapporti tra cittadino e p.a.”, cit. Si v. anche C. Napolitano, L’autotutela amministrativa. Nuovi paradigmi e modelli europei, Napoli, 2018.
[7] Il computo dei diciotto mesi decorre dal momento dell'adozione di tali provvedimenti; in caso di s.c.i.a., invece, prende avvio dalla cessazione della fase di primo controllo.
[8] Con la precisazione che, ai fini della perimetrazione della norma, l’art. 12, l. n. 241 del 1990, rubricato proprio "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici", assume un ruolo-chiave. Sul punto, si v. M. Ramajoli, L'annullamento d'ufficio alla ricerca di un punto d'equilibrio, in Giustamm.it, 6, 2016; il legame tra le due disposizione è stato già evidenziato anche da G. Strazza, Il g.a. al cospetto del nuovo “tempo” dell’annullamento d’ufficio, seminario interdisciplinare sull’Autotutela e sindacato del giudice amministrativo (coordinato dalla Prof.ssa M.A. Sandulli), Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza, 14 aprile 2016.
[9] Su cui, da ultimo, si v. G. Gianni, Profili critici sull’applicabilità all’aggiudicazione definitiva di un appalto pubblico del termine di diciotto mesi per l’annullamento in autotutela, in www.giustizia-amministrativa.it.
[10] Nel solco del Cons. Stato, sez. V, 27 giugno 2018, n. 3940, con nota di M.A. Sandulli, L’autotutela perde i limiti temporali imposti dalla «Madia», in Il sole 24 ore, 9 luglio 2018; Id., Autoannullamento dei provvedimenti ampliativi e falsa rappresentazione dei fatti: è superabile il termine di 18 mesi a prescindere dal giudicato penale?, in lamministrativista.it.
[11] Cons. Stato, 30 marzo 2016, n. 839, cit. e Id., 4 agosto 2016, n. 1784.
[12] Sul tema si v., da ultimo, C.P. Santacroce, Tempo e potere di riesame: l’insofferenza del giudice amministrativo alle “briglie” del legislatore, in Federalismi.it, 21, 2018. Si v. anche infra, par. 3.
[13] Per un approfondimento, si rinvia a P.L. Portaluri, Commento all'art. 39, in M.A. Sandulli (a cura di), Testo unico dell'edilizia, Milano, 2015, 925 ss.
[14] “Quanto alla decorrenza del termine a quo, per giurisprudenza consolidata, il termine di 18 mesi per l'esercizio del potere di annullamento delle concessioni edilizie illegittime da parte della Regione decorre non dalla mera presa di cognizione da parte della Regione dei necessari elementi di fatto, ma dalla conclusione dello svolgimento, sia pure sommario, dell'esame ragionato dei medesimi e delle pertinenti valutazioni tecnico-giuridiche. Per cui, tale termine iniziale coincide con quello di deposito della relazione del funzionario che ha svolto i necessari accertamenti tecnici”. Così T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 9 giugno 2016, n. 362. Sul procedimento che deve precedere l'annullamento d'ufficio, si v. il comma 2 del citato art. 39. Per un approfondimento, si v. anche R. Fusco, I limiti al potere di autotutela decisoria in materia edilizia: il difficile equilibrio tra il contrasto all’abusivismo edilizio e la tutela dell’affidamento dei privati, in Riv. giur. ed., 1, 2020.
[15] L’art. 38 riproduce il contenuto di tale disposizione, poi sostituita dall’art. 7, l. 6 agosto 1967, n. 765 e, infine, coordinata con l’art. 1, d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8.
[16] A. Frigo, L’annullamento dei poteri comunali in materia edilizia, in Venetoius.
[17] Si v. anche G. Pagliari, Il permesso di costruire, in Aa. Vv., Trattato di diritto del territorio, Torino, 2018, 830. In tal senso, sembra anche l’obiter dictum contenuto nella sentenza del Cons. Stato, Ad. plen., 17 ottobre 2017, n. 8, cit.
[18] P. Marzaro Gamba, Il potere regionale di annullamento dei provvedimenti comunali in materia urbanistico – edilizia: profili sistematici ed esegetici, in Riv. giur. urb., 1999, 516 ss.
[19] Cons. Stato, sez. IV, 7 settembre 2018, n. 5277; Id., 16 agosto 2017, n. 4010. Sull’annullamento straordinario dei titoli edilizi illegittimi quale “espressione di mera funzione di vigilanza e controllo da parte dell'autorità sovraordinata” si v., in particolare, Cons. Stato, sez. IV, 8 novembre 2013, n. 32; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 23 maggio 2014 n. 5521).
[20] Sul tema, si v. Cons. Stato, Ad. plen., 17 ottobre 2017, n. 8, con commento di M.A. Sandulli, G. Strazza, L’autotutela tra vecchie e nuove incertezze, cit.
[21] In termini, si v. T.A.R. Umbria, sez. I, 31 dicembre 2018, n. 690; Id., 7 novembre 2016, n. 691, in Riv. giur. ed., 5, 2016, 770. Sul punto, si v. anche C.g.a., Regione siciliana, 2 febbraio 2017, n. 667. Il Cons. Stato, sez. VI, 6 agosto 2018, n. 4822, invece, da un lato ha affermato che il potere ex art. 39, t.u. edilizia “va distinto il potere di ritiro ex art. 21-nonies l. 241/1990 da quello in questione, costituendo il primo l’esito dell’attribuzione di un vero e proprio potere di autotutela, cioè di autoannullamento degli atti illegittimi”; dall’altro, però, ha evidenziato che le prescrizioni di cui all’art. 21-nonies “debbono essere osservate anche in caso di esercizio del potere di annullamento straordinario dei titoli edilizi (…) per effetto di una doverosa lettura costituzionalmente orientata della relativa disposizione e quindi rispettosa del principio generale di cui all’art. 97 Cost.”.
[22] In realtà, tale argomento non sembra del tutto dirimente, perché il riferimento all’espressione “altro organo” potrebbe essere utilizzato per sostenere, a contrario, che tale potere non è esercitabile da altri enti.
[23] Senza dimenticare che, prima della c.d. legge Madia, talvolta la giurisprudenza si è avvalsa del limite decennale di cui all’art. 39, t.u. edilizia per individuare il tertium comparationis funzionale a perimetrare la ragionevolezza del termine di cui all’art. 21-nonies, l. n. 241 del 1990. Si v., ad es., Cons. Stato, sez. IV, 3 agosto 2010, n. 5170, in Riv. giur. ed., 2010, 6, 1897; T.A.R. Sardegna, sez. II, 16 ottobre 2013, n.651, in www.iusexplorer.it; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 5 aprile 2013, n. 340, in Foro amm-TAR, 2013, 4, 1112.
[24] M. Ramajoli, L'annullamento d'ufficio alla ricerca di un punto d'equilibrio, in Giustamm.it, 6, 2016. Del pari, la riforma non è intervenuta sull’art. 138, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (t.u. enti locali), che attribuisce al Governo il potere straordinario di annullare, “in qualunque tempo”, gli atti illegittimamente assunti dagli enti locali. In argomento, si v. il Cons. Stato, sez. I, parere 7 aprile 2020 n. 735, con commento di N. Pignatelli, Il potere di annullamento straordinario ex art. 138 TUEL di un’ordinanza comunale: il Covid-19 non “chiude” lo stretto di Messina, in www.giustizia-amministrativa.it. Per un approfondimento, si v. L. Brunetti, Considerazioni sul potere di annullamento di cui all'art.138 T.u.e.l., e sulla sua riconducibilità all'art.120, comma 2, Cost., in Dir. amm., 3, 2006, 721 ss.
[25] Introdotto dall'art. 1, d.lgs. 27 dicembre 2002, n. 301 ("Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia").
[26] L’art. 3, co. 1, lett. r), d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222 (“Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”) ha stabilito che “all'articolo 39, comma 5-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»”
[27] M.A. Sandulli, Gli effetti diretti della l. 7 agosto 2015 n. 124 sulle attività economiche: le novità in tema di s.c.i.a, silenzio-assenso e autotutela, in Federalismi.it, 17, 2015 ha auspicato una modifica del citato art. 39, proprio perché il termine decennale si pone "in evidente e irragionevole contrasto con un sistema che tende invece dichiaratamente ad incentivare gli investimenti, dando massime garanzie di stabilità agli operatori"; in argomento si v. anche M. Ramajoli, L'annullamento d'ufficio alla ricerca di un punto d'equilibrio, cit.; G. Strazza, Il potere di intervento “tardivo” sulla s.c.i.a. tra disciplina statale, regionale ed esigenze di certezza, in Riv. giur. ed., 1-2, 2016, 14 ss.
[28] Si v., a titolo esemplificativo, l’art. 30, l.r. Veneto, 23 aprile 2004, n. 11, ss.mm.ii. e l’art. 9, co. 1, l.r. Abruzzo, 5 maggio 2010, n. 14.
[29] Si v. l’art. 30, cit. In argomento, si v. A. Borella, La nuova autotutela di cui alla legge di riforma della pubblica amministrazione: annullamento d’ufficio e regolarizzazioni edilizie, in Riv. giur. urb., 2016, 2, 144 ss. Si segnalano, inoltre, “le peculiarità” dell’art. 27, l.r. Emilia-Romagna, 30 luglio 2013, n. 15, ss.mm.ii., rubricato “Pubblicità dei titoli abilitativi e richiesta di riesame”: “1. I soggetti interessati possono prendere visione presso lo Sportello unico dei permessi rilasciati, insieme ai relativi elaborati progettuali e convenzioni, ottenerne copia, e chiederne al Sindaco, entro dodici mesi dal rilascio, il riesame per contrasto con le disposizioni di legge o con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai fini dell'annullamento o della modifica del permesso stesso. 2. Il medesimo potere è riconosciuto agli stessi soggetti con riguardo alle SCIA presentate, allo scopo di richiedere al Sindaco la verifica della presenza delle condizioni per le quali l'intervento è soggetto a tale titolo abilitativo e della conformità dell'intervento asseverato alla legislazione e alla pianificazione territoriale e urbanistica. 3. Il procedimento di riesame è disciplinato dal regolamento edilizio ed è concluso con atto motivato del Sindaco entro il termine di sessanta giorni”. Per un approfondimento, si v. D. Lavermicocca, B. Graziosi, La disciplina edilizia in Emilia-Romagna, Bologna, 2015.
[30] Nel solco del titolo scelto da M. Sinisi, La nuova azione amministrativa: il 'tempo' dell’annullamento d'ufficio e l’esercizio dei poteri inibitori in caso di s.c.i.a., in Federalismi.it, 24, 2015.
[31] Valga anche quanto già osservato a proposito dell’art. 138, t.u. enti locali. Si consideri, inoltre, anche la “risoluzione” del contratto di cui all’art. 108, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice dei contratti pubblici”) e, in particolare, al co. 1-bis, introdotto dall’art. 72, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (c.d. correttivo al codice dei contratti pubblici), ai sensi del quale non si applicano “i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.” .
[32] “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
[33] Ossia dal 19 maggio, data di entrata in vigore del decreto, fino alla fine del 2020.
[34] Come già previsto dall’art. 21-nonies, co. 2-bis, l. n. 241 del 1990, tale limite trova un’unica eccezione nel caso di “false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenze di condanna passate in giudicato”.
[35] La cui perimetrazione non sembra del tutto agevole.
[36] Ossia quelli “avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni”. In tal caso, la revoca è ammessa “solo per eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenute”.
[37] Per un approfondimento, si rinvia a M.A. Sandulli, La “trappola” dell’art. 264 del dl 34/2020 (“decreto Rilancio”) per le autodichiarazioni. Le sanzioni “nascoste”, in questa Rivista, 2 giugno 2020.
[38] Tramite l’aggiunta del nuovo comma 1-bis all’art. 75, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
[39] Con un periodo aggiunto al primo comma dell’art. 76, d.P.R. n. 445 del 2000, tale sanzione “è aumentata da un terzo alla metà”.
Falcone e quella notte al Consiglio Superiore della Magistratura (quarto capitolo)
Intervista di Paola Filippi e Roberto Conti a Vito D'Ambrosio
Il Presidente emerito della Corte costituzionale Gaetano Silvestri, già componente laico del CSM, in un suo recente saggio dedicato all’analisi delle non commendevoli vicende che attualmente agitano il mondo giudiziario (Notte e nebbia nella magistratura italiana, QG,12 giugno 2020), ha osservato che la vicenda della mancata nomina di Giovanni Falcone alla funzione di Consigliere Istruttore del Tribunale di Palermo assume ancora oggi un valore emblematico rispetto alle difficoltà mostrate dal governo autonomo della magistratura sul tema della c.d. anzianità senza demerito degli aspiranti a ricoprire incarichi direttivi o semi-direttivi. Essa, a ben considerare, offre ulteriori e forse ancora maggiori punti di riflessione che riguardano da vicino il rapporto dei magistrati con le correnti, con l'opinione pubblica, la politica ed il CSM.
Giustizia Insieme intende tornare su quella vicenda per farne memoria, soprattutto a beneficio dei tanti che non vissero direttamente quella stagione ed il clima avvelenato che ne seguì, vuoi perché lontani da quella che viene considerata secondo un ben sperimentato stereotipo terra di mafia, vuoi perché non ancora entrati all’interno dell’ordine giudiziario. Ciò ha inteso fare attraverso alcuni dei protagonisti che contribuirono direttamente a scrivere le note di quella notte del 19 gennaio 1988 consumata all'interno del plenum del CSM.
Carlo Smuraglia, Stefano Racheli, Marcello Maddalena e Vito D’ambrosio, membri alcuni togati (D’Ambrosio, Racheli e Maddalena), alcuni laici (Smuraglia) del CSM che si occupò di quella pratica, hanno accettato di rileggere quegli avvenimenti a distanza di oltre trentadue anni. Una rilettura certamente mediata, per un verso, dall’esperienza maturata dai protagonisti nel corso degli anni passati al Consiglio Superiore della magistratura e, per altro verso, da quanto emerso rispetto alla gestione del goberno autonomo in tempi recenti. La drammaticità di quella vicenda sembra dunque legarsi a doppia mandata all’attuale contesto storico che sta attraversando la magistratura italiana. I contributi che seguono, nella prospettiva che ha animato la Rivista non intendono, dunque, offrire verità ma semmai stimolare la riflessione, aprire gli occhi ai tanti che non vissero quell’episodio e quell’epoca assolutamente straordinaria per tutto il Paese.
La spaccatura che si profilò all'interno dei gruppi presenti in Consiglio e delle scelte che i singoli consiglieri ebbero ad esprimere votando a favore o contro la proposta di nomina del Consigliere Istruttore Antonino Meli pongono, in definitiva, interrogativi più che mai attuali, occorrendo riflettere su quanto nelle determinazioni assunte dal singolo consigliere del CSM debba essere mutuato dall'appartenenza al gruppo e quanto, invece, debba liberamente ed autonomamente attingere al foro interno del consigliere, allentando il vincolo "culturale" con la corrente quando si tratta di adottare decisioni che riguardano gli uffici giudiziari ed i loro dirigenti.
Gli intervistati hanno mostrato tutti in dose elevata la capacità di approfondire in modo costruttivo quell'episodio e per questo va a loro un particolare senso di gratitudine.
In calce ad ognuna delle quattro interviste che saranno pubblicate in successione abbiamo riportato, oltre al verbale consiliare del 19 gennaio 1988 tratto dalla pubblicazione che il CSM ha dedicato alla memoria di Falcone, alcuni documenti storici che Giovanni Paparcuri, testimone vivente delle stragi mafiose e custode delle memorie raccolte nel museo “Falcone Borsellino” ha gentilmente messo a disposizione della Rivista. Documenti che offrono, in cifra, l’immagine dell’uomo e del magistrato Falcone e del contesto nel quale Egli operò.
La quarta ed ultima intervista è del Cons. Vito D'Ambrosio, già Sostituto Procuratore Generale presso la Procura Generale della Corte di Cassazione – dove seguì per l’accusa, con altri due colleghi, i sostituti Martusciello e Tranfo, il c.d. maxi processo contro la mafia, istruito da Falcone e dal pool di Palermo – membro togato del CSM durante il quadriennio 1986-1990 e Presidente della Giunta della regione Marche.
[In calce, la lettera inoltrata da Giovanni Falcone al Consigliere istruttore Antonino Meli il 2 settembre 1988]
1) Il contesto ed il clima nel quale si discusse il conferimento dell’incarico di Consigliere istruttore del Tribunale di Palermo nel gennaio 1988 ed il suo prodromo – la nomina di Paolo Borsellino a Procuratore della Repubblica di Marsala. Cosa ricorda?
D'Ambrosio: Io non conoscevo affatto Falcone, se non per fama, prima del gennaio 1986. Lo conobbi nella prima tappa, a Palermo, del tour elettorale che con un gruppetto di colleghi della stessa corrente (Unità per la Costituzione) avevo iniziato, essendo candidato per il CSM in carica dal 1986, alla scadenza del precedente.
A Palermo incontrammo tutto quello che già allora veniva chiamato “pool”, una squadra di magistrati addetti alle indagini sul fenomeno mafia, raccolte in un unico faldone, che poi diede vita al Maxi processo (oltre 400 imputati, 7000 pagine la sentenza di primo grado, più di 2000 quella di appello, il processo durò quasi un mese in Cassazione). L’incontro più significativo fu con il dirigente dell’ufficio Istruzione, il dottor Antonino Caponnetto, il quale confidò a qualcuno di noi la sua intenzione di chiedere a breve il trasferimento a Firenze, residenza sua e della famiglia, dalla quale era venuto a Palermo a sua domanda, dopo l’uccisione con un’auto bomba del suo predecessore, Rocco Chinnici. Caponnetto riteneva di aver compiuto la sua missione, creare una struttura efficiente di contrasto alla mafia, basata su una visione unitaria del fenomeno, le cui manifestazioni criminose erano indagate da alcuni magistrati dell’ufficio., che agivano in squadra.
A tutti noi, che facevamo riferimento alla sua stessa corrente, Caponnetto, oltre ad assicurarci il voto e augurarci un esito favorevole delle elezioni, raccomandò caldamente di sostenere la domanda di succedergli nell’incarico, domanda che sarebbe stata avanzata da Falcone, grazie alla sua indiscussa primazia nel pool.
A Caponnetto promettemmo, più o meno, che avremmo sostenuto, quelli eletti tra noi, la candidatura di Falcone. Ovviamente non ci furono documenti scritti, né impegni formali, ma la sostanza dei nostri colloqui con il lucido Consigliere Istruttore di Palermo fu quella appena indicata.
Io fui eletto, e ricordavo ancora la promessa fatta a Caponnetto, rafforzata dai contatti sempre più frequenti con Falcone, che trasformarono il nostro rapporto in una solida amicizia. Mi sembrava ovvio il mantenimento della promessa, visto anche la caratura professionale di Falcone, ormai assunto a notorietà non solo nazionale per alcune indagini in ambito mafioso, coronate da successo nei vari processi istruiti dal pool.
Anche all’epoca la nomina dei dirigenti degli uffici era, senza alcun dubbio, una delle difficoltà maggiori da affrontare in Consiglio. Mi resi conto abbastanza presto della centralità e complessità del problema, reso ancora più spinoso da una diffusa mentalità distorta tra i componenti togati, che contagiò presto anche i non togati (i laici, venivano chiamati), così che intorno alle nomine ci si confrontava duramente, ma non sempre apertamente, per far prevalere il “proprio” candidato”, il che avrebbe aumentato la capacità attrattiva della corrente verso i magistrati non schierati a favore dei vari gruppi-correnti, accrescendo così l’importanza del gruppo (quanto questo fenomeno abbia poi distorto le ragioni all’origine della nascita delle correnti, trasformandole gradatamente da gruppi uniti da una visione omogenea dell’impegno dei magistrati in macchine acchiappa consenso, è argomento ormai molto dibattuto, mentre all’epoca gli indizi, pur presenti, venivano ignorati, o male interpretati, volontariamente o meno).
Il primo caso emblematico, il primo sintomo di una patologia crescente, che si coagulò in un groviglio di difficoltà e asperità, che infine divenne “il caso Palermo”, fu la trattazione della domanda di Paolo Borsellino per l’attribuzione della funzione di Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Marsala.
All’epoca i miei rapporti con Falcone erano ai primi passi, così che seppi soltanto a tratti che quella domanda era stata concordata da Borsellino con Falcone, per costituire un avamposto in terra di mafia, nella convinzione, comune ai due magistrati, che il fenomeno mafioso era stato “contenuto” a Palermo e occorreva “esportare” le conoscenze e le tecniche investigative del pool anche in territori ancora dominati da famiglie mafiose. Borsellino, in quella strategia, avrebbe dovuto rappresentare una “testa di ponte” per facilitare un approccio diverso e ben più efficace di contrasto al fenomeno mafioso. Io conoscevo poco di quella diversità di approccio alle indagini mafiose, ma ero ben convinto della sua erroneità, derivante dalla erroneità del presupposto di base, cioè della vicinanza di un successo palermitano nelle indagini contro la mafia.
Ma non potevo esporre questa mia convinzione, perché avrebbe indebolito di molto la posizione di Falcone a Palermo. Così mi aggregai alle posizioni del mio gruppo dell’epoca, la corrente di Unità per la Costituzione, che contendeva alla corrente più conservatrice di Magistratura Indipendente la maggioranza dei consensi elettorali della magistratura.
La questione centrale divenne, così, in apparenza, quella del criterio da adottare per le nomine agli incarichi direttivi, se dare cioè la prevalenza all’anzianità o al merito, Scrivo a ragione veduta di apparenza, perché ,come vedremo per il vero e proprio “caso Falcone” successivo, sulla domanda di Borsellino, apparve che io, e quasi tutto il gruppo di Unità per la Costituzione, eravamo convinti della prevalenza del criterio dell’anzianità, che non favoriva Borsellino, mentre i colleghi di Magistratura Indipendente,, guidati e ispirati del consigliere Vincenzo Geraci, giovane e brillante sostituto procuratore a Palermo, che conosceva bene quell’ambiente, si schierarono piuttosto in favore di Borsellino, ritenendo che l’eccezionale professionalità del richiedente dovesse e potesse avere la prevalenza. Lo schieramento era paradossale, perché il gruppo più “aperto” difendeva posizioni molto tradizionali, mentre la corrente più conservatrice si era spostata su una linea più avanzata. Il caso si chiuse con la nomina di Borsellino, bollata duramente da Leonardo Sciascia come “la vittoria dei professionisti dell’antimafia” (anche se lo scrittore in una tardiva precisazione ci tenne a slegare la sua posizione critica dalla figura di Borsellino).
Durante le vivacissime discussioni sul caso, pubbliche e riservate, ebbi prima l’intuizione e poi il primo, fortissimo dubbio sulle posizioni del Consiglio, cioè di parecchi consiglieri, sui problemi palermitani, e quindi sulla posizione di Falcone, che di quell’ufficio istruzione era divenuto l’anima, dopo il ritorno di Caponnetto a Firenze.
Posso dire che il caso Borsellino mi suonò come sirena d‘allarme sul caso Falcone ,ormai all’orizzonte.
2) Media e partiti politici prima, durante e dopo il voto consiliare: quale peso giocarono? Quali furono le posizioni dei consiglieri laici? Quali quelli delle correnti? E della Presidenza della Repubblica con i suoi consiglieri giuridici? Ebbe un peso l’opinione pubblica?
D'Ambrosio: Quando arrivò al Consiglio la domanda di Falcone di essere nominato a capo dell’ufficio istruzione del tribunale di Palermo, a me, e a tutti quelli che già dal caso Borsellino si erano schierati in favore del criterio del merito, da privilegiare su quello dell’anzianità nei casi particolari, fu abbastanza chiaro fin dall’inizio il cambiamento di clima a Palazzo dei Marescialli, la sede consiliare. La assoluta importanza del caso si deduceva anche dall’attenzione con la quale in tutta Italia si cominciò a seguirlo. A prescindere dagli articoli e dai servizi, tutti i consiglieri furono sottoposti ad una pressione assolutamente inedita dal nugolo di operatori dell’informazione che cominciarono ad interessarsi del caso. Gli schieramenti furono chiari abbastanza presto, e quasi subito si capì l’importanza della questione. Vi furono audizioni in quantità, e indubbiamente, nonostante l’acredine con la quale alcuni consiglieri formularono le loro domande a Falcone, risultò chiarissimo il notevole dislivello, sul piano professionale, tra Falcone e gli altri aspiranti (se altri vi furono ad essere auditi, particolare che non ricordo). Le audizioni si estesero il più possibile, a (quasi) tutti i magistrati dell’Ufficio Istruzione, nonché a qualcuno degli altri uffici, a cominciare dalla Procura della Repubblica. Giovanni sostenne un vero e proprio interrogatorio – nel quale si capiva subito la collocazione dell’interrogante – e perse le staffe una sola volta, su una domanda inutilmente malevola del consigliere Sergio Letizia, espressione di un gruppo estraneo all’Associazione Nazionale Magistrati, il Sindacato, che era sorto in vista delle elezioni di quel Consiglio ed era riuscito a far eleggere un solo consigliere, Letizia appunto.
Le vacanze natalizie resero ancora più chiari gli schieramenti, due in sostanza, uno che sosteneva la correttezza della nomina di Falcone, per la sua indiscussa professionalità, che doveva fare premio sulla sua minore anzianità, e un altro che riteneva insuperabile questa differenza. Al primo schieramento si iscrissero, in linea di massima, i gruppi e i partiti “progressisti”, al secondo i “conservatori”; questa lettura, però valeva per il mondo “esterno” alla magistratura, mentre nella magistratura le cose stavano in maniera diversa. Pacifico il no a Falcone da parte di Magistratura indipendente, nella sua maggioranza, e il già citato Letizia, per il resto le posizioni erano trasversali: all’interno di M.I, per esempio, il suo leader, Stefano Racheli, era a favore di Falcone, mentre Maddalena oscillava, per la sua conoscenza professionale delle capacità di Falcone, e il mio gruppo, Unità per la Costituzione, annoverava tre “falconiani”, io, Pietro Calogero e Nino Abate, mentre tra i restanti decisamente contrario era Umberto Marconi, di Napoli, e gli altri, pur rimanendo abbastanza defilati, propendevano più per il no. Tra i laici quelli di provenienza di sinistra (i tre comunisti, Smuraglia, Brutti e Gomez d’Ayala, e la socialista Fernanda Contri) decisamente pro Falcone, gli altri in blocco, contro (anche se alla fine Ziccone, di indicazione democristiana, votò per Falcone).
Il particolare di rilievo era la disomogeneità delle posizioni dei consiglieri di provenienza siciliana, così Vincenzo Geraci, M.I., sostituto a Palermo, che aveva addirittura affiancato Falcone in alcune attività istruttorie, si trovava nel gruppo anti-Falcone, il catanese Renato Papa, di Unicost, non riusciva a prendere posizione e infine si astenne, mentre il laico Guido Ziccone, professore ordinario di diritto penale a Catania, indicato dalla DC, sembrava schierato per Falcone, per cui votò.
Durante il periodo di attesa della seduta del CSM per nominare il consigliere istruttore di Palermo vi fu, credo, un nutrito scambio di idee e di notizie da entrambe le parti. Ci meravigliò non poco la scelta di un anziano magistrato, Antonino Meli, che dopo aver presentato domanda sia per l’ufficio di Presidente del Tribunale di Palermo sia di consigliere istruttore, revocò la prima , eliminando così la possibilità di spianare la strada a Falcone, nominando Meli presidente del tribunale. Qualcuno pensò che l’azione fosse frutto di un suggerimento di Geraci, ormai chiaramente il più determinato avversario di Falcone, qualcuno lo scrisse perfino, dando così vita ad una causa civile, intentata da Geraci, sul cui esito non so nulla.
Non mi risulta che vi fossero stati interventi della Presidenza della Repubblica, o dei suoi consiglieri giuridici, ma questo vuol dire poco, perché della girandola di retroscena io potevo conoscere soltanto alcuni passaggi, certo non tutti. Quando iniziò la seduta famosa, il 19 gennaio i988, fu subito chiaro, quando iniziarono le dichiarazioni di voto, che ci si trovava nel mezzo di una “congrega di coccodrilli”. Rileggendo le affermazioni dei consiglieri, laici e togati, quelle più laudatorie nei confronti di Falcone furono quelle di chi gli votò contro, scegliendo Meli. La lettura del verbale di quella seduta non è stata facile per me, anche a distanza di anni, perché mi sono sentito catapultato a quella sera, mentre su Roma scendeva rapida l’oscurità invernale, e dentro di me saliva una delusione profonda, poiché la sconfitta di Falcone, ormai chiara, aveva un significato che pochi in quel salone comprendevano fino in fondo, e la maggioranza oscillava tra cinismo, ipocrisia e sofferta sincerità di due consiglieri su tre di Magistratura Democratica, Elena Paciotti e Pino Borrè, mentre il terzo, Giancarlo Caselli votò per Falcone.
Sull’atteggiamento di MD vale la pena di soffermarsi. Avevamo, tutti noi amici di Falcone, la netta sensazione che la questione avrebbe rivestito notevole importanza per tutta la corrente, ed in effetti, pur senza che trapelasse molto, ci rendemmo conto che doveva esserci stata “maretta” , al temine della quale i tre consiglieri assunsero un diverso atteggiamento di voto, ed io specialmente, rimasto molto deluso, fino all’ultimo avevo tentato di convincere almeno uno dei restanti due, perché tutti si sapeva che la decisione sarebbe stata presa a stretta maggioranza. Alla fine, dentro MD, scattò molto probabilmente un atteggiamento anti falconiano, quasi che col premiare il merito e superare un divario tanto ampio di anzianità (Meli era più anziano di Falcone di ben sedici anni), si aprisse la strada ad una gara di protagonismo tra magistrati, a discapito dei tanti che, pur non spiccando, tuttavia svolgevano onestamente e quotidianamente il loro compito. Non risparmiai le critiche a questo atteggiamento, che ,inutili fino alla votazione, alcuni anni più tardi indussero Borrè, con la sua limpida onestà intellettuale, a dichiarami di aver avuto, a cose fatte, qualche dubbio di aver fatto la scelta giusta.
Finì, la votazione, dopo un lunghissimo dibattito, col risultato di 16 a 10 e cinque astenuti. Quando, con un misto di rabbia e commozione mal trattenuta, telefonai a Giovanni il risultato, la sua risposta mi gelò. “Con questa decisione” disse,, con quella asciuttezza affilata, della cui carica di sentimento e risentimento, ero ben conscio, “mi avete esposto come un bersaglio al baraccone del luna park”, la- sciandomi con ancora più amaro in bocca.
Di quel voto si parlò tanto, dentro ma soprattutto fuori del Palazzo dei Marescialli. E gli atteggiamenti della politica e dell’informazione, rispecchiarono quasi fedelmente gli schieramenti consiliari. La sinistra tutta con Falcone, gli altri tutti contro, spendendosi nell’indicare i meriti di Meli, prigioniero dei nazisti dopo il 25 luglio, sempre accompagnando il tema con grandi riconoscimenti dei meriti di Falcone.
Assai più dirompente quel voto fu per le vicende della Associazione Nazionale Magistrati: infatti dopo un assai breve intervallo di tempo, io e Pietro Calogero per Unicost, e Stefano Racheli per MI, lasciammo i gruppi di appartenenza e ne fondammo due nuovi, chiamati Movimento per la Giustizia quello che accolse i due ,io e Calogero, della diaspora, e Stefano chiamò il suo Proposta 88. Con noi partecipò alla fondazione del nuovo gruppo una nutrita schiera di colleghi, quali (e mi scuso per eventuali dimenticanze) Falcone stesso, Giorgio Lattanzi, Armando Spataro, Vladimiro Zagrebelsky, Ernesto Lupo, Mario Almerighi, Giovanni Tamburino, Giuseppe Ayala, Gioacchino Natoli, Ernesto Aghina, Gerardo D'Ambrosio, Enrico Di Nicola, Ciro Riviezzo, Nino Condorelli, Anna Creazzo, Leo Agueci, Ippolisto Parziale, Giovannantonio Tabasso, Sergio Lari, Maria Teresa Cameli. Nella "sala rossa" di un vicino albergo, Hotel Salus, fu stilata la carta fondativa e lo statuto del neo-costituito Movimento, e ci parve che il futuro fosse meno cupo (la storia dirà chi aveva ragione).
Entrambi i nuovi gruppi proponevano una profonda riforma del costume, prima, e delle regole poi, per il mondo dell’associazionismo giudiziario, riforme che ovviamente avrebbero dovuto incidere profondamente sulle prassi del CSM. CI si trovava allora, e ci si trova ancora di più oggi, di fronte al grande problema dell’esercizio “corretto” del potere. Noi non siamo riusciti a risolverlo, nonostante l’impegno, e quelli dopo di noi hanno finto di non accorgersi delle dimensioni della questione, e si è arrivati al panorama pieno di macerie che oggi le carte processuali di Perugia ci aprono davanti agli occhi. Con una enorme difficoltà di indicare soluzioni.
3) La composizione del Consiglio superiore della magistratura come influì sulla scelta?
D'Ambrosio: La risposta a me sembra semplice e scarna: né la composizione del CSM né il sistema elettorale dell’epoca ebbero influenza sulla vicenda. Non si trattava di una semplice nomina ad un ufficio direttivo, per quanto importante. Era in ballo, in tutta la sua aggrovigliata realtà, il tema delle connessioni tra criminalità organizzata e mondo della politica. Il famoso terzo livello, del quale si cominciava a parlare non più solo tra pochi intimi. E quindi due modelli di società si fronteggiavano per il posto di Consigliere Istruttore presso il tribunale di Palermo. Il mondo criminal-affaristico, negli anni recenti, aveva lanciato messaggi chiarissimi, uccidendo prima il Procuratore Scaglione e poi, alcuni anni dopo, in rapida successione, il Procuratore Gaetano Costa e il Consigliere Istruttore Rocco Chinnici. Contro questo strapotere un pugno di magistrati, il famoso pool, cercava di costruire un muro spesso e robusto, accumulando materiale su materiale in un fascicolo diventato famoso, che sarebbe poi diventato il maxi processo alla mafia. Gli interessi in ballo erano tanti, e tanto massicci, da superare le tradizionali divisioni e influenze. Ci fu, e in pochissimi ce ne accorgemmo, una generale chiamata alle armi per bloccare quello che veniva ritenuto, dal duo mafia e politica, un avversario pericoloso, Giovanni Falcone. Questo era il tema vero, il filo rosso di tutta la vicenda, che era cominciata già alle prime avvisaglie della richiesta di trasferimento di Caponnetto, che aveva “inventato” un modo nuovo di fare le indagini di mafia, come si stava facendo per il terrorismo, ricucendo i fili e non sparpagliandoli secondo le “tradizionali” regole processuali. L’unicità del fenomeno, finalmente colta, esigeva l’unicità delle indagini, da affidare certo ai vari giudici istruttori, ma da raccogliere poi nell’unico tessuto, per comprenderne la trama complessiva. Falcone stava dimostrando di poter trarre tutte le conseguenze dell’applicazione di quel metodo e quindi Falcone andava fermato, in tutti i modi, e il modo più a portata di mano era quello di stopparne la richiesta di diventare Consigliere Istruttore del Tribunale di Palermo. Risultato che si poteva/doveva ottenere ad ogni costo, movendo le pedine disponibili, dovunque fossero collocate, e organizzando un piano, che veniva da lontano. Questo sfondo era l’esatta cornice nella quale inserire tutta la vicenda Falcone, cornice conosciuta bene dagli agenti consapevoli, e ignorata da chi non volle o non poté sforzarsi di trovare un punto di vista più ampio di quello apparente in superficie. La nomina di Falcone, ovviamente, non poteva garantire risultati quasi definitivi, dato che anche Falcone, che conosceva bene quella realtà, si muoveva su quel piano con prudenza, messo sul chi vive prima di tutto dal “co-autore del maxiprocesso”, Tommaso Buscetta, detto don Masino, il quale non volle rivelare nella sua deposizione fiume il lato oscuro della vicenda, i rapporti tra mafia e politica, spiegando che nemmeno Falcone poteva venire a conoscenza di certi retroscena, pena la sua incolumità personale. Giovanni sull’argomento restava abbottonato perfino con noi, suoi convinti sostenitori, ed anche quando fu pesantemente attaccato da Orlando, il quale straparlava di carte nei cassetti, rispose negando con disinvoltura il “terzo livello” famoso dei rapporti tra mafia e politica. Però, quando ci fu l’attentato all’Addaura, con una borsa (forse) piena di candelotti di esplosivo, trovata sulla scogliera sotto la villetta affittata da Falcone per un po’ di riposo estivo, la borsa fu distrutta, prima di essere sottoposta ad analisi ed indagini, da un maresciallo artificiere, Francesco Tumino, che per questo eccesso di zelo fu condannato con sentenza definitiva per favoreggiamento. E, in una delle interviste rilasciate dopo l’attentato, Falcone si lasciò sfuggire quel riferimento a “menti raffinatissime” , accenno rimasto misterioso per 28 anni, fino a quando, cioè, in una recente trasmissione televisiva Saverio Lodato, giornalista molto addentro nei misteri mafiosi, ha rivelato un nome che Falcone gli avrebbe confidato, nome di una persona le cui complesse vicende giudiziarie finirono alla Corte di Strasburgo. Poichè per questa vicenda è stata sporta denuncia/querela, della vicenda si sta occupando la magistratura, non intendo sposare l'una o l'altra delle posizioni in conflitto.
(Non posso non segnalare l’indegna diceria messa in giro sull’attentato, che lo riteneva organizzato dallo stesso Falcone per riprendere una primazia nel mondo dell’informazione).
4) Quali furono le ragioni espresse del voto e quali gli schieramenti che si manifestarono nel corso del Plenum. Ricorda qualche episodio in particolare che possa risultare, oggi, significativo?
D'Ambrosio: Per conoscere le singole motivazioni dei consiglieri nella seduta del gennaio 1988 basta ricercare nell’archivio del CSM; il tempo ha dimostrato le conseguenze di quelle parole, che, come ho già detto, quando poste a motivazione della scelta pro Meli, e quindi contro Falcone, furono “farcite” di riconoscimenti al bocciato, quasi più delle motivazioni opposte.
Episodi peculiari e significativi ce ne furono, ma io ricordo nitidamente che, durante la fase anteriore al voto, i magistrati palermitani, durante gli intervalli dell’attività conoscitiva del Consiglio, cercavano rifugio nella stanza dei consiglieri. Stranamente, ma non troppo, nella stanza di Vincenzo Geraci posta al centro del corridoio che portava alla grande sala del plenum entrarono quasi esclusivamente quelli che poi, negli anni, hanno reso chiaro quello che già allora appariva evidente, per chi aveva un orecchio appena allenato: Falcone non era amato, forse dalla maggioranza dei suoi colleghi, e certamente il suo “indice di gradimento” ,termine alla moda, non era affatto alto nemmeno a Palermo. Quindi quelli non pro Meli, ma anti Falcone erano in contatto con Geraci, mentre gli altri erano ospitati nella stanza mia , o di Smuraglia, o di Fernanda Contri. Se si fosse trattato di un sondaggio, il numero e le caratteristiche dei magistrati palermitani , il loro “schieramento” per dir così, si poteva dedurre con buona attendibilità ricostruendo i loro percorsi all’interno del Palazzo dei Marescialli.
5) Quale ruolo giocò il parametro dell’attitudine ovvero della specializzazione nell’attività di contrasto alla criminalità mafiosa nel giudizio di comparazione tra i magistrati che concorrevano alla direzione dell’ufficio istruzione (e) quanto il parametro dell’anzianità? Quali erano le regole della circolare dell’epoca sul conferimento degli incarichi direttivi, quale lo spazio rimesso alla discrezionalità del Consiglio?
D'Ambrosio: L’art. 105 della Costituzione, nel suo unico comma, stabilisce che “Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati”.
I problemi posti da questo articolo sono stati sempre assai spinosi, a cominciare dal richiamo alle “norme dell’ordinamento giudiziario”, che dovrebbero ispirare l’esercizio ,da parte del Consiglio, dei suoi poteri, per poi proseguire nel confronto con il successivo art. 107, i cui commi 3 e 4, stabiliscono, rispettivamente, che “i magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni” e, successivamente “ il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario” .
Il Consiglio, come è noto, fu istituito soltanto nel 1958 e il suo primo insediamento avvenne il 18 luglio 1959. Il ritardo nell’istituzione dell’organo, superiore anche a quello impiegato per la Corte Costituzionale, che si è insediata per la prima volta nel 1956, ne mostra la novità e la distanza abissale con l’organo omologo, previsto come organo ausiliario del Ministro della Giustizia fin dal 1906.
Il periodo di dieci anni, tra l’entrata in vigore della Costituzione e l’istituzione del Consiglio superiore, vide una notevole attività, sul punto, dell’Associazione Nazionale Magistrati, alla quale era iscritta la grande parte dei magistrati. Un vivace dibattito all’interno dell’associazione, prodromico alla nascita delle “correnti”, raggiunse alcuni punti fermi, tra i quali, il miglioramento del trattamento economico -tema rimasto dibattutissimo fino ad oggi- e la diminuzione dei poteri dei capi degli uffici giudiziari, soprattutto con la temporaneità degli incarichi direttivi.
Ma tutto doveva fare riferimento all’ordinamento giudiziario regolato con una legge del 1941, nota come legge Grandi, dal nome del ministro proponente.
Con questa gigantesca anomalia il Consiglio iniziò la sua vita istituzionale, ponendosi da subito come cartina di tornasole per le posizioni di “politica giudiziaria” all’interno della Associazione.
Superata, disinvoltamente, la distinzione tra magistrati giudicanti e magistrati requirenti, ritenendo applicabile la identica normativa ai magistrati del pubblico ministero, rimase, dolente fin dall’inizio, il tema delle promozioni. Dall’ordinamento giudiziario potevano venire soltanto i meccanismi di promozione, con la necessità di superare alcuni concorsi, a cascata, per passare dall’una della categorie a quella superiore, dato che ancora le funzioni erano ordinate gerarchicamente, prima da uditore ad aggiunto giudiziario, poi a magistrato di tribunale poi a consigliere di Corte d’Appello e infine, a coronamento, le funzioni di consigliere della “suprema” Corte di Cassazione, tra i quali soltanto potevano essere nominati i presidenti della diverse Sezioni della Corte stessa.
A parte la palese contraddizione dell’intero sistema con l’art. 107, comma 3, della Costituzione, esisteva un’altra lampante contraddittorietà interna del sistema: ai vincitori del concorso per la magistratura veniva affidato, dopo un tirocinio di apprendimento, l’esercizio delle funzioni giudiziarie, sia pure per le questioni di minore importanza ed interesse – le c.d. questioni bagatellari”. Dopo un biennio di esercizio delle funzioni bisognava affrontare l’esame per la nomina ad “aggiunto” giudiziario”. Il mancato superamento per due volte comportava la decadenza dall’impiego. Ma le sentenze emesse dall’uditore bi-respinto restavano in vigore, nonostante fossero state pronunciate da chi era stato dispensato addirittura dall’impiego.
Questa stridente aporia fu eliminata, e il mio concorso, nominato del decreto in data 28-12-1967, fu il primo a non sostenere la prova scritta, conservando nel fascicolo personale il parere emesso dal consiglio giudiziario territorialmente competente.
Molto più travagliata la vicenda del percorso da affrontare per le “promozioni” (anche qui il termine non sembrava del tutto coerente con l’art. 107 della Costituzione). Si doveva partire da una prassi molto solida, secondo la quale l’unico criterio da seguire per le “promozioni”, doveva essere l’anzianità di servizio. Con questa rigorosa prescrizione si era attraversato il deserto anteriore all’istituzione del Consiglio superiore. Quando entrò in funzione il nuovo organo, si vide abbastanza presto che il criterio dell’anzianità avrebbe funzionato da “imbuto”, coprendo per un periodo non trascurabile tutti i posti direttivi con la magistratura in un certo senso “compromessa” col regime fascista, e legata ad una interpretazione spiccatamente “conservatrice” – a dir poco m – di entrambi i codici sostanziale, risalenti quello civile al 1942 e quello penale addirittura al 1930 (il “famigerato” codice Rocco). Per l’insieme di queste ragioni, unite ad fisiologico tentativo di ogni istituzione di ampliare le proprie competenze, iniziò un movimento in senso lato “politico” che aprisse spazi ad una discrezionalità, sia pure limitata, del Consiglio; si arrivò, così ad un compromesso, per il quale l’anzianità conservava il suo valore predominante come criterio per le promozioni, purché, però fosse “SENZA DEMERITO”. A questa prima limitazione se ne aggiunse un’altra, che limitava l’ammissibilità della domanda, e la conseguente legittimazione del richiedente, ai candidati che fossero ricompresi in una certa “fascia di anzianità” , predeterminata dal Consiglio proprio per evitare il rischio di una eccessiva discrezionalità dell’organo. Il Consiglio del quale facevo parte oscillava, tra un criterio applicato più spesso, la legittimazione di chi rientrava nella “fascia”, ed uno più attento all’eccezionalità dei casi. Per quanto ricordi, infatti, la candidatura di Falcone non fu respinta perché proposta da magistrato ”non legittimato”, in quanto al di fuori della fascia; i consiglieri anti falconiani non ebbero il coraggio di sfidare il ridicolo.
Man mano, col passare del tempo, il Consiglio aumentava il proprio spazio di discrezionalità, mantenendo però, in vigore, almeno in apparenza, il criterio delle fasce, per evitare un secondo caso “Falcone”. L’oscillazione dei parametri di giudizio ha innescato, spesso, una accesa contrapposizione tra il Consiglio e il giudice amministrativo. Il Consiglio di Stato, qualche volta, ha ecceduto non solo negli annullamenti, ma anche nella motivazione degli annullamenti, e il CSM ha risposto non poche volte con la riproposizione della delibera bocciata, motivata quasi “ a dispetto”. Questa rapido cenno vuole soltanto gettare uno spiraglio di luce sul problema non di poco conto del “controllo” di legittimità sull’esercizio di un potere discrezionale. Il tema, spesso, viene trattato confusamente e irrazionalmente, mentre nessuna soluzione potrà essere trovata per la riforma della P.A. se non si affronterà di petto il tema del ruolo e dei poteri del giudice amministrativo.
Il graduale e surrettizio aumento della discrezionalità del CSM sarebbe stato meno devastante se non si fosse accompagnato ad una gravissima carenza di tutto il sistema, e cioè l’assoluta insufficienza degli elementi conoscitivi su ogni magistrato in tutti i passaggi nei quali occorre una comparazione tra più esaminandi. Già ai tempi della mia consiliatura, cioè più di trent’anni fa, avevo lamentato questa carenza, di fronte a valutazioni tutte strabocchevoli di aggettivi superlativi, che nascondevano una reale conoscenza della figura professionale del richiedente. La mala educaciòn cominciava, per esperienza personale, proprio dal primo passaggio valutativo, quello obbligatorio alla fine del periodo di tirocinio: avevo infatti visto ignorato totalmente il mio parere, cautamente perplesso, su un uditore bravissima persona, ma caratterialmente non ancora adatto alla attribuzione delle funzioni, perché si ritennero prevalenti i pareri, tutti positivi, degli altri “magistrati di affidamento”, i quali avevano sbrigativamente esaurito il proprio compito. Conseguenza finale: le funzioni furono attribuite all’uditore, il quale mi tolse il saluto. Imparai così, per l’affinamento dell’esperienza, a “decrittare” i pareri, smussando gli aggettivi superlativi e cercando di estrarre, da qualche elemento scarso, una valutazione più attendibile. La faccenda che più mi irritava era che, in qualunque ufficio giudiziario, se chiedevi un elenco dei dieci migliori avvocati e dei dieci migliori magistrati ad entrambe le categorie, e con la garanzia dell’anonimato, in pochi secondi raccoglievi due elenchi, in grande parte, o addirittura in tutto, sovrapponibili. Finii il mio quadriennio al CSM e i miei contatti con il palazzo dei Marescialli furono molto radi; rimasi, però, quasi incredulo quando qualche amico e collega consigliere si lamentava della difficoltà, per usare un eufemismo, di avere elementi affidabili di valutazione quando bisognava procedere ad una comparazione tra richiedenti.
La cronica carenza, accettata quasi come una maledizione biblica, comportava, in un insopportabile circolo vizioso, che la discrezionalità valutativa diveniva difficilmente motivabile, perché poggiante su fondamenta fragili, oltretutto non difficilmente manipolabili. Così, secondo i casi, acquistava rilievo una varietà di esperienze professionali, che però a distanza di pochissime valutazioni diveniva un handicap di fronte ad una specializzazione derivante da identità di funzioni espletate per lunghissimo tempo, e via così (apparentemente e contraddittoriamente) motivando.
La situazione peggiorava lentamente, ma inesorabilmente, fino a giungere a quella attuale, che impietosamente svelano la carte dell’inchiesta di Perugia sul caso Palamara.
Parlare, però, soltanto di caso Palamara non è corretto e spiega soltanto la parte più appariscente del fenomeno. In realtà Palamara rispondeva ai tanti che si rivolgevano a lui per ottenere proprio quello “sviamento di potere”, in senso letterale, che abitava da non poco tempo le stanze e i corridoi di Palazzo dei Marescialli, con conseguenze disastrose sulla fiducia dei cittadini in questa specifica istituzione.
Per tornare al caso che ci occupa, su Meli (e sul Meli di turno) abbondavano le cronache, come racconto delle sue vicende professionali, ma difettava totalmente la storia, cioè un giudizio complessivo sulla sua “attitudine”, leggasi capacità, di affrontare efficacemente le caratteristiche dell’ufficio che aveva chiesto di poter dirigere. Non era difficile prevedere, per esempio, che l’esperienza delle indagini in pool, del tutto nuova, avrebbe trovato nell’anziano dirigente una ragionevole ostilità, perché fuori dal tran-tran consuetudinario degli uffici da lui frequentati.
In conclusione di questo capitolo, forse troppo lungo, ma in effetti di dimensioni insufficienti di fronte alla complessità del tema, nei poco più di sessanta anni di storia del Consiglio (per un esame “alto” della quale sento il dovere di invitare ad approfondire le considerazioni di Giorgio Lattanzi, Presidente della Corte Costituzionale) si è assistito, indifferentemente all’introduzione di un nuovo – e cattivo ordinamento giudiziario nel 2006, ad un allargamento della discrezionalità consiliare, ma senza il necessario irrobustimento degli elementi di valutazione, così che alcuni magistrati hanno approfittato, o cercato di approfittare, delle inevitabili smagliature del sistema, e la grande maggioranza della categoria non è riuscita ad opporre i necessari anticorpi, che pure poteva/doveva trarre dalla propria silenziosa dedizione ad un mestiere tanto difficile e impegnativo.
6) Si assistette ad una votazione nella quale i componenti delle correnti non votarono in maniera compatta. Quale significato si sente di attribuire a questo fatto storico? Ebbero, in altri termini, un peso rilevante le convinzioni personali dei consiglieri o prevalsero motivazioni espressive comunque, nella diversità delle opinioni, della normale dialettica dell’esercizio del governo autonomo della magistratura?
D'Ambrosio: La risposta a questa domanda è stata in buona parte anticipata nella risposta alla seconda domanda. Faccio notare, per completezza e sempre premettendo la mia posizione/valutazione personale, che alcune delle “posizioni non allineate” erano effetto di “atteggiamenti critici” all’interno dei gruppi di appartenenza (v. i voti di Calogero, D’Ambrosio, Racheli) mentre altri “voti anomali” si dovevano alla assoluta straordinarietà del caso (Ziccone, Caselli, Abate). Ritengo, infine, di poter rispondere negativamente all’ultima parte della domanda: il “caso Falcone” non può essere esaminato e catalogato come effetto della “normale dialettica dell’esercizio dell’autogoverno”. Di questo sono assolutamente convinto, pur non escludendo una dose apprezzabile di “buona fede” in chi votò per Meli, e non essendo a conoscenza di eventuali contatti “suggeritori”, del tutto plausibili. Resta, secondo me, ignorata la reale e completa identità delle “menti raffinatissime”, cui accennò Falcone a proposito del fallito attentato dell’Addaura, perché non mi sembra del tutto convincente la versione di Saverio Lodato, che riferisce l’ indicazione di Falcone a Bruno Contrada, sia perché l’accenno fu al plurale -“menti raffinatissime”- sia perché il retroscena eventuale della vicenda era troppo complesso per potere essere orchestrato da una sola persona.
7) Anche in quel caso si ventilò che l’adesione all’una o all’altra proposta avrebbe determinato uno scostamento dalla disciplina regolamentare. Allora come oggi si evocarono precedenti scelte per legittimare le rispettive posizioni. Cosa è cambiato negli anni successivi rispetto al tema delle scelte dei posti direttivi e semi-direttivi?
D'Ambrosio: Della scarsa vicinanza delle dichiarazioni di voto di quel giorno di gennaio alla “verità” ho scritto già. Della parziale o totale strumentalità dei richiami al rispetto, e delle lamentazioni per il mancato rispetto, di regole esistenti credo non possa esserci dubbio. Lo “strappo” alla regola essenziale in materia, su qualunque tavolo, che pretende una decisione secondo buon senso, non fu il primo, ed ovviamente nemmeno l’ultimo. Resta che fu il più grande, il più carico di conseguenze negative. Che si sono allargate fino ad oggi, in un panorama desolante, dal quale non sarà per nulla facile emergere. Si potrebbe, forse, cominciare da un paio di piccole regole, quali l’eliminazione delle c.d. “nomine a pacchetto”, provvedendo sempre a nomine singole, previe comparazioni singole, e il rispetto rigoroso dei termini temporali di scoperture delle sedi da ricoprire, senza decidere strumentali rinvii.
Poco, probabilmente, ma da una grande rovina si può ripartire soltanto con la ricostruzione di piccole parti di edifici imponenti.
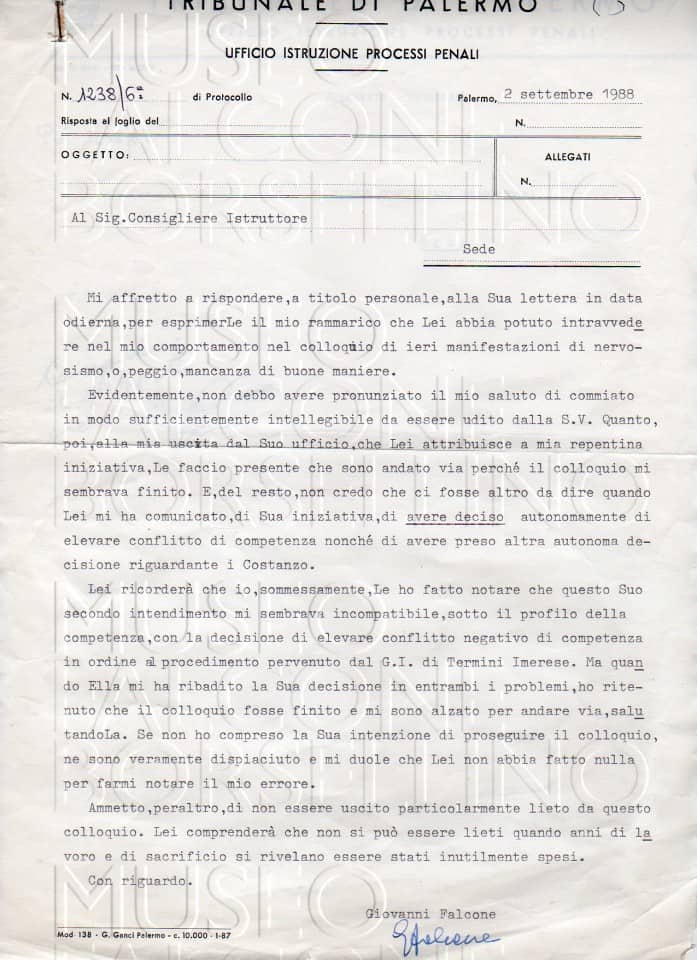
Trasferimento dati del visitatore di sito web tramite social plug-in e titolarità del loro trattamento. La forma della protezione dei dati - il caso Fashion id (nota a Corte giust. Ue, 29 luglio 2019, causa C-40/17)
di Federico Sartore
Corte giust. Ue, 29 luglio 2019, causa C-40/17 - Sez. II - Fashion ID GmbH & Co. KG c. Verbraucherzentrale NRW eV*
Privacy (tutela della) - Internet - Direttiva 95/46/CE, GDPR, e-privacy - Dati personali - Trasferimento su piattaforma social - Trattamento - Gestore sito - Titolarità.
(direttiva 95/46/ce, art. 2(d), art. 7(f), art. 7(a), art. 2(h), art. 10; regolamento (ue) 2016/679, art. 26)
1. Il gestore di un sito internet che implementa un social plug-in che trasferisca alla piattaforma social dati personali del visitatore, può essere considerato titolare del trattamento. Questa qualifica è tuttavia limitata all’operazione o all’insieme delle operazioni di trattamento dei dati personali per le quali il gestore determina effettivamente finalità e mezzi (nel caso di specie la raccolta e la comunicazione mediante trasmissione).
Privacy (tutela della) - Internet - Direttiva 95/46/CE, GDPR, e-privacy - Dati personali - Trasferimento su piattaforma social - Gestore sito - Fornitore di piattaforma social - Contitolarità - Legittimo interesse - Consenso.
2. Affinché i trattamenti di dati personali siano leciti nel caso di implementazione di un social plug-in, è necessario che sia il gestore del sito, sia il fornitore della piattaforma social perseguano ciascuno un legittimo interesse.
[v. Corte giust. Ue, 5 giugno 2018, C-210/16 Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein; Corte giust. Ue, 10 luglio 2018 C-25/17, Tietosuojavaltuutettu v. Jehovan todistajat]
Abstract
Analizzando una recente pronuncia della Corte di Giustizia, l’articolo ragiona sulla complessa conciliazione delle categorie giuridiche della protezione dei dati personali in un ambiente fortemente dematerializzato come quello online. In particolare, rispetto al delicato regime della contitolarità tra Direttiva 95/46/CE e Regolamento (UE) 2016/679. In conclusione, si affronta il tema, anche politico, dell’applicabilità della normativa in materia di protezione dei dati ai giganti del tech.
By analysing a recent case before the Court of Justice of the European Union, the paper focuses on the complex conciliation of legal categories of data protection in the highly dematerialized online environment. Particular attention is paid to the intricate legal regime of joint controllership, between Directive 95/46 / EC and Regulation (EU) 2016/679. Conclusions are devoted to the means of enforcement of data protection vis-à-vis the so-called data barons.
Sommario 1. Premessa. – 2. La vicenda e le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte. – 3. La legittimazione attiva delle associazioni di tutela dei consumatori. – 4. La (con)titolarità del trattamento di Fashion ID. – 5. Applicabilità della Direttiva e-Privacy e legittimo interesse. – 6. Trattamento dei dati in forza del consenso degli interessati. – 7. Riflessioni conclusive.
1. Premessa
Come è noto, il regime giuridico europeo posto a tutela dei dati personali ha trovato il suo primo statuto di dettaglio nella Direttiva 95/46/UE[1], il cui impianto concettuale e definitorio è stato poi sostanzialmente mutuato dal Regolamento (UE) 2016/679[2] (l’ormai celebre GDPR). Una volta delineato l’oggetto della tutela, il legislatore europeo del ’95 ha avuto il merito di risalire la corrente dei dati per strutturare i poli di responsabilità sui quali poggiare il sistema degli obblighi. Questa operazione di necessaria semplificazione ed astrazione ha portato all’elaborazione delle ben note figure di «titolare» e «responsabile» del trattamento[3]. Nel corso degli anni, la prassi applicativa e lo sviluppo tecnologico hanno sottoposto a notevoli torsioni concettuali la flessibilità di queste categorie, al punto che oggi l’interprete si trova quotidianamente dinanzi all’interrogativo circa la qualificazione più corretta da dare ai numerosi «soggetti dati» che si avvicendano e intersecano nella gestione e determinazione dei trattamenti di dati personali[4]. Anche le Autorità di sorveglianza, chiamate a svolgere il proprio ruolo di guida all’interpretazione del dettato normativo, hanno faticato a gestire in maniera lineare la qualificazione in concreto; utilizzando a volte criteri extra-testuali per risolvere le situazioni più controverse, facendo riferimento ad esempio alla percezione dell’utente e all’affidamento dell’interessato rispetto al contenuto delle attività di trattamento[5] ovvero, in altri casi, aderendo al dettato letterale del Regolamento e utilizzando come criterio determinante il fatto che si tratti di attività delegate all’esterno dell’organizzazione da parte del titolare del trattamento[6]. Diversamente da quest’ultima linea interpretativa, e solo a titolo di esempio, l’Information Commissioner Office britannico (ICO) ritiene che alcune professioni siano soggette ad obblighi deontologico-professionali tali da escludere in radice la possibilità di qualsivoglia forma di etero-direzione, configurandosi quindi in re ipsa come svolte da autonomi titolari del trattamento[7]. Al contempo, come si avrà modo di approfondire nel corso della trattazione, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (anche, CGUE) ha negli anni ritenuto preferibile l’adozione di un criterio teleologico, consistente nel garantire un livello elevato di protezione per i diritti e le libertà degli interessati, arricchendo implicitamente in questo modo la silhouette normativa delle disposizioni in materia dei dati secondo il principio per cui i casi di qualificazione controversa devono essere risolti nel senso di preferire la configurazione più tutelante per gli interessati. Piegando e subordinando così la qualificazione giuridica di (con)titolari e responsabili del trattamento a seconda delle menzionate necessità di tutela. Nel caso che si discute in questa nota, la Corte di giustizia UE ha confermato questa tendenza tipicamente orientata ai fini, esponendosi alle critiche di chi ha ritenuto superficiale l’analisi di una situazione di fatto caratterizzata dall’intrecciarsi di trattamenti di dati non facilmente distinguibili, sottovalutando (financo svilendo) la complessità e le modalità di funzionamento della tecnologia sottesa al caso di specie[8]. L’importanza e la complessità del ruolo svolto dalla Corte in questa pronuncia sono altresì confermati dal tenore e dalla vicinanza cronologica delle pronunce della medesima autorità in merito al significato da darsi in concreto alle definizioni di titolare e responsabile del trattamento[9]; senza dimenticare la recente emanazione di specifiche linee guida in materia da parte dello European Data Protection Supervisor (EDPS), l’autorità Garante per i trattamenti svolti dalle istituzioni europee[10].
Nel caso in analisi la CGUE ha dovuto confrontarsi con la qualificazione e il ruolo di contitolari del trattamento ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali[11]. In particolare, con riferimento alla relazione intercorrente tra il gestore di una pagina web ed il fornitore di un plug-in[12] incorporato all’interno della pagina stessa, nonché sui presupposti di liceità (anche detti basi giuridiche) di simili trattamenti di dati personali. Si sottolinea che le questioni sottese al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE riguardano l’interpretazione delle disposizioni dell’abrogata Direttiva 95/46/UE. Tuttavia, stante la sostanziale continuità giuridico-normativa tra Direttiva Madre e GDPR rispetto agli istituti descritti ed affrontati dalla Corte, le valutazioni svolte dai giudici di Lussemburgo trovano piena applicazione anche in riferimento al GDPR. Tuttavia, nel caso in cui le differenze tra regimi giuridici dovessero riverberarsi sulle conseguenze tratte dalla Corte, sarà cura di chi scrive sottolineare le sfumature, anche connesse al (parzialmente) mutato impianto concettuale di riferimento.
2. La vicenda e le questioni pregiudiziali sottoposte alla corte
Nel caso in analisi, la Fashion ID, un’impresa di abbigliamento moda online ha incorporato all’interno del proprio sito web il plug-in «Mi Piace» di Facebook, il noto social network. Per far funzionare queste tipologie di software, il gestore del sito principale deve includere al proprio sito internet un collegamento con il contenuto offerto dal fornitore del servizio. Nel momento in cui un visitatore chiede al proprio browser di mostrargli il sito in questione, la pagina web, mediante il collegamento, richiama il contenuto esterno e lo incorpora nella propria presentazione grafica (secondo le preferenze dei programmatori). Affinché ciò accada, il browser deve necessariamente comunicare al server del fornitore esterno l’indirizzo IP[13] del terminale dell’utilizzatore, i dati tecnici del browser medesimo oltre ad altre informazioni sul contenuto richiesto. Infatti, solo in questo modo il server può stabilire in quale formato il contenuto esterno debba essere inviato a tale indirizzo IP. Un’importante precisazione a livello tecnico riguarda il controllo del gestore del sito su raccolta e successiva utilizzazione delle informazioni raccolte da parte del fornitore del plug-in: infatti, il gestore che integra un plug-in all’interno del proprio sito non può verificare che dati il browser trasmetta e, ovviamente, nemmeno gli utilizzi successivi svolti dal terzo[14]. Un ultimo ed importante elemento da sottolineare riguarda l’ampiezza e consapevolezza della platea dei visitatori interessati dalla raccolta e trasmissione dei dati mediante il plug-in. Infatti, risulta che la trasmissione dei dati avviene a prescindere che il visitatore sia o meno iscritto al social network ovvero interagisca in alcun modo con il pulsante «Like» e, in ogni caso, senza che ne sia consapevole[15].
La vicenda giudiziaria da cui è originato il rinvio pregiudiziale alla Corte vedeva la Verbraucherzentrale NRV (associazione per la tutela dei diritti dei consumatori) contestare alla Fashion ID la trasmissione di dati personali dei visitatori a Facebook Ireland perché (a) avvenuta in assenza di manifestazioni di consenso e (b) in violazione degli obblighi informativi stabiliti dalla normativa in materia di protezione dei dati[16]. Al fine di veder cessare questo flusso di dati personali a favore di Facebook Ireland, la Verbraucherzentrale NRV proponeva un’azione di natura inibitoria nei confronti della Fashion ID, dinanzi al Landgericht Düsseldorf[17]. Interpellato, il Landgericht accoglieva solo in parte le pretese dell’associazione dei consumatori tedesca[18]. A sua volta, la parzialmente soccombente Fashion ID proponeva appello dinanzi all’Oberlandesgericht Düsseldorf. Contestualmente la Verbraucherzentrale NRV proponeva appello incidentale al fine di estendere la pronuncia favorevole ai capi esclusi[19].
Proprio l’Oberlandesgericht Düsseldorf, ritenuto di trovarsi dinanzi a questioni di interpretazione di normativa Ue, sospendeva il procedimento e sottoponeva alla Corte di Giustizia UE sei questioni pregiudiziali.
In particolare, il giudice a quo si è chiesto preliminarmente se (a) la Direttiva 95/46 ponesse limiti agli Stati Membri rispetto al riconoscimento ad associazioni per la tutela dei consumatori del diritto di agire in giudizio nei confronti degli autori di eventuali violazioni. Solo in caso di riscontro positivo alla prima questione, il giudice del rinvio ha interrogato la Corte con questioni di merito. Si è quindi domandato (b) se la Fashion ID potesse essere considerata, ai sensi dell’art. 2(d) della DPD, «titolare del trattamento» dei dati trasmessi a Facebook Ireland, pur non esercitando alcuna forma di dominio sulle operazioni di trattamento. Subordinatamente ad una risposta negativa alla seconda questione, alla Corte è stato richiesto (c) se la Direttiva dettasse una disciplina completa in materia di responsabilità (ostando infatti alla proposizione di azioni civili nei confronti di soggetti non titolari del trattamento e ugualmente coinvolti in processi di trattamento). Muovendo poi dalla qualificazione dei ruoli alla liceità dei trattamenti svolti, la Corte tedesca si è posta il problema di (d) quale fosse il legittimo interesse[20] perseguito [dal titolare] al fine di svolgere il bilanciamento richiesto dall’art. 7(f) della Direttiva[21]. Infine, alla Corte di Giustizia è stato chiesto (e) a chi dovrebbe essere eventualmente reso il consenso al trattamento dei dati previsto dall’art. 7(a) e 2(h) della DPD, nonché (f) se gli obblighi di trasparenza di cui all’art. 10 della Direttiva riguardassero anche Fashion ID – in quanto soggetto che aveva attivamente inserito il plug-in di Facebook, ponendosi quindi come antecedente causale al trattamento dei dati da parte di quest’ultima.
3. La legittimazione attiva delle associazioni di tutela dei consumatori
Come menzionato, la prima questione pregiudiziale affronta una tematica di natura procedurale, ossia la vincolatività in senso negativo o meno degli articoli 22, 23 e 24 della DPD rispetto a normative nazionali che consentano ad associazioni per la tutela dei consumatori di agire in giudizio contro il presunto autore di una lesione del diritto alla protezione dei dati[22]. Sebbene la questione non sia triviale – anche perché la Direttiva non contiene previsioni esplicite in questo senso – bisogna sottolineare che la Corte si è già espressa in passato in connessione a procedimenti intentati da associazioni dei consumatori[23]. Alla legittima precisazione secondo cui la Corte in dette occasioni non sarebbe stata investita direttamente della questione interpretativa può ribattersi che la stessa avrebbe potuto in ogni caso, magari in forma di obiter dicta, sollevare qualche dubbio sulla sussistenza della legittimazione attiva in capo all’associazione, eventualità mai verificatasi.
In sintesi, la Corte ribadisce il principio chiave della propria giurisprudenza in materia di protezione dei dati, ossia che uno degli obiettivi della DPD è quello di garantire una tutela efficace e completa dei diritti e delle libertà delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali[24]. In secondo luogo, la Corte chiarisce correttamente che l’assenza di previsione espressa non può in alcun caso ritenersi equivalente ad un divieto, di modo che l’assenza di norme esplicite in senso positivo non fanno venir meno la possibilità per i legislatori nazionali di contemplare le associazioni per la tutela dei consumatori nel novero dei legittimati attivi in questioni aventi ad oggetto la protezione dei dati. Da ultimo, ricollegandosi concettualmente al menzionato principio di tutela efficace e completa, la pronuncia ribadisce l’ampio margine di discrezionalità lasciato agli Stati membri per il perseguimento degli obiettivi tracciati dalla Direttiva Madre[25]. Da ciò ne consegue il carattere non ostativo del dettato normativo della Direttiva rispetto alla legittimazione attiva delle associazioni dei consumatori prevista ai sensi degli ordinamenti nazionali[26].
In merito alla prima questione si sottolinea la scarsa rilevanza pratica del tema in ottica futura: infatti, il neo-introdotto art. 80(2) del GDPR contempla in maniera esplicita tale possibilità per gli stati membri[27]. Tuttavia, come sottolinea Globocnik, non è escluso che la risposta della Corte possa avere un più ampio respiro in materia di protezione del consumatore e pratiche commerciali scorrette[28]. Infatti, la decisione chiarisce che il fatto che la Direttiva non rientri tra le direttive elencate dall’Allegato I della Direttiva 2009/22/CE[29] non preclude la possibilità per gli Stati Membri di introdurre norme che garantiscano la legittimazione attiva alle associazioni poste a tutela dei consumatori. In senso maggiormente tecnico, la Corte ha chiarito che la Direttiva 2009/22/CE, ai sensi dell’art. 7 della medesima, non ha operato un’armonizzazione esaustiva, lasciando quindi anch’essa ampio margine di discrezionalità agli Stati Membri[30]. Dello stesso avviso si è dimostrato l’avvocato generale Bobek, il quale ha sottolineato la sorpresa che avrebbe generato una conclusione opposta – che avrebbe quindi interpretato l’elenco esemplificativo contenuto nell’Allegato I della Direttiva 2009/22/CE nel senso di privare gli stati membri della loro potestà di scelta in merito a come dare attuazione alla DPD, come invece previsto dall’art. 288 del TFUE[31].
4. La (con)titolarità del trattamento di Fashion id
Dopo aver esaurito con esito positivo la disamina della prima questione, di natura marcatamente procedurale, la Corte si è apprestata ad affrontare il tema centrale della decisione: se la Fashion ID, per il fatto di inserire un plug-in social che consente di trasferire a Facebook dati personali del visitatore, possa essere considerato titolare del trattamento[32].
Rispetto al nucleo centrale del tema a sua volta centrale, la Corte si muove sicura nel solco tracciato dalle proprie decisioni precedenti sullo stesso tema. Infatti, ricordato che la nozione di titolare del trattamento deve essere interpretata estensivamente al fine di garantire l’elevato grado di tutela dei diritti di cui sopra[33], la Corte conferma la conclusione a cui era giunta nel caso Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein – quando aveva stabilito che l’amministratore di una pagina Facebook è titolare dei dati che raccoglie congiuntamente al social network[34]. Tuttavia, così come fatto nel caso Jehovan todistajat, i giudici aggiungono ulteriori elementi al ragionamento logico-giuridico svolto in Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein. In primo luogo, la Corte non ritiene più così essenziale la valutazione di chi stabilisca i parametri del trattamento, elemento che aveva giocato un ruolo preminente nel valutare la titolarità dell’amministratore della pagina, che era infatti in grado di influenzare le categorie di dati raccogliende[35]. Infatti, è stata ritenuta sufficiente e determinante la possibilità di Fashion ID di inserire o meno il plug-in di Facebook all’interno del proprio sito, quasi come se si trattasse di un interruttore, che non ammette modulazioni tra on e off[36]. Successivamente, la Corte effettua il test di contitolarità rilevando la contestuale presenza di determinazione congiunta di mezzi e finalità da parte di Fashion ID e Facebook[37]. Il secondo movimento di differenziazione rispetto a Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein riguarda i limiti alla responsabilità del gestore del sito internet, circoscritti alla raccolta e alla comunicazione mediante trasmissione dei dati[38].
Proprio sul tema dei confini della responsabilità tra le parti si confrontano come antagoniste le esigenze di tutela perseguite dalla Corte nel suo ruolo quasi-legislativo e la ricerca di soluzioni stilisticamente più eleganti e aderenti alla lettera della DPD (e del Regolamento). Infatti, la Corte, distanziandosi dal mero atteggiamento ricognitivo mostrato in Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein, ci tiene a spiegare che l’esistenza di una responsabilità congiunta non implica necessariamente una responsabilità equivalente.
È avviso di chi scrive che a questo punto si crei una sorta di cortocircuito nel ragionamento dei giudici di Lussemburgo. Infatti, la CGUE prima spiega che «[i contitolari] possono essere coinvolti in fasi diverse di tale trattamento e a diversi livelli, di modo che il grado di responsabilità di ciascuno di essi deve essere valutato tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti del caso di specie»; poi tuttavia aggiunge che «le operazioni di trattamento di dati personali di cui la Fashion ID, congiuntamente con la Facebook Ireland, può determinare le finalità e gli strumenti sono, […], la raccolta e la comunicazione mediante trasmissione dei dati personali dei visitatori del suo sito Internet». Considerando che (i) la finalità per cui la Fashion ID trattava i dati, ossia l’incorporazione del plug-in di Facebook all’interno della propria pagina web, non poteva essere raggiunta con le mere operazioni di raccolta e comunicazione dei dati[39] e che (ii) la Corte ha ribadito la propria massima secondo cui la responsabilità congiunta di vari soggetti per un medesimo trattamento, ai sensi di tale disposizione, non presuppone che ciascuno di essi abbia accesso ai dati[40], la naturale conseguenza sarebbe stata estendere la (con)titolarità della Fashion ID ad ogni operazione di trattamento dati necessaria al caricamento del plug-in. Tuttavia, così facendo si sarebbe probabilmente perso un criterio certo per delimitare le reciproche sfere di responsabilità. Il ragionamento seguito dalla Corte per giungere al proprio riparto di responsabilità è spiegato con dovizia di particolari dall’AG Bobek, il quale, ricordando che nel diritto moderno la responsabilità oggettiva deve essere concepita come eccezione giustificata, spiega per immagini che grandi responsabilità devono essere associate a grandi poteri[41].
A questo punto la Corte avrebbe potuto abbracciare integralmente le premesse dell’AG Bobek, utilizzando la signoria effettiva sulle operazioni di trattamento come criterio di allocazione di ruoli e responsabilità ovvero avrebbe potuto estendere l’ambito della contitolarità a tutti i trattamenti necessari al raggiungimento del fine condiviso, a prescindere dal potere effettivo, utilizzando poi detto criterio per una ripartizione (a questo punto non graficabile) della responsabilità reciproca tra le parti. La Corte ha stranamente deciso di incrociare queste due linee argomentative, giungendo ad una conclusione ibrida e, per questo motivo, criticabile. Infatti, ha usato il criterio del potere sulle operazioni non tanto per delimitare le responsabilità ma per segnare con un tratto di penna il limite esterno della contitolarità. La conclusione a cui giunge la Corte potrebbe anche essere ritenuta coerente, a patto di passare dal regime di contitolarità a quello di autonoma titolarità del trattamento. Infatti, la netta cesura rappresentata dalla comunicazione dei dati a Facebook ben potrebbe sposarsi con una configurazione dei ruoli che vedesse la Fashion ID raccogliere i dati e comunicarli ad un altro titolare del trattamento per il perseguimento ciascuno delle proprie finalità (che infatti la Corte identifica come distinte). Tuttavia, così facendo si sarebbe dovuto contraddire (correttamente) l’estensione del regime di contitolarità operato negli anni dalla giurisprudenza UE.
Diversamente, un’interpretazione che avesse ravvisato l’unicità del fine e dei mezzi tra le parti avrebbe dovuto estendere l’ambito dei trattamenti in contitolarità fino al completo caricamento del plug-in, non arrestandosi quindi alla comunicazione dei dati da Fashion ID a Facebook Ireland. In questa seconda configurazione i confini della responsabilità sarebbero stati sicuramente più sfuggevoli da identificare ma comunque ipotizzabili come asimmetrici in ragione dei diversi ruoli svolti tra le parti.
Provando a speculare sulle ragioni della Corte, è innegabile che limitare l’ambito di responsabilità della Fashion ID alle operazioni di raccolta e comunicazione dei dati fornisce un quadro applicativo chiaro per tutti i gestori di siti che implementano al proprio interno social plug-in. Tuttavia, il rischio che si corre è quello di trascurare le complessità (e l’opacità) delle operazioni necessarie al caricamento del plug-in sul browser del visitatore. Pur comprendendo le esigenze di tutela che hanno guidato i giudici europei, nonché le difficoltà di convivenza tra le categorie definitorie della DPD e l’ambiente online, è innegabile che la scelta di impostare teleologicamente le proprie decisioni porti necessariamente la Corte a dover incappare in alcune (più o meno apprezzabili) contraddizioni – che rendono più complessa l’attività di analisi e allocazione del rischio da parte di attori economici e interpreti nazionali.
5. Applicabilità della direttiva e-privacy e legittimo interesse
Dismessa per irrilevanza la terza questione pregiudiziale, la Corte è chiamata a spiegare se in un caso come in quello in analisi il giudice a quo debba indagare la sussistenza del legittimo interesse perseguito dal gestore del sito ovvero dal social network, al fine di valutare la liceità o meno del trattamento.
Come primo passaggio logico-argomentativo, la CGUE ritiene sia compito del giudice del rinvio verificare se la Facebook Ireland avesse accesso a informazioni archiviate nell’apparecchiatura terminale, ai sensi dell’art. 5(3), della Direttiva 2002/58/CE[42] (la Direttiva e-Privacy)[43]. In questo modo la Corte purtroppo fa un passo di lato, decidendo di non fornire la propria opera ermeneutica rispetto alla disciplina speciale dettata dalla Direttiva e-Privacy. Il dibattito sul punto è stato molto acceso e, anche in ragione della complessa gestazione che sta vivendo il processo di riforma della e-Privacy[44], si ritiene importante toccare tangenzialmente la questione[45]. Secondo la Commissione, infatti, la questione posta alla Corte è irrilevante poiché il consenso dell’utente deve essere in ogni caso prestato[46]. Tuttavia, l’AG e ed il collegio giudicante ritengono che poiché i dati trasmessi non si limitano necessariamente ad informazioni archiviate sui terminali degli utenti, la questione circa l’applicabilità di una base giuridica «generale» ai sensi della DPD non possa essere elusa.
Ciò chiarito, la decisione ricorda cosa si intenda per legittimo interesse del titolare o di terzi e come debba essere applicato per costituire una base giuridica per il trattamento[47]. Tanto chiarito, la CGUE giunge sbrigativamente alla conclusione per cui in una situazione come quella del caso di specie è necessario che ciascuno dei titolari persegua un interesse legittimo autonomo al fine di poter addurre una giustificazione per dette operazioni di trattamento. Tuttavia, una volta data risposta al quesito del giudice a quo, effettivamente non particolarmente ispirato, la Corte non fornisce ulteriori elementi di guida sulla natura di detti interessi legittimi – i quali saranno da valutare da parte della Corte tedesca.
6. Trattamento dei dati in forza del consenso degli interessati
Con la quinta e la sesta questione, affrontate congiuntamente dalla Corte, si rimane nella sfera della liceità del trattamento, sub specie consenso[48]. Inoltre, si discute su quale soggetto insistano gli obblighi di informativa.
Anche in questo caso, la risposta della Corte è estremamente sbrigativa, oltre che poco propensa a comprendere le complessità di natura pratica connesse al mondo online. Infatti, la CGUE, sostenendo che (i) il consenso deve essere espresso prima della raccolta e della comunicazione mediante trasmissione dei dati, che (ii) spetta al gestore del sito ottenere tale consenso e che (iii) quest’ultimo copre unicamente i trattamenti per cui il gestore determina finalità e mezzi, costringe i soggetti coinvolti in situazioni assimilabili a quella in analisi a duplicare gli oneri di raccolta del consenso e di informativa. Inoltre, pare sorprendente quanto la Corte non tenga (o non voglia tenere) in considerazione che la trasmissione dei dati al fornitore del social plug-in è contestuale alla pressione del comando di caricamento della pagina web da parte dell’utente. Bisognerebbe quindi costringere i gestori delle pagine internet a bloccare il caricamento di determinati elementi fino all’ottenimento del consenso specifico dell’utente in tal senso. Inoltre, per il vizio logico già discusso secondo cui (a) la Fashion ID determina finalità e mezzi di raccolta e trasmissione, (b) altre operazioni di trattamento sono necessarie da parte di Facebook per il corretto caricamento del plug-in e (c) il consenso dell’utente copre unicamente raccolta e trasmissione, il caricamento del plug-in richiederebbe due consensi – il primo per raccogliere e comunicare i dati a Facebook e il secondo per condurre ogni ulteriore e necessaria operazione da parte di Facebook al fine di caricare correttamente il plug-in –. Basta anche una scarsa dimestichezza con il mondo online per comprendere la totale inadeguatezza di un processo del genere rispetto alle esigenze degli operatori economici e alle aspettative degli utenti.
A onor del vero, bisogna rammentare che non si tratta del c.d. consenso cookie e che la possibilità di far leva sugli altri presupposti di legittimità del trattamento (in particolare del citato legittimo interesse del titolare o di un terzo) rende la discussione estremamente teorica.
Per quanto parallelamente riguarda gli obblighi di informativa (molto simili tra DPD e GDPR), l’enfasi posta dalla CGUE è minima: la Corte affronta infatti congiuntamente le due questioni, limitandosi a rammentare che così come il consenso dovrà essere raccolto unicamente per le fasi di trattamento di cui il gestore determina finalità e mezzi, alle sole e medesime fasi è circoscritto ogni obbligo informativo.
7. Riflessioni conclusive
Provando a guardare al di là della coltre di fumo del tecnicismo giuridico, bisogna sicuramente riconoscere che la decisione della Corte nel caso Fashion ID avrà un’eco non solo mediatica, ma anche pratico-applicativa. Infatti, l’integrazione dei siti web mediante contenuti di terza parte è una realtà estremamente ramificata e di complessa catalogazione: basti pensare, oltre ai social network, ad ogni plug-in che contenga una mappa o delle previsioni del tempo. Inoltre, non bisogna dimenticare, anche in ottica futura, la peculiarità dei dati oggetto di trattamento nella fattispecie in esame. Infatti, l’indirizzo IP dinamico rientra nella categoria di dati che hanno necessitato l’intervento della stessa CGUE per essere ritenuti personali, vista la necessità di combinarli con altri dati[49]. Si aggiunga inoltre che tali dati semi-personali (non nel senso che rappresentino una nuova categoria ma semplicemente che siano personali al ricorrere di condizioni aggiuntive ed estrinseche) sono trattati in un ambiente caratterizzato da logiche imposte più da ragioni di funzionalità ed efficienza delle macchine che da profondi ragionamenti sul corretto design giuridico dei flussi di dati. Sicuramente la decisione in commento segna un ulteriore passo verso la riconciliazione tra la linearità[50] del modello di regolamentazione scelto per la protezione dei dati e la realtà economica dell’economia c.d. data-driven.
Dall’altro lato, come discusso, non può negarsi una certa perplessità sulle modalità argomentative scelte dalla Corte, nonché sulla solidità logico-giuridica delle conclusioni. La sensazione è che le esigenze di tutela e certezza dei ruoli tra le parti abbiano prevalso sulla chiarezza e linearità della ricostruzione. Inoltre, non vanno trascurate le complessità di enforcement nei confronti delle big tech companies; la tendenza delle associazioni dei consumatori come la Verbraucherzentrale NRV è infatti quella di preferire l’azione nei confronti di soggetti relativamente più piccoli, come la Fashion ID, al fine di raggiungere indirettamente Facebook mediante le interconnessioni di natura tecnologica tra le parti[51]. In ogni caso, dalla Corte di giustizia ci si sarebbe potuti attendere un maggior rigore nella ricostruzione dei ruoli tra le parti. Infatti, con il passaggio dalla disciplina embrionale della DPD in materia di contitolarità del trattamento a quella più di dettaglio del GDPR[52] il mondo dei titolari del trattamento, con particolare riguardo ai gruppi industriali, è alla ricerca di preziosi elementi interpretativi da parte delle autorità e delle Corti. A tale proposito è importante ricordare che alla contitolarità, anche asimmetrica, è associato il regime della responsabilità in solido nei confronti degli interessati: ciò si traduce in maggiori tutele (teoriche) per gli interessati e in contestuali maggiori rischi per i soggetti dati convolti nelle operazioni di trattamento[53].
Inoltre, anche se per ragioni in fondo condivisibili, ci si rammarica che la tematica dell’applicabilità e dei limiti della direttiva e-Privacy sia stata solo sfiorata dalle valutazioni dei giudici di Lussemburgo. In ogni caso, la decisione della Corte nel caso Fashion ID sta facendo e farà discutere animatamente pratici e teorici della protezione dei dati. Proprio per questo, oltre alla centralità dei temi trattati, è molto probabile diventi un parametro di riferimento per lo sviluppo della giurisprudenza in materia.
[1] Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; anche detta Direttiva Madre o Data Protection Directive (DPD).
[2] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). Sulla sostanziale continuità tra categorie cfr. ex multis Passaglia, Privacy e nuove tecnologie, un rapporto difficile. Il caso emblematico dei social media tra regole generali e ricerca di una specificità, in Consulta online, 3, 2016, 7.
[3] Come è noto, per questioni di traduzione e trasposizione normativa il testo (italiano) della Direttiva e, di rimando, le pronunce della CGUE fanno riferimento al data controller indicandolo come responsabile del trattamento e al data processor indicandolo come incaricato. Tuttavia, fin dal primo recepimento della DPD mediante la l. n. 675/1996, il legislatore italiano ha tradotto data controller con l’espressione «titolare del trattamento» e data processor come «responsabile del trattamento». La traduzione ufficiale del GDPR ha quindi mutuato questa nomenclatura ormai invalsa nel nostro paese. Si precisa quindi che in questa nota si utilizzerà la nomenclatura corretta, attualmente in uso da parte del GDPR. In realtà, si ritiene che la traduzione originaria sia più allineata al significato della terminologia di lingua inglese. Questa, infatti, associa al termine controller una forma di dominio (e quindi di responsabilità) sui dati personali; mentre il ruolo di processor, mero «masticatore» di dati e giuridicamente privo di un’autonoma volontà, ben si sposerebbe con il termine di «incaricato del trattamento». Tuttavia, vista l’introduzione dell’autonoma figura dell’incaricato del trattamento nel panorama italiano (la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile), è stato necessario introdurre un nuovo termine, ossia quello di «titolare». Sul punto, v. anche Pizzetti, Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. Dalla Direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo, Torino 2016, 196; e Kirschen, Codice della Privacy, tradizione ed innovazione, in R. Panetta (a cura di), Libera circolazione e protezione dei dati personali, Milano 2006.
Il Garante italiano ha affrontato il tema fin dalla propria istituzione, «Titolare, responsabile, incaricato - Precisazioni sulla figura del “titolare”» - 9 dicembre 1997, doc. web n. 39785.
[4] Si ricorda che per «dato personale» deve intendersi: «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (detta «interessato»)». Ai sensi del GDPR, «si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale».
Per quanto invece riguarda le operazioni manipolative dei dati, si definisce «trattamento» «qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione».
[5] Il Garante si è espresso in tal senso, inter alia, nel Provv. n. 230 del 15 giugno 2011 - Titolarità del trattamento di dati personali in capo ai soggetti che si avvalgono di agenti per attività promozionali. Per giungere a tale conclusione si fa riferimento ai criteri indicati dall’Opinion 1/2010 sui ruoli di «titolare» e «responsabile» del trattamento, emanata dal WP29. In questa sede il Gruppo di lavoro ex art. 29 ha chiarito che ai fini dell’individuazione della titolarità concretamente esercitata occorre esaminare anche «elementi extracontrattuali, quali il controllo reale esercitato da una parte, l’immagine data agli interessati e il legittimo affidamento di questi ultimi sulla base di questa visibilità». Sulla natura non formale del concetto di titolare, Finocchiaro, Privacy e protezione dei dati personali. Disciplina e strumenti operativi, Bologna, 2012, 80 s.
[6] Cfr. sul punto la Risposta del Garante a un quesito relativo al ruolo del consulente del lavoro dopo la piena applicazione del Regolamento (UE) 679/2016 del 22 gennaio 2019. Nel caso di specie il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro aveva interpellato l’autorità per ottenere chiarimenti circa il ruolo dei consulenti. L’Autorità, in maniera forse eccessivamente netta, ha tracciato come linea di demarcazione il fatto che si tratti di attività delegate o meno dal cliente (eventualmente) titolare del trattamento al fornitore di servizi (a prescindere dalla natura degli stessi), il quale agirebbe quindi come responsabile del trattamento senza che le valutazioni in merito al margine di autonomia connesso alla professione o funzione di volta in volta svolte assumano un significato giuridico.
[7] V. Information Commissioner Office, What are ‘controllers’ and ‘processors’?, in https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/controllers-and-processors/what-are-controllers-and-processors.
L’esempio dell’ICO affronta il caso dei commercialisti ed esperti contabili: «A firm uses an accountant to do its books. When acting for his client, the accountant is a controller in relation to the personal data in the accounts. This is because accountants and similar providers of professional services work under a range of professional obligations that oblige them to take responsibility for the personal data they process. For example, if the accountant detects malpractice while doing the firm’s accounts he may, depending on its nature, be required under his monitoring obligations to report the malpractice to the police or other authorities. In doing so, an accountant would not be acting on the client’s instructions but in line with his own professional obligations and therefore as a controller in his own right.
If specialist service providers are processing data in line with their own professional obligations, they will always be acting as the controller. In this context, they cannot agree to hand over or share controller obligations with the client».
[8] Globocnik, On Joint Controllership for Social Plug-ins and Other Third-Party Content - A Case Note on the CJEU Decision in Fashion ID, in IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law (2019) 50: 1033-1044.
[9] Cfr. in particolare le decisioni Corte giust. Ue, 13 maggio 2014, causa C-131/12, Google Spain e Google; Corte giust. Ue, 5 giugno 2018, causa C-210/16 Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein; Corte giust. Ue, 10 luglio 2018, causa C-25/17, Tietosuojavaltuutettu v. Jehovan todistajat. In merito a quest’ultima si segnala inelegantemente Panetta-Sartore, Proselitismo religioso e protezione dei dati personali: tra esigenze di tutela e particolarità della fattispecie, in questa Rivista, 2019, 101 ss.
[10] European Data Protection Supervisor, EDPS Guidelines on the concepts of controller, processor and joint controllership under Regulation (EU) 2018/1725 - 7 novembre 2019.
[11] Sul tema della contitolarità cfr. ex plurimis D’Ottavio, Ruoli e funzioni privacy principali ai sensi del Regolamento, in Panetta (a cura di), Circolazione e protezione dei dati personali, tra libertà e regole del mercato, Milano, 2019; Bassini, Data Controller: A Shifting Paradigm in the Digital Age, in Bocconi Legal Papers , 13, 2019, 103 ss.; Pelino, I soggetti del trattamento, in Bolognini-Pelino-Bistolfi (a cura di), Il regolamento privacy europeo, Milano, 2016, 133 ss.; L. Greco, I ruoli: titolare e responsabile, in Finocchiaro (a cura di), Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali, Bologna, 2017, 251 ss.; Salvati, Art.26, in Riccio-Scorza-Belisario (a cura di), GDPR e normativa privacy, Padova, 2018, 258 ss.; Zipponi, Art. 26 , in Bolognini-Pelino (a cura di), Codice della disciplina privacy, Milano, 2019, 206 ss.
[12] Si tratta di software per computer in grado di aggiungere nuove funzioni a un programma ospite senza alterarne la natura.
[13] Si ricorda che la Corte ha stabilito che, al ricorrere di determinate circostanze, un indirizzo IP deve essere considerato alla stregua di un dato personale. Sul punto cfr. Corte giust. Ue, 29 luglio 2019, causa C-582/14, Breyer, punti 33-49.
[14] Corte giust. Ue, 29 luglio 2019, causa C-40/17, Fashion ID, punto 26, in commento.
[15] Corte giust. Ue, 29 luglio 2019, causa C-40/17, Fashion ID, punto 27, in commento.
[16] Corte giust. Ue, 29 luglio 2019, causa C-40/17, Fashion ID, in commento, punto 28.
[17] Corte giust. Ue, 29 luglio 2019, causa C-40/17, Fashion ID, in commento, punto 29.
[18] Corte giust. Ue, 29 luglio 2019, causa C-40/17, Fashion ID, in commento, punto 30.
[19] Corte giust. Ue, 29 luglio 2019, causa C-40/17, Fashion ID, in commento, punto 31.
[20] Come nel caso discusso alla nota 3, il traduttore della direttiva in italiano ha trasposto legitimate interest con l’espressione «interesse legittimo», forse inconsapevole del significato di questo binomio nel diritto italiano. Per questo motivo, contrariamente al testo tradotto della pronuncia in esame, si utilizzerà la più corretta (ancorché ambigua) espressione «legittimo interesse», adoperata anche dal traduttore del GDPR.
[21] Sul fatto che si tratti o meno di bilanciamento in senso stretto si è aperto un interessante dibattito, riguardo al quale si segnala Van der Sloot, Editorial, in European Data Protection Law Review, 1, 2017.
[22] L’art. 22 della Direttiva stabilisce che: «[f]atti salvi ricorsi amministrativi che possono essere promossi, segnatamente dinanzi all'autorità di controllo di cui all'articolo 28, prima che sia adita l'autorità giudiziaria, gli Stati membri stabiliscono che chiunque possa disporre di un ricorso giurisdizionale in caso di violazione dei diritti garantitigli dalle disposizioni nazionali applicabili al trattamento in questione».
[23] Ex multis, può menzionarsi Corte giust. Ue, 28 luglio 2016, causa C-191/15, Verein für Konsumenteninformation.
[24] Corte giust. Ue, 29 luglio 2019, causa C-582/14, Breyer, punto 50.
[25] Ivi, punti 47-49.
[26] Ivi, punto 63.
[27] È previsto infatti che «[g]li Stati membri possono prevedere che un organismo, organizzazione o associazione [i cui obiettivi statutari siano di pubblico interesse e che sia attiva nel settore della protezione dei diritti e delle libertà degli interessati con riguardo alla protezione dei dati personali], indipendentemente dal mandato conferito dall'interessato, abbia il diritto di proporre, in tale Stato membro, un reclamo all'autorità di controllo competente, e di esercitare i diritti di cui agli articoli 78 e 79, qualora ritenga che i diritti di cui un interessato gode a norma del presente regolamento siano stati violati in seguito al trattamento».
[28] Globocknik, op. cit., 1035.
[29] Direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori.
[30] Nota 13, punto 61.
[31] Conclusioni dell’Avvocato Generale Michal Bobek, 19 dicembre 2018, causa C-40/17, Fashion ID, punto 38.
[32] Gli artt. 2(d) della DPD e 4(n.7) del GDPR sono allineate nel ritenere che il titolare del trattamento sia il soggetto che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.
[33] Giova incidentalmente ricordare che il sistema degli obblighi e delle responsabilità in materia di protezione dei dati personali è ancorato alla qualificazione di un soggetto quale titolare, ovvero responsabile del trattamento. In assenza delle diverse forme di controllo sui dati connesse a tali qualifiche, l’ordinamento europeo non impone obblighi, né muove rimproveri. Ciò tuttavia non vuol dire che operazioni di trattamento (in senso atecnico) escluse dall’ambito da applicazione del Regolamento siano prive di tutela; semplicemente, troveranno applicazione le norme generali in materia di responsabilità (extra)contrattuale.
[34] Cfr. i commenti di De Gregorio, Social network, contitolarità del trattamento e stabilimento: la dimensione costituzionale della tutela dei dati personali tra vecchie e prospettive passate e future, in Dir. inf. inform., 2018, 462; Marcello, Responsabilità e corresponsabilità nel trattamento dei dati personali, in Giustiziacivile.com, 2018.
[35] Corte giust. Ue, 5 giugno 2018, causa C-210/16, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein, punto 36.
[36] Nota 13, punti 76-78.
[37] Per quanto concerne gli strumenti (o mezzi) del trattamento, la Corte spiega che «la Fashion ID sembra aver inserito sul suo sito Internet il pulsante “Mi piace” di Facebook messo a disposizione dei gestori di siti internet da parte della Facebook Ireland, pur essendo consapevole del fatto che lo stesso serve da strumento di raccolta e di trasmissione di dati personali dei visitatori di tale sito, indipendentemente dal fatto che essi siano o meno iscritti al social network Facebook» (punto 77). Per quanto riguarda le finalità, la CGUE ritiene che «l’inserimento da parte della Fashion ID del pulsante “Mi piace” di Facebook nel suo sito Internet le consenta di ottimizzare la pubblicità per i suoi prodotti rendendoli più visibili sul social network Facebook quando un visitatore del suo sito internet clicca su detto pulsante»; dall’altro lato, Facebook «ottiene come contropartita negoziale il fatto di poter disporre di tali dati ai propri fini commerciali».
[38] Nota 13, punto 85.
[39] Lo spiega bene Globocnik, op. cit., 1037.
[40] Corte giust. Ue, 10 luglio 2018, causa C-25/17, Tietosuojavaltuutettu v. Jehovan todistajat, cit., punto 69.
[41] Il riferimento dell’AG è più raffinato, ricordando alla nt. 42 delle sue conclusioni che «La responsabilità senza potere [è] la prerogativa dell’eunuco nei secoli», citando Sir Humphrey Appleby (che a sua volta citava l’anonimo) in Yes, Prime Minister, Stagione 2, Episodio 7.
[42] Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche.
[43] Nota 13, punto 90.
[44] Nel 2017 è stata resa nota la volontà delle istituzioni europee di procedere alla riforma della Direttiva e-Privacy da coordinarsi, in quanto lex specialis, con l’appena approvato GDPR. Il punto sicuramente centrale, che sta infatti rallentando i lavori, è la regolamentazione dei c.d. servizi Over-the-Top (OTTs). Ad oggi, la posizione del Consiglio è stata rigettata dal Coreper e nel 2020 la Commissione dovrà decidere se ritirare la proposta o rimaneggiarla radicalmente.
[45] L’AG Bobek riporta che vi è stato un ampio dibattito in udienza sul punto. Conclusioni dell’Avvocato Generale Michal Bobek, 19 dicembre 2018, C-40/17, Fashion ID, punto 115.
[46] L’art. 5(3) della Direttiva e-Prvacy, gli Stati membri devono assicurare «l’uso di reti di comunicazione elettronica per archiviare informazioni o per avere accesso a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un abbonato o di un utente sia consentito unicamente a condizione che l'abbonato o l'utente interessato sia stato informato in modo chiaro e completo, tra l'altro, sugli scopi del trattamento in conformità della direttiva 95/46/CE e che gli sia offerta la possibilità di rifiutare tale trattamento da parte del titolare del trattamento». Si tratta del noto «consenso cookie», trasposto il Italia dall’art. 122 del d.lgs. n. 196/2003 del 30 giugno 2003 (il «Codice privacy»). La scivolosa disciplina sui cookies è stata poi integrata dall’intervento chiarificatore del Garante con il Provv. Generale dell’8 maggio 2014 - Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l´uso dei cookie.
[47] V. nt. 19 e 20.
[48] V. ex plurimis Solove, Privacy Self-Management and the Consent Dilemma, in 126 Harv. L. Rev. (2013).
[49] Espandendo quanto accennato in nt. 12, nella causa C-582/14, Breyer la Corte ha spiegato che in «[U]n indirizzo di protocollo Internet (indirizzo IP) dinamico registrato da un fornitore di servizi di media online in occasione della consultazione, da parte di una persona, di un sito Internet che tale fornitore rende accessibile al pubblico costituisce, nei confronti di tale fornitore, un dato personale ai sensi di detta disposizione, qualora detto fornitore disponga di mezzi giuridici che gli consentano di far identificare la persona interessata grazie alle informazioni aggiuntive di cui il fornitore di accesso a Internet di detta persona dispone» (punti. 44-49).
[50] Tene, Privacy law’s midlife crisis: a critical assessment of the second wave of global privacy laws, in 74 Ohio State Law J, 1219.
[51] Cfr. sul panorama tedesco, Globocnik, op. cit., 1042.
[52] L’art. 26 del GDPR prevede in particolare che i contitolari «determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14, a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti».
[53] A mente dell’art. 82 del GDPR, «[q]ualora più titolari del trattamento o responsabili del trattamento oppure entrambi il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento siano coinvolti nello stesso trattamento e siano, ai sensi dei paragrafi 2 e 3, responsabili dell'eventuale danno causato dal trattamento, ogni titolare del trattamento o responsabile del trattamento è responsabile in solido per l'intero ammontare del danno, al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato».
La Cassazione Civile. Lezioni dei magistrati della Corte suprema italiana (terza edizione), a cura di Acierno, Curzio e Giusti
Recensione di Bruno Capponi
La terza edizione de La Cassazione Civile sviluppa un numero di pagine quasi doppio rispetto alla prima (Cacucci, Bari, 2011). Rispetto alla seconda edizione (Cacucci, Bari, 2015), si nota una diversa distribuzione degli argomenti e una limitata successione di autori, di modo che che attorno a un nucleo di saggi “classici” (Rordorf, Giusti, Amoroso) ruotano aggiornamenti e interventi che danno conto dell’evoluzione interna alla Corte. Apprezzabilissimo, per chiarezza e completezza, il Viaggio all’interno della Corte del pres. Curzio, che apre il volume e nella sua essenzialità ben fa comprendere come un procedimento elementare, come quello camerale, possa essere diversamente declinato in ragione del suo oggetto (lo studio più sistematico in argomento, sebbene bisognoso di aggiornamenti, continua a essere quello di F.S. Damiani, Il procedimento camerale in Cassazione, Esi, Napoli, 2011).
I pregi dell’Opera sono evidenti: si parla della Cassazione dal suo interno all’indirizzo dei nuovi consiglieri, che grazie alle Lezioni possono far tesoro dell’esperienza dei predecessori. Ma il pregio dell’Opera – una sorta di self-help – ne è al tempo stesso anche il limite: mancano le voci della Procura Generale, dell’Accademia, dell’Avvocatura. E, giacché la più spinta cameralizzazione del procedimento di legittimità si è avuta nel 2016, sarebbe stato forse opportuno, nell’edizione rinnovata, dedicare uno spazio quantomeno alla Procura Generale, la cui attività è (ancora) parte integrante del lavoro dell’organo di legittimità.
L’impressione che riceve l’extraneus è dunque quella di osservare, sia pure da un osservatorio privilegiato, una realtà chiusa in sé stessa che parla soltanto per il suo interno. Ma questa è e deve restare soltanto un’impressione, perché la Corte Suprema appartiene a tutti e la stessa sua “giurisprudenza” (quella, per intenderci, di cui parla l’art. 360 bis, n. 1, c.p.c.) è inevitabilmente il frutto di un lavoro e un impegno collettivi che richiamano anzitutto l’opera di chi si rivolge alla Corte vedendo in essa il garante della legalità dei giudizi civili.
Ma già questa espressione, che richiama da vicino il testo costituzionale (art. 111, comma 7, Cost.), necessita oggi di una spiegazione.
La nostra Corte di Cassazione è troppe cose insieme. È il giudice di legittimità (che però vincola il solo giudice di rinvio), ma è anche un giudice di merito. È il regolatore del suo proprio contenzioso che non ha mai avuto aiuti chiari e decisivi dal legislatore: al punto che l’art. 360 bis c.p.c. è ormai quasi lettera morta, e la Corte si ingegna a sopperire con strumenti pretori altamente controversi, quali l’autosufficienza del ricorso e la specificità del motivo. È il controllore dei suoi propri giudicati e dei propri errori materiali, che sono purtroppo assai frequenti. È purtroppo – unica nel panorama delle Corti Supreme – un giudice che decide troppo e in modo troppo caotico, certamente incompatibile con le “pure” funzioni di legittimità.
Nella continua ricerca di una sua precisa identità, è anche altro.
Nel 1999 (l. cost. n. 2), l’art. 111 Cost. è stato novellato con l’inserimento, nei primi cinque commi, dei princìpi sul “giusto processo”. E giacché la ragionevole durata deve essere garantita dalla “legge” (e non, ad es., dall’organizzazione e dai servizi di cui parla l’art. 110 Cost., dalla gestione dei ruoli nei singoli uffici giudiziari, dalle misure organizzative dei capi degli uffici, dal rispetto dei termini per il compimento degli atti, etc.), la Cassazione ha iniziato a interpretare la legge, e quella processuale in particolare, secondo il canone costituzionalmente orientato della ragionevole durata. In questa operazione – tuttora in corso: frequentissime sono le motivazioni che giustificano scelte “interpretative” della legge processuale grazie all’utilizzo, spesso in via esclusiva, di quel canone – la Cassazione ha pensato di potersi collocare in una posizione intermedia tra la Costituzione e la legge processuale, giungendo a disapplicare o derogare norme del c.p.c. (chiare nella portata prescrittiva) perché giudicate in contrasto col principio di ragionevole durata. Agendo in questo modo, la Cassazione si è forse appropriata di una parte non secondaria di quel controllo di conformità a Costituzione della legge ordinaria (non esclusa la legge del processo) che la nostra Carta rimette alla Corte costituzionale: agli interpreti viene indicato quali norme (anche e soprattutto del c.p.c.) possono essere disattese o derogate perché in contrasto col fondamentale canone della ragionevole durata. Questa operazione “politica” ha conferito alla Cassazione un potere del tutto eccezionale e senza confini certi, perché nel processo civile standard in cui la ragionevole durata appare, spesso per ragioni del tutto estranee al problema dell’interpretazione della legge, come un’irraggiungibile chimera, le occasioni per esercitare il diffuso controllo di adeguamento al canone costituzionale sono praticamente infinite. Giuseppe Pera soleva ripetere che l’unico limite alla fantasia del processualista era la legge; ora c’è un canone sovrapposto, le cui applicazioni conducono verso un’area di assoluta discrezionalità.
In questo movimentato (e per certi versi inedito) clima culturale è intervenuto il d.lgs. n. 40/2006, col suo tentativo di rilanciare il ruolo “nomofilattico” della Corte, già interprete della legge e ora interprete anche della sua giustificazione o legittimità costituzionale: il dispositivo quesìto-princìpio di diritto e la riscrittura del rapporto tra Sezioni unite e Sezioni semplici avrebbe dovuto razionalizzare lo svolgimento di compiti che la pubblicazione di migliaia di decisioni all’anno rende, va senz’altro riconosciuto, molto difficile.
Collocatasi la Cassazione sul piano intermedio tra la Costituzione e la legge, ecco emergere l’equivoco di fondo: il d.lgs. 40 nasceva con l’obiettivo di far decidere meglio, laddove la necessità che la Suprema Corte avvertiva in modo sempre più urgente e netto era quella di decidere meno. Meno e in modo più selezionato: la Corte manifestava sempre maggiore interesse per decisioni di principio (“di particolare importanza”, secondo l’espressione dell’art. 363, comma 3, c.p.c.), non anche per regolare questioni che non si elevavano dal contesto di una lite tra parti (“meramente patrimoniale”, si legge spesso nelle sentenze della Corte per lamentare lo scarso rilievo di principio delle questioni). Una Corte abituata a dialogare con la Costituzione si confonde malvolentieri con la polvere dei contenziosi minuti: non bastano, a risolverli, i tanti giudici di merito?
Lo strumento che il legislatore delegato del 2006 aveva predisposto per decidere meglio è così stato subito utilizzato per decidere meno nel tentativo di indirettamente regolare il flusso apparentemente incessante e anzi – nonostante tutto – crescente dei ricorsi. Quella stessa Corte che nel tempo aveva accolto tutto (o quasi) come supremo organo di garanzia allorché si trattasse di reprimere violazioni di legge (si pensi alla significativa esperienza, fin dai primi anni ’50, del ricorso straordinario) ha iniziato a porsi il problema dei respingimenti e così a utilizzare i quesìti di diritto come spietati regolatori dell’accesso al giudizio di legittimità (dandone letture ingiustificate e sorprendentemente punitive, addirittura scovando il quesìto anche nel luogo – il motivo del n. 5, nella previgente lezione – che il legislatore delegato aveva deliberatamente trascurato), mentre la funzione nomofilattica è stata utilizzata non tanto per sopprimere i contrasti interni alla Corte, consapevoli e inconsapevoli, consentendole di consolidare una chiara “giurisprudenza” nei vari settori, quanto per allontanare la Cassazione da quello che si definisce jus litigatoris al fine di orientarla senz’altro sullo jus constitutionis: che i vertici della Cassazione hanno identificato come oggetto e obiettivo della vera funzione istituzionale della Corte.
Si è così affermata una funzione della Corte che, bypassando per quanto possibile il caso (e con esso il contraddittorio che ha avuto luogo nel processo), si è orientata verso l’astrattezza dei princìpi. Il ricorso, per la Corte, ha un senso se le consente di affermare un principio “di particolare importanza”; ha un significato totalmente diverso, e chiama dunque un impegno anche formale diverso, ove si tratti di regolare una semplice lite, specie se di rilievo “meramente patrimoniale”. In molte motivazioni traspare l’insofferenza dei supremi giudici per la piccola diatriba, così come per quei difensori – e debbono essere la maggioranza – che non sappiano individuare una ragione abbastanza nobile da poter giustificare l’intervento dell’organo di legittimità. C’è insofferenza anche per il rispetto delle regole formali: che non contano in sé stesse – il cittadino non ha diritto al rispetto delle regole in quanto tali – ma soltanto se determinano un pregiudizio effettivo e dimostrabile: e che deve essere dedotto a pena di inammissibilità.
Vista da quest’angolo prospettico, la riforma del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. avvenuta nel 2012 quale nuova espressione dei respingimenti di contenzioso, è sintomo di una limitazione non soltanto quantitativa, ma soprattutto qualitativa dell’accesso alla Corte, che della “nomofilachia” offre una lettura concettuale e tendente all’astrazione. Spesso il risultato è l’affermazione di princìpi di diritto slegati dalla risoluzione del caso giunto, dai piani inferiori, nelle aule del Palazzaccio. Così come la Corte costituzionale identifica le norme colpite da illegittimità consequenziale, così la Corte di cassazione muove da un principio, che dovrebbe identificare la regola del caso, per poi galoppare indisturbata nella prateria dei principi connessi e derivati.
La soppressione del sistema dei quesìti, precipitosamente avvenuta con la legge n. 69/2009, non ha saputo invertire la tendenza in atto, che dal quesìto è tracimata non tanto verso l’art. 360 bis c.p.c. – norma di difficile comprensione e applicazione, e che la stessa giurisprudenza della Cassazione non è riuscita a chiarire in ben dieci anni di sua applicazione – quanto, abbiamo detto, verso i requisiti pretori dell’autosufficienza e della specificità del ricorso (e dei suoi singoli motivi). Il nuovo rito camerale, fortemente voluto dalla stessa Cassazione nel 2016 per fini di efficienza e deflazione, ha fatto il resto. La funzione attuale della Corte è, principalmente, quella di respingere il contenzioso, ovvero di forgiare gli strumenti più credibili per affermare la regola del respingimento, applicando un rito che non è più nel controllo delle parti (parte pubblica inclusa).
In questo non facile contesto, la realtà che abbiamo attualmente sotto gli occhi è quella di una Corte di Cassazione poco interessata al processo e alle ragioni delle parti (e così a chi ha torto e chi ha ragione, avrebbe chiosato Virgilio Andrioli); molto più interessata, invece, all’affermazione di princìpi astratti, ricostruzioni dogmatiche di istituti specie processuali, terze e impreviste soluzioni di casi discussi, regole di comportamento indirizzate ai pratici, norme che integrano o addirittura si sostituiscono alla disciplina del codice di procedura (se giudicata obsoleta: è il caso dell’art. 37 c.p.c.; se giudicata diseconomica: è il caso della chiamata del terzo da parte del convenuto; se giudicata non garantista: è il caso del comma 1 dell’art. 615 c.p.c., ecc.). Come se, spazzolandosi di dosso la polvere dei casi, la Corte potesse finalmente indossare il suo vestito migliore e concentrarsi sul “sistema” (la nomofilachia).
Preferibilmente, queste decisioni – sorta di sentenza-editto – vengono adottate allorché il ricorso sarà dichiarato inammissibile e dunque la Corte si sentirà libera, affrancata dalla decisione del caso, di affermare princìpi nell’interesse della legge che, alimentati da articolati (e imprevedibili) obiter dicta, sempre più tendono ad allontanarsi dal caso che aveva originato il ricorso in sede di legittimità. Il processo di cassazione diventa così mera occasione per l’esercizio di un potere “nomofilattico” (ma che in realtà andrebbe definito nomopoietico) reciso dal singolo processo – potere che del resto può sempre essere autonomamente sollecitato dal P.G.: art. 363 c.p.c. – mentre l’occasione che aveva sollecitato l’esercizio di quella funzione rimane discretamente sullo sfondo. Una consolidata giurisprudenza della stessa Corte applica l’art. 384, comma 3, c.p.c. al solo caso della decisione sostitutiva nel merito (comma 2), laddove il senso della disposizione è affatto generale: ogni volta che la Corte solleva una questione d’ufficio, anche e specie se di portata processuale, deve sottoporla al contraddittorio delle parti. Se l’interpretazione esatta del comma 3 fosse quella patrocinata dalla stessa Corte, quel comma sarebbe stato un ulteriore periodo del comma 2, non una previsione a parte. E, in ogni caso, c’è ora una previsione generale (art. 101, comma 2, c.p.c.) che tuttavia la Corte continua a ignorare. In conseguenza – è un paradosso – proprio dinanzi alla Corte di Cassazione ci si può imbattere in decisioni “a sorpresa”, su questioni mai assoggettate al contraddittorio delle parti.
Queste operazioni – che appartengono all’attuale esperienza della Corte – mostrano la solitudine dell’organo di legittimità: vuoi perché il ricorso nell’interesse della legge proposto dal P.G. non prevede l’instaurazione del contraddittorio con alcuno (né con le parti del giudizio da cui origina la proposizione dell’istanza, né con parti professionali o culturali che potrebbero essere chiamate a collaborare «nell’interesse della legge»); vuoi perché, nel giudizio a quo, non apparteneva al contraddittorio processuale la lunga coda di obiter dicta su cui la Corte si concentra, una volta liberatasi dai lacci del giudizio, per affermare i suoi princìpi nell’interesse della legge. Si parla quindi di una funzione nomofilattica, vòlta all’affermazione di princìpi astratti e così di “norme”, che ben poco ha a che vedere con gli obiettivi originari del d.lgs. 40, che certo non intendeva mutare così profondamente la funzione istituzionale della Corte.
D’altra parte, chiunque può constatare che i contrasti interni alla Corte permangono, permangono i diversi filoni interpretativi che la Corte mostra di ignorare quando sceglie di seguire uno (si pensi alla vexata quaestio delle restituzioni in appello: cfr. Sez. III, ord. 2 marzo 2018, n. 4918, in relazione a Sez. I, sent. 12 febbraio 2016, n. 2819), si riaffacciano decisione “a sorpresa”, sovente smentite a distanza di pochi mesi, che nascono sempre con l’obiettivo di respingere i contenziosi (si confrontino la sorprendente ord. della III sez., 17 gennaio 2018, n. 1058, immediatamente corretta dalla stessa III sez. con sent. 30 settembre 2019, n. 24224). Chiunque può constatare che la Corte non riesce ad applicare l’art. 360-bis c.p.c. perché in troppi settori non è possibile identificare quale sia la “giurisprudenza” cui far riferimento per sottoporre il ricorso a un controllo preliminare di ammissibilità.
Insomma, al termine di un percorso non lineare abbiamo dinanzi ai nostri occhi una Corte di Cassazione più sola, meno disposta al dialogo, comunque oberata di ricorsi e che spesso combatte, da sola, contro la sua stessa giurisprudenza. Una Corte che non ha strumenti per “imporre” le sue decisioni ai giudici di merito, che sempre più la osservano, interdetti, come un produttore di “norme” (a volte astruse) piuttosto che come il più autorevole risolutore di conflitti.
Il volume qui recensito è lo specchio fedele di questa Corte, della quale, dall’esterno, tutti auspichiamo un cambiamento: che sarà però possibile solo una volta usciti dall’emergenza.
Incostituzionale il favor territoriale per p.m.i. negli appalti pubblici (nota a Corte cost. 98/2020)
di Simone Francario
Le norme regionali di protezione delle imprese locali nel settore degli appalti pubblici sono incostituzionali per violazione del principio di tutela della concorrenza.
Sommario: 1. La questione di legittimità; 2. Le fasi della procedura negoziata per l’affidamento di lavori “sotto soglia”; 3. La contestata disciplina regionale; 4. L’incostituzionalità della disposizione regionale per violazione del principio di tutela della concorrenza e del mercato.
1.- La questione di legittimità
Il Presidente del Consiglio dei ministri impugnava davanti la Corte Costituzionale l’art. 10, co. 4, della legge della regione Toscana n. 18/2019, il quale, nell’ambito delle procedure negoziate per l’affidamento di lavori sotto soglia, stabiliva che le stazioni appaltanti “possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale per una quota non superiore al 50 per cento […].”
Ad avviso del ricorrente, la norma de quo sarebbe in contrasto, in primo luogo, con l’art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, in secondo luogo, con l’art. 30, comma 1, del d. lgs. 50/2016 per violazione dei principi dei principi di libera concorrenza e non discriminazione, in quanto si creerebbe una indebita restrizione del mercato escludendo gli operatori economici non toscani dalla possibilità di essere affidatari di commesse pubbliche.
Nel vagliare la prospettata incostituzionalità della disposizione, i giudici della Consulta hanno dapprima esaminato brevemente l’ambito normativo in cui si inserisce, poi la sua esatta portata ed infine la sua conformità ai principi di tutela della concorrenza.
2.- Le fasi della procedura negoziata per l’affidamento di lavori “sotto soglia”
Nella sentenza 98/2020, La Corte ricorda preliminarmente che l’affidamento dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria è disciplinato dall’art. 36 del Codice Appalti, di cui al d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale va letto anche alla luce delle Linee Guida ANAC adottate con la delibera 26 ottobre 2016, n. 1097.
L’art. 36 del d. lgs. 50/2016 prevede che, salva la possibilità di ricorrere comunque alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti possano procedere all’affidamento di tali lavori tramite la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (di cui all’art. 63 del d. lgs. 50/2016) in due ipotesi: quando il valore complessivo dell’appalto sia compreso tra 150.000 euro e 350.000 euro oppure tra 350.000 euro e 1.000.000 euro.
In entrambi i casi è necessaria, rispettivamente, la previa consultazione di almeno 10 o 15 operatori economici -ove esistenti-, da effettuarsi nel rispetto di “un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagine di mercato o tramite elenchi di operatori economici.”
Le già menzionate Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, poi, specificano che, una volta iniziata la procedura con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente, essa si articola in tre fasi che il giudice delle leggi schematizza nel seguente modo: a) svolgimento delle indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo; b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell’affidatario; c) stipulazione del contratto.
3.- La contestata disciplina regionale.
Prendendo in esame la disciplina regionale, la sentenza sottolinea preliminarmente che la disposizione censurata non fissa un requisito di accesso alle procedure negoziale in quanto non esclude a priori le imprese non toscane dalla partecipazione agli appalti.
Più nello specifico, l’art 10, co. 4, della legge della regione Toscana n. 18/2019, si inserisce nella seconda fase della procedura, cioè nella fase di invito a presentare un’offerta: tale norma consentirebbe alla stazione appaltante di prevedere che un certo numero di offerte (non più del 50%) debba provenire da micro, piccole e medie imprese toscane, di fatto disapplicando i criteri generali previsti per la selezione delle imprese da invitare.
Usando termini più incisivi, la Corte Costituzionale ha rilevato che la norma impugnata “può giustificare l’invito di imprese toscane che dovrebbero essere escluse a favore di imprese non toscane, in quanto -in ipotesi- maggiormente qualificate sulla base dei criteri stessi.”
4.- L’incostituzionalità della disposizione regionale norma per violazione del principio di tutela della concorrenza e del mercato.
Ciò posto, la Corte, sulla base di un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, richiama il principio per cui le disposizioni del codice dei contratti pubblici che regolano le procedure di gara sono riconducili direttamente alla materia di tutela della concorrenza per cui vige la riserva legislativa esclusiva dello Stato (sul punto, si richiamano, ex multis le sentenze della Corte Costituzionale n. 263/2016; 36/2013; 328/2011; 411 e 322 del 2008) e, di conseguenza, le Regioni, anche se a statuto speciale, non possono dettare una diversa disciplina, neanche nel caso di contratti sotto soglia (si vedano a riguardo le sentenze n. 263/2011; 184/2011; 283 e 160 del 2009; 401/2007).
La norma impugnata dal Presidente del consiglio dei ministri, quindi, risulta di ostacolo alla concorrenza in quanto incide su una materia riservata alla competenza legislativa esclusiva statale, quale la disciplina della procedura negoziata di affidamento di contratti di lavori pubblici sotto soglia, e la regola in maniera difforme.
Infatti, prosegue la Corte, la norma si pone in aperto contrasto con gli artt. 30, comma 1, e 36, comma 2, del d. lgs. 50/2016 in quanto, introducendo una possibile riserva di partecipazione a favore di imprese locali altera la par condicio fra gli operatori economici -regionali ed extraregionali- interessati a partecipare all’appalto, e di conseguenza viola i principi di libera concorrenza e non discriminazione sanciti in tali articoli (sul punto, inoltre, la sentenza ribadisce che tale orientamento è da tempo consolidato in seno alla Corte costituzionale, per cui più volte sono state dichiarate costituzionalmente illegittime norme regionali di protezione di imprese locali, sia nel settore degli appalti pubblici che in altri ambiti; si vedano a riguardo le sent. nn. 28/2013; 440/2006; 221 e 83 del 2018; 190/2014.)

To install this Web App in your iPhone/iPad press icon.
