Rapporti tra il giudizio sulla legittimità dell’informativa antimafia e l’istituto del controllo giudiziario*
di Maria Alessandra Sandulli
Sommario: 1. Premessa di inquadramento - 2. Il percorso verso una mitigazione del sistema di prevenzione: l’art. 34-bis del codice antimafia - 3. La riforma del 2021 - 4. Conclusioni.
1. Premessa di inquadramento. Le misure di prevenzione amministrativa antimafia sono al centro del dibattito scientifico e giurisprudenziale. Negli ultimi anni, le informazioni interdittive sono passate da poche centinaia a quasi due migliaia e il raggiungimento di un giusto punto di equilibrio tra la primaria esigenza di tutela dell’ordine pubblico economico, della sicurezza sociale e della libera concorrenza che esse perseguono e l’altrettanto innegabile esigenza di tutela dei diritti degli operatori economici su cui esse pesantemente incidono acquista ancora maggiore rilevanza in relazione agli obiettivi del PNRR e, più in generale, alla irrinunciabile esigenza di combattere i diversi fattori di crisi economica.
Come ripetutamente segnalato dalla dottrina, sia accademica che togata, e ben avvertito anche dalla più recente giurisprudenza, l’informazione interdittiva antimafia -nonostante la sua, formale, provvisorietà- può avere un effetto esiziale sull’impresa che ne è attinta.
Concepita come una misura di nicchia, essenzialmente focalizzata sui rapporti contrattuali della pubblica amministrazione e come tale in qualche modo giustificata dal diritto del committente (pubblico e privato) di scegliere contraenti -almeno apparentemente- “sicuri”, la misura ha acquistato sempre maggiore valenza quando, come ben evidenziato anche in un recente convegno dal consigliere di Stato Giulio VELTRI, il legislatore ne ha esteso l'ambito di applicazione alle autorizzazioni commerciali e, attraverso i protocolli di legalità, alla contrattazione privata, e la giurisprudenza ha traslato i principi e le linee interpretative maturati quando l’informativa era riferita ai soli rapporti contrattuali con la p.A. anche a questa nuova e più ampia area di incidenza dello strumento.
L’operatore colpito dall’interdittiva perché l’autorità prefettizia, da una serie di elementi puramente indiziari, ha rinvenuto un rischio di potenziale pericolo non si vedrà invero più soltanto precluso l’accesso ai contratti pubblici, ma si troverà più generalmente impossibilitato ad avviare qualsivoglia attività economica (tanto che si è parlato di “ergastolo imprenditoriale”). Il che, verosimilmente, lo esporrà al dissesto o al fallimento, anche se all’esito del giudizio -amministrativo e/o penale- intentato per reagire allo strumento, il pericolo si rivelasse insussistente o comunque evitabile attraverso la sottoposizione a misure di prevenzione meno radicali. Ricordo a tale proposito che la Corte costituzionale, con la sent. n. 57/2020, per giustificare la conformità dell’istituto dell’interdittiva ai principi sostanziali e procedimentali a tutela dei diritti fondamentali dei soggetti colpiti, ha riconosciuto “un ruolo particolarmente rilevante [al] carattere provvisorio della misura”, propugnando una lettura rigorosa del termine annuale di validità previsto dall’art. 86 del codice: “È questo il senso della disposizione dell’art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, secondo il quale l’informativa antimafia ha una validità limitata di dodici mesi, cosicché alla scadenza del termine occorre procedere alla verifica della persistenza o meno delle circostanze poste a fondamento dell’interdittiva, con l’effetto, in caso di conclusione positiva, della reiscrizione nell’albo delle imprese artigiane, nella specie, e in generale del recupero dell’impresa al mercato. E va sottolineata al riguardo la necessità di un’applicazione puntuale e sostanziale della norma, per scongiurare il rischio della persistenza di una misura non più giustificata e quindi di un danno realmente irreversibile…”. Merita sul punto rimarcare che la giurisprudenza amministrativa è consolidata nell’affermare che il decorso del termine annuale indicato dall’art. 86 non implica la decadenza automatica dell’eventuale misura interdittiva, ma impone soltanto di procedere alla verifica della persistenza o meno delle circostanze poste a fondamento dell’interdittiva, con l’effetto, in caso di conclusione positiva, della reiscrizione dell’impresa nell’albo le imprese e, in generale, del suo recupero al mercato. Il principio è ribadito, citando anche l’Adunanza Plenaria n. 23 del 2020, in un ampio e puntuale scritto del consigliere di Stato Massimiliano NOCCELLI, pubblicato nel 2021 sul sito della giustizia amministrativa, il quale sottolinea che la durata annuale della misura non implica che, alla scadenza dei 12 mesi, gli elementi posti a base dell’originario provvedimento perdano di attualità, poiché essi, in mancanza di elementi sopravvenuti di segno contrario, mantengono inalterata la loro valenza indiziaria e ben possono giustificare il rinnovo del provvedimento interdittivo negli anni a seguire. L’A. richiama in proposito Cons. St., sez. III, 5 ottobre 2016, n. 4121, nel senso che la persistente rilevanza degli elementi indiziari posti a base dell’informativa affermata dalla giurisprudenza, anche dopo il decorso del termine annuale previsto dall'art. 86, co 2, cit., non è l’effetto di una non prevista ultrattività dell'informativa positiva, a differenza di quella c.d. negativa (o liberatoria), né tantomeno il frutto di una non consentita interpretazione in malam partem, come pure si è ritenuto, ma l’oggetto di una precisa disposizione normativa e, in particolare, dell’art. 91, comma 5, dello stesso d. lgs. n. 159 del 2011, per il quale «il Prefetto, anche sulla documentata richiesta dell’interessato, aggiorna l’esito dell’informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa». Secondo la giurisprudenza amministrativa, tale disposizione ha evidentemente considerato che gli elementi posti a base dell’informativa antimafia a effetto interdittivo non “scadono” per il decorso del termine annuale, in quanto l’aggiornamento “liberatorio” dell’informativa può esservi solo quando essi perdano la loro rilevanza indiziaria del pericolo di infiltrazione (così ad es. TAR Lazio, Latina, Sez. I, n. 32 del 2021). A conferma e sostegno di tale chiave di lettura, il Collegio ha aggiunto che sarebbe del resto irragionevole e contrario alla ratio della normativa antimafia «sostenere che elementi di consistente gravità, quali ad esempio l’assidua frequentazione, nel tempo, di soggetti pregiudicati o l’altrettanto costante collaborazione economica dell’impresa con la mafia o, addirittura, la presenza di soggetti controindicati nelle cariche societarie, perdano la loro efficacia indiziante solo perché l'informativa sia “scaduta” decorso l’anno dalla sua emanazione».
Nei fatti, a quanto mi si dice, l’interdittiva viene tendenzialmente confermata.
Sicché -nonostante il carattere formalmente preventivo e provvisorio, sul quale la giurisprudenza amministrativa e costituzionale appoggia anche la sufficienza della cd tassativizzazione giurisprudenziale dei presupposti indiziari, incompatibile con uno strumento di tipo sanzionatorio- essa finisce in buona sostanza per limitare in via permanente l'esercizio dell’attività di impresa. Limite che viene, come noto, “giustificato dalla considerazione che il metodo mafioso, per sua stessa ragion di essere, costituisce un «danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana» (art. 41, comma secondo, Cost.), già sul piano dei rapporti tra privati (prima ancora che in quello con le pubbliche amministrazioni), oltre a porsi in contrasto, ovviamente, con l’utilità sociale, limite, quest’ultimo, allo stesso esercizio della proprietà privata. Il metodo mafioso è e resta tale, per un essenziale principio di eguaglianza sostanziale prima ancora che di logica giuridica, non solo nelle contrattazioni con la pubblica amministrazione, ma anche tra privati, nello svolgimento della libera iniziativa economica” (Cons. Stato, sent. 565/2017).
Nella Relazione della DIA al Parlamento sul I semestre 2021 si legge infatti significativamente che con l’interdittiva, “in termini generali, si impedisce quindi alle imprese interessate di stipulare contratti con la pubblica amministrazione in ossequio al principio costituzionale di assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione” e, “nel contempo si concorre al mantenimento di un sano regime concorrenziale ed alla difesa dell’ordine pubblico economico che ha la funzione di garantire, proteggere e dirigere l’attività economica nazionale”. Nella precedente Relazione per il I semestre 2020, la stessa Direzione rimarcava che la misura rappresenta “la massima anticipazione della tutela preventiva dello Stato dal crimine organizzato (...) in quanto comporta l'esclusione di un soggetto, ritenuto potenzialmente infiltrato dalla criminalità organizzata, dalla possibilità di intrattenere rapporti con le pubbliche amministrazioni”, esplicitando che essa è l’esito di un’apposita istruttoria effettuata in riferimento a “condizioni che non costituiscono un numero chiuso e non consistono solo in circostanze desumibili dalle sentenze di condanna per particolari delitti e dalle misure di prevenzione antimafia”, nella quale possono rilevare anche le “motivazioni che lumeggino situazioni di infiltrazione mafiosa da provvedimenti giudiziari non ancora definitivi”, ovvero i “rapporti di parentela, amicizia e collaborazione con soggetti controindicati e che indichino un verosimile pericolo di condizionamento criminale per intensità e durata”, nonché “aspetti anomali nella composizione e gestione dell’impresa sintomatici di cointeressenza dell’azienda e dei soci con il fenomeno mafioso”. Si tratta, come si vede e come noto, di elementi necessariamente indiziari che, per di più, il Prefetto valuta con un forte deficit di contraddittorio e che il giudice amministrativo sindaca, alla luce della richiamata tipizzazione giurisprudenziale e secondo la regola del “più probabile che non” (affatto diversa da quella dell’“in dubio pro reo”), con i limiti che inevitabilmente derivano da un procedimento che, per garantire l’effetto “sorpresa” non era e, nonostante la riforma del 2021, non è pienamente trasparente.
2. Il percorso verso una mitigazione del sistema di prevenzione: l’art. 34-bis del codice antimafia. Pur nella consapevolezza della massima importanza che assume l’effettività della lotta alla criminalità organizzata e dell’apprezzamento che merita chiunque vi sia impegnato, i principi di proporzionalità e di equo bilanciamento dei diversi interessi primari -pubblici e privati- che devono guidare l’azione dei poteri pubblici -in sede legislativa e amministrativa- stanno, come noto, spingendo a una riconsiderazione del sistema e a una più attenta riflessione sulla effettiva necessità e opportunità di una misura così drastica.
Il tema sul quale concentrerò il mio intervento è, proprio, legato al percorso legislativo che ha portato a un progressivo alleggerimento del sistema di prevenzione antimafia nei casi in cui il richiamato obiettivo di tutelare le imprese e la collettività dall’espansione dei fenomeni di criminalità organizzata nelle attività economiche possa essere più proporzionalmente perseguito attraverso strumenti di “vigilanza prescrittiva”, in forma di monitoraggio e/o tutoraggio, dei soggetti ritenuti a rischio di favorire le cd infiltrazioni mafiose nelle suddette attività, consentendo comunque loro di continuare a espletare le loro attività e di dimostrare, se non la sostanziale insussistenza, quanto meno il superamento di un tale rischio. Si sta in altri termini “abbandonando progressivamente un approccio punitivo repressivo, preferendo strumenti di matrice preventiva e di controllo capaci di modularsi in base al differente grado di infiltrazione e di salvaguardare la continuità operativa dell'attività imprenditoriale mediante un'operazione di bonifica dall'inquinamento mafioso”.
Il profilo -che, come emerso anche dai confronti tra giudici amministrativi e penali in precedenti incontri di studio, è di grande interesse- è particolarmente attuale alla luce delle modifiche introdotte, a margine delle disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR, dagli artt. 47, 48 e 49 del d.l. n. 152, convertito nella l. n. 233 del 2021.
*
Il “percorso” parte però, come noto, dal sistema penale. Gli articoli 34 e 34-bis del codice antimafia prevedono infatti, ove ne ricorrano i presupposti e in luogo del sequestro e della confisca dei beni del soggetto proposto, l'applicazione, a seconda del livello di rischio, di due diverse misure di prevenzione penale: l'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende e il cd controllo giudiziario di queste ultime. In dottrina si è rimarcato che tali misure, “raramente adottate dal giudice che decide sul sequestro o sulla confisca, e raramente invocate dai difensori in via subordinata rispetto alle richieste di rigetto/revoca del sequestro o della confisca”, sono state qualificate dalla Cassazione penale come “modalità di intervento potenzialmente alternativo rispetto all'ordinario binomio sequestro/confisca dei beni del soggetto portatore di pericolosità” (sent. n. 24678/21), delle quali - come aggiunge la sent. n. 21412/21 - “il legislatore, ricorrendone i presupposti, ha inteso privilegiare l'applicazione in attuazione del principio di proporzionalità e in vista del possibile recupero dell'impresa alle fisiologiche regole del mercato, una volta ridotta l'ingerenza dei soggetti portatori di pericolosità”. In particolare, seguendo un approccio gradualistico “a scalare” in relazione ai diversi livelli di contaminazione dell’operatore economico, il controllo è stato introdotto dalla riforma codicistica di cui alla l. n. 161 del 2017 mediante l’inserimento del richiamato art. 34-bis, per intervenire in via conservativa e recuperatoria nelle ipotesi in cui i comportamenti a rischio di infiltrazione sono stati meramente occasionali e il condizionamento subito dall’impresa sia a un livello ancora embrionale e suscettibile di agevole rimozione. Esso persegue una prioritaria finalità di cd “bonifica” delle imprese che versino in una situazione di assoggettamento o intimidazione o si siano occasionalmente prestate per agevolare le associazioni di natura mafiosa, consentendo loro di continuare ad operare in una economia sana e di salvaguardare i livelli occupazionali e così favorendo il loro ritorno a un regime di piena legalità. Come efficacemente evidenziato, si tratta di “un delicatissimo ‘istituto cerniera’, in cui trovano risoluzione equilibrata le possibili frizioni tra la giurisdizione amministrativa e la giurisdizione ordinaria e si saldano in modo armonico le contrapposte esigenze sottese alle interdittive antimafia, da un lato, della tutela dell’ordine pubblico e dei valori fondanti della democrazia avverso i tentativi di infiltrazione mafiosa nelle attività economiche lecite e, dall’altro, della libertà di impresa e del diritto di proprietà del destinatario del provvedimento prefettizio”.
Il comma 2 dell’art. 34-bis prevede che il controllo possa essere attuato in due modalità diverse:
-una modalità meno invasiva, consistente in un obbligo di comunicazione periodica al Questore e al nucleo di polizia tributaria degli atti di disposizione patrimoniale o di altri atti o contratti individuati dal Tribunale (lett a);
-e una modalità più invasiva, attraverso la nomina di un amministratore giudiziario, che però, diversamente da quanto avviene nell’amministrazione giudiziaria, non si sostituisce all’impresa, ma ha soltanto funzione di tutoraggio e di bonifica e riferisce periodicamente, con relazioni scritte bimestrali, al giudice delegato e al pubblico ministero (lett b).
In entrambi i casi, comunque, anche se nel secondo caso “sotto controllo” dell’amministratore, che adotterà le opportune cautele, l’impresa rimane quindi titolare della gestione e può continuare direttamente a operare anche in rapporto con l’amministrazione.
Il Tribunale può poi autorizzare la polizia giudiziaria all’accesso negli uffici dell’impresa per l’acquisizione di documenti o disporre il passaggio all’amministrazione giudiziaria di cui all’art 34 dello stesso codice.
È dunque evidente la differenza rispetto all’informazione prefettizia interdittiva, che, come detto, inibendo qualsiasi rapporto con la p.A., non soltanto contrattuale, ma anche autorizzatorio, determina spesso la chiusura dell’impresa. Sicché, come è stato esattamente rilevato anche dalla dottrina togata amministrativa, è chiaro che “visto dal lato delle imprese è meglio essere colpiti dalla prevenzione antimafia penale che non dalla misura interdittiva amministrativa”.
L’accento si sposta allora inevitabilmente sul rapporto tra i due sistemi di prevenzione.
Il legislatore del 2017 ha espressamente disposto che l’applicazione delle riferite misure di prevenzione penale -tanto di amministrazione che di controllo giudiziario- sospende gli effetti dell'informativa amministrativa, attestando in tal modo la prevalenza della prevenzione penale.
La peculiarità del sistema è però determinata dal fatto che esso ha creato un’osmosi, un ponte fra le due aree, introducendo uno strumento assolutamente atipico e sicuramente anomalo in ambito penale: per raccordare in qualche modo i due sistemi di prevenzione, l’art. 34-bis ha infatti stabilito, al co 6, che l’imprenditore colpito da un’informativa antimafia possa, in parallelo all’impugnazione della misura davanti al giudice amministrativo e nelle more della sua decisione, chiedere al Tribunale di prevenzione di essere sottoposto al controllo giudiziario nella forma prevista dalla lett. b) dello stesso articolo, con sottoposizione cioè al solo controllo dell'amministratore giudiziario e non anche agli obblighi di comunicazione indicati alla lett. a). L’applicazione del controllo determina, anche in questo caso, l’effetto sospensivo automatico dell'interdittiva prefettizia, fermo che, qualora, nelle more del periodo di controllo, il giudice amministrativo accolga il ricorso e annulli l’interdittiva, l’imprenditore potrà chiedere al Tribunale della prevenzione la revoca del controllo. Ci si è dunque interrogati se l’istituto non sia piuttosto configurabile come un “beneficio”, proponendo un paragone con l'ipotesi della messa alla prova in senso proprio, prevista per l'imputato minorenne dall'art. 28 D.P.R. 448/88 sulla base del progetto elaborato ai sensi dell'art. 27 d.lgs. 272/89, il cui esito positivo comporta l'estinzione di qualunque reato, anche se astrattamente punibile con l'ergastolo, o, analogamente, per quella dell'imputato maggiorenne introdotta dagli artt. 168-bis ss. c.p. e 141-bis ss. c.p.p..
La misura lascia peraltro aperte varie incertezze.
Il legislatore ha infatti dimenticato di chiarire cosa accade al termine, con esito favorevole, del periodo di controllo, e quale effetto abbia sul controllo la sentenza amministrativa -di accoglimento o di rigetto- dell’impugnazione dell’interdittiva.
Nel primo caso mi sembra abbastanza evidente che il Prefetto debba, quantomeno, rivalutare la situazione alla luce degli esiti del controllo, che, diversamente, avrebbe soltanto l’effetto di posticipare l’effetto dell’interdittiva. Si dovrebbe, dunque, aprire un procedimento di riesame di quest’ultima, nel frattempo sospesa, nelle forme dell’autotutela revocatoria, per valutarne, attraverso un’adeguata istruttoria e con le opportune garanzie di contraddittorio, la perdurante necessità. Con conseguente possibilità del destinatario di adire il giudice amministrativo contro il provvedimento confermativo della misura o contro l’eventuale inerzia sull’istanza del suo riesame. Ho parlato di revoca e non di annullamento in considerazione della differenza tra i presupposti delle due misure, tendenzialmente sottolineata anche dalla giurisprudenza. In particolare, con riferimento agli effetti dell’ammissione al controllo e dei suoi esiti sul giudizio amministrativo di impugnazione dell’interdittiva, il Consiglio di Stato ha affermato che “il controllo giudiziario presuppone l’adozione dell’informativa, rispetto alla quale rappresenta un post factum” (…) perché inevitabilmente diversi sono gli elementi fattuali considerati anche sul piano diacronico nelle due diverse sedi (…) la valutazione finale del giudice della prevenzione penale si riferisce dunque alla funzione tipica di tale istituto, che è un controllo successivo all’adozione dell’interdittiva, ed ha riguardo alle sopravvenienze rispetto a tale provvedimento”, concludendo che l'esito favorevole del controllo a richiesta e l'eliminazione del rischio di infiltrazione non rilevano nel giudizio amministrativo, che riguarda gli elementi esistenti al momento dell'interdittiva (sent. 319/21).
In buona sostanza, si è chiarito che il provvedimento interdittivo valuta il passato e, in base a ciò che l’imprenditore è stato e a come si è comportato, ne inibisce i rapporti con la pubblica amministrazione, mentre il controllo giudiziario si colloca in una dimensione dinamica, proiettata alla riferita possibilità di risanamento dell'impresa per rimetterla nell'economia legale. Come messo efficacemente in evidenza dal TAR Calabria, Catanzaro, nell’ordinanza Sez. I, n. 658 del 2019, “l’ammissione al controllo non sconfessa la legittimità dell’informativa in punto di sussistenza di pericolo di infiltrazione non costituendone un superamento, ma in un certo modo conferma[ndone] la sussistenza (v. Cons. Stato, n. 6377/2018; 3268/ 2018)”, ma rappresenta “un sostegno previsto dall'ordinamento per l'imprenditore che sia marginalmente toccato dai clan e che individualmente (specie in realtà piccole e contaminate e ad economia scarsa non sia in grado di reagire alla criminalità)”.
Anche le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione hanno del resto significativamente affermato che, nel controllo a richiesta, il giudizio sull'occasionalità non riguarda esclusivamente o prevalentemente la pregressa attività di impresa (momento diagnostico), ma si riferisce anche alle prospettive di recupero all'economia sana (momento prognostico), guardando alle quali può valutarsi in modo concreto la contingenza o meno del fenomeno di agevolazione (sent. n. 46898/19, Ricchiuto). E, nel richiamare tale giurisprudenza, la stessa Corte di Cassazione, ha coerentemente sottolineato che, con la relativa richiesta, “l'istante è chiamata a (necessariamente) dedurre solo quegli elementi, favorevoli, utili a giudicare recuperabile una situazione di condizionamento che può essere data per scontata, in quanto ritenuta in un diverso provvedimento (amministrativo), che la presuppone. Situazione di condizionamento che dunque, pur potendo essere apprezzata (specie nella sua intensità) dal giudice ordinario, non entra nel fuoco dell'accertamento necessario ai fini dell'ammissione all'istituto in esame (cfr. S.U. Ricchiuto, sopra richiamate), volto piuttosto alla disamina del profilo della recuperabilità dell'azienda all'economia sana” (sent. n. 21412/21).
Come è stato giustamente osservato dalla dottrina, il concorso di giurisdizioni, amministrativa sull'atto di interdittiva e ordinaria sul rapporto tra impresa a rischio ed economia sana, ha del resto ragion d’essere “solo se l’oggetto dei due giudizi è diverso e tale da non comportare un rischio sistemico di contrasto di pronunce, in un ordinamento policentrico che, pur limitando l'efficacia diretta del giudicato in altri giudizi, persegue pur sempre l'obiettivo della tendenziale coerenza e complementarietà degli accertamenti di giudici diversi”.
Non convince tuttavia l’affermazione, in una recentissima pronuncia del TAR Catania (1° maggio 2022 n. 1219), che la richiesta di controllo giudiziario presupporrebbe l’ammissione del contagio mafioso, sia pure nei limiti dell’occasionalità. Il ragionamento condotto, sicuramente suggestivo e interessante, trova invero a mio parere un insormontabile ostacolo nel fatto che, in senso diametralmente opposto, il legislatore ha individuato nell’impugnazione dell’interdittiva -e dunque nella non accettazione dei suoi presupposti- una pre-condizione dell’istanza di ammissione al controllo.
Venendo più specificamente ai rapporti tra giudizio amministrativo e giudizio penale, nella riferita ottica di autonomia tra le due misure, la decisione del giudice amministrativo confermativa della validità dell’interdittiva non dovrebbe ragionevolmente interferire con il controllo a richiesta. E la richiamata “condizione” dell’impugnazione dell’interdittiva per richiedere il controllo avrebbe soltanto una valenza di mancata acquiescenza alla misura.
Va però segnalato che l’impostazione sopra accolta non è unanimemente seguita dalla Cassazione penale: nella citata sent. n. 24678/21, condividendo la tesi della Corte d’appello secondo cui il giudice della prevenzione deve valutare solo la situazione di fatto esistente al momento dell'interdittiva e non gli accadimenti posteriori, la Corte di legittimità ne ha infatti cassato con rinvio la sentenza per difetto di motivazione, sollecitandola a effettuare una valutazione sostanzialmente sovrapponibile a quella del giudice amministrativo, mentre non ha ritenuto rilevanti le misure di self cleaning adottate dall’impresa dopo l’interdittiva.
Non è meno delicato il tema degli effetti dell’ammissione al controllo sul giudizio amministrativo. Come riferitoci dal consigliere VELTRI nei richiamati convegni e riportato nella citata ultima sentenza del TAR Catania, il Consiglio di Stato sta adottando una prassi di sospensione impropria del processo (inter alia ordd. 4873 e 5482/19), in attesa della fine del controllo, che, per quanto detto, se attestante l’intervenuta “bonifica”, dovrebbe, in un’ottica di ragionevolezza e di proporzionalità, determinare la revoca dell’interdittiva. Di contro, il TAR Calabria, sezione di Reggio Calabria, ha ritenuto che, in ragione della non interferenza dei due ambiti giurisdizionali, il giudice amministrativo abbia comunque l’obbligo di definire il giudizio. Mentre, da ultimo, il TAR Catania, muovendo dal suddetto ardito presupposto che la richiesta di controllo implicherebbe il riconoscimento dell’illecito, ne ha affermato la radicale improcedibilità, non residuando in tesi spazi neppure per la tutela risarcitoria.
Il tema, come si vede, richiede un sollecito intervento del legislatore. O, quantomeno, dell’Adunanza plenaria, che avrebbe però, ancora una volta, l’ingrato compito di fare “chiarezza” senza indulgere in interventi “creativi”.
La casistica giurisprudenziale ha dimostrato peraltro che questa osmosi tra i due ambiti di prevenzione ha determinato anche effetti paradossali. La Cassazione penale, si è trovata così di fronte al caso di un operatore che, dopo avere infruttuosamente adito il giudice amministrativo per l’annullamento dell’interdittiva, si era visto respingere la domanda di controllo giudiziario dal giudice della prevenzione penale sul presupposto che non vi fosse alcun rischio infiltrativo. Sicché, paradossalmente, proprio il fatto che era stato ritenuto indenne dal giudice penale, lo costringeva a subire gli effetti dell’interdizione nei rapporti con l’amministrazione. In linea con la richiamata posizione delle Sezioni Unite, la Corte ha risolto la questione affermando che, quando il controllo è a domanda e non c'è quindi, come nel controllo giudiziario ordinario, una sfera di valutazione riservata al giudice penale, il “fatto” presupposto della misura di prevenzione penale è l’informativa, la valutazione della cui legittimità è rimessa al giudice amministrativo, sicché il giudice penale non può entrare nel merito della sussistenza del rischio infiltrativo e negare la misura sul presupposto che esso non sussista, ma deve unicamente verificare la ricorrenza delle condizioni per l’ammissione al controllo.
3. La riforma del 2021. Nel sistema sopra descritto si è inserita la riforma del 2021. Il legislatore, preso atto della crescente rilevanza delle misure di prevenzione antimafia anche in relazione all'attuazione del PNRR, è intervenuto sulla disciplina della documentazione amministrativa antimafia sul duplice fronte, procedimentale e sostanziale. Sul piano procedimentale, rispondendo, in parte, alle sollecitazioni della dottrina e della giurisprudenza, ha aggiunto alla possibilità del Prefetto di disporre un’“audizione personale” dell’interessato prevista (solo in forma eventuale e peraltro non in forma sistemica) dall’art. 93, co 7 (pure novellato), 8 e 9 del codice, la previsione, in via generale, di una “procedura in contraddittorio”, che si apre però solo dopo che il Prefetto si sia già determinato all’adozione delle misure di prevenzione amministrativa (attraverso un mero “preavviso” di tali misure), contempla espressamente una deroga in caso di particolari esigenze di celerità del procedimento, e, soprattutto, specifica che “in ogni caso, non possono formare oggetto della comunicazione … elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l’esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose” (cfr. il nuovo art. 92, co. 2-bis, del codice).
Sul piano sostanziale, la novella ha introdotto, mutuandola dal sistema di prevenzione penale, una graduazione delle misure di prevenzione amministrativa.
Prendendo evidentemente atto della eccessiva rigidità della misura interdittiva a fronte di contatti meramente occasionali e della difficoltà di conciliare la maggiore severità delle misure amministrative rispetto a quelle penali, la riforma, inserendo nel codice un nuovo art. 94-bis, ha previsto che, qualora accerti che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di “agevolazione occasionale”, il Prefetto, invece di disporre l’informazione interdittiva, possa/debba semplicemente adottare, per un periodo variabile dai 6 ai 12 mesi una o più “misure amministrative di prevenzione collaborativa”, consistenti in misure organizzative, specificamente individuate dalla stessa norma, atte a rimuovere e prevenire le cause dei suddetti rischi di agevolazione. Come rilevato nella richiamata Relazione DIA sul I semestre 2021, si richiede, in estrema sintesi all’impresa di comunicare al gruppo interforze istituito presso la prefettura gli atti di disposizione, gli incarichi professionali conferiti e ricevuti, le forme di finanziamento da parte dei soci o di terzi dei contratti di associazione in partecipazione stipulati, nonché l’utilizzazione di un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, per gli atti di pagamento e riscossione.
In buona sostanza, si tratta di uno strumento che si differenzia nei contenuti dal controllo giudiziario a richiesta (perché non prevede un amministratore giudiziario), assimilandosi, salvo che per l’applicazione della legge 231/2001, a quello previsto dalla lett. a) dell’art. 34-bis per il controllo giudiziario ordinario. Del controllo giudiziario -ordinario o volontario- il nuovo “controllo amministrativo” condivide comunque i presupposti e la ratio di evitare di travolgere le imprese attinte da contatti mafiosi meramente marginali, talvolta inevitabili in alcuni territori. In coerenza con i già richiamati principi di solidarietà e di buon andamento della pubblica Amministrazione, di cui è corollario il principio di leale collaborazione inserito dal dl 76/20 nell’art. 1 della l. n. 241/90, le nuove misure di prevenzione collaborativa consentono di anticipare nella fase amministrativa, a fronte del carattere meramente occasionale dei tentativi di infiltrazione, le misure di self cleaning previste per il controllo giudiziario. Si apre così utilmente la strada a una cooperazione “tra impresa e autorità amministrativa, consentendo a quest’ultima di entrare in azienda e verificare la presenza o meno dei pericoli di infiltrazione mafiosa, senza però esporla al rischio di una paralisi e salvaguardando il going concern aziendale e i livelli occupazionali”.
L’inserimento della novella nel decreto-legge sull’attuazione del PNRR rileva peraltro che le nuove misure di collaborazione preventiva non perseguono soltanto l’obiettivo privatistico di permettere all’impresa attinta dall’interdittiva di proseguire la propria attività imprenditoriale, ma anche un importante obiettivo pubblicistico, volto ad arginare i ritardi nell’attuazione delle politiche economiche nazionali (tra cui la realizzazione delle opere pubbliche di rilevanza nazionale, la ripresa delle attività edilizie e del turismo, ecc.) derivanti dai provvedimenti interdittivi, consentendo direttamente ai prefetti di sostituire, laddove possibile, le misure di prevenzione inibitoria con strumenti finalizzati a “recuperare” le imprese a rischio, indirizzandole verso una economia sana.
Il legislatore ha previsto opportune forme di coordinamento con le misure di prevenzione penale. Con particolare riferimento al controllo giudiziario ordinario, che può comunque sempre intervenire, l’art. 34-bis, co 1, nel testo novellato dalla riforma, precisa infatti che il Tribunale della prevenzione “valuta altresì se risultino applicate le misure di cui all’articolo 94-bis e, in tal caso, se … adottare, in loro sostituzione, il provvedimento di cui al comma 2, lettera b)”, consistente, come ricordato, nel monitoraggio e tutoraggio dell’amministratore giudiziario, tenendo eventualmente conto del periodo di esecuzione di tali misure ai fini della durata del controllo giudiziario. A conferma del rapporto di necessaria interrelazione con le misure di prevenzione penali, la novella dispone poi, significativamente, che, prima dell’adozione delle nuove misure collaborative, il Prefetto dovrà verificare l’eventuale sottoposizione del destinatario, nel quinquennio precedente, a pregressi provvedimenti di amministrazione giudiziaria o di controllo giudiziario ai sensi degli artt. 34 e 34-bis del codice. Inoltre, riscrivendo il co 7 dell’art. 34-bis, l’art. 47 del d.l. 152/21 specifica che l’applicazione di tali misure di prevenzione penale sospende, oltre che gli effetti dell’interdittiva, anche i termini indicati dall’art. 92, co 2, per l’effettuazione delle verifiche prefettizie e il conseguente rilascio dell’informazione antimafia.
Accogliendo i suggerimenti della Commissione parlamentare antimafia, lo stesso articolo, peraltro, inserisce il Prefetto che ha emesso l’interdittiva tra i soggetti che devono essere sentiti dal Tribunale al fine di decidere se concedere all’impresa il controllo giudiziario su richiesta. Il legislatore non ha invece accolto l’altra proposta della Commissione di estendere al Prefetto la facoltà di impugnare la decisione penale.
È comunque indubbio che il sistema assegna un ruolo centrale al Prefetto e al gruppo interforze istituito a suo supporto presso la prefettura. Il Prefetto può, peraltro, nominare anche uno o più esperti, in numero comunque non superiore a tre, con funzioni di supporto finalizzate all’attuazione delle nuove misure (art. 94-bis co. 2).
Formulando un’utile precisazione, l’art. 94-bis dispone poi, al 4° comma, che, alla scadenza del termine di durata delle misure amministrative adottate, il Prefetto, ove accerti, sulla base delle analisi formulate dal gruppo interforze, il venir meno dell’agevolazione occasionale e l’assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia un’informazione antimafia liberatoria ed effettua le conseguenti iscrizioni nella banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. La previsione, che potrebbe essere utilmente traslata anche al rapporto tra interdittiva amministrativa e controllo giudiziario, dovrebbe però essere completata da un’indicazione delle tempistiche del riesame, necessaria a rendere più effettiva la tutela giurisdizionale contro eventuali ritardi nell’aggiornamento del rischio.
La nuova misura di prevenzione amministrativa dovrebbe avere un impatto estremamente importante sul sistema. Innanzitutto, sul sindacato giurisdizionale sull’interdittiva. Fino a oggi il giudice poteva/doveva soltanto valutare se l’istruttoria e la motivazione giustificavano, alla luce degli elementi fattuali acquisiti e alla stregua del riferito criterio del “più probabile che non” (cd “probabilità cruciale”), la rilevazione di un rischio di dare spazio a tentativi di infiltrazione mafiosa. Un sindacato di legittimità sotto il profilo del rispetto delle -scarne- regole procedimentali e dell’eccesso di potere, nei limiti della non irragionevolezza della ritenuta sussistenza dei presupposti per l’adozione di una misura di prevenzione amministrativa, che si identificava necessariamente nell’interdizione dei rapporti con l’amministrazione. La valutazione di proporzionalità era stata fatta a monte dal legislatore e la Corte costituzionale ne aveva, come detto, affermato la coerenza sul presupposto del carattere preventivo e astrattamente provvisorio della misura, in tesi sufficiente a giustificare la prevalenza dell’interesse pubblico a fugare ogni possibile rischio di infiltrazione della cd criminalità organizzata nell’economia sull’interesse dell’imprenditore a non essere estromesso dal mercato. In questa luce, la Consulta aveva, come noto, affermato anche la compatibilità costituzionale della cd tassativizzazione giurisprudenziale delle ipotesi indiziarie della contaminazione, legata alla necessità di rispondere con la massima prontezza alla capacità delle organizzazioni mafiose di adattarsi rapidamente (“camaleonticamente”) ai mutamenti economici e sociali, coniando nuovi strumenti di infiltrazione. E l’unico paracadute dato all’impresa ritenuta a rischio di contaminazione era il controllo giudiziario su richiesta. Con le criticità di coordinamento cui si è sopra fatto cenno.
Oggi le cose sono, o almeno dovrebbero essere, profondamente cambiate.
Il Prefetto ha a sua disposizione due misure alternative di prevenzione, che, pur consentendo di fronteggiare il rischio di contagio, incidono in termini di ben diversa gravità sulla vita dell’impresa. Egli è quindi chiamato a valutare attentamente la situazione per operare la scelta più idonea. Non deve, in altri termini, più soltanto rappresentare, sulla scorta degli elementi indiziari tipizzati dalla giurisprudenza, una minima probabilità di rischio, ma deve anche dimostrare, attraverso un corretto adempimento degli oneri istruttori e motivazionali, che la misura adottata risponde ai rigorosi canoni dell’adeguatezza e della proporzionalità. E il giudice potrà e dovrà valutare la legittimità di questa scelta anche attraverso un vaglio del rispetto di tali canoni, indagando, con un sindacato effettivo sul fatto, sul carattere strutturale od occasionale delle circostanze da cui il Prefetto ha rilevato un pericolo di infiltrazione. Si pongono peraltro almeno due ordini di problemi.
Il primo -acutamente sollevato dal consigliere M. SANTISE nel già richiamato convegno di Palazzo Spada del 1° aprile scorso- è quello degli effetti del giudizio amministrativo di annullamento dell’interdittiva per difetto di motivazione sulla necessità di tale misura rispetto a quella introdotta dall’art. 94-bis. È chiaro che il ricorrente ha interesse a un annullamento tout court, ma una maggiore coerenza con la ratio delle misure di prevenzione antimafia renderebbe più opportuno, laddove ve ne siano i presupposti, un annullamento parziale -nella parte in cui non giustifica tale scelta- con conseguente immediata applicazione in via residuale delle misure collaborative.
Il secondo problema attiene, come è agevole comprendere e come ben emerso dalla citata sentenza del TAR Catania del 1° maggio scorso, ai rapporti con il controllo giudiziario a richiesta. Il fatto che le due misure rispondono a un’analoga ratio e muovono da un analogo presupposto -costituito dal carattere meramente occasionale della potenziale contaminazione e dal conseguente minore livello del rischio di infiltrazione- in una con la richiamata disciplina dei rapporti tra misure di collaborazione e controllo giudiziario, con l’espressa previsione che il giudice penale può, se del caso, sostituire le nuove, più miti, misure amministrative con il controllo attraverso l’amministratore giudiziario, indurrebbero a ritenere che il nuovo sistema di graduazione della prevenzione amministrativa dovrebbe implicare il superamento -e la conseguente eliminazione- dello strumento del controllo giudiziario su richiesta, preordinato, come detto, ad arginare gli effetti perniciosi dell’interdittiva in un contesto in cui il Prefetto non aveva alternative. Il fatto che la riforma abbia, come sopra ricordato, inserito il Prefetto che ha emesso l’interdittiva tra i soggetti che il Tribunale deve sentire prima di decidere sulla richiesta di ammissione al cd controllo volontario esclude però che il legislatore abbia operato (sia pure implicitamente) questa scelta. La permanenza delle due forme di controllo -peraltro con modalità diverse- crea tuttavia un evidente cortocircuito sul piano dei rapporti tra giudice amministrativo e giudice penale. Se, infatti, il Prefetto, nonostante la nuova possibilità di adottare la misura di collaborazione, ha ritenuto comunque necessario disporre la più grave misura interdittiva, vuol dire che ha già escluso il carattere “occasionale” della contaminazione e la conseguente possibilità di “bonificare” l’azienda, traghettandola in un contesto economico “sano”. Sicché, come è stato giustamente evidenziato, il giudice della prevenzione, per accogliere la richiesta di controllo, dovrebbe inevitabilmente effettuare una valutazione critica sui presupposti, e, dunque, sulla legittimità della decisione amministrativa: valutazione che è invece istituzionalmente riservata al giudice amministrativo. Significativamente il TAR Catania ha affermato che il fatto stesso dell’ammissione al controllo imporrebbe al Prefetto un immediato riesame della propria decisione interdittiva, secondo le nuove regole del contraddittorio procedimentale, con la precisazione che qualora la nuova istruttoria si concludesse con un giudizio prognostico positivo per l’impresa, alla rimozione dell’interdittiva dovrebbe fare automaticamente seguito la cessazione della misura di prevenzione penale, anche se medio tempore reiterata.
Si ripropone, dunque, l’annoso tema del rapporto tra giurisdizione penale e giurisdizione amministrativa, che, come ho avuto occasione di segnalare in riferimento alla materia edilizia, costituisce uno dei più gravi vulnera alla certezza del diritto e alla fiducia degli operatori e degli investitori.
*4. Conclusioni. Non resta quindi che auspicare un sollecito re-intervento legislativo, che, oltre a regolare i rapporti tra controllo giudiziario e informazione amministrativa e le tempistiche del riesame della persistenza dei presupposti per le misure di prevenzione -garantendo un costante aggiornamento della loro effettività necessità, soprattutto con riferimento all’interdittiva- rivaluti l’opportunità della permanenza del controllo su richiesta e, magari, come suggerito dal TAR Catania, consideri anche l’opportunità di intervenire sulle regole e sulle tempistiche processuali, a questo punto, tanto del giudizio amministrativo, quanto di quello penale. Aleggia peraltro sempre il problema dei limiti della trasparenza e delle garanzie partecipative del procedimento che ha condotto all’adozione delle misure di prevenzione amministrativa: problema che la riforma ha solo attenuato e che inevitabilmente si riflette sull’effettività di un sindacato giurisdizionale che non ha sempre pieno accesso al fatto.
Come è stato da varie parti segnalato, sarebbe peraltro parimenti auspicabile un intervento normativo uniformante dell’Unione europea, analogamente a quanto avvenuto per il mandato d’arresto europeo, riprendendo l’iniziativa a suo tempo bloccata dal “veto” opposto da alcuni Paesi (tra i quali, significativamente, Austria e Germania).
È in ogni caso assolutamente necessaria la creazione -a livello sia nazionale che europeo- di una valida “rete” di trasmissione delle informazioni e di coordinamento delle azioni tra le autorità competenti.
Si legge significativamente in un recente articolo sull’Huffington Post[29] che “il Consiglio europeo ci conferma che nel 2019 i proventi da attività illecite nei principali mercati criminali ammontavano all′1% del PIL dell’Unione europea, ossia a 139 miliardi di euro. Non è disponibile una statistica più recente, ma a parità di condizioni, è indubbio che la cifra per il periodo 2020-21 (periodo di pandemia da covid-19) sia notevolmente più alta. Finora negli anni precedenti non è mai scesa. Le organizzazioni criminali sono presenti in tutti gli Stati membri e operano a livello transfrontaliero.
Le principali attività criminali in Europa sono il traffico di stupefacenti, la cyber-criminalità, le frodi, il traffico di armi e la tratta di esseri umani. Nonostante una serie di nuove leggi e di sequestri di grandi dimensioni il colpo inferto alle organizzazioni mafiose è del tutto insufficiente”.
Non vi è dubbio quindi che il tema debba essere seriamente affrontato anche a livello europeo.
* Il lavoro costituisce rielaborazione dell'intervento svolto dall’A. il 4 maggio scorso alla Tavola rotonda sul tema delle “Misure interdittive antimafia”, organizzata dalla Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia nell’ambito del XXXVII Corso di Alta Formazione (anno accademico 2021/2022) ed è destinato anche agli scritti in memoria del Pres. Luigi Giampaolino.
Sull’informazione antimafia, senza alcuna pretesa di esaustività, si vedano, F. FIGORILLI-W. GIULIETTI, Contributo allo studio della documentazione antimafia: aspetti sostanziali, procedurali e di tutela giurisdizionale, in federalismi, 2021; R. DI MARIA e A. AMORE, Effetti “inibitori” della interdittiva antimafia e bilanciamento fra principi costituzionali: alcune questioni di legittimità dedotte in una recente ordinanza di rimessione alla Consulta, ivi, 2021; G. AMARELLI, Interdittive antimafia e “valori fondanti della democrazia”: il pericoloso equivoco da evitare, in giustiziainsieme, 2020; R. GAROFOLI e G. FERRARI, Sicurezza pubblica e funzioni amministrative di contrasto alla criminalità; le interdittive antimafia, in giustizia-amministrativa.it, 2019; J. P. DE JORIO, Le interdittive antimafia e il difficile bilanciamento con i diritti fondamentali, Napoli, 2019; A. LONGO, La «massima anticipazione di tutela». Interdittive antimafia e sofferenze costituzionali, in federalismi, 2019; AA. VV. in G. AMARELLI-STICCHI DAMIANI (a cura di), Le interdittive antimafia e le altre misure di contrasto all’infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici, Torino, 2019; M. MAZZAMUTO, Pil salvataggio delle imprese tra controllo giudiziario volontario, interdittive prefettizie e giustizia amministrativa, in Sistema penale, 2020; ID, Pagamento di imprese colpite da interdittiva antimafia e obbligatorietà delle misure anticorruzione, in Giur. it., 2019, 1, p. 157 ss.; A. BONGARZONE, L’informativa antimafia nelle dinamiche negoziali tra privati e pubbliche amministrazioni, Napoli, 2018; F.G. SCOCA, Le interdittive antimafia e la razionalità, la ragionevolezza e la costituzionalità della lotta “anticipata” alla criminalità organizzata, in giustamm.it, 2018; M. NOCCELLI, I più recenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa sul complesso sistema antimafia, in Foro amm., 2017, pp. 2524 ss.; A. MARCHESE, Soggetto e oggetto nel “diritto civile antimafia”, Milano, 2017; G. D’ANGELO, La documentazione antimafia nel D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159: profili critici, in Urb. e app., 2013, 3, p. 256 ss.
G. VELTRI, Questioni controverse in tema di interdittive antimafia, Relazione al convegno su “Questioni controverse di diritto amministrativo. Un dialogo tra Accademia e Giurisprudenza”, svoltosi a Palazzo Spada il 1° aprile scorso e visualizzabile dal link youtube indicato sul sito della giustizia amministrativa.
Su cui cfr. inter alia A. LONGO La Corte costituzionale e le informative antimafia. Minime riflessioni a partire dalla sentenza n. 57 del 2020, in Nomos, n. 2/2020).
M. NOCCELLI, Le informazioni antimafia tra tassatività sostanziale e tassatività processuale, in www.giustizia-amministrativa 2020.
Cfr. da ultimo, prima della riforma del 2021, Cons. Stato, III, 25 ottobre 2021 n. 7165 (con nota di P. CACACE, Conformità dell’interdittiva antimafia alle norme costituzionali, euro unitarie e internazionali pattizie, in giustamm.it, 2022, che, richiamando anche la sentenza n. 3 del 2018 dell’Adunanza plenaria, rimarca che la natura cautelare, anticipatoria e prudenziale, affermata da consolidata giurisprudenza, rende estranee al sistema sanzionatorio penale le misure interdittive antimafia, soggette, invece, al principio di legalità e a quello del giusto procedimento “secondo criteri di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità”.
Cfr. in argomento F. Fracchia-M. Occhiena, Il giudice amministrativo e l’inferenza logica: “più probabile che non” e “oltre”, “rilevante probabilità” e “oltre ogni ragionevole dubbio”. Paradigmi argomentativi e rilevanza dell’interesse pubblico, in Dir. econ., 2018, 3, pp. 1125-1164.
V. infra.
R. ROLLI, L’argine inadatto. Pluriformi verità sull’interdittiva antimafia, in corso di stampa, su gentile concessione dell’A.
Segnalo in particolare il convegno organizzato dalla Sezione di Reggio Calabria del TAR Calabria e dal Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze umane dell’Università Mediterranea su Il nuovo volto delle interdittive antimafia nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), svoltosi l’8 aprile scorso a Reggio Calabria.
V. GAETA, Il controllo giudiziario a richiesta dell'impresa e il compito del giudice ordinario, in giustiziainsieme,2021.
In argomento, inter alia, V. SALAMONE, La documentazione antimafia nella normativa e nella giurisprudenza, Napoli, 2019.
G. AMARELLI, La Cassazione riduce i presupposti applicativi del controllo giudiziario volontario ed i poteri cognitivi del giudice ordinario (a margine della sent. Cass. Pen., II, n. 9122 del 2021, in Sistema penale, 2021.
G. VELTRI, cit.
Sull’istituto del controllo giudiziario volontario, cfr., inter alia, S. FINOCCHIARO, La riforma del codice antimafia (e non solo): uno sguardo d’insieme alle modifiche appena introdotte, in Dir. pen. cont., 2017, 10, pp. 256 ss.A. MAUGERI, La riforma delle misure di prevenzione patrimoniali ad opera della l. 161/2017 tra istanze efficientiste e tentativi incompiuti di giurisdizionalizzazione del procedimento di prevenzione, in Arch. pen., 2018, pp. 368 ss.; C. VISCONTI, Il controllo giudiziario “volontario”: una moderna “messa alla prova” aziendale per una tutela recuperatoria contro le infiltrazioni mafiose, in G. AMARELLI-S. STICCHI DAMIANI (a cura di), Le interdittive antimafia, cit. pp. 237 e ss.; R. CANTONE-B. COCCAGNA, L’impresa raggiunta da interdittiva antimafia tra commissariamenti prefettizi e controllo giudiziario, ivi, pp. 283 e ss.;; E. BIRRITTERI, I nuovi strumenti di bonifica aziendale nel Codice Antimafia: amministrazione e controllo giudiziario delle aziende, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2019, pp. 859 ss.; M. MAZZAMUTO, Il salvataggio, cit. ; A.G. DIANA, Il controllo giudiziario nelle aziende, Pisa, 2021, pp. 237 ss.
V. GAETA, Il controllo, cit.; v. anche C. VISCONTI, Il controllo giudiziario “volontario”, cit.
Ancora V. GAETA, op. cit. Cfr. anche R. ROLLI e M. MAGGIOLINI, Interdittiva antimafia e giudicato penale, nota a Cons. Stato, III, 4 febbraio 2021, n. 1049, in giustiziainsieme, 2021.
[17] In argomento, cfr. da ultimo, gli Atti del convegno organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre e dal Consiglio di Stato su “I materiali della legge nella teoria delle fonti e nell’interpretazione del diritto”, svoltosi a Palazzo Spada il 20 aprile scorso, consultabili su youtube con il link indicato sul sito della giustizia amministrativa. Per una riflessione critica sulla giurisprudenza “creativa” si consenta il richiamo alle considerazioni svolte e agli scritti richiamati in M.A. SANDULLI, Per la Corte costituzionale non c’è incertezza sui termini per ricorrere nel rito appalti: la sentenza n. 204 del 2021 e il creazionismo normativo dell’Adunanza plenaria, in federalismi, 2021, e in Silenzio assenso e termine a provvedere. Esiste ancora l’inesauribilità del potere amministrativo?, in corso di pubblicazione in Il processo, n. 1/2022 e già leggibile e visualizzabile sul sito della giustizia amministrativa, cui adde l’Intervento al citato convegno del 20 aprile.
Sul punto, specificamente, G. AMARELLI, La Cassazione, cit.
Cfr. il già menzionato scritto di M. NOCCELLI, che, con riferimento all’ ordinanza Corte di Giustizia 28 maggio 2020, in C-17/20 (che non aveva affrontato la questione non rilevandone un interesse transfrontaliero, ma aveva nondimeno incidentalmente ricordato che il rispetto dei diritti di difesa costituisce un “principio generale del diritto dell’Unione che trova applicazione quando l’amministrazione intende adottare nei confronti di una persona un atto che le arrechi pregiudizio”), osservava che restava quindi “sullo sfondo l’interrogativo, se la partecipazione procedimentale, almeno in certe ipotesi, non sia necessaria ad evitare l’emissione del provvedimento interdittivo ed adottare misure meno invasive per l’impresa a rischio di infiltrazione mafiosa, anche in una prospettiva de iure condendo”. Significativamente, nella pluricommentata sent. n. 4979 del 2020, redatta dall’A., la III Sezione del Consiglio di Stato, pur ricordando che nel sistema disegnato dall’art 93 del codice 2011 l’audizione degli interessati “non è assente, ma solo eventuale, rimettendo alla valutazione discrezionale del prefetto la scelta sulla ‘… utilità di detto contraddittorio procedimentale in seno ad un procedimento informato da speditezza, riservatezza ed urgenza, per evidenti ragioni di ordine pubblico’ ” e che il sacrificio delle garanzie procedimentali, giustificato anche dall’esigenza di evitare strumentali iniziative dilatorie, sarebbe compensato dalla possibilità di far valere le proprie ragioni in sede giurisdizionale, attraverso il sindacato sull’atto adottato dal Prefetto che, contrariamente a quanto assume parte della dottrina, sarebbe pieno ed effettivo, in termini di full jurisdiction (cfr sent. n. 2854 del 2020), nei passaggi conclusivi, accogliendo anche le sollecitazioni della dottrina, suggeriva, de iure condendo, un recupero, quantomeno parziale, delle garanzie procedimentali, nel rispetto dei diritti di difesa spettanti al soggetto destinatario del provvedimento, in tutte quelle ipotesi in cui la permeabilità mafiosa «appaia alquanto dubbia, incerta, e presenti, per così dire, delle zone grigie o interstiziali, rispetto alle quali l’apporto procedimentale del soggetto potrebbe fornire utili elementi a chiarire alla stessa autorità procedente la natura dei rapporti tra il soggetto e le dinamiche, spesso ambigue e fluide, del mondo criminale». Sull’ordinanza di rimessione alla Corte di Giustizia, cfr. G. CARRATELLI Il (mancato) contraddittorio endoprocedimentale in materia di informazione antimafia – Nota a: Tar Puglia – Bari, sez. III, ordinanza 13 gennaio 2020, n. 28, in Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti pubblici [www.contabilita-pubblica.it] (30.01.2021).
Tema sul quale mi sono soffermata nella Relazione svolta al richiamato convegno di Reggio Calabria (in corso di pubblicazione e reperibile su youtube con il link segnalato su giustiziainsieme 2022) e sul quale segnalo, da ultimi, gli scritti di R. ROLLI e M. MAGGIOLINI, Notarelle sul riformato contraddittorio procedimentale in tema di interdittiva antimafia (nota a ordinanza Tar Lecce, sez. III, n. 116/2022), in giustiziainsieme 2022 e di N. DURANTE, Il contraddittorio nel procedimento di rilascio d’informazione antimafia, in giustizia-amministrativa, it.
M. VULCANO, Le modifiche del decreto-legge n. 152/2021 al codice antimafia: il legislatore punta sulla prevenzione amministrativa e sulla compliance 231 ma non risolve i nodi del controllo giudiziario, in Giur. pen. web, 2021, 11.
M. VULCANO, cit. V. anche D. ALBANESE, Le modifiche del d.l. 152/2021 al ‘codice antimafia’ in sistemapenale.it.
Cfr. R. ROLLI, L’argine inadatto, cit.: “Si è venuto così a creare un sistema bidirezionale: da un lato, l’insistenza dei mezzi di ablazione tradizionali quali la confisca e il sequestro, quali sistemi di lotta alla ricchezza di provenienza illecita; dall'altro, la previsione di un intervento pubblico finalizzato a soccorrere soggetti economici a rischio infiltrazione al fine di restituirli al mercato”, liberandoli dai “rischi derivanti dal condizionamento mafioso in un percorso di risanamento della legalità …a beneficio dell’intero sistema economico”.
Cfr. ancora la lucida analisi di M. NOCCELLI, cit.
G. VELTRI, cit.
Da ultimo, voce Edilizia, cit.
Sul tema, F. FRANCARIO, L’accertamento del fatto illecito nel giudizio amministrativo e nel giudizio penale: problemi ed interferenze, in Pubblica amministrazione diritto penale e criminalità organizzata (Atti del convegno), Milano, 2008, p. 93 ss; ID, Illecito urbanistico o edilizio e cosa giudicata. Spunti per una ridefinizione della regola del rapporto tra processo penale ed amministrativo, in Riv. Giur. Edil., 2015, p. 99 ss.
Cfr. gli scritti citati alla nota 20.
V. MUSACCHIO, L’Europa ha bisogno di nuove strategie per combattere le mafie, 9 gennaio 2022.





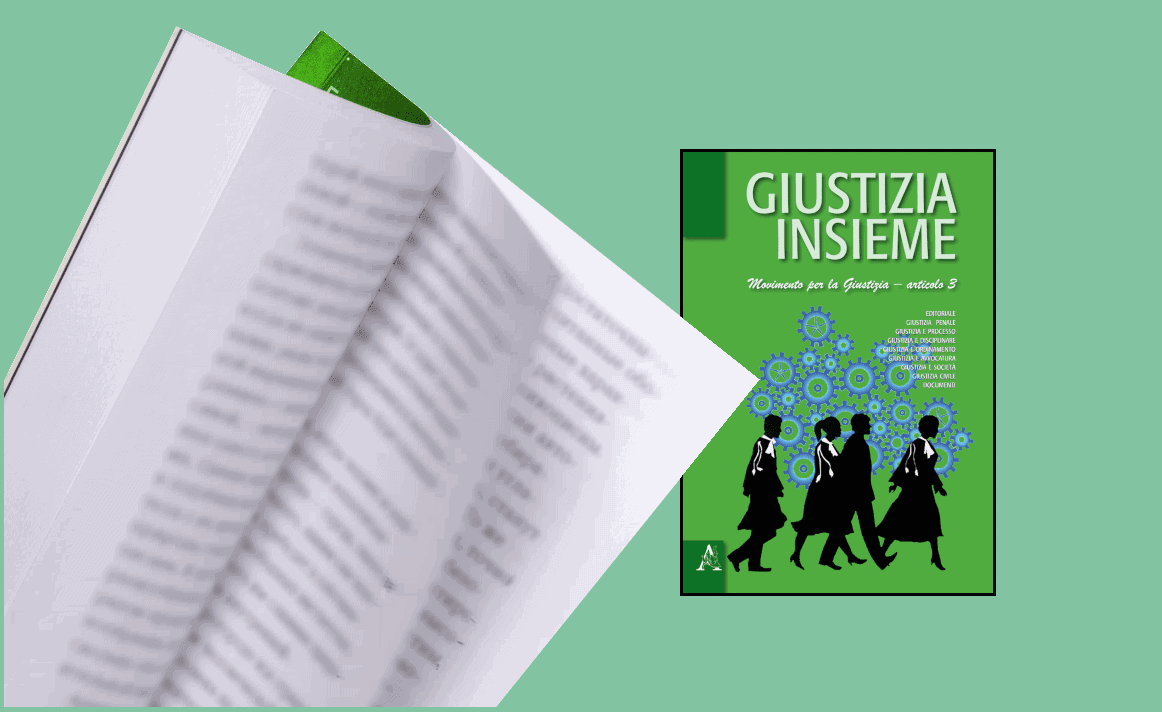
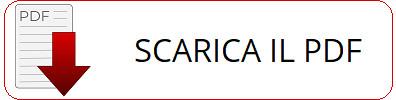

 E poi Aggiungi alla schermata principale.
E poi Aggiungi alla schermata principale.