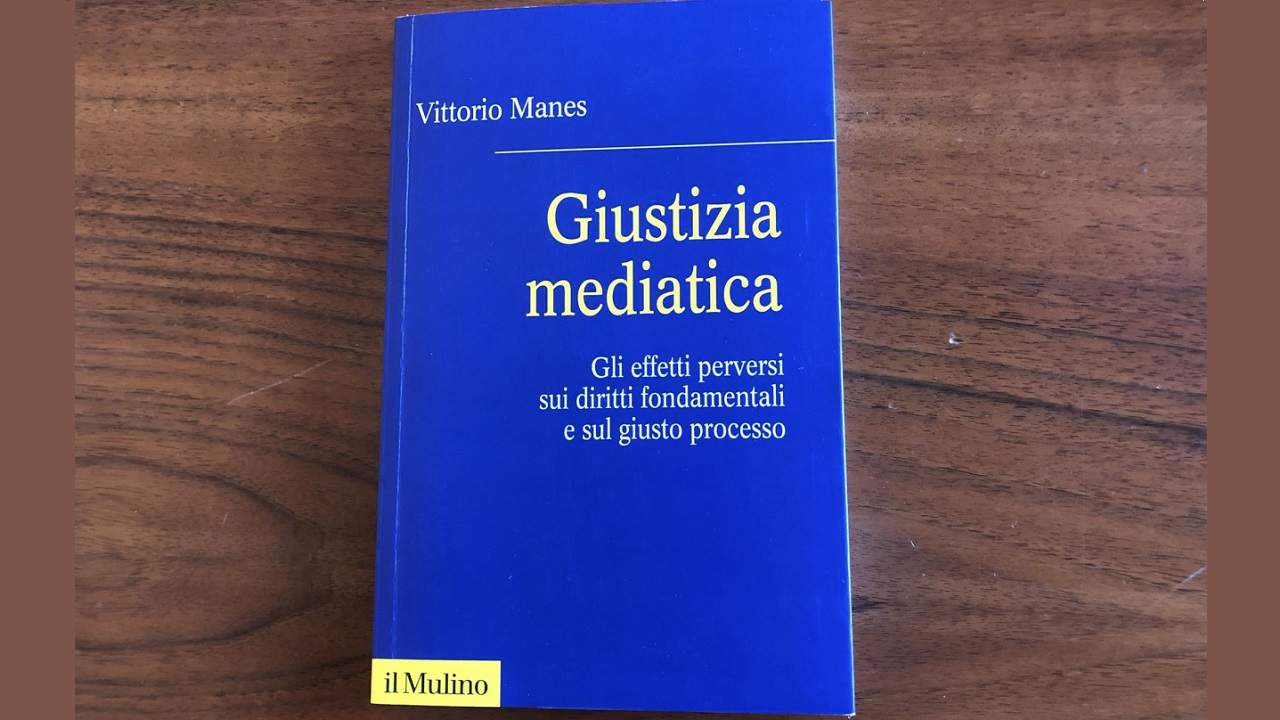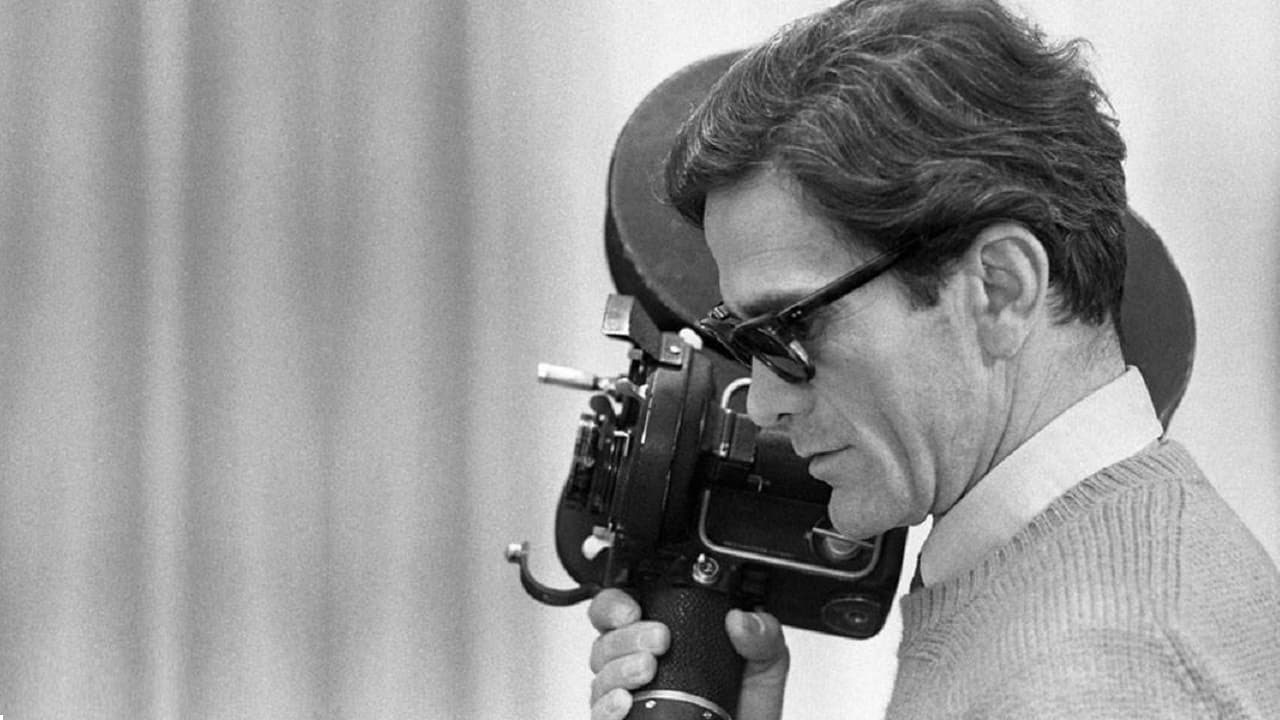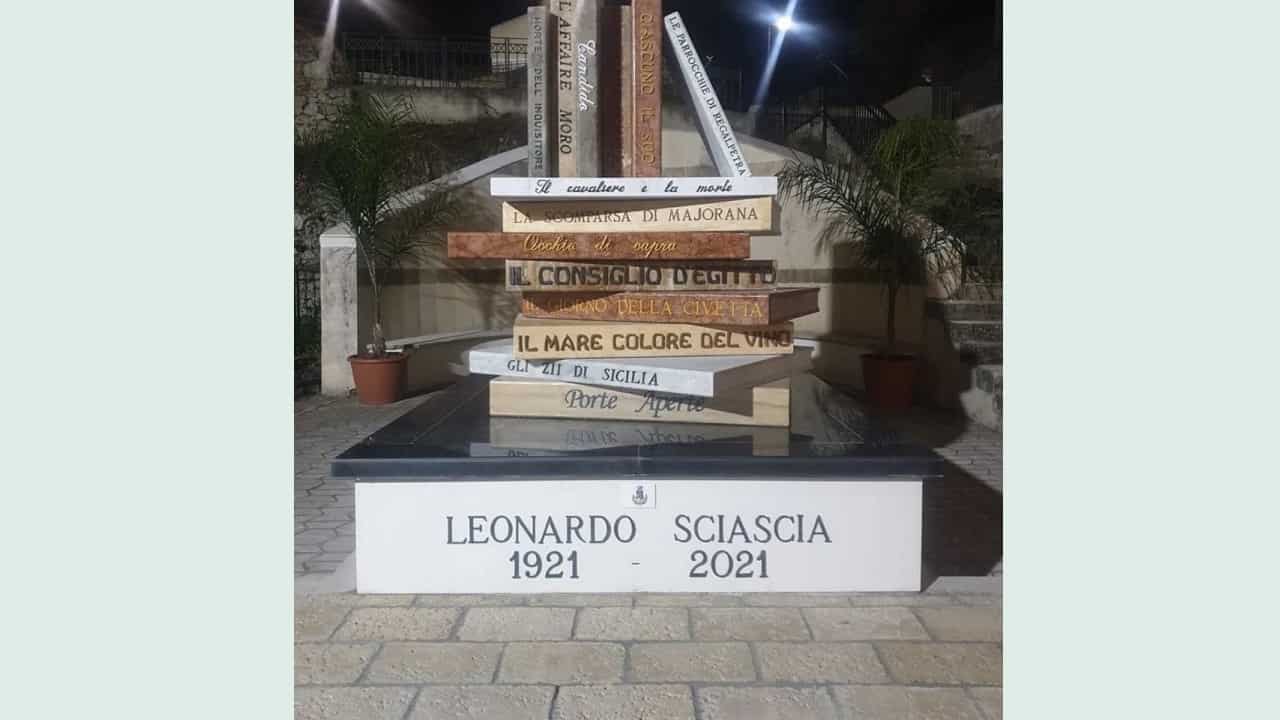Vivere e morire nella modernità: la fulminante lezione di Luciano Violante
Recensione al libro "Ma io ti ho sempre salvato". La maschera della morte e il nomos della vita (Bollati Boringhieri, 2024).
di Andrea Apollonio
Da tempo Luciano Violante si interroga sulle cause della "scomparsa" della politica, che si è trascinata dietro i corpi intermedi, e sulle conseguenti mutazioni delle strutture sociali. Egli ha proiettato le sue riflessioni sul principale nomosdell'Occidente, la democrazia (solo da ultimo: "La democrazia non è gratis" è dello scorso anno), sulla giustizia (ben noto il suo pamphlet "Magistrati" del 2009), sull'etica individuale ("Il dovere di avere doveri", del 2014, inaugurava l'approfondimento di un tema fin lì molto poco esplorato, a dispetto della sua centralità); tutti lavori che, a valle di una biografia scientifica e istituzionale senza termini di paragone, e assieme a molti altri dall'ampio respiro civile (pensiamo agli innumerevoli testi, dall'angolatura sempre diversa, sulla lotta alla mafia), si saldano e formano la trama di un pensiero coerente tutto incentrato sull'uomo e permeato di un umanesimo mai retorico, sempre vigoroso e franco.
Le riflessioni di Luciano Violante transitano adesso – parallelamente – per l'ultima tappa "terrena" dell'uomo: la morte; ma in realtà è il nomos di segno opposto a caratterizzarle: quello della vita. "Ma io ti ho sempre salvato". La maschera della morte e il nomos della vita" (Bollati Boringhieri, 2024 – una casa editrice, lo si tenga a mente, che ha pubblicato tra i più importanti testi della moderna filosofia) non è infatti un libro sulla morte, ma sulla vita. «Riprendere il senso della vita per governare la tecnica e dare un senso anche alla morte»: questa è forse la felice sintesi di un messaggio che, senza essere trattato come una questione di fede, viene lanciato guardando ad una realtà paradossale, centrata sul predominio della morte e – ciò che è ancora più tragico – alla sua banalizzazione.
È paradossale che «per un complesso di tabù, per abitudine, per la terribilità che la circonda, per il vuoto di pensiero, non si parla della morte», sebbene tutt'attorno a noi, attorniati da guerre sempre più insensate e micidiali, da dittature sempre più sanguinose, da migrazioni sempre più disperate, «la morte domina». E «resta singolare la contraddizione di un bene come la vita, che è sacro in quanto tale, e che poi nella concretezza della vita quotidiana, se appartiene a un immigrato irregolare, a un povero, a un debole, è abbandonata a ogni sorta di aggressione in un vuoto di diritti». D'altro canto, gli ultimi, nelle pagine di Luciano Violante, trovano ampio spazio: sono enumerate molte colpevoli indifferenze del nostro tempo, e quando si richiama il disastro di Cutro, viene ricordato ciò che in pochi hanno voluto ricordare: e cioè che è parte del mestiere di uomo, del faber, la ricerca, la lotta e la speranza, in vista di condizioni migliori di vita, anche per quelli che verranno; un mestiere la cui traduzione costituzionale sembra rintracciarsi all'art. 4 della nostra Carta. Eppure, in questo nostro sistema costituzionale e democratico, la vita degli ultimi vale sempre di meno. Forse va posto un problema morale?
La vita degli ultimi, sopratutto di quelli che esercitano consapevolmente il mestiere di uomo (e di quelli che non si determinano ma sono determinati, anch'essi sono tra gli ultimi: troppo spesso, ad esempio, «tacciamo delle vite dei giovani russi mandati a morire da Putin. Come se stare – giustamente – con gli ucraini ci debba rendere indifferenti di fronte alla morte dei loro coetanei russi»), è continuamente a rischio. «Sarebbe eticamente inaccettabile porre alla democrazia un problema morale?».
Ma è paradossale anche come alla morte, che ha da sempre un ruolo sociale ineludibile (e qui, come in altre parti del testo, si inseriscono a mo' di fotogrammi brevi racconti dell'adolescenza nell'assolata provincia barese, ove di fronte alla morte «si osservavano elaborati codici di comportamento»), oggi la modernità abbia dedicato i suoi non-luoghi: primi tra tutti le piattaforme social, dove «vita e morte sono mescolate insieme; reale e virtuale, il comico e il tragico, il dolore e la gioia. Il rischio è la perdita del senso del reale, con l'interruzione dei rapporti vitali che è la prima conseguenza della morte». Ci si avvia, così, verso la sua tragica banalizzazione.
Una riflessione colta e mai fine a se stessa: che da un lato pesca a piene mani nella storia e nel mito (e torna alla mente "Giustizia e mito", scritto con Marta Cartabia), che assume nel libro la valenza di una chiave di lettura, perché «i miti non sono favole; sono narrazioni che aiutano a dare un senso alla vita»; che dall'altro guarda oltre il tempo presente, agli strumenti che possano consentire la «ripresa della politica attraverso un nuovo umanesimo, come guida per un futuro a misura dell'uomo». Molto futuro e molto passato: «Mondo capitalistico e mondo sovietico avevano idee inconciliabili, ma entrambe parlavano del futuro, e per questa ragione ponevano la speranza, il progresso, la fiducia, la vita al centro dei progetti politici».
E nel mezzo? Nel mezzo ci siamo noi, impauriti; e siamo nel guado, impantanati in un presente di fatuo sviluppo che non rappresenta più una prova della nostra evoluzione ma la maschera del nostro declino – la maschera della morte, appunto.
Questo libro ultimo di Luciano Violante riesce a scuoterci, anche perché è diverso dagli altri – forse il punto non è cosa dice il libro, ma perché questo libro è stato scritto – financo nello stile, che rimane indefinibile: è uno scambio di battute fittissimo, che si espande, si dilata, davanti al quale siamo chiamati a far agire nel tempo minimo i nostri riflessi, la nostra indignazione, ma anche la nostra carica di futuro, quella che ancora rimane. Il messaggio, a questo punto, si fa ancora più chiaro: bisogna uscire dalla contemplazione, spiegare che è in gioco il valore dell'umanità e che il mondo non può dividersi tra quelli che muoiono e quelli che ne decidono la morte come danno collaterale. Le democrazie devono riacquisire la loro ragion d'essere; «produrre idee e politiche che facciano nascere speranza».
Ecco un'altra felice sintesi: «il potere politico, nella sua dimensione biopolitica, deve costruire speranza e quindi fiducia nella vita». Ma la politica non era "scomparsa"? Appunto, è necessario ricominciare, ripartire dal basso, dal «vivo, aperto e disponibile tessuto della nostra vita sociale», per dirla con le parole di Aldo Moro richiamate nel testo. Produrre idee e politiche che ridiano valore alla vita in un tempo di morte, che facciano nascere speranza nel futuro e ci liberino dall'illusione che la magistratura, ma sopratutto le leggi e le regole, sempre di più e sempre più inutili, possano risolvere l'enigma della vita: che va piuttosto compresa nel suo nomos.
Un libro densissimo, fulminante, necessario. Che trascina velocemente il lettore nei meandri di una modernità che non ha mantenuto le sue promesse; e che nella sua ultima parte si ferma, con l'affanno di chi, ad un certo punto, deve lasciare spazio alle parole più intime: quelle sì, davvero necessarie, davvero definitive.
L'unicità di questo libro sta infatti nell'ultimo capitolo: "Le mie morti".
Luciano Violante vi richiama con intensità le morti di sua nonna, di sua madre, infine di sua moglie: di quest'ultima, ne ripercorre gli ultimi giorni, l'agonia, e poi l'assenza. Giulia De Marco è stata una delle prime otto donne a diventare magistrato; come presidente del Tribunale dei Minorenni di Torino, ha introdotto importanti innovazioni ancora oggi ricordate dagli specialisti; ma sopratutto era «una parte di sé, quella che si era costruita attraverso il dialogo e la vita comune per 56 anni».
Perché scendere così a fondo nella propria biografia, nei ricordi, in fratture mai sanate, e da ultimo nei dolori più intensi?
Non lo so, o forse lo intuisco: Luciano Violante non ha mai accettato l'insostenibile retorica del nostro tempo, quella che gira a vuoto, che sfugge dai significati per rifugiarsi in slogan sempre più grezzi e vuoti; che è, in ultima analisi, la causa prima della scomparsa della politica. L'unico modo per opporsi alla crisi culturale (e quindi politica) della modernità è la cultura autenticamente reale – accompagnata dalla forza del proprio pensiero – della propria biografia: che configura, con il linguaggio immediato della fisicità – una fisicità che in questo caso drammaticamente svanisce – un mezzo espressivo potentissimo.
Quest'ultimo e più intimo capitolo si rivela quindi uno strumento di contaminazione stilistica, provoca l'occhio – attraverso una scrittura così potente – a vedere diversamente e a riflettere sul vedere stesso. A riflettere sulla maschera della morte e sul nomos della vita, che la società, da tempo priva di riferimenti politico-culturali, ha irrimediabilmente smarrito, assieme alla tenerezza palingenetica della frase che dà il titolo al libro: «Ma io ti ho sempre salvato», diceva la madre ormai agonizzante, «e io pensavo che quel corpo prima mi aveva fatto nascere e poi mi aveva salvato più di una volta». La vita è questo.
Perché, in fondo, non ha alcun senso parlare di politica, di società, di democrazia, di giustizia, di etica individuale, se prima non riacquistiamo il senso della vita: che va compresa nel suo nomos.