Forma dell’atto di riassunzione di un precedente giudizio e sinteticità degli atti nel processo amministrativo (Nota a Cons. giust. amm. Regione Sicilia, 3 marzo 2022, n. 20)
di Ilaria Genuessi
Sommario: 1. Il caso di specie. – 2. Il richiamo nella pronuncia alla riassunzione di un precedente giudizio: cenni al fenomeno della translatio iudicii. – 3. Forma dell’atto di riassunzione e principio di sinteticità in ambito processuale amministrativo nelle previsioni ante Codice del processo amministrativo. – 4. Sinteticità e limiti dimensionali degli atti processuali di parte nelle previsioni normative vigenti: l’art. 13-ter All. II c.p.a. e il d.P.C.S. 167/2016. – 5. Il decreto in esame nel quadro delle pronunce giurisprudenziali sul punto. – 6. L’assenza di un’applicazione sistematica da parte della giurisprudenza delle conseguenze delle condotte difformi rispetto al principio di sinteticità. – 7. Osservazioni conclusive anche alla luce dell’art. 24 Cost.
1. Il caso di specie
Nella vicenda in esame, concernente un giudizio in ambito risarcitorio, il Presidente della sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana si pronuncia a seguito del deposito dell’istanza, formulata dalla società appellante, in relazione al proponendo appello per la riforma della sentenza del Tar Sicilia – Catania, sez. III, 17 settembre 2021, n. 2791, espressasi con dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto.
L’appellante, nel dettaglio, presenta al Presidente del CGARS un’istanza di deroga ai limiti dimensionali degli atti previsti per il giudizio di appello, motivando l’istanza suddetta con l’esigenza di attaccare la sentenza del giudice di prime cure, riproponendo i motivi del ricorso di primo grado, a sua volta rappresentante, di fatto, atto di riassunzione del giudizio in precedenza incardinato davanti al giudice civile, in sede di appello.
Il decreto in questione si pronuncia, pertanto, in prima battuta, sulla questione della riassunzione di un precedente giudizio davanti al giudice amministrativo: nelle statuizioni del Presidente della Sezione giurisdizionale del CGARS si rinvengono, infatti, rilevanti precisazioni proprio a proposito dell’atto di riassunzione avanti al giudice amministrativo, circa il contenuto del medesimo, ma altresì con riguardo alla forma, anche e soprattutto in termini di estensione e limiti dimensionali dell’atto di parte nel giudizio di appello e relative possibili deroghe.
In altri termini, la pronuncia opera un riferimento generale alle modalità di riassunzione del giudizio avanti ad altro giudice, sebbene il giudicante si soffermi, in particolar modo, sul dato formale della estensione dell’atto di riassunzione medesimo; per tali ragioni, si ritiene il decreto in commento offra lo spunto per operare una compiuta riflessione a proposito dei fondamentali principi di sinteticità e chiarezza del ricorso e degli atti difensivi nell’ambito del processo amministrativo, anche alla luce dei criteri di redazione e dei limiti dimensionali degli atti in tale ottica individuati mediante decreto del Presidente del Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 13-ter dell'Allegato II al Codice del processo amministrativo.
È proprio sull’essenziale principio di sinteticità degli atti nel processo amministrativo, anche in termini di approdi della dottrina e della giurisprudenza, che si intende dunque soffermarsi nella presente sede.
2. Il richiamo nella pronuncia alla riassunzione di un precedente giudizio: cenni al fenomeno della translatio iudicii
Come anticipato, il Presidente, esprimendosi sull’istanza formulata, rileva anzitutto nel decreto come, al fine di impugnare la sentenza di primo grado, l’appellante abbia prodotto uno «schema di atto di appello redatto con tecnica di copia e incolla e struttura “a matrioska” », laddove l’atto di appello ricalca in maniera pedissequa il ricorso presentato al T.a.r., a sua volta identico rispetto all’atto di appello in sede civile e occupante 174 cartelle.
Ne consegue la rilevante statuizione in tema di forma (e sostanza) dell’atto di riassunzione di un precedente giudizio, riassunzione che – come espresso chiaramente dall’organo giudicante nel caso di specie – determina e richiede la “riproduzione sostanziale” di un precedente atto processuale, senza novazione. In altri termini, la riassunzione non richiederebbe una riproduzione in senso “formale” dell’atto precedente, specialmente laddove la struttura dell’atto riprodotto non appaia conforme – come del resto nel caso in questione – ai parametri ed alle specifiche previsioni vigenti in relazione agli atti del processo amministrativo[i].
In merito, non si può non richiamare, di conseguenza, il noto principio della "traslatio iudicii", compiutamente trattato nell’ambito della nota sentenza della Corte costituzionale 12 marzo 2007, n. 77[ii], laddove si è dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 30 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, nella parte in cui non prevedeva che gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione si conservassero, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione.
Nella pronuncia si è altresì ravvisata l'esigenza di colmare una lacuna dell'ordinamento processuale, introducendo con urgenza una disciplina legislativa sul punto che – si è evidenziato – dovesse essere vincolata solo nel senso della attuazione del principio della conservazione degli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione nel giudizio ritualmente riattivato – a seguito di declinatoria di giurisdizione – davanti al giudice che ne è munito.
La suddetta pronuncia del Giudice costituzionale, peraltro, ha rammentato nell’ambito della motivazione come immediato precedente della pronuncia stessa fosse rappresentato dalla sentenza della Corte costituzionale del 6 luglio 2004 n. 204, la quale ha precedentemente dichiarato la «illegittimità costituzionale di talune norme che, secondo il criterio dei "blocchi di materie", ripartivano la giurisdizione tra autorità giudiziaria ordinaria e giudice amministrativo»[iii].
L’istituto in questione, recentemente disciplinato dall'art. 59 della l. 18 giugno 2009, n. 69, risulta oggi regolato, per quel che concerne nello specifico il processo amministrativo, dall'art. 11 d.lgs. 104/2010 s.m.i.[iv], ai sensi del quale il processo promosso avanti ad un giudice carente di giurisdizione può essere riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, laddove il processo sia riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.
A seguito dell’entrata in vigore delle predette norme i giudici amministrativi hanno dunque ribadito in numerose occasioni come la "traslatio iudicií", in conseguenza della declaratoria di difetto di giurisdizione ad opera del giudice adito, determini la riassunzione del giudizio innanzi al giudice indicato, sebbene nei limiti della domanda inizialmente proposta, ossia con esclusivo riferimento al petitum ed alla causa petendi propri dell'originario giudizio promosso innanzi al giudice sfornito di giurisdizione, non essendo ammissibili in sostanza domande nuove[v].
Tale interpretazione è, del resto, sostenuta anche dall’organo giudicante nella pronuncia in esame, laddove opera sul punto uno specifico richiamo alla riproduzione “sostanziale” del precedente atto processuale di parte, “senza novazione”.
Chiarito il suddetto aspetto relativo alle peculiarità dell’atto di riassunzione e proprio poggiando le ulteriori indicazioni su tale presupposto, il giudice evidenzia, nel decreto preso in esame, come la necessità di operare una riproduzione pedissequa e formale degli atti – peraltro estremamente estesi e articolati – del precedente giudizio avanti al giudice civile e di riassunzione in primo grado avanti al giudice amministrativo nella fattispecie in questione, non possa essere ritenuta quale giusta causa di deroga dei limiti dimensionali del ricorso in appello nell’ambito del processo amministrativo.
Peraltro, nel caso di specie, l’organo giudicante osserva come anche in relazione al tipo di contenzioso azionato, di ordine risarcitorio, non si ravvisi ricorrenza statistica di atti processuali estesi “oltre 170 pagine” e neppure vi sia prova di ragioni peculiari ed eccezionali, tali da giustificare, nel caso concreto in questione, tale estensione dell’atto introduttivo del giudizio di appello.
3. Forma dell’atto di riassunzione e principio di sinteticità in ambito processuale amministrativo in senso generale e nelle previsioni ante Codice del processo amministrativo
Come accennato, la pronuncia in commento viene resa a proposito della questione dei limiti dimensionali del ricorso in appello, nel caso di specie atto di riassunzione di un precedente giudizio, nell’ambito del processo amministrativo e relative deroghe.
La medesima offre così l’opportunità di riflettere a proposito della questione della sinteticità degli atti difensivi nell’ambito del processo amministrativo, principio da ultimo codificato in specifiche previsioni di cui al d.lgs. n.104/2010[vi].
In senso generale, è negli anni Novanta che si origina un vero e proprio dibattito circa la sinteticità degli atti, peraltro sviluppatosi con l’avvento dell’informatica e la inevitabile ed evidente conseguenza della possibile redazione degli atti giudiziari secondo un sistema “copia e incolla” – peraltro menzionato nella stessa pronuncia in commento – determinante una produzione di atti difensivi sovente di dimensioni spropositate od abnormi[vii].
In ambito sovranazionale, la questione della necessaria sinteticità degli atti è presa in considerazione dalle stesse Corti internazionali, le quali hanno individuato precisi limiti dimensionali rispetto agli atti di parte: così la Corte di Giustizia UE, avanti la quale è prevista la presentazione di ricorsi e memorie aventi un predeterminato numero massimo di pagine[viii]e la stessa Corte europea dei diritti dell’uomo che prevede l’impiego di un formulario di ricorso, che rechi una esposizione dei fatti e dei motivi “succinta”[ix].
Nel nostro ordinamento il principio di sinteticità ha investito lo stesso processo civile, peraltro con l’affermazione, in tempi recenti, di un accesso dibattito sul punto, anche in conseguenza di precise disposizioni introdotte dal legislatore nel senso della semplificazione del momento decisorio nell’ambito del processo civile[x].
Nell’ambito del contenzioso amministrativo, nello specifico, tale principio ha lentamente fatto capolino sul piano normativo, dapprima – come si avrà modo di evidenziare – con esclusivo riferimento al rito in materia di appalti pubblici, mentre ad oggi, a seguito della intervenuta codificazione generale all’interno del c.p.a., il principio di necessaria sinteticità degli atti rappresenta un vero e proprio principio generale del processo amministrativo[xi].
Ripercorrendo le tappe della sua affermazione, occorre osservare anzitutto come nella legislazione che precede il Codice del processo amministrativo si ravvisano unicamente disorganiche e sporadiche previsioni relative alla sinteticità degli atti: così l’art. 6 del r.d. n. 642/1907, laddove rispetto al contenuto del ricorso, si menzionava l’”esposizione sommaria dei fatti”, ovvero l’art. 41, comma 1 del r.d. n. 1054/1924, il quale prevedeva che nella pubblica udienza l’avvocato potesse essere ammesso a svolgere “succintamente il proprio assunto”.
Procedendo con ordine, tuttavia, si può rilevare come il principio di sinteticità degli atti abbia fatto ingresso nell’ambito del processo amministrativo, come accennato, mediante le specifiche previsioni di cui al d.lgs. 20 marzo 2010, n. 53, recante normativa interna di attuazione della direttiva 2007/66/CE con riferimento al miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia di contratti pubblici. Tali previsioni hanno in sostanza individuato una disciplina speciale finalizzata ad una più rapida definizione dei giudizi in materia di appalti pubblici, rispetto al giudizio: nello specifico, l’art. 245, comma 2-undecies del d.lgs. 163/2006 ha disposto che tutti gli atti di parte, con riferimento ai predetti ricorsi, dovessero essere sintetici, mentre la sentenza dovesse essere di norma redatta in forma semplificata.
La previsione in questione, concernente il rito in materia di appalti, è stata inoltre ribadita nell’ambito dell’art. 120, comma 10 c.p.a.: rispetto alle controversie in materia di contratti pubblici cioè il codice del processo amministrativo ha dettato una speciale disciplina in materia di sinteticità degli atti, alla luce della quale “tutti gli atti di parte e i provvedimenti del giudice devono essere sintetici”[xii].
Di seguito, mediante la previsione di cui all’art. 3 c.p.a., riguardante proprio il dovere di motivazione ed il principio di sinteticità degli atti, quest’ultimo è stato introdotto nell’ambito dell’ordinamento interno quale vero e proprio principio generale, valevole non più soltanto con riguardo alla materia dei contratti pubblici, ma esteso a qualsiasi giudizio amministrativo[xiii].
La regola generale di sinteticità suddetta, peraltro, non gode di una “tutela” costituzionale, a differenza del dovere di motivazione laddove si consideri la previsione di cui all’art. 111 Cost; il principio di cui trattasi, può conseguentemente essere considerato una specificazione od un corollario del principio generale e, di rilievo costituzionale, del giusto processo, inteso, in particolare, nel senso della ragionevole durata del processo[xiv].
Il principio, inoltre, al momento della sua generale codificazione nell’ambito processuale amministrativo, è stato previsto quale disposizione meramente programmatica, in quanto tale non assistita da alcuna sanzione per il caso di violazione del precetto[xv].
Soltanto in seguito, mediante il c.d. secondo correttivo al c.p.a., di cui al d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160, che ha introdotto “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell’articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69”, si è disposta una modifica alla disciplina specifica di cui all’art. 26 in tema di spese di giudizio, con la previsione per cui l’organo giudicante possa, ai fini della condanna alle spese di lite, prendere in considerazione, altresì, il “rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità” di cui all’articolo 3, comma 2 c.p.a.[xvi]
Ulteriori specificazioni al principio in esame, in particolare con riferimento ai parametri per la definizione della sinteticità, intervengono sul piano normativo sempre in un secondo momento e – come già evidenziato rispetto al principio in senso generale – dapprima con esclusivo riguardo al rito speciale dedicato alla materia degli appalti pubblici e, in seguito, anche rispetto all’intero processo amministrativo.
Nel dettaglio, occorre riferirsi in primo luogo alla modifica apportata all’art. 120, comma 6 c.p.a. ad opera dell’art. 40, comma 1, lett. a) del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, laddove si è previsto, al fine di consentire uno spedito svolgimento del giudizio, coerentemente con la previsione di cui all’art. 3, comma 2 c.p.a., che le parti dovessero contenere le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini previsti da apposito decreto del Presidente del Consiglio di Stato, adottato sentiti il Consiglio nazionale forense e l’Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria riconosciute degli avvocati amministrativisti.
Con lo stesso decreto si prevedeva dovessero in aggiunta essere individuati i casi per i quali, per specifiche ragioni, potesse essere consentito superare i relativi limiti. Il medesimo decreto, nel fissare i predetti limiti dimensionali, stabiliva si dovesse tenere conto di una serie di aspetti, tra i quali: il valore effettivo della controversia, la sua natura tecnica e il valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti.
La medesima previsione di cui all’art. 120, comma 6 c.p.a. prevedeva che il giudice dovesse esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti[xvii].
In attuazione della previsione suddetta, riferita al rito appalti, è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 40 del 25 maggio 2015; quest’ultimo rappresenta un approdo fondamentale con particolare riguardo ai limiti dimensionali degli atti, posto che, mediante tale decreto, per la prima volta si è individuato un preciso contenuto dimensionale rispetto al principio di sinteticità[xviii].
Successivamente l’art. 7-bis della legge 25 ottobre 2016, n. 197 di conversione del d.l. 31 agosto 2016, n. 168 recante “Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l’efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa” ha disposto l’abrogazione della suddetta norma, introducendo l’art. 13-ter in sede di Allegato II al c.p.a. rubricato “Criteri per la sinteticità e la chiarezza degli atti di parte”.
Tale norma, in sostanza, ha esteso la disciplina poc’anzi esposta e riferita al solo rito in materia di appalti a tutto il processo amministrativo.
4. Sinteticità e limiti dimensionali degli atti processuali di parte nelle previsioni normative vigenti: l’art. 13-ter All. II c.p.a. e il d.P.C.S. 167/2016
L’art. 13-ter dell’All. II c.p.a. oggi dispone che “1. Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con i principi di sinteticità e chiarezza di cui all'articolo 3, comma 2, del codice, le parti redigono il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del presidente del Consiglio di Stato, da adottare entro il 31 dicembre 2016, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria degli avvocati amministrativisti. 2. Nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi si tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto. 3. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti. 4. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, anche mediante audizione degli organi e delle associazioni di cui al comma 1, effettua un monitoraggio annuale al fine di verificare l'impatto e lo stato di attuazione del decreto di cui al comma 1 e di formulare eventuali proposte di modifica. Il decreto è soggetto ad aggiornamento con cadenza almeno biennale, con il medesimo procedimento di cui al comma 1. 5. Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti. L'omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione”.
Il decreto n. 40/2015 sopra menzionato è stato successivamente sostituito dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016, emanato in ottica generale con riferimento all’intero processo amministrativo, in attuazione dell’art. 13-ter suddetto, decreto a sua volta modificato dal successivo d.P.C.S. 16 ottobre 2017, n. 127.
Il provvedimento in questione riveste particolare rilevanza ai fini della trattazione presente considerato che, in primo luogo, ha individuato precisi criteri di redazione degli atti processuali di parte, tra i quali: l’indicazione distinta dei fatti e dei motivi in parti specificamente rubricate; l’individuazione, sempre in distinti paragrafi, specificamente titolati, delle eccezioni di rito e di merito, le richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, le richieste di rinvio alla Corte costituzionale, le istanze istruttorie e processuali; la formulazione di motivi e specifiche domande in paragrafi numerati e muniti di titolo.
Tra gli altri criteri redazionali di cui al decreto presidenziale, avuto riguardo in particolare alla pronuncia in commento, si evidenzia inoltre la specifica previsione di cui all’art. 2, lett. d) alla luce della quale le parti “evitano, se non è strettamente necessario, la riproduzione pedissequa di parti del provvedimento amministrativo o giurisdizionale impugnato, di documenti e di atti di precedenti gradi di giudizio mediante “copia e incolla”; in caso di riproduzione, riportano la parte riprodotta tra virgolette, e/o in corsivo, o con altra modalità atta ad evidenziarla e differenziarla dall’atto difensivo”.
L’art. successivo del decreto in esame detta, in aggiunta, i precisi limiti dimensionali degli atti processuali di parte individuando nello specifico un numero massimo di caratteri, in conformità alle specifiche tecniche di cui all’articolo 8 del medesimo decreto, indicati per ciascun rito ed in particolare: “a) nei riti dell’accesso, del silenzio, del decreto ingiuntivo (sia ricorso che opposizione), elettorale di cui all’articolo 129 del codice del processo amministrativo, dell’ottemperanza per decisioni rese nell’ambito dei suddetti riti, dell’ottemperanza a decisioni del giudice ordinario, e in ogni altro rito speciale non espressamente menzionato nel presente comma, 30.000 caratteri (corrispondenti a circa 15 pagine nel formato di cui all’articolo 8); b) nel rito ordinario, nel rito abbreviato comune di cui all’art. 119, nel rito appalti, nel rito elettorale di cui all’articolo 130 e seguenti del codice del processo amministrativo, e nei giudizi di ottemperanza a decisioni rese nell’ambito di tali riti, 70.000 caratteri (corrispondenti a circa 35 pagine nel formato di cui all’articolo 8); c) la memoria di costituzione unica relativa a un numero di ricorsi o impugnazioni superiori a due, proposti contro un atto plurimo, non può eccedere le dimensioni della somma delle singole memorie diviso due”.
Ulteriore questione prevista nell’ambito del decreto Presidenziale più recente, la quale rileva con riferimento alla pronuncia in commento, è certamente quella delle deroghe previste rispetto ai suddetti limiti dimensionali degli atti (espressamente indicate all’art. 5 del decreto) secondo un procedimento di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali – descritto al successivo art. 6 – consistente nella valutazione in ordine alla sussistenza dei predetti presupposti di cui all’art. 5 ad opera del Presidente del tribunale adito.
Al fine dell’ottenimento dell’autorizzazione al superamento dei limiti, il ricorrente, principale o incidentale, è in concreto chiamato a formulare istanza motivata, allegando ove possibile lo schema di ricorso, sulla quale il Presidente o il magistrato delegato debbono pronunciarsi con decreto, entro i tre giorni successivi, così come avvenuto mediante la pronuncia in commento[xix].
5. Il decreto in esame nel quadro delle pronunce giurisprudenziali sul punto
La giurisprudenza ha applicato il suddetto principio generale di sinteticità di cui all’art. 3, comma 2 del c.p.a. individuando rispetto a singoli casi una violazione del dovere di sinteticità, anche prima della introduzione nell’ordinamento interno, rispetto a tutti i giudizi promossi avanti ai giudici amministrativi, degli specifici criteri di redazione degli atti e dei precisi limiti dimensionali degli atti di parte.
In tal senso, si è ritenuto contrario al dovere di sinteticità un atto di appello connotato da “estrema prolissità e ripetitività (…), che ha particolarmente aggravato l’attività difensiva delle controparti mediante violazione dei principi di cui al cit. art. 3 c.p.a., soprattutto in quanto reca: 1) 53 pagine di oltre 30 righe, palesemente non proporzionate al livello di complessità della causa; 2) un evidente abuso della funzione di c.d. “copia e incolla”, applicata ad atti già necessariamente presenti nel fascicolo (ricorso di primo grado e sentenza appellata); 3) una frequente ripetizione di concetti già esposti”[xx].
Nel caso di specie, applicando le previsioni generali di cui all’art. 3, comma 2 c.p.a. e all’art. 13-ter All. 2 c.p.a, ma altresì gli artt. 5 e 6 del d.P.C.S. n. 167/2016, l’organo giudicante adito ai fini dell’autorizzazione di cui all’art. 6 del medesimo decreto, mediante istanza di deroga ai limiti dimensionali, precisa come giusta causa di deroga ai suddetti limiti, in sede di riassunzione e nell’ambito del giudizio di appello, non possa essere ritenuta la circostanza della particolare estensione degli atti precedenti di ricorso alla Corte d’appello e di ricorso al T.A.R. in primo grado.
In aggiunta, come asserito, né si ravvisano, né risultano provate “eccezionali ragioni” giustificanti nel caso concreto l’estensione dell’atto, in deroga al principio di sinteticità.
L’istanza è pertanto solo parzialmente accolta, in applicazione del disposto di cui all’art. 5, comma 1 del d.P.C.S. richiamato, in particolare con autorizzazione di 100.000 caratteri, esclusi spazi, epigrafe, dispositivo e riassunto iniziale.
Un aspetto sul quale si è incentrato il dibattito dottrinale, laddove si consideri anche quanto osservato nella pronuncia in commento, è senza dubbio quello della innegabile discrezionalità che connota le decisioni degli organi giudicanti, nell’interpretazione e nell’applicazione concreta delle previsioni di cui all’art. 5 del d.P.C.S. e così, caso per caso, nella valutazione circa la sussistenza dei generali presupposti di fatto legittimanti l’autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali degli atti.
Il menzionato art. 5 fa riferimento in particolare ad una controversia che “presenti questioni tecniche, giuridiche o di fatto particolarmente complesse ovvero attenga ad interessi sostanziali perseguiti di particolare rilievo anche economico, politico e sociale, o alla tutela di diritti civili, sociali e politici; a tal fine vengono valutati, esemplificativamente, il valore della causa, ove comunque non inferiore a 50 milioni di euro nel rito appalti, determinato secondo i criteri relativi al contributo unificato; il numero e l'ampiezza degli atti e provvedimenti effettivamente impugnati, la dimensione della sentenza gravata, l'esigenza di riproposizione di motivi dichiarati assorbiti ovvero di domande od eccezioni non esaminate, la necessità di dedurre distintamente motivi rescindenti e motivi rescissori, l'avvenuto riconoscimento della presenza dei presupposti di cui al presente articolo nel precedente grado del giudizio, la rilevanza della controversia in relazione allo stato economico dell’impresa; l'attinenza della causa, nel rito appalti, a taluna delle opere di cui all'articolo 125 del codice del processo amministrativo”.
Oltretutto, le predette deroghe ai limiti dimensionali individuati in attuazione del generale e codificato principio di sinteticità – occorre precisare – si rinvengono nell’ambito di un atto, il decreto del Presidente del Consiglio di Stato, che difficilmente può essere inquadrato nell’ambito delle fonti di rango primario.
Ulteriore questione connessa e – si ritiene – maggiormente rilevante, oltre che, ad oggi, oggetto di vivace dibattito in ambito dottrinale e giurisprudenziale laddove si faccia riferimento alla sinteticità degli atti nell’ambito del processo amministrativo, pare quella concernente le conseguenze della violazione del principio di sinteticità, parimenti in assenza di una espressa previsione legislativa sul punto[xxi].
6. L’assenza di un’applicazione sistematica da parte della giurisprudenza delle conseguenze delle condotte difformi rispetto al principio di sinteticità
In sostanza, codificato il principio sul piano normativo e disciplinati – in attuazione del principio in questione – taluni requisiti formali degli atti di parte nell’ambito del processo amministrativo, si è tuttavia rimessa a dottrina e giurisprudenza l’interpretazione circa le conseguenze della violazione delle suddette norme, anche in termini di requisiti e limiti dimensionali degli atti.
Di fatto, come posto in evidenza dalla dottrina, nessuna norma di rango primario prevede esplicitamente che la violazione del principio di sinteticità possa dar luogo alla inammissibilità – in parte qua – della domanda: come accennato, infatti, rispetto alle conseguenze della eventuale violazione del principio occorre fare riferimento all’art. 26 c.p.a., con esclusivo riguardo all’aspetto della condanna alle spese di lite e all’art. 13-ter, comma 5, All. II c.p.a., laddove è previsto che l'omesso esame delle questioni contenute nelle pagine dell’atto eccedenti i limiti dimensionali prescritti o autorizzati non rappresenta motivo di impugnazione[xxii].
Di conseguenza, la giurisprudenza si è pronunciata sulla questione della sinteticità degli atti ed in particolar modo, altresì, sulle conseguenze del mancato rispetto dei limiti dimensionali secondo orientamenti contrastanti.
Un recente filone della giurisprudenza amministrativa si è consolidato sull’assunto per cui il superamento dei limiti dimensionali determinerebbe, alla luce dell’interpretazione preferibile delle previsioni normative analizzate, l’inammissibilità delle specifiche censure o delle deduzioni svolte dalla parte[xxiii].
In dottrina, tuttavia, si è eccepito che non pare chiaro quale sia la norma dalla quale sarebbe possibile far derivare la conseguenza dell’irricevibilità od inammissibilità in parte qua dell’atto processuale di parte eccedente i limiti dimensionali previsti[xxiv].
Altro orientamento, di contro, ha escluso che la violazione dei limiti dimensionali comporti la irricevibilità, in parte qua, dell’atto[xxv].
Da ultimo, peraltro, sembra si sia affermato quale orientamento prevalente in seno alla giurisprudenza amministrativa quello volto a sanzionare proprio in termini di irricevibilità, ovvero inammissibilità il superamento non autorizzato dei suddetti limiti, sebbene con alcune cautele di seguito poste in evidenza[xxvi].
Nell’ambito della recente sentenza del Consiglio di Stato n. 3006/2021, in particolare il collegio giudicante – richiamando il principio di leale collaborazione (ai sensi dell’art. 2, comma 2, del c.p.a.) – ha invitato le parti a riformulare le difese nell’ambito di precisi limiti dimensionali, con il divieto di introdurre fatti, motivi ed eccezioni nuovi rispetto a quelli già dedotti e, nel caso di specie, ha assunto tale determinazione al precipuo fine di “non "sorprendere" le parti in una fase caratterizzata dall'assenza di una applicazione sistematica da parte della giurisprudenza delle suddette conseguenze delle condotte difformi (salvo alcuni sporadici ma significativi precedenti: cfr. Sez. IV, 7 novembre 2016, n. 4636.; Sez. V, 12 giugno 2017, n. 2852)”[xxvii].
Nella stessa pronuncia il supremo consesso amministrativo ha rilevato, a proposito del requisito della sinteticità degli atti di parte e del rispetto dei limiti dimensionali richiamati all’art. 13-bis All. 2 c.p.a., che “mentre l'iniziale impostazione legislativa faceva leva unicamente sulla condanna alle spese di lite (art. 26 del c.p.a.), il citato art. 13-ter, in modo estremamente innovativo sul piano sistematico, sanziona in termini (non di nullità, bensì) di "inutilizzabilità" le difese sovrabbondanti, in quanto il giudice è autorizzato a presumere che la violazione dei limiti dimensionali (ove ingiustificata) sia tale da compromettere l'esame tempestivo e l'intellegibilità della domanda; in questi termini va interpretata la disposizione che ha introdotto una deroga rispetto all'obbligo generalmente esistente in campo al giudice di pronunciare su tutta la domanda (il mancato esame delle difese sovrabbondanti non è infatti censurabile come vizio di infra-petizione)”.
Merita attenzione, dunque, anche alla luce di quanto statuito dalla pronuncia anzidetta, così come dalla pronuncia in commento, la seguente precisazione.
Considerando la ratio delle disposizioni da ultimo introdotte con riferimento alla sinteticità degli atti di parte nell’ambito del processo amministrativo appare fondamentale, anche laddove si sposti il focus sulla questione delle conseguenze – per gli atti di parte – del mancato rispetto della sinteticità nella redazione degli atti medesimi, l’aspetto della intellegibilità della domanda.
Lo stesso Consiglio di Stato, in merito, ha recentemente evidenziato come il mancato rispetto dei princìpi di chiarezza e sinteticità di cui all’art. 3, c. 2 c.p.a. esponga l'appellante alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non tanto per la irragionevole estensione del ricorso, bensì in quanto rischia di pregiudicare l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e – in caso di appello – confuse le stesse censure mosse alla sentenza gravata, con conseguente violazione della regola di specificità dei motivi di appello, ex art. 101, c. 1 c.p.a., imposta a pena di ammissibilità del gravame[xxviii].
In altri termini, come – si ritiene – correttamente affermato dalla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, la brevità dell'atto processuale (in termini di caratteri, pagine e battute) andrebbe intesa quale “strumento attraverso il quale il legislatore ha inteso vincolare le parti a quello sforzo di "sintesi" giuridica della materia controversa, sul presupposto che l'intellegibilità dell'atto (e quindi la giustizia della decisione) è grandemente ostacolata da esposizioni confuse e causidiche”[xxix].
Il principio di sinteticità avrebbe, in altri termini, una particolare rilevanza nella misura in cui il mancato rispetto del suddetto principio generale pregiudichi l’intelligibilità delle questioni, rendendo non chiara l’esposizione dei fatti di causa e non precisamente individuabili le censure mosse alla sentenza appellata, ponendosi in tal senso in contrasto con il principio di rilevanza costituzionale di ragionevole durata del processo, oltre che con il principio di leale collaborazione tra le parti processuali e tra queste ed il giudice, determinando di fatto un impedimento al pieno e proficuo svolgimento dello stesso contraddittorio processuale[xxx].
7. Osservazioni conclusive anche alla luce dell’art. 24 Cost.
Dall’analisi condotta emerge, con evidenza, il dato per cui le tecniche di redazione degli atti ed in particolare la sinteticità degli atti processuali quale principio generale del processo amministrativo, non si pongano quali tematiche concernenti la forma, ma investano la stessa sostanza del processo, in quanto la sinteticità diverrebbe uno dei mezzi per assicurare una più celere risposta alla domanda di giustizia della collettività[xxxi].
In termini generali, le recenti previsioni circa la necessaria sinteticità degli atti di parte hanno generato un ampio e complesso dibattito in dottrina. Larga parte di quest’ultima, in particolare, ha posto in dubbio la compatibilità delle suddette previsioni in termini di sostanziale contrarietà con il diritto di difesa presidiato dalla previsione di rango costituzionale di cui all’art. 24 Cost.
Del pari, numerose critiche sono state mosse dalla dottrina rispetto alla formulazione dell’art. 5 del d.P.C.S. 167/2016 quale norma “in bianco” che attribuirebbe una amplissima discrezionalità in capo al giudicante, in contrasto con i principi di parità delle parti, del giusto processo, oltre che di legalità[xxxii].
D’altra parte, nell’ambito della stessa giurisprudenza amministrativa si è posto in evidenza come gli oneri di specificità, sinteticità e chiarezza incombenti sulla parte ricorrente (e sul suo difensore) trovino un preciso fondamento nell’ambito dello stesso art. 24 Cost., posto che solo un’esposizione chiara dei morivi di ricorso o, comunque, delle ragioni che sorreggono la domanda, consentirebbe l’esplicazione del diritto di difesa delle altre parti evocate in giudizio[xxxiii].
Un primo punto fermo, dunque, laddove si tratti del principio di sinteticità degli atti – peraltro come codificato in ambito normativo nell’ambito del rammentato art. 3, comma 2 c.p.a. – pare essere in conclusione quello per cui il principio debba essere concretamente applicato non soltanto dagli avvocati nella redazione degli atti di parte, ma altresì dall’organo giudicante nella stesura dei provvedimenti[xxxiv].
Una seconda considerazione di sintesi che si intende formulare, ricollegandosi in particolare alla ratio della norma che ha codificato il principio di sinteticità anche in ambito amministrativo, pare possa essere, altresì, quella per cui il principio assume una valenza generale, ma anche e soprattutto pratica, ponendosi a presidio della effettività della tutela e della giustizia delle decisioni nell’ambito del processo amministrativo, nella misura in cui sia inteso quale principio volto a disincentivare e – di fatto in qualche misura, come osservato, sanzionare – la classe forense laddove nella redazione degli atti introduttivi del giudizio e difensivi, in particolar modo laddove non siano coinvolte questioni tecniche particolarmente complesse, rediga atti sproporzionati e sovrabbondanti, densi di ripetizioni e forieri di confusione sul piano interpretativo[xxxv].
Ciò precisato, sembra opportuno aggiungere, sul piano delle conseguenze ed a livello pratico, considerate altresì le norme di rango primario ad oggi in vigore sul tema, come il superamento dei limiti dimensionali previsti proprio allo scopo di garantire la sinteticità degli atti processuali di parte, non produrrebbe ex se l’inammissibilità o irricevibilità dell’atto processuale, la quale potrebbe essere dichiarata dal giudicante solamente nella misura in cui il superamento dei limiti dimensionali si riverberi, come esposto, sulla intellegibilità dell’atto[xxxvi].
[i] In tema di riassunzione, tra le più recenti e rilevanti pronunce della giurisprudenza amministrativa si v. T.a.r. Lombardia, Brescia, sez. II, 2 luglio 2021, n. 626, in Foro amm, 2021, 7-8, 1169, laddove si è chiarito che il giudice ad quem, avanti al quale avviene la riassunzione, erediti un giudizio nel medesimo stato in chiuso si è chiuso davanti al giudice per primo adito, con la conseguenza per cui, perché la riassunzione operi, occorre che petitum e causa petendi coincidano, non essendo ammissibili nuove domande. Sempre sul punto la giurisprudenza amministrativa, di recente, è giunta ad affermare che, in sede di translatio iudicii dal giudice ordinario al giudice amministrativo, è ammissibile la domanda che, seppur risultando quella in origine proposta avanti al giudice civile, sia stata tuttavia formulata in maniera differente, per esigenze di mero adeguamento convenzionale alle formule di stile tipiche del processo amministrativo (cfr. T.a.r. Sardegna, Cagliari, sez. II, 28 aprile 2021, n. 304, in Foro amm., 2021, 4, 712).
[ii] Trattasi di Corte cost., 12 marzo 2007, n. 77, in Foro amm. CDS, 2007, 7-8, 2103, con nota di Scognamiglio e in Dir. proc. amm. 2007, 3, 796,con nota di Sigismondi. La questione di legittimità costituzionale decisa dalla pronuncia in commento è stata sollevata da T.a.r. Liguria, ord. 21 novembre 2005, n. 148. Per un’analisi della pronuncia in questione, oltre che di Cass., sez. un., 22 febbraio 2007 n. 4109, si v. in dottrina, R. Oriani, È possibile la translatio iudicii nei rapporti tra giudice ordinario e giudice speciale: divergenze e consonanze tra Corte di cassazione e Corte costituzionale, in Foro it., 2007, I, 1013; M. Lipari, La translatio del processo nel disegno di legge governativo approvato dalla camera dei deputati (as-1082): certezze e dubbi, in Federalismi.it, 2008; M.A. Sandulli, Dopo la “translatio iudicii”, le Sezioni Unite riscrivono l’art. 37 c.p.c. e muovono un altro passo verso l’unità della tutela (a primissima lettura in margine a Cass. SS.UU., 24883 del 2008), in Federalismi.it, 20, 2008.
Tra i contributi più recenti sull’istituto si v. M. Cirulli, Profili dinamici della giurisdizione nel Codice della giustizia contabile, in Federalismi.it, 6, 2020.
[iii] Si fa riferimento a Corte cost., 6 luglio 2004, n. 204, in Diritto e Giustizia, 2005, 20, 99, con nota di Proietti e in Dir. proc. amm., 2005, 214, con nota di Mazzarolli. Sulla storica pronuncia in questione si v. tra gli altri A. Travi, La giurisdizione esclusiva prevista dagli art. 33 e 34 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, dopo la sentenza della C. cost. 6 luglio 2004 n. 204, in Foro it., 2004, I, 2594; M.A. Sandulli, Un passo avanti e uno indietro: il giudice amministrativo è giudice pieno, ma non può giudicare dei diritti (prima lettura a margine di Corte cost. n. 204 del 2004), in RGE, 2004, I, 1230; F. Satta, La giustizia amministrativa tra ieri, oggi e domani: la sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004, in Foro amm. CdS, 2004, 1903; C.E. Gallo, La giurisdizione esclusiva ridisegnata dalla Corte costituzionale alla prova dei fatti, ivi, 1908; D. Siclari, La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie afferenti alla vigilanza sul credito: una conferma implicita e alcune incertezze residue, ivi.
[iv] Sulla previsione normativa in questione, tra i contributi più recenti, si v. M. Clarich, Il dualismo giurisdizionale nel sistema della giustizia amministrativa: un equilibrio perennemente instabile, in Dir. proc. amm., 2, 2021, 213 ss.
[v] Si v., tra le altre, T.A.R. Molise, Campobasso, 4 agosto 2011, n. 528, in Foro amm. TAR, 2011, 7-8, 2421 (s.m); T.A.R. Umbria, Perugia, sez. I, 5 dicembre 2014, n. 605, in Foro Amm., 2014, 12, 3215. Peraltro, proprio a proposito dell’atto di riassunzione, le stesse sezioni unite della Cassazione hanno avuto modo di rammentare la certezza della regola di perpetuazione anche nell’ipotesi di una traslatio effettuata prima dell'entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, art. 59, comma 2. Così, nell’ambito della sentenza Cass civ., sez. un., 23 novembre 2010, n. 23596, si è posto in rilievo come “il processo iniziato davanti ad un giudice, che ha poi dichiarato il difetto di giurisdizione, e riassunto nel termine di legge davanti al giudice, indicato dal primo come dotato di giurisdizione, non costituisce un nuovo ed autonomo procedimento, ma la naturale prosecuzione dell'unico giudizio per quanto inizialmente introdotto davanti a giudice carente della, giurisdizione”. Conformemente, nell’ambito di una successiva pronuncia delle sezioni unite, Cass. civ., sez. un., 21 aprile 2011, n. 9130, si è ribadito come “mediante l'istituto della translatio iudicii si intende proprio realizzare la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria, con esclusione della necessità della riproposizione ex novo della domanda, allorchè il giudizio è riattivato innanzi al giudice provvisto di giurisdizione, secondo i principi fissati dalla Corte costituzionale (si v. la già menzionata sent. Corte cost. n. 77/2007) e dalle stesse sezioni unite (Cass. civ., sez. un., 22 febbraio 2007, n. 4109). Il principio della conservazione degli effetti che la domanda avrebbe proposto se presentata al giusto giudice, deve trovare attuazione pratica col consentire alle parti di proseguire davanti ad un secondo giudice quello stesso processo iniziato davanti a quello male individuato dall'attore. I principi costituzionali di effettività e certezza della tutela giurisdizionale impongono che la funzione di dare giustizia, pur articolata secondo il sistema della Costituzione, attraverso una pluralità di ordini giurisdizionali non sia da questa ostacolata”. Sempre nell’ambito di tale pronuncia si è posta in evidenza la necessità di tenere distinte le fattispecie della riassunzione e della riproposizione, chiarendo come il legislatore abbia adottato, non casualmente, i diversi termini di riassunzione e di riproposizione (di seguito unificati nel regime del termine dall'art. 59, comma 4) “avendo ben presente la necessità di distinguere le ipotesi della conservata attività della prima domanda per la identità dell'"ambiente" processuale, quello a quo e quello ad quem, da quella del passaggio da un regime prevalentemente impugnatorio ad un regime esclusivamente cognitivo del rapporto, ferma restando in entrambe le ipotesi la conservazione di una unicità del rapporto (che giustifica la preclusione a contestare la giurisdizione ai sensi dell'art. 41 c.p.c. come queste Sezioni Unite hanno ripetutamente affermato: n. 23596 citata e nn. 19256 e 14828, tutte del 2010). Nel primo caso nessuna revisione della domanda, nè alcun adattamento del petitum, appare essere predicabile, nel secondo caso emerge essere necessaria la riproposizione - con relativa emendatio - "con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile" (art. 59, comma 2 ultima parte citato), e pertanto tal riproposizione deve essere ragguagliata , nella sua idoneità, alla regola del giudice e del rito innanzi al quale il processo viene a continuare” (così Cass. civ., sez. un., 21 aprile 2011, n. 9130, in Giust. civ., 2012, 11-12, I, 2741). In senso conforme nell’ambito della giurisprudenza amministrativa si v., altresì, Cons. St., sez. VI, 9 aprile 2015, n. 1781, in Dir. proc. amm., 2015, 4, 1415, con nota di Tropea. In dottrina si v. M. Mazzamuto, La translatio iudicii si “schiude”?, in Dir. proc. amm., 2, 2012, 660 ss.; A. Caldarera, Considerazioni sulla c.d. translatio iudicii, in Dir. proc. amm., 3, 2009, 715; A. Travi, Difetto di giurisdizione e riassunzione della causa: alcune questioni aperte, in Urb. e app., 2008, 857 ss.
[vi] Sul principio in esame, tra i numerosi contributi in dottrina, si v. F. Saitta, La violazione del principio di sinteticità degli atti processuali, in Il Processo, n. 3/2019, 539 ss.; G. Milizia, Il dovere di sinteticità non riguarda solo gli scritti difensivi ma anche i documenti depositati, nota a T.A.R. Palermo, 17 settembre 2019, n. 2203, in Diritto & Giustizia, 176, 2019, 17; F. Francario, Il principio di sinteticità, in Enc. Giur., Treccani, Roma, 2018, 683 ss.; M. Taruffo, Note sintetiche sulla sinteticità, in Riv. trim. dir. proc. civ., n. 2/2017, 453 ss.; G. Corso, Abuso del processo amministrativo?, in Dir. proc. amm., 1, 2016, 1 ss; F. Cordopatri, La violazione del dovere di sinteticità degli atti e l’abuso del processo, in Federalismi.it, 2014; G.P. Cirillo, Dovere di motivazione e sinteticità degli atti, in www.giustizia-amministrativa.it, 2012; F. Merusi, Sul giusto processo amministrativo, in Foro amm., CDS, 2011, 13533 ss.
[vii] Cfr. sul punto R. De Nictolis, La sinteticità degli atti di parte e del giudice nel processo amministrativo, Relazione al Convegno presso la Corte di Cassazione “Giornata europea della giustizia civile”, Roma, 26 ottobre 2016, in www.giustizia-amministrativa.it.
[viii] Si v. il Reg. n. 629 del 17 aprile 2019 del Parlamento e Consiglio europeo, recante modifica del Protocollo n. 3 concernente lo statuto della Corte di giustizia UE, di introduzione di un limite dimensionale degli atti di parte.
[ix] Cfr. in particolare l’art. 47 del Regolamento della Corte EDU.
[x] Cfr., tra gli altri contributi sul tema, L.R. Luongo, Il «principio» di sinteticità e chiarezza degli atti di parte e il diritto di accesso al giudice (anche alla luce dell’art. 1, co. 17 lett. d ed e, d.d.l. 1662, in Judicium, 2021.
[xi] In tal senso F. Francario, Principio di sinteticità e processo amministrativo. Il superamento dei limiti dimensionali dell’atto di parte, in Dir. proc. amm., n. 1/2018, 129 ss.
[xii] Si v. sul punto M. Nunziata, La sinteticità degli atti processuali di parte nel processo amministrativo sui contratti pubblici, in www.l’amministrativista.it, 2016.
[xiii] In dottrina, a proposito del principio in esame, in senso generale, si v., tra gli altri contributi, M. Sinisi, Il giusto processo amministrativo tra esigenze di celerità e garanzie di effettività della tutela, Torino, 2017, in partic. 203 ss.; G. P. Cirillo, Dovere di motivazione e sinteticità degli atti, in Il nuovo diritto processuale amministrativo, in Trattato di diritto amministrativo diretto da G. Santaniello, vol. XXXXII, 39 ss.
[xiv] Si v. in argomento Cons. St., sez. V, 11 giugno 2013, n. 3210, in Foro amm. - C.d.S., 2013, 6, 1650.
[xv] Su tale specifico aspetto si v. in particolare il successivo par. 6.
[xvi] Ulteriori modifiche all’art. 26 sono state disposte mediante l'art. 41, comma 1, lettera a), della legge n. 114 del 2014.
[xvii] Per un’analisi del contenuto dell’art. 120, comma 6 c.p.a. nella predetta formulazione si v. M.A. Sandulli, Il tempo del processo come bene della vita, Relazione al 60° Convegno di Studi di scienze amministrative di Varenna, 2014, in Federalismi.it, 18, 2014, 32-35; F. Volpe, Sui limiti all’estensione degli atti di difesa nel processo amministrativo, in www.lexitalia.it, 5, 2015.
[xviii] Sino alla determinazione di limiti quantitativi nell’ambito degli atti evidenziati l’elaborazione di canoni di sinteticità è stata affidata alla giurisprudenza che, sul piano interpretativo, in relazione a diversi casi, ha considerato non conformi a sinteticità, tra gli altri, atti che: ripetono lo stesso concetto più di una volta, anche se con espressioni diverse; si dilungano a riportare interi brani di giurisprudenza o dottrina, non necessari; indugiano nella ricostruzione teorica di istituti, non necessaria per la soluzione della questione controversa; propongono un numero elevato di motivi di ricorso palesemente infondati o inammissibili.
[xix] L’autorizzazione, ai sensi dell’art. 7 del decreto presidenziale, può anche essere successiva a seguito di istanza formulata dalla parte, in caso di mancata autorizzazione preventiva per gravi e giustificati motivi.
[xx] Così Cons. giust. reg. sic., 19 aprile 2012, n. 395, in www.giustizia-amministrativa.it.
[xxi] Cfr. G. Ferrari, Sinteticità degli atti nel giudizio amministrativo, in Treccani, Libro dell’anno del diritto 2013, Roma, 2013, 706.
[xxii] F. Francario, Principio di sinteticità e processo amministrativo. Il superamento dei limiti dimensionali dell’atto di parte, cit., 141.
[xxiii] In tal senso, in particolare, v. Cons. St., sez. IV, 7 novembre 2016, n. 4636, in Foro amm., 2016, 11, 2644, la quale ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto per violazione del dovere di specificità dei motivi di ricorso ex artt. 40, comma 1, lett. d) e 101, comma 1, c.p.a. ed altresì del dovere di sinteticità di cui all’art. 3, comma 2, c.p.a. Nella pronuncia si è posto in evidenza, in particolare, come “il dovere di sinteticità sancito dall’art. 3, comma 2, c.p.a., strumentalmente connesso al principio della ragionevole durata del processo (art. 2, comma 2, c.p.a.), è a sua volta corollario del giusto processo, ed assume una valenza peculiare nel giudizio amministrativo caratterizzato dal rilievo dell’interesse pubblico in occasione del controllo sull’esercizio della funzione pubblica; tale impostazione è conforme alla considerazione della « ...giurisdizione come risorsa a disposizione della collettività, che proprio per tale ragione deve essere impiegata in maniera razionale, sì da preservare la possibilità di consentirne l’utilizzo anche alle parti nelle altre cause pendenti e agli utenti che in futuro indirizzeranno le loro controversie alla cognizione del giudice statale» (l’idea della funzione giurisdizionale quale “risorsa scarsa” è stata sviluppato dall’ Adunanza plenaria del Consiglio di Stato in due recenti pronunce, 25 febbraio 2014, n. 9 e 27 aprile 2015, n. 5, e ripreso dalle Sezioni unite della Corte di cassazione nelle sentenze 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243 e, da ultimo, nella sentenza 20 ottobre 2016 n. 21260)”. In senso conforme si v., altresì, Cons. St., sez. III, 21 marzo 2016, n. 1120, in www.giustizia-amministrativa.it e Cons. St., sez. V, 12 giugno 2017, n. 2852, in Foro amm., 2017, 6, 1273, laddove, in particolare, si è statuito che, in mancanza di autorizzazione, l’atto risulta irricevibile per la parte eccedente i limiti dimensionali.
[xxiv] V. F. Francario, Principio di sinteticità e processo amministrativo. Il superamento dei limiti dimensionali dell’atto di parte, cit., in partic. 145 e 153 ss.
[xxv] Si v., tra le altre, CGARS (ord.) 15 settembre 2014, n. 536, in Foro it. 2014, 11, III, 631, a proposito di un caso analogo a quello in commento, nell’ambito del quale, a fronte di un appello di dimensioni palesemente sproporzionate se comparate con la complessità della vicenda, dunque contrastante con i principi di chiarezza e sinteticità di cui all’art. 3, comma 2, c.p.a., non ha dichiarato inammissibile l’appello nel caso concreto, ma ha invitato la parte appellante a produrre una memoria riepilogativa sintetica di non oltre venti pagine. In senso conforme, tra le altre, anche Cons. St., sez. VI, 19 giugno 2017, n. 2969, in Foro amm., 2017, 6, 1279.
[xxvi] Così, tra le altre, Cons. St. sez. IV, 1° dicembre 2020, n.7622, in Diritto & Giustizia, 2020, 3 dicembre, laddove si è statuito che deve ritenersi inammissibile il ricorso che viola il principio di sinteticità, a nulla rilevando che tale gravame sia stato proposto prima dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016 sui limiti dimensionali, avendo il dovere di sinteticità una valenza peculiare nel giudizio amministrativo caratterizzato dalla centralità dell'interesse pubblico in occasione del controllo sull'esercizio della funzione pubblica. V. altresì Cons. St., sez. IV, 24 aprile 2019, n. 2651, in Foro amm., 2019, 4, 634.
[xxvii] Cons. St., sez. VI, 13 aprile 2021, n. 3006, in Guida al diritto, 2021, 18. Per un commento alla specifica recente pronuncia si v. F. Valerini, L'avvocato deve fare il riassunto se vuole che le sue difese siano esaminate, in Diritto & Giustizia, 76, 2021, 6.
[xxviii] V. Cons. St., sez. II, 17 febbraio 2021, n. 1450, a conferma di T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, n. 5497/2012, in www.giustizia-amministrativa.it; Cons. St., sez. IV, 1° dicembre 2020, n. 7622, cit.; Cons. St., sez III, 12 ottobre 2020, n. 6043, in Foro amm., 2020, 10, 1850; oltre che Cass. civ., sez. trib., 21 marzo 2019, n. 8009 in Dejure.it.
[xxix] Cfr. Cons. St., sez. VI, 13 aprile 2021, n. 3006, cit. Sul punto si v. anche C.E. Gallo, Il secondo correttivo al codice del processo amministrativo, in Urb. e app., 2012, 1240.
[xxx] In questo senso si sono espresse le stesse sezioni unite nell’ambito della rilevante pronuncia sul tema Cass. civ., sez. un., 17 gennaio 2017, n. 964, in Foro it., 2017, 2, I, 509.
[xxxi] In tal senso, R. De Nictolis, La sinteticità degli atti di parte e del giudice nel processo amministrativo, cit.
[xxxii] Così I. Impastato, “Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole e più non dimandare”: la scure del giudice amministrativo sui “limiti dimensionali di sinteticità” degli atti processuali di parte (e sul diritto di difesa), in Judicium.it, 2021. Si v., altresì, M. Ramajoli, Giusto processo e giudizio amministrativo, in Dir. proc. amm., 1, 2013, 100 ss.
[xxxiii] Cfr. in partic. Cons. St. n. 4636/2016, cit.
[xxxiv] Tra gli altri contributi sul tema si v. F. Patroni Griffi, La sentenza amministrativa, in Trattato di diritto amministrativo, a cura di S. Cassese, Diritto amministrativo speciale, V, Il processo amministrativo, Milano, 2003, 4466; R. De Nictolis, La tecnica di redazione delle sentenze del giudice amministrativo, in www.giustizia-amministrativa.it; G.P. Cirillo, Dovere di motivazione e sinteticità degli atti, ivi. In giurisprudenza, si v. da ultimo, Cons. St., sez. III, 20 ottobre 2021, n. 7045, in Foro amm., 2021, 10, 1415. Nell’ambito della pronuncia si è posto in evidenza come “l'essenza della sinteticità, prescritta dal codice di rito, non risiede nel numero delle pagine o delle righe in ogni pagina, ma nella proporzione tra la molteplicità e la complessità delle questioni dibattute e l'ampiezza dell'atto che le veicola, in quanto la sinteticità è "un concetto di relazione, che esprime una corretta proporzione tra due grandezze, la mole, da un lato, delle questioni da esaminare e, dall'altro, la consistenza dell'atto - ricorso, memoria o, infine, sentenza - chiamato ad esaminarle" (Cons. St., sez. III, 12 giugno 2015, n. 2900) ed è, si deve qui aggiungere, sul piano processuale un bene-mezzo, un valore strumentale rispetto al fine ultimo, e al valore superiore, della chiarezza e della intelligibilità della decisione nel suo percorso motivazionale”.
[xxxv] Si v., in questo senso, il riferimento, nell’ambito di una pronuncia del giudice amministrativo sulla questione, ad un atto di appello caratterizzato “da plurime reiterazioni delle medesime argomentazioni, dalla conseguente esposizione delle stesse in modo non specifico ed esaustivo ma attraverso motivi intrusi, da interpolazioni con atti giudiziari ed amministrativi (talora fotocopiati ed inseriti nel testo), dallo stralcio di dibattiti in sedute di organi collegiali nonché da manifesta prolissità”. Così Cons. St. n. 4636/2016, cit.
[xxxvi] V. F. Francario, Principio di sinteticità e processo amministrativo. Il superamento dei limiti dimensionali dell’atto di parte, cit., 132. L’A. rileva, in particolare, sul punto come “ferma restando l’attenuazione dell’obbligo di pronunciare su tutta la domanda, al giudice non è precluso conoscere l’atto nella sua interezza, anche se sovradimensionato” ed ancora “è vero dunque che l’art. 13-ter dell’All. 2 del c.p.a. introduce il limite dimensionale come requisito formale dell’atto processuale di parte, ma è altrettanto vero che non è stata espressamente prevista e comminata la nullità dell’atto che risulti privo del suddetto requisito”.

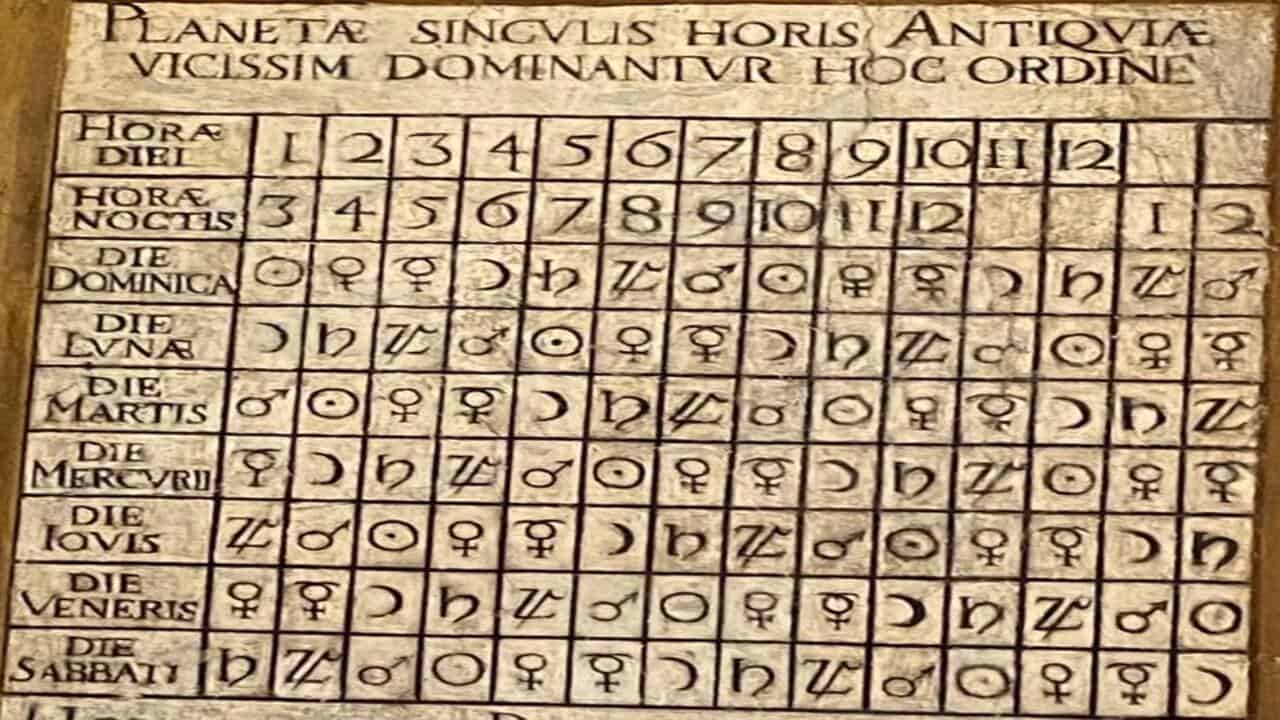

 E poi Aggiungi alla schermata principale.
E poi Aggiungi alla schermata principale.