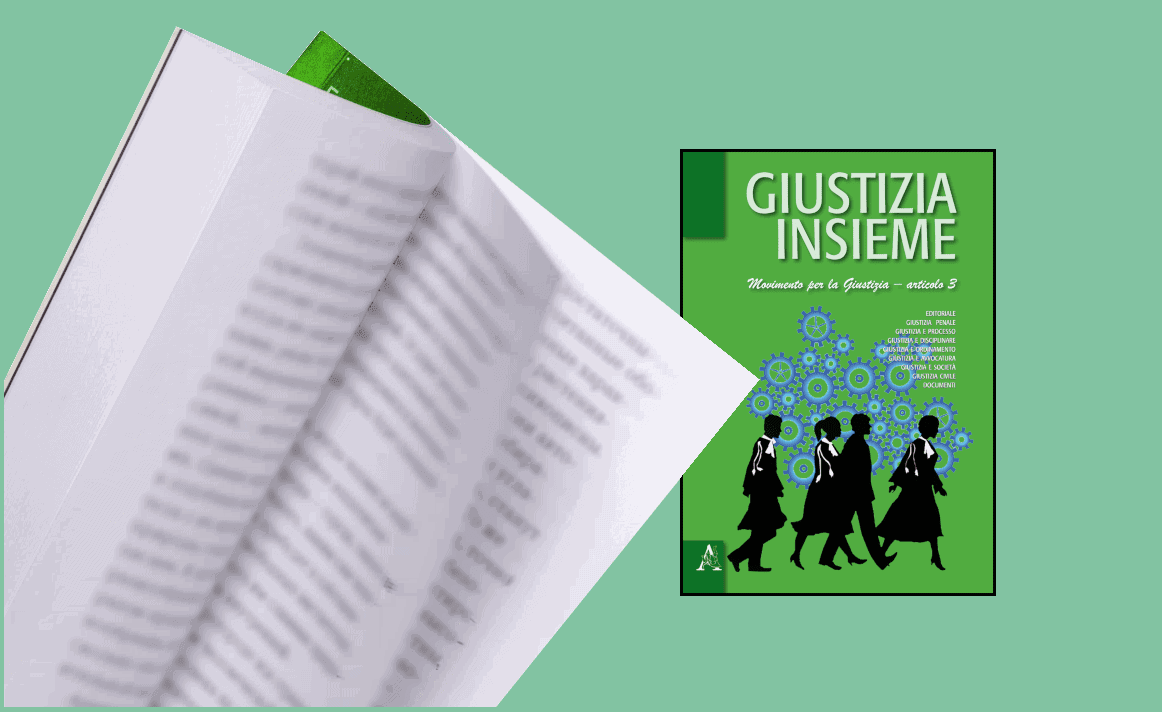(Seminario C.S.M. su “La nuova responsabilità civile dei magistrati tra giurisdizione e governo autonomo”, Roma 11-12 giugno 2015 – Relazione della Procura generale presso la Corte di cassazione, a cura di M. Fresa e C. Sgroi)
Premessa. Il testo che segue esprime esclusivamente un primo – e ancora “aperto” – tentativo di sistemazione da parte dell’Ufficio della Procura generale presso la Corte di cassazione, titolare dell’iniziativa obbligatoria in materia disciplinare nei riguardi del personale di magistratura, in ordine ai rapporti che intercorrono tra la sede del giudizio per danno da esercizio della funzione giudiziaria (legge 13 aprile 1988, n. 117, nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 27 febbraio 2015, n. 18) e la sede del procedimento disciplinare oggi regolata dal d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109.
Resta estranea, quindi, tutta la serie di questioni problematiche che attengono all’interpretazione e classificazione delle disposizioni in tema di responsabilità civile, dello Stato in via diretta e del magistrato in via di rivalsa, interne al sistema della legge n. 117. Questi aspetti, che sono stati oggetto delle riflessioni della sessione di stamattina e che saranno ulteriormente affrontati domani, costituiscono presupposti sui quali l’Ufficio non può che registrare e valutare le posizioni che si manifesteranno e si consolideranno nella elaborazione della giurisprudenza civile intorno ad essi. Si tratta, esemplificativamente, dei profili: della eliminazione del requisito della “negligenza inescusabile” quale elemento costitutivo della “colpa grave” che fonda la pretesa risarcitoria verso lo Stato; della testuale diversificazione sul punto tra domanda di danno e iniziativa di rivalsa, che invece quel requisito – che è per comune opinione un quid pluris – continua a richiedere (art. 7 della legge n. 117); della necessità di parametrare l’ipotesi della violazione “manifesta” del diritto – certamente del diritto dell’Unione – ai connotati che la stessa giurisprudenza della Corte del Lussemburgo ha man mano indicato nelle pronunce che hanno condotto nel tempo all’approvazione della recente riforma (le sentenze Kobler, Traghetti del Mediterraneo, Commissione c. Italia), e che in definitiva si riconducono proprio a quella nozione di “inescusabilità” o eccezionalità della violazione; della diversa declinazione e del diverso spazio applicativo che assumono la responsabilità dello Stato – più ampia – rispetto a quella del magistrato in sede di rivalsa – più ristretta – e della conformità di questa diversificazione ai principi (preesistenti alla legge ed immanenti nel sistema costituzionale) di garanzia della indipendenza della giurisdizione, tanto più una volta espunto il c.d. filtro di ammissibilità della domanda di danno.
Di questi aspetti, dunque, non verrà trattato nell’economia del presente lavoro, benché naturalmente essi rappresentino per così dire le premesse maggiori della tematica della correlazione tra le due sedi, segnatamente sul piano sostanziale.
A) Responsabilità civile e responsabilità disciplinare. Autonomia.
La responsabilità civile prevista dalla legge n. 117 del 1988 – così come modificata dalla legge n. 18 del 2015 – attiene ai rapporti del magistrato con le parti processuali o con altri soggetti a causa di eventuali errori o inosservanze nell’esercizio delle funzioni.
La responsabilità disciplinare – oggi prevista dal d.lgs. n. 109 del 2006 – consegue alla violazione dei doveri funzionali del magistrato nei confronti dello Stato-datore di lavoro. Essa prescinde dalla imputazione della responsabilità civile (extracontrattuale).
Ciascuna delle due forme di responsabilità risponde ad una funzione e ad una ratio sua propria; la prima, inoltre, si manifesta come a sua volta articolata nei due segmenti, quello della responsabilità diretta dello Stato e quello dell’azione di rivalsa, che si presentano caratterizzate da diversa funzione e ratio, giacché l’una è preordinata a riconoscere una garanzia patrimoniale a fronte del pregiudizio che il cittadino abbia subito per effetto dell’esercizio non corretto della funzione statuale di giurisdizione, l’altra concerne propriamente il rapporto di impiego e il riparto dell’obbligazione di pagamento, al quale la posizione del terzo (cittadino) resta indifferente.
Le due responsabilità, civile e disciplinare, possono – ma di certo non debbono – a volte concorrere, pur conservando i relativi iter una reciproca autonomia strutturale e procedimentale, senza alcun vincolo decisionale derivante dall’esito civile in sede disciplinare e viceversa, come è reso manifesto, ad esempio, dall’art. 20, primo comma, del d.lgs. n.109 del 2006: “L'azione disciplinare è promossa indipendentemente dall'azione civile di risarcimento del danno o dall'azione penale relativa allo stesso fatto, ferme restando le ipotesi di sospensione dei termini di cui all'articolo 15, comma 8”.
Ad esempio, dove l’attività funzionale del magistrato sia riconducibile ad una delle fattispecie contemplate dall’art. 2 del d.lgs. n. 109 – che sono, salvo qualche eccezione, illeciti di pericolo per la cui imputazione è, di regola, sufficiente la colpa lieve – ed abbia prodotto un danno ingiusto ad una parte processuale privata, purché ricorrano le connotazioni soggettive ed oggettive della condotta richieste dall’art. 2 della legge n. 117 e le limitazioni nello stesso previste, le due tipologie di responsabilità possono in concreto concorrere. Non può, comunque, non rilevarsi che mentre è più alta la probabilità che un fatto produttivo di responsabilità civile dia origine anche a separata responsabilità disciplinare, altrettanto non può dirsi nel caso opposto, considerato che solo in alcuni, limitati casi in sede disciplinare è richiesta la colpa grave e che taluni illeciti disciplinari sono strutturalmente inidonei ad arrecare un ingiusto danno alle parti processuali (si pensi alle fattispecie di cui all’art. 2, lett. aa) e cc), del d.lgs. n. 109).
L’autonomia tra illecito disciplinare e civile e conseguentemente tra i rispettivi procedimenti è confermata dagli artt. 6 e 9 della legge n. 117 del 1988, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 18 del 2015.
La legge n. 18 del 2015, come è ovvio, non riguarda il procedimento disciplinare, non innova né intende farlo alla regolazione che ne è data nel d.lgs. 109 del 2006.
Le poche disposizioni preesistenti in materia contenute nella legge n. 117 del 1988 (legge anteriore alla riforma del 2006, e che si collocavano in un sistema improntato a discrezionalità e non-tipizzazione), ritoccate dal legislatore del 2015, lo sono state appunto secondo questa linea di autonomia.
Una legge che si colloca esclusivamente sul piano dei rapporti risarcitori civili cittadino-Stato non è abilitata a snaturare o mutare sia pure solo pro parte la struttura del sistema di giustizia disciplinare; se il legislatore avesse voluto interferire su questa materia lo avrebbe potuto e dovuto fare con modifiche sul d.lgs. n. 109 del 2006.
E poiché la giustizia disciplinare partecipa dell’assetto costituzionale della magistratura, si deve accedere a una interpretazione che tenga fermi i capisaldi sui quali si basa la normativa deontologica del 2006: obbligatorietà, tassatività nonché modello procedurale, che il legislatore ha voluto fosse articolato in una duplice fase, di vaglio preliminare (predisciplinare) e poi di vera e propria istruttoria sulla notizia di rilevanza disciplinare, e che verrebbe certamente alterato se si desse ingresso a un’azione immediata ed automatica in base a una valutazione “altra” – quella del giudice civile – o addirittura in base al solo dato materiale della proposizione di una domanda di danno.
L’esposta premessa appare conforme alla regola più generale di indipendenza degli ambiti processuali (civile, penale, amministrativo e disciplinare) e, soprattutto, è conforme al sopramenzionato principio posto dall’art. 20 del d.lgs. n. 109 del 2006.
In prima approssimazione al tema, si può enucleare questo rilievo nel senso che, nella prospettiva del sistema disciplinare del personale di magistratura al quale solo ha riguardo il presente testo, è la legge n. 117 del 1988 a dover essere resa compatibile con l’assetto del d.lgs. n. 109 del 2006 e non viceversa.
***
D’altronde, ai sensi del secondo comma dell’art. 6 della legge n. 117 del 1988, la decisione pronunciata nel giudizio promosso contro lo Stato “non fa stato nel procedimento disciplinare”.
Tale previsione è espressiva dei principi generali in tema di giudicato, secondo i quali la cosa giudicata presuppone – tra l’altro – l’identità dei soggetti che partecipano ai rispettivi procedimenti.
Essa potrebbe dirsi perfino superflua, giacché il secondo comma dell’art. 20 del d.lgs. n. 109 del 2006 – dopo l’enunciazione del principio generale dell’autonomia del giudizio disciplinare rispetto ai giudizi civili e penali – prevede limitate ipotesi di possibile autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare in riferimento esclusivo alla sentenza penale, di condanna o di assoluzione, ma nulla prevede in relazione ad analoghe ipotesi di cosa giudicata per effetto di sentenze civili, tanto meno di danno, pronunciate ai sensi della legge n. 117 del 1988.
Il che sta a significare che nessuna sentenza civile – e non solo quella prevista dall’art. 6, secondo comma, della legge n. 117 – fa stato in senso proprio nel procedimento disciplinare. E tale impermeabilità di principio tra le due aree di decisione si traduce nella assenza di una relazione di pregiudizialità in senso tecnico.
Questa considerazione preliminare orienta la soluzione dei vari problemi interpretativi attinenti ai rapporti tra giudizio civile di danno e giudizio disciplinare.
Anche secondo una univoca interpretazione formatasi anteriormente alla legge n. 18 del 2015, è la stessa struttura della legge in materia di responsabilità civile per danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie n. 117 del 1988 che porta a escludere una relazione di pregiudizialità, perché si presuppone la non coincidenza degli elementi costitutivi, rispettivamente, dell’illecito civile di danno e di quello disciplinare.
Anzi: proprio la “inversione” di una relazione di pregiudizialità è stata generalmente ravvisata dalla dottrina alla luce della disposizione posta dal secondo comma dell’art. 9 della legge n. 117 del 1988, rimasto oggi invariato, che ammette l’acquisizione di atti del procedimento disciplinare in quello di rivalsa, così appunto predicando semmai una interferenza (probatoria, non di contenuto) a rovescio, dal disciplinare al civile e non il contrario. La possibilità di acquisizione degli atti del procedimento disciplinare nel corso della causa civile porta a ribadire che le due procedure, che possono coesistere nel tempo, hanno comunque percorsi indipendenti.
B) Processo civile e procedimento disciplinare. Regolazione delle interferenze.
Dopo l’abrogazione dell’art. 5, quinto comma, della legge n. 117, secondo cui “se la domanda [era] dichiarata ammissibile, il tribunale ordina[va] la trasmissione di copia degli atti ai titolari dell’azione disciplinare”, è alla luce delle esposte considerazioni che deve oggi essere verificato il rapporto di compatibilità – e il senso che deve esserne dato – con il sistema disciplinare della vigente disposizione dell’art. 9 della legge, secondo cui “il Procuratore generale presso la Corte di cassazione per i magistrati ordinari o il titolare dell’azione disciplinare negli altri casi devono esercitare l’azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa all’azione di risarcimento, salvo che non sia stata già proposta”.
In particolare, dopo l’abrogazione dell’inciso “entro due mesi dalla comunicazione di cui al comma 5 dell’articolo 5”, si pone – rimanendo inizialmente nell’ambito di un possibile criterio di interpretazione letterale – un primo problema, riguardante il momento a partire dal quale i titolari dell’azione disciplinare nei confronti dei magistrati, ordinari e non, “devono” esercitare l’azione disciplinare.
Prima della legge n. 18 del 2015 (e, come si dirà a breve, del d.lgs. n. 109 del 2006) questo momento era cristallizzato nel breve termine di due mesi decorrente dalla obbligatoria trasmissione, da parte del presidente del tribunale deliberante sulla ammissibilità della domanda risarcitoria, di copia degli atti del giudizio civile.
Ora, abrogata la norma che regolava il filtro di ammissibilità della domanda risarcitoria e non essendo specificato alcun termine per l’esercizio della “doverosa” azione disciplinare – che presupporrebbe ovviamente una comunicazione formale al titolare dell’azione dei “fatti che hanno dato causa all’azione di risarcimento”, comunicazione che tuttavia non è più prevista come obbligatoria dalla legge e che difficilmente potrebbe trovare base giustificativa nella ipotesi di violazione disciplinare che afferisce ai capi degli uffici in caso di omissione di notitia di interesse disciplinare, ex art. 2, comma 1, lettera dd), del d.lgs. n. 109 del 2006 – si pongono possibili diverse opzioni interpretative, che dovrebbero essere risolte alla stregua del criterio di autonomia, già indicato nel paragrafo A):
1) Deve anzitutto escludersi che l’obbligo di azione scaturisca a partire dalla mera proposizione della domanda risarcitoria in sede civile, tanto meno dell’azione risarcitoria nei confronti dello Stato e, quindi, nei confronti di un soggetto che è terzo rispetto al magistrato. Se così fosse, qualsiasi cittadino, di fatto, potrebbe decidere se far esercitare l’azione disciplinare nei confronti di un magistrato, determinandone immediati effetti sulla carriera (valutazioni di professionalità e altro) e quindi incidendo anche indirettamente su procedimenti di copertura degli uffici direttivi, semidirettivi, ecc.; il che comporterebbe molteplici dubbi di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 104 primo comma, 105 e, per le giurisdizioni speciali, all’art. 108 Cost.
Questa conclusione è in linea con le prime indicazioni che provengono dalla giurisprudenza di legittimità: Cass. pen., sez. VI, n. 16924/2015, secondo cui il magistrato non assume la qualità di parte ai fini della configurazione della situazione di astensione della condizione di “debitore” della parte, neanche se sia esercitata la rivalsa.
Del resto, la Corte Costituzionale (n. 18/1989) ha già affermato – a proposito della legittimità costituzionale del c.d. filtro di ammissibilità, ora abrogato – che il giudice va garantito dalla proposizione di “azioni infondate che possano turbarne la serenità impedendo al tempo stesso di creare con malizia i presupposti per l’astensione e la ricusazione”.
Non è pensabile dunque che l’art. 9 della legge n. 117, come sopra modificato, abbia inteso derogare a tale principio, introducendo – e solo per alcune fattispecie che possono dare causa al risarcimento, complessivamente riconducibili all’errore di diritto o all’errore percettivo – una sorta di illecito disciplinare “processuale” atipico cioè consistente nella mera pendenza di una controversia di danno introdotta dal privato verso lo Stato.
Ciò conduce a una prima generale conclusione: la sola notizia della pendenza di una causa civile di danno verso la Stato non è ragione di esercizio obbligatorio dell’azione disciplinare.
Si delinea così la prima seguente conclusione: la locuzione “deve” esercitare l’azione, di cui all’art. 9, co. 1, non può in definitiva essere interpretata come obbligo di iniziativa sulla sola base della proposizione di una domanda giudiziale, del singolo contro lo Stato, di cui sia data in qualsiasi modo notizia all’Ufficio. Vi osta l’evidente insostenibilità anche costituzionale di un’azione disciplinare “coatta” per effetto di una iniziativa di qualsiasi soggetto sia entrato in contatto con la giurisdizione (sarebbe perfino prospettabile una incostituzionalità per irrazionalità ossia per aberratio della finalità legislativa di cui alla legge n. 18 del 2015, che vuole regolare i rapporti risarcitori dello Stato verso i privati e non istituire un nuovo statuto disciplinare del personale di magistratura, lesivo delle garanzie minime di autonomia).
Merita segnalare, sul punto, che a non diversa conclusione interpretativa era pervenuto l’Ufficio già nella vigenza del testo anteriore dell’art. 9 in discorso, ossia nel vigore della disposizione relativa al termine bimestrale: decreti di archiviazione predisciplinare 8 febbraio 2013, proc. n. 370/2012-SD1, e 10 febbraio 2014, proc. n. 409/2013, alle cui complessive motivazioni si fa rinvio. In questi provvedimenti, resi in procedimenti iscritti a seguito della comunicazione del superamento del filtro di ammissibilità della domanda di danno, si è escluso di potere per ciò solo avviare l’azione disciplinare, in difetto (come era in quei casi) di una condotta classificabile nell’ambito del catalogo del d.lgs. n. 109 del 2006. Riguardo all’accennato rapporto tra sistema della responsabilità civile e regolazione della responsabilità disciplinare, si è escluso che potesse parlarsi di autonoma fattispecie di illecito e, quindi, che sussistesse un obbligo ineludibile di esercitare, comunque, l’azione disciplinare a seguito della semplice conoscenza, nel termine bimestrale, della domanda risarcitoria, sul rilievo della duplice incompatibilità (a) procedurale, “perché il sistema odierno, proprio perché caratterizzato in termini di regola e non di eccezione della obbligatorietà dell’iniziativa del Procuratore generale, prevede appunto per questo una fase c.d. predisciplinare (art. 15 del d.lgs. n. 109) di valutazione e ponderazione – anche con acquisizioni “istruttorie” in senso lato – della natura “circostanziata” dell’addebito disciplinare e della plausibilità della incolpazione, in difetto della quale è prevista la archiviazione del caso da parte del Procuratore generale (art. 16, comma 5-bis), salva la diversa determinazione da parte del Ministro della giustizia destinatario del provvedimento di archiviazione”, e (b) sostanziale, “perché il principio di legalità e tassatività dell’illecito disciplinare, che si esprime nel catalogo chiuso degli artt. 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 109 del 2006, impedisce che si possa predicare una azione disciplinare per un fatto – quale che ne sia la fonte di informazione – che non vi rientra”.
2) Escluso quindi che l’azione disciplinare debba avviarsi per la sola introduzione/pendenza della causa civile, si potrebbe in ipotesi ritenere che l’azione disciplinare debba essere “spostata” in avanti nel tempo e cioè essere legata non più all’iniziativa di danno principale – privato contro Stato – o a quella in sede di rivalsa, bensì alla formazione del giudicato, sull’una e/o sull’altra.
La lettera dell’art. 9 della legge, con l’uso del passato, apparentemente non escluderebbe questa lettura, intendendosi per fatti che “hanno dato” causa all’azione di risarcimento quelli che possono legittimare la domanda del singolo contro lo Stato (o che fondano l’azione di rivalsa, anche se non vi è coincidenza integrale tra i due ambiti).
In tale ipotesi, la notizia della pendenza della causa civile di danno opererebbe come ragione della iscrizione di un procedimento predisciplinare, il cui esito però sarebbe necessariamente condizionato dalla conclusione del giudizio di danno (o, come sotto-ipotesi, di quello di rivalsa), in attesa della formazione del giudicato sul punto; da ciò logicamente la necessità della sospensione del procedimento.
Una simile lettura potrebbe in prima approssimazione giustificarsi specialmente in relazione alla ipotesi del giudicato sulla rivalsa, per la maggiore “personalizzazione” dell’illecito, posto che la rivalsa dello Stato verso il magistrato ha un terreno più limitato rispetto a quello che fonda la responsabilità dello Stato verso il privato.
A questa possibilità interpretativa si contrappongono più considerazioni.
2.1) In primo luogo, vi osta quanto già detto circa l’assenza di un rapporto di pregiudizialità e l’inefficacia (non fa stato) della decisione civile, senza distinzioni.
2.2) La situazione disciplinare muterebbe a seconda che il magistrato abbia o non abbia partecipato al giudizio “principale”; se vi partecipa, con l’intervento volontario, la rivalsa è generalmente ad esito obbligato (perché il primo giudizio civile fa stato nel secondo); se non vi partecipa potrebbe anche aversi un esito della fase di rivalsa diverso rispetto a quello contro lo Stato (cfr. art. 6, co. 2), anche perché come si è accennato e come è generalmente riconosciuto in dottrina l’area descrittiva dei presupposti del diritto di rivalsa non è pienamente coincidente, per difetto, con quella dei presupposti di responsabilità per lo Stato (si vedano gli artt. 2 e 7 della legge). Ai nostri fini, ciò spezzerebbe l’unità fattuale da cui l’impianto della legge muove (“i fatti che hanno dato causa all’azione di risarcimento”), con la conseguenza di variabili incerte e secondo evento, anche perché se il magistrato interviene nella causa principale non vi sarebbe a stretto rigore ragione di attendere l’esito del giudizio di rivalsa.
2.3) In questa ipotesi si avrebbe una restrizione dell’ambito oggettivo dell’illecito, posto che, secondo la disciplina della rivalsa posta dall’art. 7, la relativa azione riguarda una casistica (diniego di giustizia, violazione manifesta della legge o del diritto UE o travisamento del fatto o della prova se determinati da dolo o da negligenza inescusabile) non coincidente e – anche secondo i commentatori – più limitata rispetto a quella che autorizza l’azione principale;1 la formulazione del novellato art. 7 della legge non comprende infatti tra i presupposti della rivalsa obbligatoria tutte ed intere le condotte e le ipotesi di colpa grave elencate nell’art. 2 della legge stessa.
2.4) Si avrebbe una sostanziale aleatorietà, in contrasto proprio con il principio di obbligatorietà pur contestualmente riaffermato (“deve esercitare”); è infatti rimessa alla iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri, soggetta a termine biennale (decadenziale), l’attivazione della rivalsa, che potrebbe non essere messa in opera in alcuni casi ossia in quelli che non integrano il catalogo di cui al primo comma dell’art. 7 ancorché idonei a dare luogo alla responsabilità dello Stato; conseguenza che stride con il sistema obbligatorio/tipizzato su cui si basa la riforma del d.lgs. n. 109/2006.
2.5) La soluzione porterebbe, realisticamente e soprattutto, a un rinvio sine die dell’iniziativa disciplinare: occorrerebbe attendere prima la conclusione della causa principale e poi anche di quella di rivalsa se il magistrato non è intervenuto nella prima, con una sospensione pluriennale evidentemente critica, per la ovvia necessità di una giustizia disciplinare per quanto possibile tempestiva e “vicina” ai fatti, cfr. i termini di fase disciplinare e altresì il limite generale decennale dell’art. 15, comma 1-bis del d.lgs. n. 109 del 2006, a tacere d’altro, come dimissioni, cessazione dal servizio, etc.
Sembra quindi da escludere che l’obbligo di esercizio dell’azione scaturisca dalla sentenza di condanna nei confronti dello Stato, sia per le precedenti considerazioni generali in tema di mancanza di alcun rapporto di pregiudizialità tra giudizio civile e giudizio disciplinare, sia per il disposto specifico dell’art. 6 della legge n. 117 del 1988 secondo il quale – come si è osservato – è espressamente previsto che la sentenza nei confronti dello Stato non fa stato nel procedimento disciplinare e, prima ancora, non fa stato nel giudizio di rivalsa se il magistrato non è intervenuto volontariamente in giudizio.
Pur dovendo escludersi che l’obbligo scaturisca dalla mera proposizione dell’azione di rivalsa, dato che anch’essa sfocia in una sentenza che – per le stesse ragioni già esposte – non fa stato nel giudizio disciplinare, si potrebbe come detto in via di ipotesi collegare l’obbligo di esercizio dell’azione disciplinare alla sentenza di condanna (definitiva) del magistrato nel giudizio di rivalsa.
In questa sotto-ipotesi interpretativa, non sarebbe in ogni caso sufficiente per l’obbligatorio esercizio dell’azione disciplinare la pronuncia non ancora definitiva, ma sarebbe necessario il passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Infatti, poiché la legge nulla prevede in proposito, sembra in ogni caso preferibile l’opzione interpretativa meno estensiva e maggiormente garantista per il magistrato condannato, anche tenuto conto dei dubbi di costituzionalità che, enunciati in precedenza, potrebbero porsi, sia pure in maniera meno evidente, anche in quest’ultima ipotesi.
Per di più, con riferimento al rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, la sospensione dei termini del primo procedimento, nel caso di esercizio dell’azione penale, cessa con il giudicato della sentenza pronunciata in tale sede (art. 15, ottavo comma, lett. a, del d.lgs. n. 109 del 2006) e questo dato – anche sul piano dell’interpretazione logico-sistematica della norma, cui si deve ricorrere in mancanza di un inequivoco dato letterale – è significativo della intenzione del legislatore di esigere perlomeno, ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare, che “i fatti che hanno dato causa all’azione di risarcimento” non siano contestabili.
D’altra parte, a prescindere dall’utilità pratica di rendere l’azione disciplinare obbligatoria in relazione a questioni destinate a passare in giudicato dopo anni, in contrasto con la stessa ratio che ispira le regole processuali nel settore disciplinare, disseminato di decadenze in ogni fase e grado del relativo procedimento, il primo comma dell’art. 9 pone, a monte, un problema ancor più delicato, al quale si è già data una prima risposta in precedenza.
Il problema è quello della compatibilità con il vigente sistema disciplinare tipizzato – riguardante soltanto i magistrati ordinari e quelli militari – di una previsione legale di obbligatorietà di esercizio dell’azione disciplinare in assenza di una fattispecie tipizzata. In altre parole, al di là della insoddisfacente interpretazione letterale, va verificato, sul piano della interpretazione logico sistematica, se l’espressione “deve” possa rispondere al suo significato letterale nella vigenza di un sistema disciplinare basato – a partire dal 2006 – non più su un unico illecito atipico (art. 18 del R.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511), ma su una serie definita e circoscritta di illeciti tipizzati.
Con il vigente sistema disciplinare, invero, si deve procedere ad una valutazione ex ante dei fatti suscettibili di dar luogo alla violazione, per cui si ha illecito (rectius, si ha l’ipotesi di illecito, tale da rendere obbligatorio l’esercizio dell’azione) soltanto quando c’è violazione (rectius, l’ipotesi di violazione) dei doveri fondamentali di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 109 del 2006 e ricorre una delle ipotesi previste nei successivi artt. 2 (illeciti posti in essere nell’esercizio delle funzioni), 3 (illeciti posti in essere fuori dell’esercizio delle funzioni) e 4 (illeciti conseguenti a reato), non ricorrendo al contempo l’ipotesi di cui all’art. 3-bis (irrilevanza disciplinare della condotta).
La condotta del magistrato che abbia dato luogo ad una ipotesi risarcitoria in sede civile non è insomma di per sé sola sintomatica della configurabilità di una ipotesi disciplinare, non coincidendo sempre le ipotesi di responsabilità civile e le ipotesi di responsabilità disciplinare, e non essendo stato posto in discussione dal legislatore del 2015 il principio di autonomia del procedimento disciplinare anche rispetto al giudizio civile, come rispetto al giudizio penale, principio che – come si è già osservato – è sancito dall’art. 20 del d.lgs. 109/2006.
Questa norma non potrebbe neanche implicitamente dirsi abrogata per incompatibilità con le sopravvenute norme della legge n. 18 del 2015 e ciò conduce ad escludere, in ogni caso di azione di risarcimento, un automatismo in sede di valutazione della responsabilità disciplinare, la quale può non sussistere nel caso di affermazione di responsabilità civile, come può all’inverso essere affermata in assenza di azione risarcitoria.
Si pensi ad esempio all’illecito civile del diniego di giustizia (art. 3, legge n. 117 del 1988, la cui integrazione forse potrebbe interferire con il sistema disciplinare solo attraverso la duplice mediazione della commissione del reato di cui all’art. 328 cod. pen. e, con esso, della violazione ex art. 4, lettera d, d.lgs. n. 109 del 2006, nel qual caso peraltro la questione si sposterebbe su un illecito doloso e su una pregiudizialità penale che pone altri ordini di questioni) e all’illecito disciplinare del ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio della funzione (lett. q del primo comma dell’art. 2 del d.lgs. n. 109 del 2006), figure di illecito affatto diverse nei presupposti di diritto che rendono configurabili le rispettive fattispecie.
Si pensi ancora all’illecito civile della violazione manifesta del diritto dell’Unione europea (art. 2, terzo comma, legge n. 117 del 1988, così come modificata dalla legge n. 18 del 2015), con le specificazioni (di cui al successivo comma 3-bis) della “mancata osservanza dell’obbligo di rinvio pregiudiziale” e “del contrasto dell’atto o del provvedimento con l’interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell’Unione europea”, ed alla relativa difficoltà di inquadrare la stessa condotta – quando non si riverberi in una violazione di legge interna – nell’ambito delle fattispecie disciplinari poste quali eccezioni al c.d. principio di salvaguardia interpretativa (art. 2 lett. g), ff), m) del d.lgs. 109 del 2006), con la difficoltà di adottare interpretazioni estensive in materia in senso lato sanzionatoria al fine di rispettare l’esigenza di una interpretazione conforme al diritto (alla giurisprudenza) dell’Unione.
D’altronde, se il legislatore avesse voluto configurare una nuova fattispecie disciplinare tipizzata, coincidente con la condotta foriera di responsabilità civile del magistrato, in base ai principi generali in tema di tipizzazione degli illeciti, avrebbe dovuto prevederlo espressamente.
Inoltre, non si comprende come, in assenza di un formale obbligo di comunicazione ai titolari dell’azione disciplinare da parte del presidente (del tribunale o della corte d’appello) ove si sia svolto il giudizio di rivalsa eventualmente sfociato in condanna (definitiva o non definitiva che sia), il Procuratore generale della Corte di cassazione “debba” (sempre) esercitare l’azione disciplinare indipendentemente dal fatto che abbia o meno ricevuto formale comunicazione della sentenza, divenuta irrevocabile.
***
Per di più, è lo stesso legislatore a ritenere già sul piano sostanziale, che è ciò che più conta, la non coincidenza tra responsabilità civile e responsabilità disciplinare là dove si prevede, al terzo comma dell’art. 9 della legge n. 117 del 1988 (sul punto non modificata dalla successiva legge n. 18 del 2015) che la disposizione “che circoscrive la rilevanza della colpa ai casi di colpa grave ivi previsti, non si applica nel giudizio disciplinare”, proprio in considerazione della diversità dei piani sui quali le due regolazioni si muovono.
Peraltro, è noto che nel giudizio disciplinare, a seguito della tipizzazione del 2006, la rilevanza dell’errore del magistrato nell’esercizio delle funzioni, è limitata alle ipotesi di “ignoranza o negligenza inescusabile”, che sono ipotesi di intervento sanzionatorio anche più restrittive rispetto alla “colpa grave”, com’è riconosciuto proprio dal legislatore del 2015, che – per gli illeciti consistenti nella violazione manifesta della legge, del diritto dell’Unione europea o nel travisamento del fatto o delle prove – limita l’azione di rivalsa ai soli casi in cui essi siano stati determinati da dolo o negligenza inescusabile (art. 7, primo comma).
Diversamente potrebbe forse ipotizzarsi in relazione all’azione disciplinare nei confronti dei magistrati amministrativi e contabili, per i quali non sussiste un sistema di tipizzazione degli illeciti, non essendo ad essi applicabile il d.lgs. n. 109 del 2006 e vigendo ancora il sistema dell’atipicità degli illeciti disciplinari.
In tali casi, sarebbe possibile una obbligatorietà dell’esercizio dell’azione disciplinare “per i fatti che hanno dato causa all’azione di risarcimento”, sia pure dopo che quei fatti non siano più controversi, e cioè all’esito di sentenza irrevocabile nel giudizio di rivalsa.
Dunque, per i magistrati ordinari (e per quelli militari) non avendo previsto il legislatore una nuova forma di illecito disciplinare, non potendo ipotizzarsi tout court una responsabilità disciplinare per il solo fatto dell’accertamento definitivo di una responsabilità civile, deve conseguentemente escludersi anche il solo obbligo di esercizio dell’azione disciplinare “per i fatti che hanno dato causa all’azione di risarcimento” in sede civile.
Pertanto, le considerazioni che, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 109 del 2006, avevano fatto ritenere al Procuratore generale della Corte di cassazione – in più di un provvedimento di archiviazione – che nel sistema disciplinare vigente non è più compatibile l’applicazione della legge n. 117 del 1988 sulla responsabilità civile dei magistrati, nella parte in cui prevede l’obbligatorio esercizio entro due mesi dell’azione disciplinare nel caso di semplice ammissibilità della domanda di risarcimento nei confronti dello Stato, devono essere – a maggior ragione – ribadite anche alla luce della legge n. 18 del 2015, ove il filtro di ammissibilità è venuto meno e dove il termine “devono” può e deve essere considerato – proprio alla luce della proposta interpretazione logico sistematica – nulla più di un mero enunciato conseguente al mancato coordinamento tra l’originario testo del 1988, antecedente alla tipizzazione degli illeciti disciplinari del 2006, ed il nuovo testo del 2015, che ha previsto l’abrogazione dell’obbligo di comunicazione ai titolari dell’azione disciplinare nel caso di ammissibilità dell’azione risarcitoria.
D’altra parte, su di un piano sistematico generale, la accennata autonomia di valutazione giuridica tra le due sedi, civile e disciplinare, si dimostra la sola coerente con le diversità di connotazione e conformazione dei requisiti dell’illecito civile e di quello disciplinare, rispettivamente: così in ordine al nesso causale tra condotta ed evento (che nell’ambito della materia civile è regolato, come è noto, dal criterio del “più probabile che non” mentre in ambito disciplinare, assimilabile per questa parte all’area penale, vige il principio dell’”al di là di ogni ragionevole dubbio”), alla ripartizione dell’onere probatorio, alla qualificazione della colpa e relativa graduazione.
In conclusione, l’apparente distonia tra le normative che disciplinano le diverse responsabilità del magistrato – civile e disciplinare – va risolta nel senso che, per le parti in cui vi siano disposizioni estremamente sintetiche nel corpo della legge n. 117 novellata, è questa legge sulla responsabilità civile che deve adeguarsi ai principi speciali propri della responsabilità disciplinare, tanto più che, mentre l’esercizio dell’azione civile è una facoltà della parte che si ritenga danneggiata (la quale se ne assume in proprio la responsabilità, con relativa esposizione ad eventuale azione di danni nei suoi confronti ove la “lite” si dovesse rivelare “temeraria”), l’esercizio dell’azione disciplinare è un obbligo di legge per il Procuratore generale della Corte di cassazione (art. 14, terzo comma, del d.lgs. n. 109 del 2006) e ciò sta a significare che l’alto organo della magistratura requirente deve iniziarla soltanto quando ne sussistano i presupposti, non certo quando tali presupposti non sussistono perché, pur dopo un lungo giudizio risarcitorio conclusosi con condanna del magistrato responsabile, manchi la notizia circostanziata di una fattispecie tipizzata dal legislatore (quanto al Ministro della giustizia, la facoltà di esercizio dell’azione disciplinare è prevista, oltre che ovviamente nella Costituzione, art. 107, secondo comma, anche dal primo comma dell’art. 9 della legge n. 117 del 1988, oltre che dal secondo comma dell’art. 14 del d.lgs. n. 109 del 2006).
C) Segue. Analisi casistica. Pregiudizialità logica e regime probatorio.
L’esclusione della obbligatorietà di intervento, da parte dei titolari dell’azione disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari (e militari), non copre il ventaglio di tutte le possibili ipotesi di rapporti tra l’azione risarcitoria e quella disciplinare.
E’ verosimile ritenere che ciò che è stato solito avvenire sino all’entrata in vigore della legge n. 18 del 2015, e cioè la contemporanea trasmissione, da parte del preteso danneggiato ai titolari dell’azione disciplinare, dell’esposto nei confronti del magistrato per gli stessi fatti che hanno determinato la domanda risarcitoria, continui ad accadere e, anzi, divenga sempre più frequente, non potendo negarsi che la forza del messaggio mediatico diffuso con l’entrata in vigore della legge n. 18 del 2015 (“chi sbaglia paga”) sia assai più dirompente della effettiva portata dei precetti in esso contenuti.
Non può ignorarsi – per questo profilo – che il procedimento disciplinare sia assai più incisivo, efficace e rapido rispetto al giudizio di danno, che risente certamente dei problemi connessi alla “insostenibile lentezza della giustizia civile”,2 che tante condanne dello Stato italiano ha determinato presso la Corte di Strasburgo, e che potrà determinarne anche in sede di responsabilità civile dei magistrati ed all’esito di rivalsa, tanto più in quanto vi sia un ricorso massiccio all’azione risarcitoria.
Se ciò è vero, le preliminari determinazioni del Procuratore generale della Corte di cassazione in ordine all’esercizio dell’azione disciplinare o all’emissione del decreto di archiviazione potrebbero essere rilevanti e, in ogni caso, rivelarsi utili nel più lungo e articolato giudizio civile.
D’altronde, che vi sia una utilità degli atti del giudizio disciplinare ai fini della decisione da assumere in sede civile è circostanza tenuta presente dallo stesso legislatore del 1988 – non smentita dal legislatore del 2015 – là dove, al secondo comma dell’art. 9 della legge sulla responsabilità civile dei magistrati, si prevede che “gli atti del giudizio disciplinare possono essere acquisiti, su istanza di parte o d’ufficio, nel giudizio di rivalsa”.
La norma, in verità, appare il frutto di uno scrupolo forse eccessivo, proprio in considerazione del fatto che essa prevede una mera facoltà di acquisizione di atti nel giudizio di rivalsa.
E’ pacifico che tale facoltà vi sarebbe stata ugualmente in assenza di specifica previsione di legge, sulla base dei principi generali in materia di acquisizione processuale di atti di altri procedimenti; peraltro, l’utilizzazione del termine “giudizio” e non “procedimento” sta a significare che il legislatore non ha considerato la circostanza che, ove il procedimento disciplinare non sia ancora sfociato nella fase dibattimentale, sia garantita la necessaria riservatezza propria del procedimento disciplinare in fase istruttoria che, in concreto, potrebbe portare anche ad un diniego motivato di ostensibilità da parte del Procuratore generale della Corte di cassazione, se gli aspetti di riservatezza siano ritenuti prevalenti sull’interesse delle parti in sede civile all’acquisizione degli stessi nel giudizio contro lo Stato.
Per di più, proprio i principi generali in materia di acquisizione di atti nel giudizio civile fanno sì che possa ritenersi possibile che tali atti possano essere acquisiti su istanza di parte o d’ufficio, non solo nel giudizio di rivalsa, ma anche nel giudizio contro lo Stato.
Ancora, gli stessi principi possono consentire l’acquisizione nel giudizio risarcitorio, su istanza di parte o d’ufficio, anche di atti relativi al giudizio predisciplinare, compreso l’eventuale decreto di archiviazione, che potrebbe immediatamente sgombrare il campo da equivoci e strumentalizzazioni legate ad azioni risarcitorie del tutto pretestuose e infondate (ma non più inammissibili, per assenza del filtro), fatto salvo – sempre – il diniego motivato da parte del Procuratore generale, ove questi ritenga che le esigenze di riservatezza prevalenti sull’interesse delle parti alla produzione nel giudizio civile di atti o documenti riservati.
Dunque, nel nuovo contesto normativo, le sollecite determinazioni del Procuratore generale della Corte di cassazione (nel termine di un anno dalla conoscenza del fatto) potrebbero essere di rilievo proprio in quei casi di contemporanea formulazione dell’esposto (in sede disciplinare) e della domanda risarcitoria (in sede civile) e, soprattutto, ogni qualvolta il magistrato sia stato attinto da azioni giudiziarie ictu oculi infondate o strumentali.
Fermo restando che, dove invece la doglianza del preteso danneggiato si riveli degna di attenzione e, comunque, complessa, tale da determinare l’inizio dell’azione disciplinare, soccorrono le norme previgenti all’entrata in vigore della legge n. 18 del 2015, in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e giudizio civile.
In questa prospettiva, va ricordato il principio per cui tutti i termini di decadenza del procedimento disciplinare e per l’esercizio della relativa azione sono sospesi (con possibile sospensione facoltativa del procedimento giurisdizionale disciplinare o, prima, di quello amministrativo predisciplinare) in caso di pendenza di un procedimento civile, penale o amministrativo che sia pregiudiziale all’accertamento del fatto costituente l’illecito disciplinare della grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile (lett. g) dell’art. 2) ovvero del travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile (lett. h) dell’art. 2), e ciò ai sensi della lett. d)-bis dell’art. 15, ottavo comma, del d.lgs. n. 109 del 2006.
Peraltro, va sottolineato che, nella ipotesi di giudizio risarcitorio pendente in sede civile, il termine “pregiudizialità” deve essere inteso, per quanto si è detto fin qui, non in senso strettamente giuridico, con riferimento alla identità del fatto e ad un potenziale conflitto tra giudicati – che, come si è prima osservato, non potrebbe sussistere – ma soltanto in senso logico e nelle limitate ipotesi previste dalla norma, onde evitare una duplicazione di attività probatorie volte ad accertare gli stessi fatti, che possono comunque essere diversamente valutati nelle diverse sedi competenti secondo i criteri propri di ciascun illecito, civile e disciplinare.
Detta pregiudizialità, pur in tal modo intesa, non può sussistere in ogni caso con riferimento al giudizio risarcitorio nei confronti dello Stato in quanto non può esservi all’evidenza pregiudizialità, nemmeno logica, ove il magistrato attinto dalle indagini, sommarie o non, in sede disciplinare, non sia parte in un giudizio risarcitorio in sede civile.
Nei casi di possibile pregiudizialità (logica) in sede di rivalsa, il Procuratore generale della Corte di cassazione (e, successivamente, il giudice disciplinare, se la questione sia sollevata in giudizio), al fine di apprezzare la “inescusabilità” del comportamento negligente del magistrato, potrà valutare se sia opportuno o meno attendere l’esito del processo civile (come di quello penale o di quello amministrativo), che metta definitivamente in luce la “grave violazione di legge” ovvero il “travisamento dei fatti”.
Con particolare riferimento ai rapporti del procedimento disciplinare con i processi civili, infatti – come si è già osservato – l’art. 20 del d.lgs. n. 109 del 2006 non detta, come per i processi penali, specifiche disposizioni che sanciscano autorità o efficacia di cosa giudicata alle sentenze civili rispetto agli accertamenti ed alle valutazioni in sede disciplinare.
Viceversa – come si è pure osservato – il primo comma dell’art. 20 dispone la più completa autonomia dell’azione disciplinare, promossa “indipendentemente dall’azione civile di risarcimento del danno (…) relativa allo stesso fatto”.
La valutazione della possibile sospensione facoltativa (e non necessaria) del procedimento predisciplinare (che, si ricorda, ha natura amministrativa e non giurisdizionale: Cass., S.U., n. 26809/2009) va coordinata invece con la previsione di legge che ne prende in considerazione l’ipotesi di sospensione, l’art. 16, quarto comma, ultimo periodo, del d.lgs. n. 109 del 2006; tale norma prevede, oltre la specifica sospensione per esigenze motivate di segretezza opposte dall’ufficio procedente in sede penale, che “il procedimento può essere altresì sospeso nel corso delle indagini preliminari”.
E’ stato in particolare ritenuto che detta facoltà “persegue la ‘ratio’ di consentire al P.G. presso la Corte di cassazione di differire l'iniziativa disciplinare fino all'esito certo delle indagini preliminari, che si manifesta solo nella decisione del G.I.P. sull'esercizio dell'azione penale”: così Cass., S.U., n. 21853/2012.
Pur nel convincimento che, nella pratica attuazione del diritto, il Procuratore generale difficilmente si determinerà alla sospensione di un procedimento predisciplinare che poi si protrarrebbe inevitabilmente per un tempo irragionevole, sino al passaggio in giudicato della sentenza resa nel giudizio di rivalsa, in via meramente teorica la specifica previsione di cui all’art. 16, quarto comma, ultimo periodo, del d.lgs. n. 109 del 2006 può aprire la facoltà di sospensione del procedimento predisciplinare in pendenza di giudizio civile, facoltà che solo in astratto è predicabile.
La previsione di sospensione dei termini, anche del termine annuale per l’esercizio dell’azione disciplinare (art. 15, primo comma, del d.lgs. n. 109 del 2006) – nel caso di giudizio risarcitorio pregiudiziale all’accertamento del fatto costituente l’illecito disciplinare della grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile (lett. g) dell’art. 2) ovvero del travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile (lett. h) dell’art. 2) – si concilierebbe con la possibilità di disporre la sospensione del procedimento stesso; questo, del resto, è pacifico nell’ipotesi di c.d. pregiudiziale penale, ove la sospensione dei termini comporta, per prassi consolidata, la sospensione del procedimento.
Vero è che il legislatore del 2006 non ha tenuto conto della diversità dei tempi di durata che nella situazione contingente caratterizzano, rispettivamente, i processi civili ed i procedimenti disciplinari.
Dubbi anche in via astratta possono esservi invece sulla possibilità di sospensione del procedimento predisciplinare qualora si esuli dalla previsione di cui all’art. 15, ottavo comma, del d.lgs. n. 109 del 2006, perché in tale ultima ipotesi, in assenza di una pregiudizialità logica che sospende i termini (anche) del procedimento predisciplinare, la diversità di natura – amministrativa e giurisdizionale – dei due diversi procedimenti rende plausibile l’opzione interpretativa che neghi in radice tale possibilità.
In queste ultime ipotesi è invero assai dubbia la sola opportunità di dover attendere – ai fini delle determinazioni sulla iniziativa disciplinare – l’esito certo del giudizio civile, sia pure per profili non strettamente pregiudiziali, ma solo se fondati sull’esigenza di evitare una duplicazione di attività istruttorie e probatorie.
Resta fermo che in ogni ipotesi di pendenza del giudizio civile di danno – oggi come prima – il Procuratore generale della Corte di cassazione che procede in via predisciplinare potrà acquisire dal giudice civile ogni notizia, atto o informazione utile ai fini delle sue determinazioni sull’esercizio dell’azione disciplinare, ma questa – se del caso – dovrà essere esercitata in piena autonomia e prescindendo dal giudizio civile, entro l’anno dalla notizia circostanziata del fatto (termine sospeso solo nel caso della suindicata ipotesi di cui all’ottavo comma dell’art. 15, lett. d)-bis del d.lgs. n. 109).
Ove invece il Procuratore generale si determini per l’archiviazione del procedimento predisciplinare, anche ed eventualmente con la formula “allo stato degli atti”, si potrebbe porre l’ipotesi di esercizio dell’azione disciplinare successivamente alla definizione del giudizio civile di rivalsa negativa per il magistrato responsabile.
Vero è che, in tal caso, si dovrebbe verificare sia l’eventuale decadenza per il decorso del termine annuale dalla notizia circostanziata del fatto per l’esercizio dell’azione disciplinare (art. 15, primo comma, del d.lgs. n. 109 del 2006) e, in tal caso, si dovrà verificare se via sia stata o meno la sospensione automatica dei termini (ai sensi della lett. d)-bis dell’art. 15, ottavo comma), sia l’eventuale decadenza per il decorso del termine decennale decorrente dal momento del fatto in valutazione (art. 15, comma 1-bis), che non può certo considerarsi inverosimile, tenuto conto proprio dei normalmente lunghi tempi di definizione dei giudizi civili.
***
A conclusione di questa disamina inerente i rapporti tra i giudizi di responsabilità, civile e penale, possono quindi svolgersi le seguenti conclusioni:
a) La trasmissione della notizia della pendenza di una controversia civile di danno ex art. 2 legge n. 117/1988 non costituisce un obbligo a carico dei capi degli uffici, rilevante a norma dell’art. 2, comma 1, lettera dd), del d.lgs. n. 109/2006.
b) Non è necessario istituire un raccordo istituzionale tra la Procura generale e gli uffici (giudicanti) di merito ai fini disciplinari; tuttavia può essere utile prefigurare canali informativi a fini di rilevazione statistica e di applicazione della legge n. 18/2015.
c) L’acquisizione, in qualsiasi modo, della notizia della proposizione di un giudizio civile di danno ex lege n. 117/1988 non autorizza come tale l’esercizio dell’azione disciplinare per i fatti che vi hanno dato causa.
d) L’acquisizione della notizia della proposizione di un giudizio civile di danno autorizza l’iscrizione di un procedimento predisciplinare e lo svolgimento della relativa sommaria indagine a norma dell’art. 15 del d.lgs. n. 109/2006.
e) Il procedimento predisciplinare non è di regola soggetto a sospensione per pregiudizialità (art. 15, comma 8, lettera d-bis, d.lgs. n. 109/2006) rispetto alla causa civile di danno verso lo Stato, vi sia o non vi sia in quest’ultima l’intervento volontario del magistrato, o rispetto al giudizio di rivalsa.
f) All’esito della sommaria indagine predisciplinare, il Procuratore generale “deve” esercitare l’azione disciplinare solo in quanto i fatti che hanno dato causa all’azione civile di danno e che sono stati comunicati all’Ufficio integrino gli estremi di una ipotesi disciplinare tipizzata a norma dell’art. 2 del d.lgs. n. 109/2006, indipendentemente dalla valutazione che sia data ai fatti in ambito civile.
g) Il procedimento in fase disciplinare non è di regola soggetto a sospensione per pregiudizialità della causa civile di danno o del giudizio di rivalsa.
h) E’ possibile la trasmissione di atti del procedimento predisciplinare o disciplinare per l’acquisizione nel giudizio civile di rivalsa, solo se pervenuto alla fase del giudizio (e con gli eventuali limiti di pubblicabilità/divulgabilità degli stessi); l’acquisizione di atti relativi alle fasi del procedimento predisciplinare o disciplinare nella causa civile non è regolata dalla legge n. 18/2015 ed è soggetta alle regole e ai limiti generali di pubblicabilità.
i) La definizione, con pronuncia passata in giudicato, della causa civile di danno o del giudizio di rivalsa non ha efficacia nel processo disciplinare.
La responsabilità disciplinare del magistrato e
i rapporti con le valutazioni di professionalità
La insoddisfazione dei cittadini per il servizio reso dalla amministrazione della giustizia, le cui disfunzioni sono innegabili (come è innegabile lo sforzo di fronteggiarle da parte dei magistrati e degli altri operatori), ha generato una crescente diffidenza – sovente tramutatasi in vera e propria sfiducia, al pari di quella manifestatasi verso altre istituzioni fondamentali dello Stato – che ha trovato negli anni sponda e risonanza in settori della politica e dell’informazione.
L’insofferenza non si manifesta solo, come sarebbe più che comprensibile, per la lunghezza dei tempi dei procedimenti, ma nei confronti della decisione in sé, che la parte soccombente (sia nei giudizi civili sia in quelli penali) sempre più spesso non sembra disposta ad accettare ed imputa a inadempimenti o errori del giudice o a iniziative persecutorie delle procure. Il numero degli esposti presentati ogni anno contro i magistrati, fenomeno pressoché sconosciuto in altre realtà europee, costituisce l’epifenomeno di una reattività che rischia di minare alla base la legittimazione stessa della giurisdizione, la quale risiede anche nella riconosciuta autorevolezza delle sue decisioni. D’altra parte, quegli stessi esposti a volte rivelano condotte e prassi non corrispondenti a standard adeguati di comportamento.
Sarebbe un gravissimo errore considerare questo come un problema esclusivo della giustizia disciplinare e pretendere da questa la soluzione.
I numeri dimostrano, come chiarito in più sedi, che la giustizia disciplinare italiana è rigorosa e tutt’altro che compiacente, ma il suo intervento deve essere riservato alla sanzione di condotte patologiche, specifiche e rilevanti: non è strumento che possa essere impropriamente utilizzato per più generiche, per quanto meritorie, finalità di maggiore efficienza e di politica della giurisdizione.
Per la sua intrinseca natura il sistema disciplinare può intervenire solo su casi singoli e quando la lesione degli interessi fondanti della giurisdizione si è già determinata: è impossibile piegarlo al raggiungimento di altri obbiettivi, ferma restando, così come per ogni sistema sanzionatorio, la funzione di prevenzione generale, che ha indubbiamente ricadute sulla condotta della generalità dei destinatari della norma.
Allo stesso modo sarebbe un errore trasferire interamente sull’iniziativa disciplinare il peso della (ri)affermazione e del consolidamento dei principi deontologici di comportamento alla cui violazione rinviano molti di quegli esposti che, come si è detto, vengono rivolti contro i magistrati.
La magistratura, come sovente ha dimostrato di saper fare, deve essere esigente e rigorosa in primo luogo nei confronti di sé stessa, ma il presidio primo dei valori di indipendenza, imparzialità, correttezza, diligenza, professionalità, riserbo ed equilibrio, che fondano il corretto esercizio della giurisdizione, consiste nella condivisa assunzione di tali valori come parametri quotidiani ispiratori della propria condotta e metro reciproco di valutazione del comportamento tra gli stessi colleghi.
Prima della caduta patologica, che impone l’intervento degli organi ai quali è affidato il controllo disciplinare dei magistrati, rileva il costante rispetto del codice etico da parte di ciascuno. Non deve trarre in inganno la intrinseca imperfezione di una norma, come quella del codice etico, priva di sanzione.
La tipizzazione del 2006 ha attuato un’osmosi non sempre felice tra norme deontologiche e alcune fattispecie disciplinari elaborate dalla precedente giurisprudenza e tra le due materie vi è certo una evidente contiguità. Ciononostante non bisogna assolutamente confonderle tra loro e non è quello disciplinare, come s’è già detto, il solo – e neanche il primo – terreno sul quale i valori della giurisdizione devono essere difesi.
La formazione iniziale e permanente, ora affidata alla Scuola superiore della magistratura, le valutazioni di professionalità, l’esercizio della discrezionalità consiliare nella scelta dei dirigenti vengono prima e hanno forse maggiore importanza. Gli organi disciplinari intervengono dopo, quando tutti gli altri presìdi sono stati travolti e il danno è già stato fatto. Non si può chiedere ad essi qualcosa di diverso e non devono essere caricati di funzioni ulteriori rispetto a quelle, già gravose, che l’ordinamento attribuisce loro.
Sta forse nella confusione tra questi diversi piani la radice dell’evidente contraddizione per la quale, a fronte di un sistema disciplinare il cui bilancio è certamente in attivo, se ne chiede da più parti la riforma. L’insoddisfazione per il funzionamento della giustizia e, in molti settori della società e della politica, la delusione per la ritenuta inattuazione della legge 13 aprile 1988, n. 117, sulla responsabilità civile dei magistrati hanno coltivato l’illusione che un diverso sistema, sottratto ad una Sezione disciplinare espressione esclusiva del Consiglio superiore, sarebbe in grado di esercitare un maggior controllo sulla magistratura e di migliorarne il funzionamento. Non ci si accorge, invece, di chiedere così al sistema disciplinare di assolvere una funzione che non gli è propria, deresponsabilizzando chi, sul piano normativo, regolamentare, organizzativo, dirigenziale, operativo, dovrebbe intervenire, ciascuno secondo il proprio ruolo, le proprie responsabilità, la propria consapevolezza professionale.
Prima dell’intervento disciplinare è dunque necessario un adeguato intervento sulle verifiche della professionalità di ogni magistrato, comparative e non.
Molte delle condotte non ritenute dal Procuratore generale meritevoli di sanzione disciplinare, e sovente nemmeno di inizio di azione disciplinare, ben potrebbero o dovrebbero essere tenute in considerazione dal CSM per i diversi profili attinenti le valutazioni di professionalità.
Questo è il motivo per cui, da diverso tempo, taluni sostengono l’opportunità che i decreti di archiviazione – almeno quelli di particolare rilievo – siano trasmessi per conoscenza al CSM, onde porre l’organo di autogoverno in grado di conoscere condotte delle quali non è in alcun modo informato, visto che, dopo la riforma del 2006, gli sono state sottratte competenze anche in tema di art. 2 L.G.
Se infatti l’esposto del privato viene trasmesso ai soli titolari dell’azione disciplinare e non al CSM, l’organo del governo autonomo della magistratura può venire a conoscenza di quei fatti e di quelle condotte, oggetto di doglianza da parte del cittadino, soltanto nella ipotesi in cui l’azione disciplinare venga esercitata.
Poiché ogni anno il filtro della Procura generale fa sì che più del 90% delle notizie di illecito disciplinare venga ritenuto di alcun rilievo disciplinare, o – in molto minore misura - di scarsa rilevanza ai sensi dell’art. 3-bis del d.lgs. n. 109/2006, nella ipotesi largamente prevalente di archiviazione del Procuratore generale il CSM non viene informato di quei fatti che, se irrilevanti disciplinarmente, possono e debbono essere valutati in sede di valutazioni di professionalità.
Di qui una triplice alternativa per il Procuratore generale, in concreto manifestatasi già da tempo.
1) Trasmettere al CSM ogni decreto di archiviazione in base al principio generale dell’ordinamento giudiziario secondo il quale l’organo del governo autonomo della magistratura deve essere informato di ogni fatto, atto, comportamento del magistrato utile – nel bene o nel male – a valutarne la professionalità.
2) Non trasmettere al CSM alcun decreto di archiviazione in base alla considerazione che manca nell’ordinamento giudiziario una specifica norma di legge che lo preveda.
3) Valutare caso per caso la trasmissione del decreto di archiviazione, a seconda del rilievo che quei fatti, atti o comportamenti del magistrato abbiano ai fini delle valutazioni di professionalità, secondo la personale opinione che lo stesso Procuratore generale ne abbia.
La prima alternativa potrebbe essere quella preferibile sul piano sostanziale, perché porrebbe il CSM nella condizione di procedere, nella collegialità propria dell’organo, alla valutazione di ciò che può essere o no rilevante ai fini del percorso professionale del magistrato. Essa però si scontra con l’aspetto pratico, di non secondaria importanza, di dare spazio ad un rilevantissimo – e spesso inutile –“carteggio” tra la Procura generale ed il CSM, che si colloca mediamente intorno alla cifra di 1200 - 1400 decreti di archiviazione all’anno.
La seconda ipotesi, quella di non trasmettere al CSM alcun decreto di archiviazione, potrebbe essere la soluzione più semplice, ma anche quella più burocratica e priverebbe al contempo l’organo di governo autonomo di una serie di notizie utili alle valutazioni.
La terza ipotesi potrebbe essere, forse, quella più razionale rebus sic stantibus, ma comporterebbe il rischio di spostare la valutazione preliminare relativa al possibile rilievo di professionalità della condotta oggetto di archiviazione disciplinare dall’organo collegiale preposto al Procuratore generale della Corte di cassazione, che è solo uno dei 27 componenti del CSM.
Peraltro, essa è stata già negativamente valutata, in buona sostanza, dal CSM che in un caso di proposta di inserimento agli atti del fascicolo personale del magistrato di un decreto di archiviazione ha ritenuto di non dover procedere all’incombente.
Ciò non impedisce oggi di affermare in questa sede che la scelta dell’alternativa più praticabile e comunque più opportuna dovrebbe essere demandata proprio al CSM, mediante apposita, generale regolamentazione di fonte secondaria e sarebbe idonea ad evitare per il futuro prolungate discussioni plenarie finalizzate all’inserimento nel fascicolo personale del magistrato di questo o quell’altro decreto di archiviazione, con la conseguenza di demandare in buona sostanza la valutabilità o meno della condotta del magistrato oggetto di archiviazione disciplinare ai fini delle verifiche di professionalità alla mutevolezza delle maggioranze che, volta per volta, si determinano nel CSM stesso.
D’altronde, sulla questione dell’ingresso dei provvedimenti di archiviazione predisciplinare nei fascicoli personali dei magistrati, che è tema istituzionalmente demandato alla competenza dell’organo di governo autonomo, dopo la predetta delibera consiliare che ha stabilito di non dare accesso a tale acquisizione informativa, in base alla regolazione di cui alla Circolare in materia (Circolare sulla tenuta dei fascicoli personali dei magistrati n. P-4718/09 del 27 febbraio 2009 e successive modifiche), è stata aperta una pratica presso la competente Commissione IV e in detta sede si ritiene che dovranno essere nuovamente presi in considerazione i profili relativi alla indubbia interferenza tra le determinazioni che risultano all’esito di una procedura predisciplinare e la complessiva valutazione professionale del magistrato: tanto più in un sistema disciplinare che, per unanime constatazione, presenta notevoli lacune e zone “franche” che lasciano, per questo, spazio a condotte non sanzionabili disciplinarmente e tuttavia tutt’altro che insignificanti nella definizione della deontologia complessiva e della figura del magistrato.
Ossia “qualsiasi comportamento, atto o provvedimento posto in essere con dolo o colpa grave nell’esercizio delle funzioni”, ai sensi del comma 1 dell’art. 2. La “colpa grave” si integra con l’enumerazione del comma 3, che include il travisamento “revocatorio” nonché l’adozione di misura cautelare immotivata o abnorme e ulteriormente si specifica, ma solo esemplificativamente (“si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché della inescusabilità e della gravità dell’inosservanza”), nel co. 3-bis.
2 Cfr. l’intervento del Procuratore generale della Corte di cassazione all’inaugurazione dell’anno giudiziario del 26 gennaio 2012, pubblicato nel sito della Corte di cassazione, www.cortedicassazione.it.