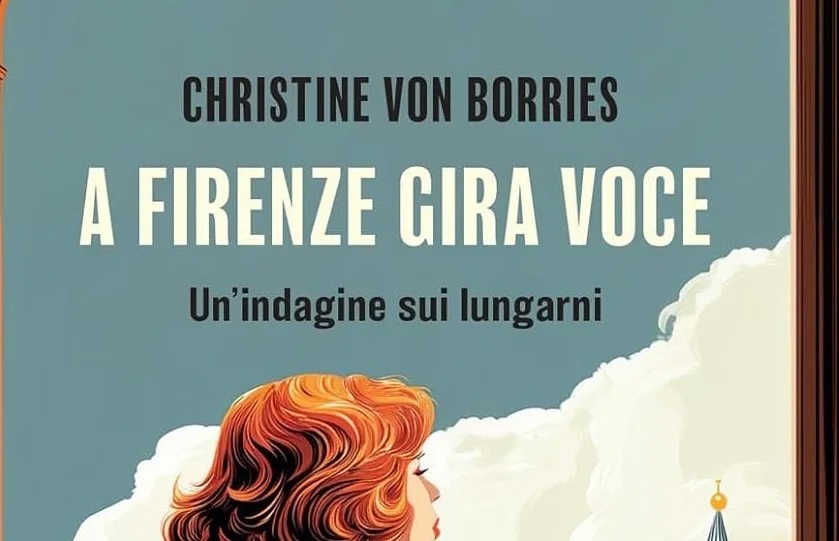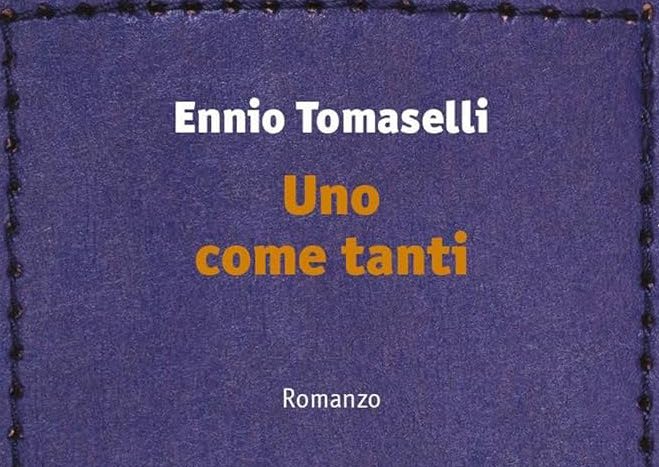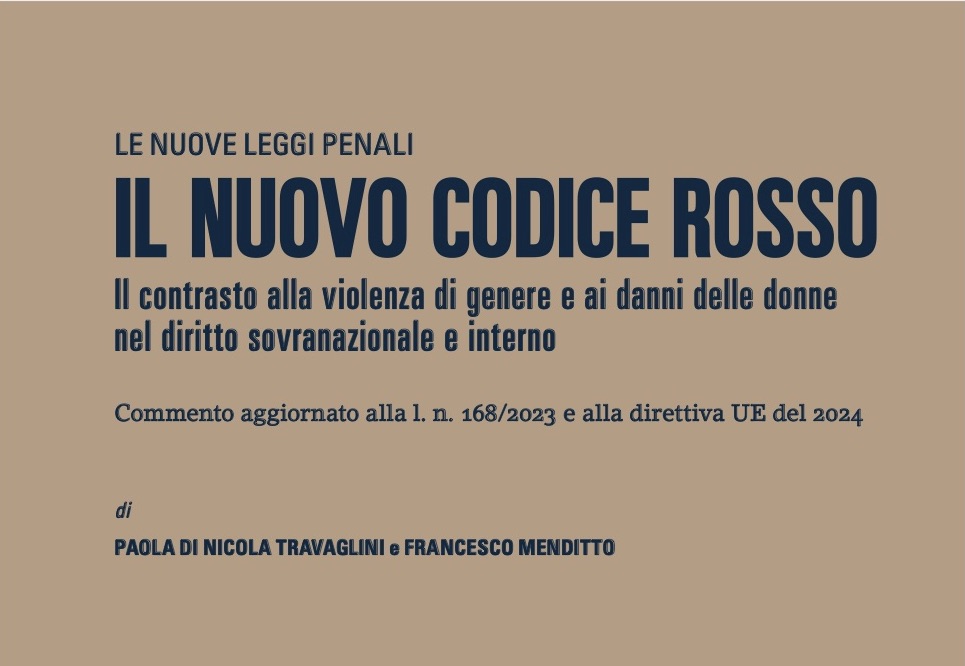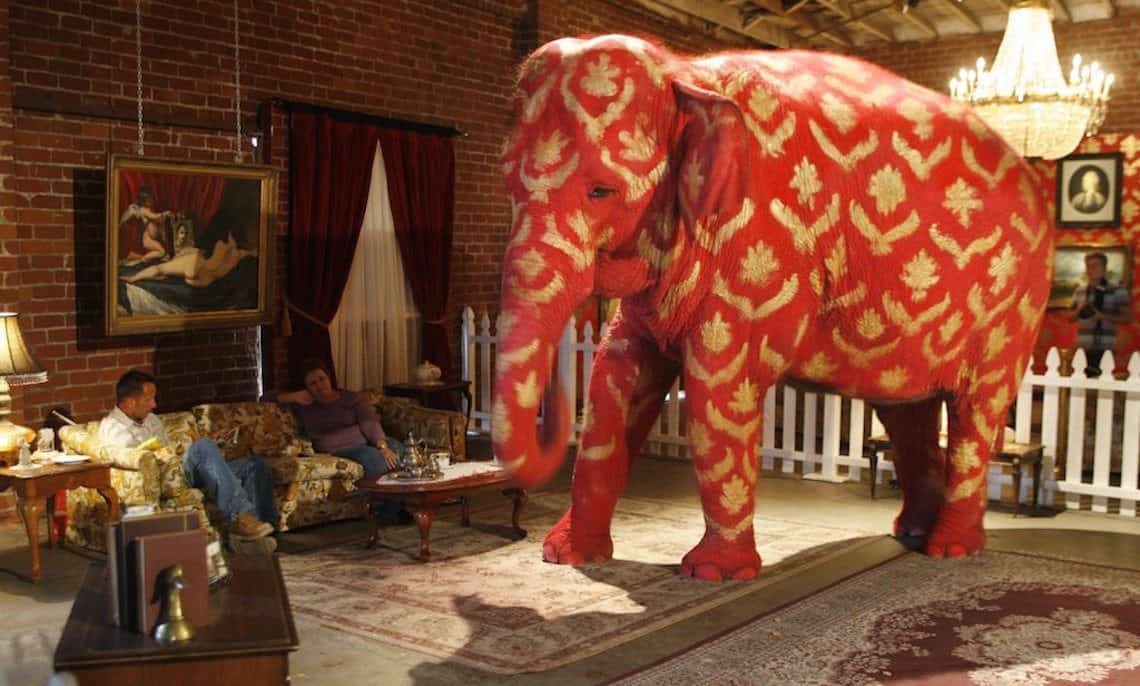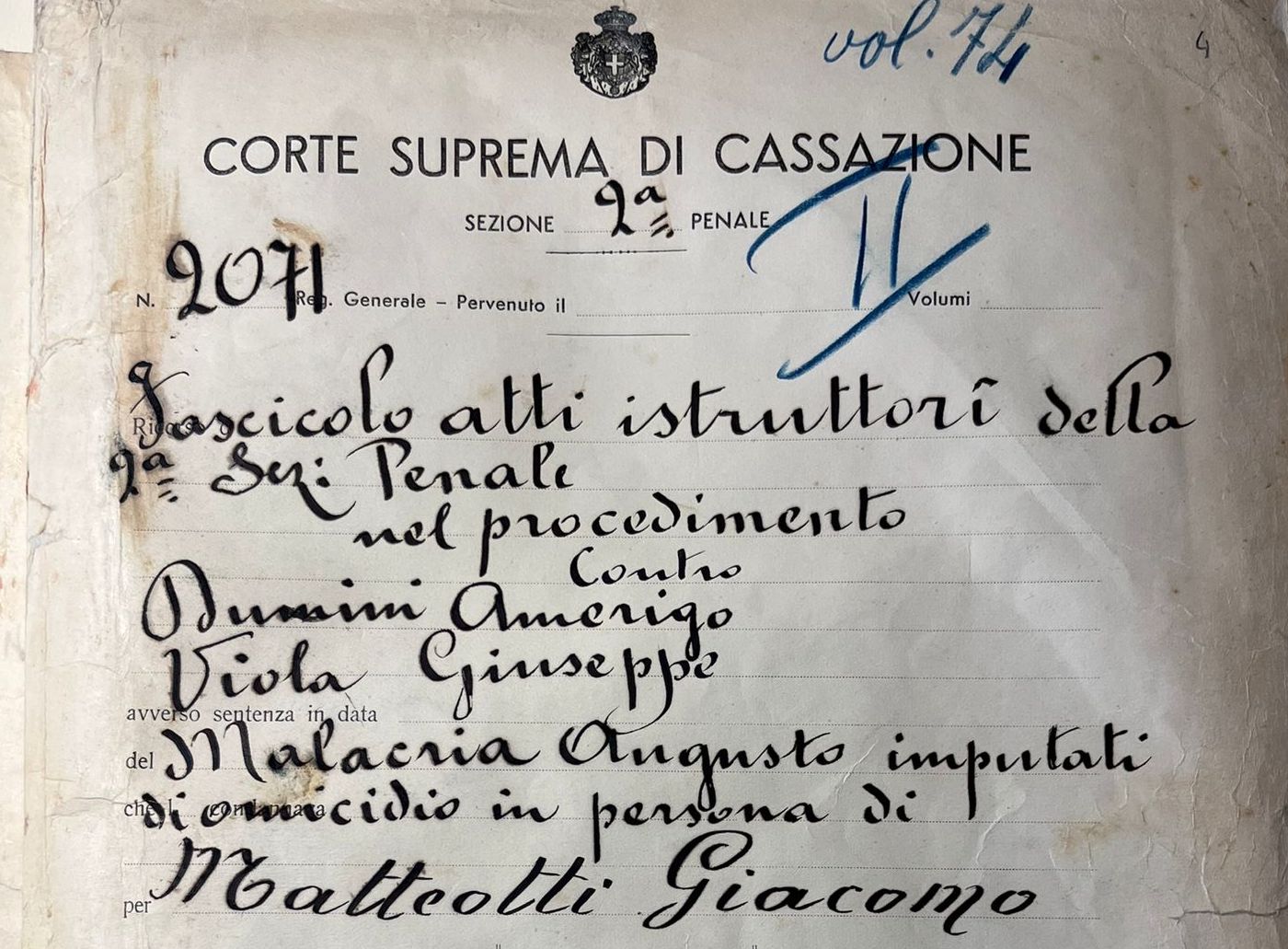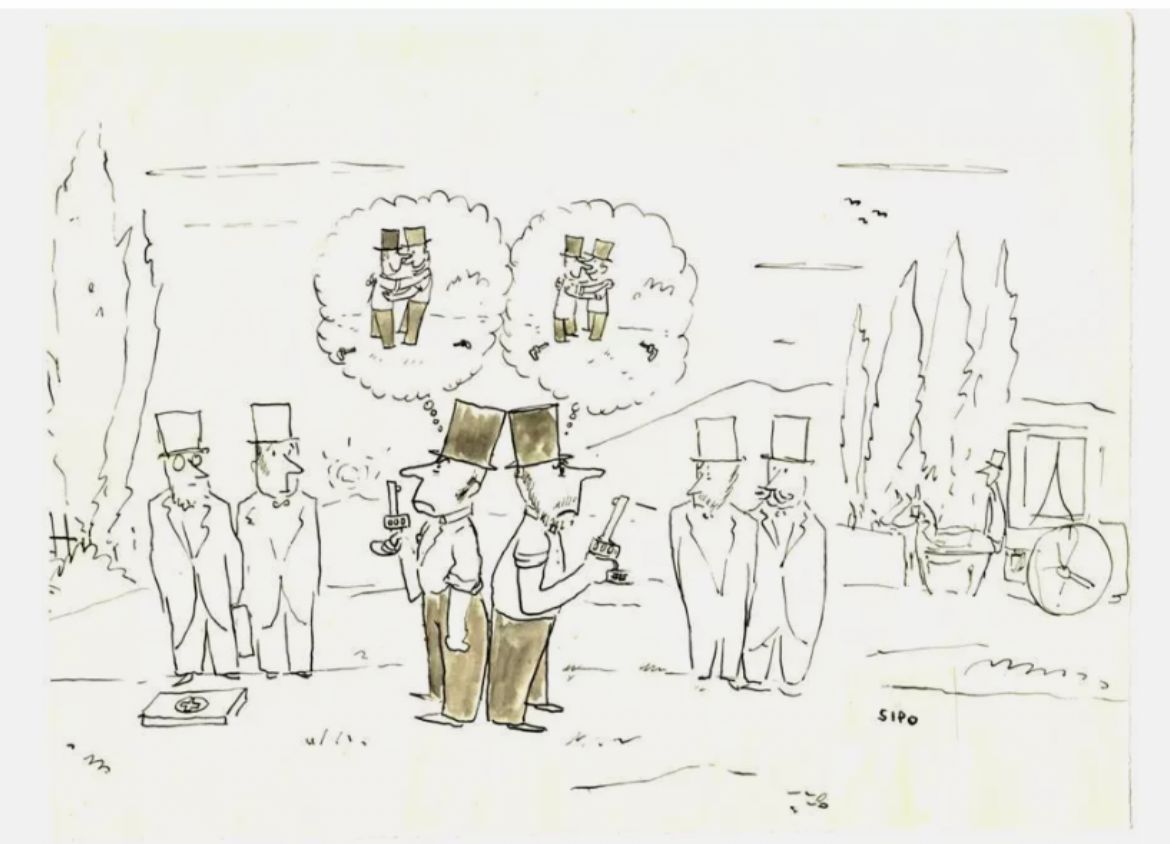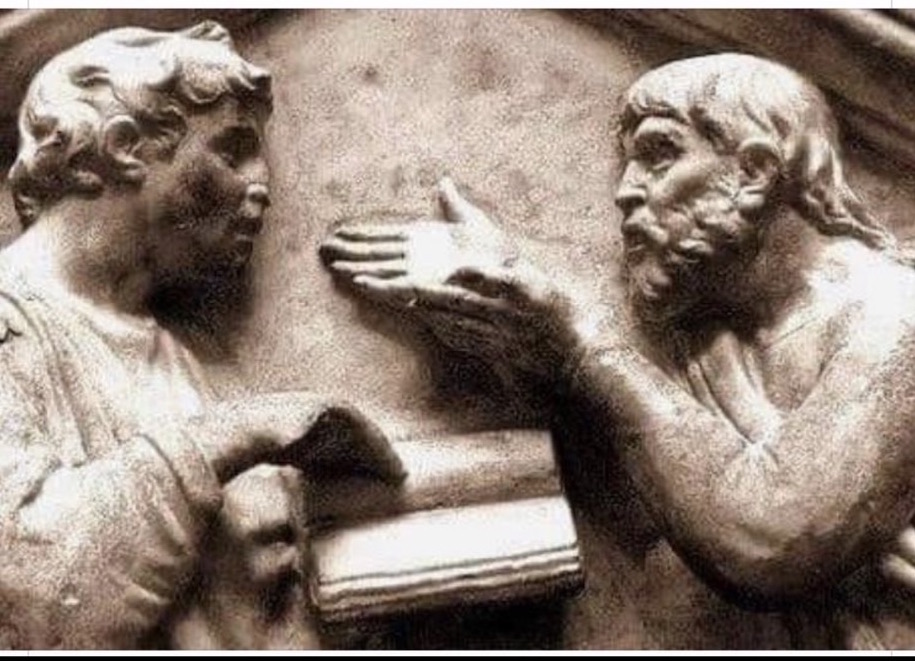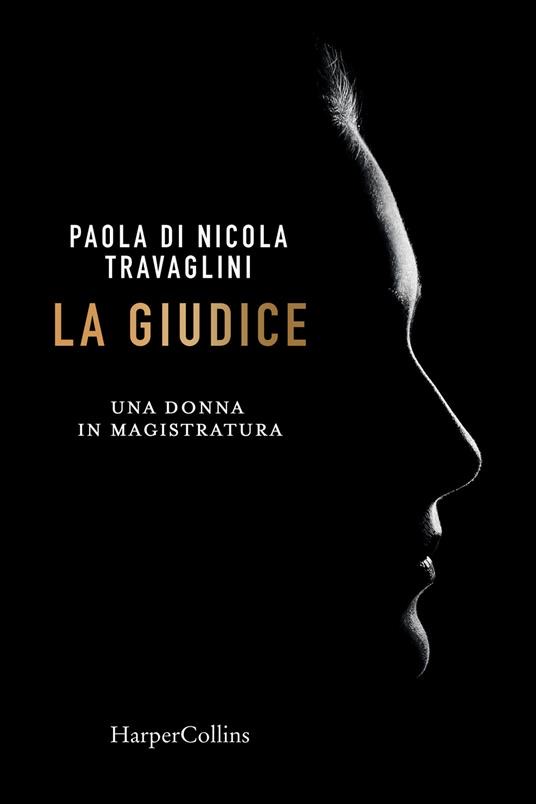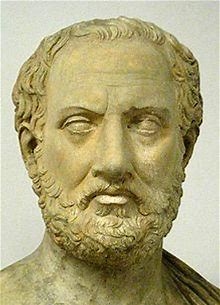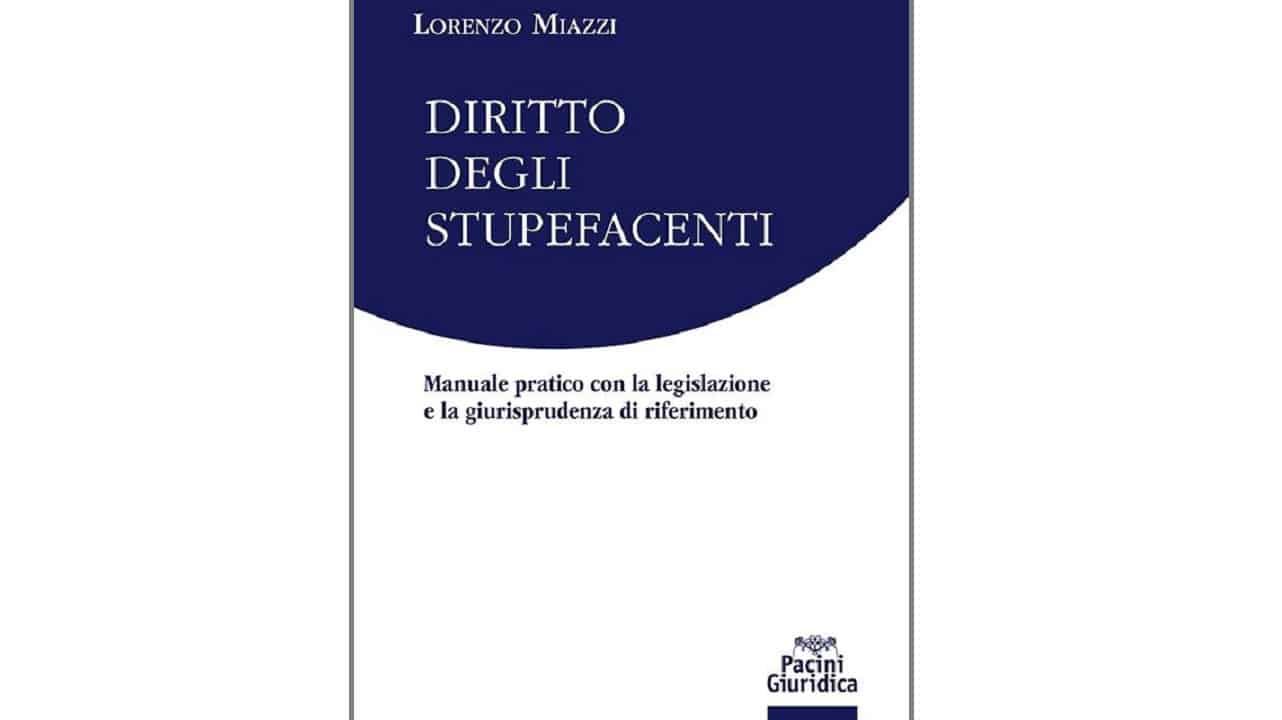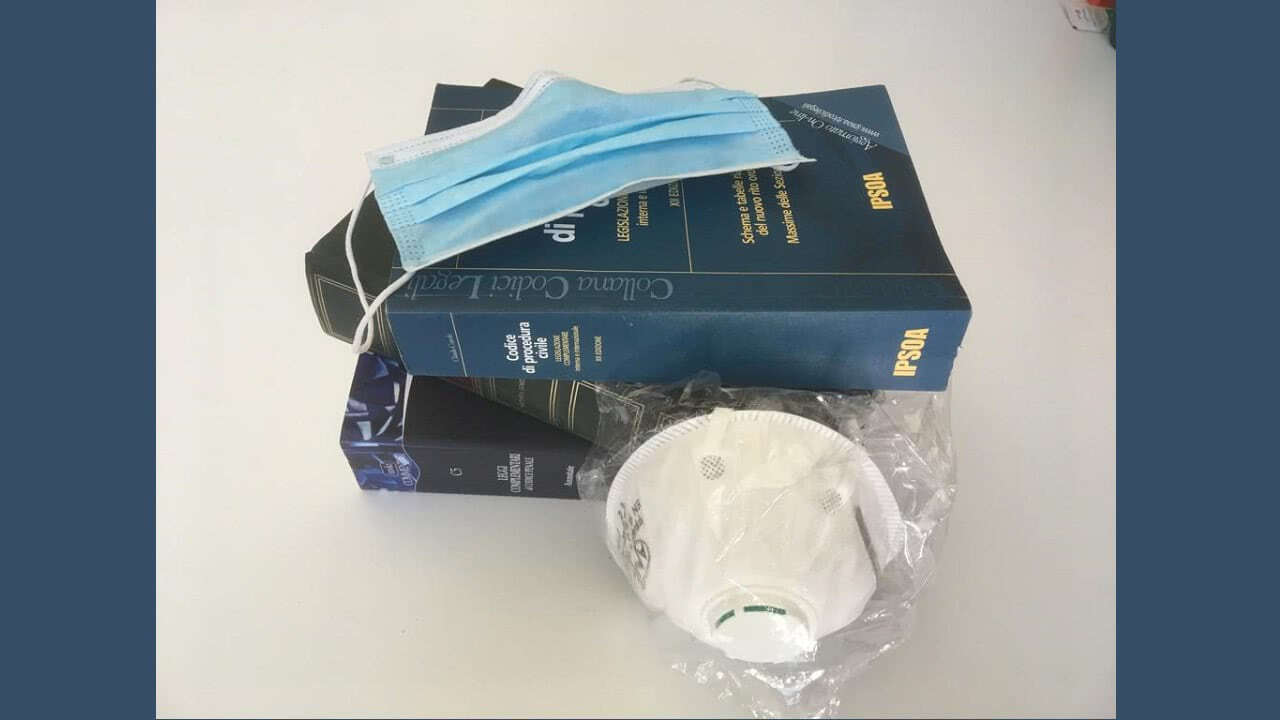La riforma delle intercettazioni: il Punto di vista del Giudice per le Indagini preliminari
di Costantino De Robbio*
In occasione della ormai prossima entrata in vigore dell’ultima parte della riforma delle intercettazioni, una riflessione sul significato della riforma dal punto di vista del Giudice, con particolare riferimento alle modifiche in tema di motivazione delle ordinanze di custodia cautelare ed ai riferimenti alle conversazioni intercettate nonché all'udienza stralcio
Sommario: 1. Le modifiche in tema di motivazione dell’ordinanza cautelare. 2. I precedenti recenti: la legge 47 del 2015.2. 3. Segue: la “riforma Orlando”.4.Le modifiche in tema di intercettazioni.
Le modifiche in tema di motivazione dell’ordinanza cautelare.
Nell'ambito del provvedimento in commento, le modifiche più incisive sul lavoro del giudice per le indagini preliminari, almeno nelle intenzioni del legislatore, dovrebbero essere quelle apportate agli articoli 291 e 292 del codice di procedura penale in tema di motivazione delle ordinanze di custodia cautelare.
Ancora una volta si interviene sul percorso logico-motivazionale dell’organo decidente, nel tentativo di incanalarlo in binari sempre più stretti e limitare la discrezionalità nella forma della redazione dei provvedimenti.
La ratio evidente delle modifiche legislative in commento va ricercata nell'esigenza di limitare abusi e superficialità nella scrittura dei provvedimenti, nella convinzione che il giudice sia costantemente esposto alla tentazione di non approfondire il materiale cautelare o probatorio a lui sottoposto e di accontentarsi della ricostruzione accusatoria il cui vaglio è chiamato ad effettuare.
E’ dunque la sfiducia verso il ruolo della magistratura inquirente, ormai una costante negli interventi legislativi degli ultimi anni, a trascinare con sé una sfiducia “di riflesso” nella funzione giudicante, ritenuta non all’altezza di arginare lo strapotere della parte accusatoria nell’attuale assetto del processo penale.
Le modifiche in esame seguono infatti quella che si appalesa sempre più come una linea di tendenza degli ultimi interventi legislativi sul processo penale.
In particolare, si può agevolmente rinvenire la medesima ratio legis in almeno due precedenti recenti, limitando la ricognizione ai soli provvedimenti legislativi di riforma degli ultimi tre anni
2. I precedenti recenti: la legge 47 del 2015.
Con la legge 16 aprile del 2015, numero 47 sono stati aggiunti ai già numerosi requisiti formali dell’ordinanza cautelare due importanti incisi: con il primo si è impedito che si possa affermare la pericolosità ex articolo 274 lettera c del codice di procedura penale sulla scorta della sola gravità astratta del reato; con il secondo è stato aggiunto l’aggettivo “attuale” alla descrizione del pericolo “concreto”.
Si è trattato, in entrambi i casi, di mera sacralizzazione nel testo dell’articolo 292 di filoni interpretativi già consolidati in giurisprudenza, senza contenuto effettivamente innovativo, ma il segnale è stato chiaro: al giudice è stato imposto un onere motivazionale assai più stringente nell’adozione dei suoi provvedimenti.
Ancora in conseguenza delle innovazioni della legge numero 47 del 2015, uno specifico passaggio della motivazione dell’ordinanza deve oggi essere dedicato alla confutazione degli argomenti a favore dell’indagato, nelle ipotesi in cui questi siano stati forniti dalla difesa: non è possibile ignorare gli allegati e le memorie della difesa, ed occorre superare la ricostruzione alternativa a quella dell’accusa laddove presente nel fascicolo.
Ancora con lo stesso provvedimento di riforma è stato imposto un obbligo di esporre le concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all’art 274 non possono essere soddisfatte con altre misure diverse da quella massimamente afflittiva.
A completamento delle modifiche in esame, è stato poi specificato che in siffatte ipotesi, non è ammesso alcun intervento integratore del Tribunale per il Riesame: anche questo principio, già affermatosi in giurisprudenza, è stato consacrato nel nuovo comma 9 dell’articolo 309 del codice di procedura penale, che per effetto delle modifiche della legge n. 47 del 2015 prevede oggi che “Il Tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l’autonoma valutazione, a norma dell’articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi o degli elementi forniti dalla difesa”.
3. Segue: la “riforma Orlando”.
Non erano ancora stati metabolizzati, nella mentalità dei giudici cautelari e nelle aule dei Tribunali, i cambiamenti ora descritti che, poche settimane orsono, la cosiddetta “riforma Orlando” ha profondamente modificato l’articolo 546 del codice di procedura penale, imponendo al giudice una vera e propria griglia motivazionale con analitica e puntigliosa indicazione delle parti in cui dovrà essere articolata la sentenza e specificazione di cosa e come motivare.
Anche in questo caso si è dunque inciso profondamente sulla discrezionalità del giudice nella redazione e nella motivazione dei suoi provvedimenti, allo scopo di limitarne veri o supposti abusi in favore della parte accusatoria.
Ecco perché se ne parla in questa sede: sbaglierebbe chi ritenesse che questo intervento legislativo, che spiega i suoi effetti sul contenuto del provvedimento conclusivo del processo ed è estraneo alla materia cautelare, sia eccentrico rispetto alla materia in esame, poiché al contrario figlio della stessa linea di tendenza di quello che lo ha preceduto e di quello che si andrà a commentare di qui a breve.
E’ infatti importante tenere presente in quale contesto il legislatore si sta muovendo nell’ultimo periodo, con coerenza di fini pur nella differenziazione degli strumenti su cui va ad incidere: il denominatore comune di tutte le riforme degli ultimi anni è quello di limitare la discrezionalità del giudice, analogamente a quanto già accaduto in occasione delle numerose modifiche al codice di procedure penale tendenti ad elidere la discrezionalità nel bilanciamento delle circostanze (modifiche, sia detto per inciso, dichiarate una dopo l’altra incostituzionali dalla Corte Costituzionale proprio per l’illegittima compromissione della discrezionalità del giudice).
In questo clima di crescente sfiducia per la funzione giurisdizionale e di progressivo ampliamento dell’intervento ri-equilibratore in funzione garantista del sistema processuale si inserisce il provvedimento sulle intercettazioni oggi in commento, che per la terza volta in pochi mesi viene ad incidere sul delicato settore della motivazione dei provvedimenti dell’articolo 125 del codice di procedura penale.
A farne le spese è, ancora, l’ordinanza di applicazione della misura cautelare, con nuove ed ulteriori modifiche agli articoli 291 e 292 del codice di procedura penale.
Questa volta il bersaglio da colpire sono i richiami contenuti nelle ordinanze cautelari ai brani delle intercettazioni, che non potranno più essere riprodotti integralmente ma solo “nelle parti essenziali” ed esclusivamente quando “è necessario”.
Va preliminarmente rilevato che il nuovo comma 2 ter dell’articolo 292 del codice di procedura penale, così come le norme esaminate in precedenza, non è importante tanto per l’impatto pratico ma per la valenza simbolica che assume e per il messaggio che si è voluto lanciare alla categoria dei magistrati giudicanti.
L’incidenza effettiva della riforma del 2015 si è rivelato infatti meno dirompente di quanto voluto (o temuto) e si può dire alla luce di questi primi anni di applicazione giurisprudenziale che le modifiche apportate al sistema non hanno comportato sostanziali cambiamenti nella tecnica di redazione delle ordinanze, limitandosi a codificare prassi virtuose già esistenti.
La maggior parte dei giudici cautelari motivavano già analiticamente sulla sussistenza delle esigenze cautelari e davano conto delle ragioni per cui non valutavano gli eventuali elementi a favore dell’indagato idonei a superare il giudizio di pericolosità (lo stesso discorso vale ovviamente per la tecnica di redazione delle sentenze).
Allo stesso modo, nessun giudice cautelare dovrebbe vedere il proprio lavoro modificato dalla necessità di adottare i nuovi criteri oggi imposti dall’articolo 292 comma 2 ter del codice di procedura penale.
Entrambe le specificazioni inserite nella norma in commento – sia quella relativa alla necessità di riprodurre solo i “brani essenziali” che quella che riguarda la limitazione dei cenni alle intercettazione ai soli casi in cui “è necessario” - sembrano infatti superflue.
La prima, che impone di riprodurre brani delle intercettazioni (solo) quando è necessario, se interpretata letteralmente, è addirittura priva di senso: prescrive al giudice di non inserire nelle proprie ordinanze elementi non necessari, sottintendendo che – fino all’entrata in vigore della norma – le ordinanze contenessero conversazioni irrilevanti ai fini del decidere.
Si fa in altri termini riferimento ad una supposta prassi che - prima di essere illegittima – costituirebbe se vera un palese controsenso.
E’ infatti evidente che il giudice, proprio come faceva prima della riforma in esame, inserirà nei propri provvedimenti cautelari solo gli elementi idonei a sostenere il proprio giudizio di pericolosità, e non elementi neutri o peggio contrari alla tesi che si vuole sostenere.
Viene da chiedersi se fosse davvero necessario impedire per legge al giudice per le indagini preliminari di riportare nell’ordinanza in cui è tenuto a motivare perché è necessario privare taluno della libertà personale elementi relativi alla vita privata dell’indagato o ad altre circostanze inutili ai fini dell’adozione del provvedimento stesso ma eventualmente in grado di danneggiarlo da un punto di vista politico o extragiuridico, come se nel momento in cui taluno viene ristretto in carcere perché accusato di un grave reato la sua preoccupazione maggiore sia quella di non apparire pubblicamente come fedifrago o irriguardoso nei confronti degli alleati politici.
Identiche considerazioni possono essere fatte per l’altra significativa modifica contenuta nella norma in esame, secondo cui dovranno essere riportati solo “i brani essenziali” delle intercettazioni e non più le conversazioni per esteso.
La formulazione della norma appare ambigua, poiché nella prassi è molto raro che nelle ordinanze si riportino conversazioni per intero: le conversazioni telefoniche intercettate durano normalmente diversi minuti, sicché soltanto le frasi importanti o i brani rilevanti delle conversazioni sono selezionati per essere riportati nelle ordinanze (ed il discorso vale a maggior ragione per le conversazioni ambientali, che possono durare anche ore).
Da questo punto di vista, ancora una volta, si potrebbe concludere che nulla è cambiato, e che la norma non fa che prescrivere al giudice di non riportare saluti, commenti sula salute degli interlocutori o altri argomenti del tutto estranei al delitto di cui ci si occupa.
Tuttavia, è evidente anche in questo caso il valore simbolico e suggestivo cui sarà difficile sottrarsi: nella scelta di cosa è essenziale e cosa superfluo il giudice si sentirà chiamato ad un vaglio più rigoroso, anche se manca qualsiasi criterio di riferimento sul punto nella norma del comma 2 ter di nuovo conio.
La genericità della norma è comunque tale che può concludersi che se questo inciso doveva servire a limitare eventuali arbitri, è forte il rischio di un intervento inutile se non controproducente.
Peraltro, la scelta di ricopiare nella motivazione dell’ordinanza intere conversazioni o lunghi tratti delle stesse, ad avviso di chi scrive, è da sempre un utile strumento per dare contezza del contesto in cui una conversazione che si ritiene avere valore indiziante è stata pronunciata, fornendo a chi legge uno strumento diretto e facile di confronto, salvo poi il doveroso commento e l’interpretazione del giudice, tenuto a spiegare perché ritiene la conversazione indiziante ed a contestualizzarla rispetto al giudizio di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.
L’indicazione che sembra provenire dal legislatore, di sostituire tale prassi con il mero commento indiretto rischia di impedire alla difesa ed al Tribunale per il Riesame la verifica diretta (o di renderla comunque più disagevole) della correttezza del lavoro interpretativo del giudice, con conseguente compromissione del contraddittorio.
4. Le modifiche in tema di intercettazione
La disciplina delle intercettazioni ha subito con il provvedimento in esame profonde e radicali modifiche, che incidono sensibilmente anche sul lavoro del giudice per le indagini preliminari.
Come si è visto, l’attuale assetto voluto dal legislatore per contemperare le esigenze investigative con quelle della privacy degli indagati e del diritto all’informazione prevede un’immediata distinzione tra le conversazioni rilevanti e quelle irrilevanti, ed il tempestivo e subitaneo abbandono di quelle vietate (come le conversazioni tra indagato e difensore).
Il vaglio, in precedenza affidato al giudice, è oggi demandato in maniera preponderante alla polizia giudiziaria, che dovrà immediatamente selezionare le conversazioni irrilevanti e quelle vietate evitando di procedere alla trascrizione per impedire finanche l’esistenza di un supporto fisico facilmente consultabile e divulgabile di conversazioni che sono destinate a non essere utilizzate nel procedimento penale.
Se è vero infatti che, a norma dell’articolo 267, quarto comma del codice di procedura penale, la polizia giudiziaria redigerà preventivamente delle annotazioni “sui contenuti delle comunicazioni e conversazioni”, tale annotazione non pare tranquillizzante dal punto di vista del rispetto del contraddittorio.
Ciò in primo luogo perché, a differenza di quanto accadeva in passato, una volta che le conversazioni descritte nell’annotazione solo sommariamente siano state giudicate irrilevanti o illegittime, delle stesse non si conserverà alcuna traccia se non l’anonima indicazione dell’ora della conversazione e degli interlocutori, destinata a finire in un elenco spesso composto da centinaia di annotazioni del tutto simili: di fatto, recuperare ex post la conversazione per rivederne la rilevanza alla luce degli ulteriori sviluppi di indagine (che spesso forniscono informazioni e delucidazioni sul contenuto di una conversazione che in un primo momento poteva sembrare irrilevante) diventerà impossibile.
O il Pubblico Ministero riesce a capire, “in corsa” ed allo stato degli atti, basandosi su un’annotazione che può anche essere poco chiara o redatta male, se una conversazione merita di essere sottratta all’oblio o non sarà più possibile recuperarla, anche se questa si dovesse rivelare ex post decisiva ai fini dell’affermazione della responsabilità (e perché no, dell’innocenza) dell’indagato.
Non stupisce dunque che su questo punto della riforma la stragrande maggioranza dei magistrati abbia appuntato i propri strali ed espresso le proprie preoccupazioni.
A tali difficoltà operative per la magistratura inquirente e giudicane si sommano quelle, ancora più rilevanti, per i difensori, che saranno costretti a cercare eventuali conversazioni favorevoli al proprio assistito e non trascritte nell’elenco anonimo di cui si è detto.
Al termine delle operazioni di intercettazione, sempre che non chieda al giudice l’autorizzazione al ritardato deposito (sul punto nulla è cambiato, a parte lo spostamento fisico della norma dai commi 5 e 6 dell’articolo 268 del codice di procedura penale al nuovo articolo 268 bis) il Pubblico Ministero formerà l’elenco delle conversazioni rilevanti e lo depositerà in segreteria dando avviso alla difesa, cui è concesso un (breve) tempo per esaminarle.
Se le intercettazioni sono state utilizzate per un’ordinanza cautelare, saranno poi acquisite de plano al fascicolo per le indagini preliminari.
In caso contrario, il Pubblico Ministero dovrà chiedere al Giudice per le indagini preliminari l’autorizzazione all’acquisizione.
In questa fase si aprirà un contraddittorio con la difesa, che potrà – esaminate le conversazioni e l’elenco del Pubblico Ministero – chiedere al Giudice l’eliminazione di alcune conversazioni dall’elenco presentato dal Pubblico Ministero, o l’inserimento di ulteriori conversazioni che il Pubblico Ministero non aveva selezionato.
E’ dunque stata prevista una netta distinzione tra il momento del deposito delle conversazioni rilevanti e quello dell’acquisizione delle stesse.
L’acquisizione è preceduta dal vaglio necessario da parte del Giudice per le Indagini preliminari, che assume un ruolo inedito rispetto al passato: non esiste più la possibilità che i risultati delle intercettazioni transitino nel fascicolo del Pubblico Ministero senza il filtro dell’organo giudicante.
Se le conversazioni sono state utilizzate per l’adozione di una misura cautelare, come si è etto in precedenza, il procedimento incidentale di acquisizione non è necessario: il vaglio è infatti già avvenuto al momento dell’adozione della misura cautelare, e la selezione delle conversazioni è stata fatta a monte dal Pubblico Ministero e dal Giudice nella fase di redazione rispettivamente della richiesta e dell’ordinanza cautelare.
Naturalmente, se il Pubblico Ministero vorrà utilizzare ulteriori conversazioni rispetto a quelle già utilizzate in sede cautelare – sia che le conversazioni fossero già state registrate e non utilizzate, sia nel caso in cui siano state ascoltate e registrate successivamente – il ricorso alla procedura prevista dall’articolo 268 ter, commi due e seguenti sarà necessario, almeno per quelle conversazioni ulteriori non vagliate in precedenza.
Al di fuori del caso in cui siano state tutte già utilizzate per una misura cautelare, le conversazioni dovranno dunque essere acquisite dal giudice per le indagini preliminari, che per esplicita previsione di legge (articolo 268 quater, sesto comma) è individuato nello stesso che ha autorizzato le operazioni di intercettazioni.
Questa specificazione è necessaria per rendere esplicito che la fase di acquisizione non può essere più rinviata non solo alla fase dibattimentale ma nemmeno all’udienza preliminare, e dovrà essere inserita prima della conclusione delle indagini preliminari (prima cioè che il giudice che ha concesso l’autorizzazione alle intercettazioni consumi la sua competenza sul fascicolo).
Il Giudice delle indagini preliminari dunque riceverà l’elenco delle conversazioni rilevanti dal Pubblico Ministero, con le ulteriori eventuali osservazioni della difesa, che come detto potrà chiedere l’inserimento di conversazioni ulteriori o l’esclusione di alcune o delle conversazioni dell’elenco del magistrato inquirente.
Per adempiere al compito di valutazione delle conversazioni rilevanti il giudice ha a disposizione due procedimenti, tra i quali sceglierà in assoluta libertà:
potrà emettere un’ordinanza di acquisizione valutando gli elenchi delle parti ed eventualmente procedendo all’ascolto delle conversazioni in solitudine: in questo caso il contraddittorio sarà esclusivamente cartolare (“Decorsi cinque giorni dalla presentazione delle richieste, il giudice dispone con ordinanza, emessa in camera di consiglio senza l’intervento del pubblico ministero e dei difensori, l’acquisizione delle conversazioni e comunicazioni indicate dalle parti”: così recita il primo comma del nuovo articolo 268 ter del codice di procedura penale);
in alternativa, potrà aprire un procedimento camerale alla presenza delle parti; in questo caso, si apre una fase incidentale in contraddittorio eventuale che si modella naturalmente nelle forme previste dall’articolo 127 del codice di procedura penale (“quando necessario, l’ordinanza è emessa all’esito dell’udienza fissata per il quinto giorno successivo alla scadenza del termine indicato al comma 1, con tempestivo avviso al pubblico ministero e ai difensori”: articolo 268 ter, secondo comma).
La scelta tra i due procedimenti sopra descritti è del tutto libera e, in assenza di previsioni contrarie, deve ritenersi insindacabile: sostanzialmente il G.I.P. sceglierà se assumere la sua decisione in ordine all’acquisizione delle intercettazioni da inserire nel fascicolo del Pubblico Ministero basandosi solo sulle richieste scritte delle parti o dopo averle chiamarte a partecipare al momento valutativo.
E’ evidente che, in questo secondo caso, le parti avranno un ruolo attivo, potendo chiedere l’ascolto in contraddittorio di una o più conversazioni e ribadire al termine del procedimento camerale le proprie convinzioni nella (necessaria) discussione che concluderà la fase del contraddittorio.
Verosimilmente, il Giudice sceglierà la procedura più garantita chiamando le parti a partecipare al contraddittorio in caso di dubbio sulla necessità di acquisire una o più delle conversazioni indicate dalle parti, e procederà de plano nei casi meno controversi: l’adozione del procedimento camerale dunque seguirà, almeno idealmente, il procedimento senza la presenza delle parti indicato dal secondo comma dell’articolo 268 quater.
All’esito della procedura di acquisizione, qualora il Giudice dovesse disporre l’acquisizione di conversazioni richieste dal difensore e non presenti nell’elenco del Pubblico Ministero, dovrà esserne disposta la trascrizione, che sarà eseguita a cura di quest’ultimo su ordine del Giudice per le Indagini preliminari.
Il procedimento di acquisizione diviene dunque necessario e non più solo eventuale come era previsto per la vecchia “udienza stralcio”, formalmente abolita: questo dovrebbe comportare un aggravio del carico di lavoro degli uffici del G.I.P., ma sicuramente garantisce un maggior rispetto del contraddittorio, almeno nella fase finale.
Non va infatti dimenticato che le conversazioni il cui inserimento è sottoposto al vaglio del Giudice per le indagini preliminari sono esclusivamente quelle che hanno passato il vaglio preliminare di rilevanza e legittimità che la nuova normativa demanda alla polizia giudiziaria, anche se al pubblico ministero è formalmente rimasto un potere di controllo che pare però di difficile attuazione pratica dovendo essere esercitato su conversazioni che, laddove non trasmesse dalla polizia giudiziaria, dovranno essere individuate nel mare di quelle indicate solo per numero e data senza alcuna specificazione o indicazione.
Può dunque concludersi che dal punto di vista del giudice per le indagini preliminari, al di là delle possibili difficoltà gestionali dovute all’aggravio del lavoro in una situazione di cronica carenza di organico e di risorse, il giudizio sulla nuova fase di acquisizione delle intercettazioni è senz’altro positivo, pur con le riserve dovute al fatto che la “partita” sulla scelta delle conversazioni rilevanti si è già giocata in un momento precedente, al di fuori di ogni tipo di contraddittorio.
*contributo già pubblicato sul volume “Nuove norme in tema di intercettazioni – Tutela della riservatezza, garanzie difensive e nuove tecnologie informatiche”, a cura di Glauco Giostra e Renzo Orlandi, ed. GIAPPICHELLI EDITORE