Sommario: 1. Follow the money: il filo di Arianna nel libro di Andrea Apollonio - 2. Il grimaldello dei capitali illeciti: la leva mafiosa sull’economia legale- 3. Un mosaico normativo frammentato: la critica ad un sistema senza regia unitaria - 4. Tre questioni nodali per capire il riciclaggio secondo Apollonio - 4.1. Il “metodo mafioso” come chiave di lettura del riciclaggio - 4.2. Il fine di agevolazione mafiosa come volto soggettivo del riciclaggio - 4.3. Riciclatore o mafioso? - 5. Riciclaggio, cyberlaundering e cripto-denaro: l’Europa alza l’asticella - 6. Diritto e politica criminale nel contrasto al riciclaggio dei capitali mafiosi.
1. Follow the money: il filo di Arianna nel libro di Andrea Apollonio
Il fenomeno del riciclaggio mafioso mi ha sempre colpito per la sua ambiguità sistemica: è insieme proiezione di potere – non solo finanziario, ma anche sociale e politico – e sofisticato strumento di invisibilità, capace di sfumare i confini dell’illegalità. Leggendo la monografia di Andrea Apollonio su “Il riciclaggio dei capitali mafiosi", ho trovato non soltanto una critica puntuale alle carenze strutturali della risposta repressiva, ma anche un insieme coerente di soluzioni esegetiche e proposte di politica criminale. Queste ultime contribuiscono a delineare un moderno filo di Arianna, capace di guidare l’interprete nel labirinto del paper trail degli investimenti mafiosi e di rafforzare gli strumenti di contrasto all’infiltrazione criminale nell’economia legale.
Ebbene, i capitali di provenienza mafiosa, la loro accumulazione, ripulitura e reinvestimento – fin dalle note intuizioni investigative del giudice Falcone del “follow the money” – svelano una fenomenologia cangiante e innovativa, che non sempre trova corrispondenti innovazioni normative capaci di intercettare le nuove dinamiche criminali, con l’ulteriore aggravante che le corti si sono spesso polarizzate su contrasti ermeneutici, indebolendo la coerenza della risposta penalistica e l’efficacia degli strumenti repressivi.
L’opera si addentra nelle zone d’ombra del riciclaggio, restituendone un’immagine nuova e complessa: non è solo dissimulazione dei reati, ma una strategia funzionale all’esistenza stessa delle consorterie mafiose. Dopo numerosi contributi su varie problematiche penalistiche, in questo nuovo e approfondito studio, l’Autore intreccia diritto e contesto, teoria e prassi, enucleando – anche in chiave de iure condendo – i contorni di un possibile “statuto penale del riciclaggio dei capitali mafiosi”. Ne emerge un affresco inedito, in cui le trame giuridiche si intersecano con le dimensioni economiche, sociali e culturali del fenomeno, offrendo al lettore non solo strumenti analitici, ma anche chiavi di lettura per anticipare le metamorfosi della criminalità mafiosa.
L’ampiezza di visuale con cui viene affrontata la materia si evince già dalla struttura bipartita impressa allo studio.
La prima sezione è dedicata ad un’analisi sistematica della dimensione criminologica dell’accumulazione e della circolazione dei capitali di provenienza illecita, e segnatamente di stampo mafioso. Tale indagine è condotta tenendo conto del contesto sociale, individuato quale humus favorevole alla proliferazione delle economie criminali, soprattutto in epoche segnate da crisi economico-finanziarie sistemiche. Dopo un’analisi sull’evoluzione del quadro normativo internazionale ed europeo, si offre un’analisi, anche comparatistica, degli elementi strutturali delle fattispecie incriminatrici italiane in materia di riciclaggio (art. 648-bis, art. 648-ter, art. 648-ter.1, art. 512-bis). Il proposto approccio di diritto comparato si rivela decisivo nella comprensione dei profili problematici della normativa nazionale, peraltro nella logica di un fenomeno tendenzialmente transnazionale, in cui è necessario un ‘dialogo’ tra le giurisdizioni domestiche dei vari Paesi.
La seconda parte dell’opera rappresenta – nella logica dello sviluppo argomentativo offerto – una naturale prosecuzione della precedente. Infatti, una volta definito il campo d’indagine, l’indagine si articola attorno all’osmosi concettuale e normativa tra due ambiti distinti ma interconnessi: da un lato, il reato di riciclaggio, declinato nelle varie fattispecie di reimpiego, intestazione fittizia e la più recente figura delittuosa dell’autoriciclaggio e, dall’altro, il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, caratterizzato dal “fine” e dal “metodo” nonché per la peculiare attenzione alla pericolosità dell’autore più che alla sola tipicità del fatto di reato.
Attraverso una riflessione metodologica – costantemente accompagnata da attente soluzioni esegetiche – sui criteri di imputazione soggettiva, sulla finalità del riciclaggio e sulla riconducibilità all’agire mafioso in termini di struttura e di rapporti di specialità – passando dai recenti approdi giurisprudenziali – si giunge all’elaborazione di uno statuto penalistico specifico del riciclaggio mafioso che tenga conto delle peculiarità del contesto criminale organizzato.
2. Il grimaldello dei capitali illeciti: la leva mafiosa sull’economia legale
Le organizzazioni mafiose condividono molti aspetti in comune con i prestatori “professionali” di servizi di riciclaggio: si attraggono a vicenda e creano degli spazi in cui il modus operandi e gli obiettivi di profit-making tendono a coincidere. Sotto tale prospettiva deve essere intesa l’intera opera: intersezioni fenomenologiche, difficoltà ermeneutiche e, in definitiva, deficit di contrasto.
Il riciclaggio dei capitali illeciti si caratterizza per una struttura metagiuridica e transnazionale, dotata di una duttilità operativa che consente di mimetizzare i capitali di provenienza illecita all’interno del sistema economico legale, rendendoli difficilmente tracciabili e assoggettabili a sanzione penale. La riflessione di Apollonio approda a una constatazione di carattere politico-istituzionale: lo Stato italiano ha progressivamente perduto la sua centralità nella regolazione dell’economia legale in determinati territori, lasciando campo aperto alle organizzazioni mafiose, le quali — tramite l’immissione di capitali illeciti — assumono un ruolo “sostitutivo” nel sostegno alle imprese e nella gestione di flussi finanziari. Tale meccanismo, che – come evidenziato – si è intensificato durante la crisi pandemica, produce un fenomeno gravemente distorsivo: l’economia legale finisce per divenire una piattaforma di “lavaggio” per le rendite mafiose, e le imprese oneste, non beneficiando degli stessi canali di credito né degli stessi margini di rischio, vengono estromesse o marginalizzate. Non è forse un paradosso che interroga la legittimità dello Stato? Eclatante, a mio giudizio, appare il cortocircuito tra legalità formale e legalità sostanziale: laddove le mafie riescono ad acquisire consenso sociale tramite l’uso (anche “solidaristico”) dei capitali illeciti, lo Stato perde legittimità agli occhi di intere fasce sociali, con implicazioni dirompenti sulla tenuta democratica del Paese.
Per un verso, le dinamiche dell’infiltrazione mafiosa nell’economia presentano caratteristiche evolutive e difficilmente riconducibili a schemi rigidi. La ricaduta in concreto è che, in sede di accertamento giudiziario, le diverse gradazioni dell’infiltrazione vengono confuse o sovrapposte: in questi slittamenti concettuali si insinuano le ambiguità normative e il rischio di un’applicazione normativa disomogenea. In questa situazione, si potrebbe ipotizzare una tipizzazione delle principali relazioni intercorrenti fra le organizzazioni criminali e l’economia legale, secondo un possibile schema tripartito: a) a volte, la criminalità organizzata impone con la violenza o il potere intimidatorio (la c.d. “riserva di violenza”, su cui infra par. 4.1) il proprio volere nei confronti dell’imprenditore legale, imponendogli un costo o un peso; b) altre volte, invece, il professionista-riciclatore persegue obiettivi di arricchimento, approfittando del vantaggio competitivo di collaborare con la criminalità organizzata, rimanendone però estraneo; c) infine, la criminalità organizzata penetra il sistema economico legale, minacciando la stabilità del mercato e la concorrenza tra i competitor legali: in quest’ultimo profilo, si avvererebbe la tesi dell’Autore secondo cui il riciclatore di proventi mafiosi, ora intraneo all’associazione, sarebbe da considerarsi autoriciclatore, anche laddove i beni oggetto delle attività di ripulitura provengano da delitti-fine ai quali egli non abbia partecipato, dacché questi sono pur sempre una esplicazione operativa della mafia stessa. Secondo l’Autore, con riguardo a questo particolare profilo che lega il delitto-scopo all’associazione (recte: le ricchezze prodotte dagli associati alla cosca), sussisterebbe una sorta di rapporto di accessorietà per cui il provento illecito sarebbe da considerarsi in re ipsa (seppur con alcuni temperamenti su cui infra) proveniente dall’associazione.
Questa impostazione, a mio avviso, consente di sciogliere quel nodo giurisprudenziale che da anni affatica l’interprete: l’erronea contrapposizione tra condotta ‘interna’ all’associazione e condotta ‘ulteriore’. In effetti, laddove il patrimonio generato dall’associazione sia impiegato da suoi partecipi, non si tratta più di distinguere il prima e il dopo, ma di cogliere l’unitarietà funzionale dell’agire mafioso, nella sua estrinsecazione economico-finanziaria.
Per altro verso, il reato di riciclaggio emerge come un reato comune a soggettività ristretta, che può essere commesso da chiunque, purché però non abbia partecipato alla commissione del Vortat. Secondo tale impostazione, il riciclaggio sarebbe un post factum non punibile del reato presupposto, se commesso dallo stesso soggetto: la repressione del fatto che lo presuppone elimina il disvalore complessivo e il bisogno di repressione. L’attività di riciclaggio sarebbe un naturale sviluppo della condotta precedente, mediante il quale il soggetto si assicura il vantaggio economico conseguito dal reato presupposto. Tuttavia, l’impossibilità di incriminare il riciclatore, in quanto autore o concorrente nel reato base, potrebbe comportare una vanificazione dello strumento penale, oltre a determinare vuoti di tutela, allorquando la stessa clausola si relazioni con i reati di stampo associativo, come sancito dalla sentenza “Iavarazzo” delle Sezioni Unite. L’importanza della sentenza – evidenziata dall’autore “con riferimento alla dimensione economica dell’associazione mafiosa” (p. 202) – sta nel fatto di avere riconosciuto l’operatività della clausola di non esclusione della punibilità nei confronti degli associati e dei concorrenti esterni che commettano condotte di riciclaggio o reimpiego in quanti l’associazione stessa è essa stessa in grado di generare utilità illecite. Tale ricostruzione, sottolinea Apollonio, non vale però per la condotta di autoriciclaggio, introdotto solo dopo le Sezioni Unite e sprovvista della clausola di riserva: d’altronde, ai fini di un concorso apparente di norme sarebbe necessaria un’identica realtà fattuale e tale sovrapposizione non vi sarebbe per l’autoriciclaggio per cui non risulterebbe violato il divieto di bis in idem.
L’autoriciclaggio (art. 648-ter.1), infatti, sanziona e tipizza il diverso comportamento consistente nella re-immissione nel circuito dell’economia legale di beni, attraverso modalità in concreto idonee ad ostacolare la identificazione della loro provenienza, secondo una qualche funzionalizzazione decettiva. Pertanto, da un lato, il nucleo di disvalore è in esso contenuto ed esaurito e, dall’altro, l’agente non è affatto ‘obbligato’ a tenere la condotta tipica, ben potendo astenersi da condotte di re-immissione. Questo è il vero core del reato di autoriciclaggio, che lo distingue, definendone le peculiarità, dal corrispondente reato di money laundering. Se si riflette approfonditamente sulla rilevanza della modalità della condotta, a mio avviso, è agile avvedersi che questa consente, in ultima istanza, di evitare sovrapposizioni con il reato presupposto.
Nei termini che precedono può predicarsi un concorso tra reati associativi e reato di autoriciclaggio, come suggerito anche dall’Autore.
3. Un mosaico normativo frammentato: la critica ad un sistema senza regia unitaria
La tesi che emerge dall’opera di Apollonio – capace di coniugare rigore teorico, consapevolezza empirica e senso critico – è chiara: l’Italia ha conosciuto il fenomeno del riciclaggio dei capitali mafiosi nella sua dimensioni più insidiosa e subdola, quella dell’infiltrazione finanziaria nei circuiti dell’economia legale, e al contempo necessita di una riforma strutturale del quadro repressivo, che sia in grado di raccordare le esigenze della prevenzione economica, le direttiva euro-unitarie e le sfide poste dall’evoluzione delle mafie imprenditrici (i.e. cyberlaundering). Una delle critiche più serrate, ma al tempo stesso metodicamente argomentate, è rivolta al carattere frammentario e privo di coerenza sistemica in materia di riciclaggio e autoriciclaggio, in particolare quando si interseca con il delitto associativo mafioso. Il mosaico normativo – artt. 416-bis, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 e 512-bis – si presenta come un reticolo eterogeneo di norme prive di una regia unitaria, spesso affastellate in momenti riformatori scoordinati, rispondenti a esigenze contingenti più che a un disegno strategico. In tale contesto, si è determinata una deriva preoccupante: il diritto vivente si è trovato a supplire a un vuoto normativo, esercitando una funzione sostanzialmente para-legislativa, con inevitabili riflessi sul piano della certezza del diritto e dell’effettività delle tutele. Condivisibile, dunque, la critica dell’Autore sulla “scarsa resa sistematica” (p. 456) del principio di specialità: l’assenza di una razionalizzazione tra le fattispecie generali e tra queste e le figure aggravate o satellite produce una sovrapposizione normativa che indebolisce l’efficacia delle incriminazioni, aprendo margini interpretativi ambigui e spazi di impunità potenziale.
4. Tre questioni nodali per capire il riciclaggio secondo Apollonio
Nella ricchezza di spunti che offre l’opera di Apollonio, vorrei soffermarmi sulle questioni che maggiormente stimolano l’interesse dell’interprete e su cui interessanti sono le soluzioni esegetiche dell’Autore: il c.d. “metodo mafioso” ex 416-bis, comma 3; il fine dell’agevolazione mafiosa ex art. 416-bis.1; e, infine, la rilevanza dell’intraneità (o estraneità) alla societas sceleris della condotta del riciclatore. Tematiche analizzate con dovizia di dettagli e spunti critici nella seconda parte dell’opera che segna il preludio alle conclusioni e alle proposte riformatrici dell’Autore nel capitolo finale.
4.1. Il “metodo mafioso” come chiave di lettura del riciclaggio
Una premessa ineludibile al ragionamento sviluppato è quella secondo cui “il riciclaggio dei capitali mafiosi si confronta, anzitutto, col metodo mafioso: con il tipo di mafia che opera a monte, con i requisiti di partecipazione ad essa e con le forme di manifestazione all’esterno” (p. 283-284). Il “metodo” mafioso, che connoterebbe la condotta riciclatoria sottesa all’indagine in esame, si manifesta sia sul crinale giurisprudenziale, laddove emergerebbero recenti arresti in cui il metodo sarebbe riconducibile anche alle attività criminali di associazioni non tradizionali, nonché su quello criminologico, che – una volta prestato lo strumentario terminologico per la descrizione normativa della fattispecie incriminatrice, secondo i tre parametri di intimidazione, assoggettamento e omertà – consente di qualificare anche quelle che vengono definite dall’Autore come mafie giuridiche. E tale distinzione, a ben vedere, tra mafie tradizionali e mafie giuridiche “assume un grande peso empirico-criminologico, essendo il riciclaggio un predicato connaturato solo alle prime, per ragioni che risalgono alla loro stessa conformazione politica” (p. 244), ossia alla intrinseca capacità di infiltrare il potere politico-istituzionale locale, ed è questa “vocazione politica a rendere imprescindibili i meccanismi di riciclaggio nell’ambito delle mafie tradizionali”. In questa riflessione si annida, a mio avviso, uno dei nodi più delicati dell'intera opera: comprendere la funzione del riciclaggio come indice di mafiosità sistemica e non solo come strumento accessorio. La tesi dell’Autore induce a riflettere su quanto il riciclaggio – più della violenza esplicita – sia oggi la vera cifra della pervasività mafiosa: silenziosa, adattiva, formalmente legale.
Il successivo momento riciclatorio sarebbe, ad avviso dell’Autore, soltanto eventuale per le mafie giuridiche o non tradizionali, mentre al contrario sarebbe “una delle più efficaci cartine tornasole della reale essenza (criminologica, in prima battuta, con ripercussioni sul piano normativo) dell’associazione mafiosa” (p. 249). In tal senso, appare opportuno l’approfondimento offerto sulla vicenda giudiziaria di “Mafia Capitale”, che – al netto delle note difficoltà qualificatorie per l’imputazione del reato di cui all’art. 416-bis – dimostra come nel momento in cui si riqualifica il fatto presupposto – allontanandosi dall’associazione mafiosa – anche il delitto di riciclaggio dovrà assumere una diversa conformazione. E così, sulla scorta delle pronunce giurisprudenziali richiamate nell’opera, si enucleano quelle estrinsecazioni normativamente caratterizzanti la mafia, sia nella sua accezione tradizionale che in quella giuridica, tra cui la c.d. “riserva di violenza”, che sottende sia una forma statica – che non si serve di violenza o minaccia espresse, tipica della mafia tradizionale – che una forma dinamica: di quest’ultima si avvalgono sia le mafie politico-amministrative che quelle autoctone, entrambe incapaci di esprimere un controllo totalitario, ma soltanto selettivo sul sistema di riferimento, da un punto di vista economico (per quelle politico-amministrative) e territoriale (per quelle autoctone).
E allora le vicende giudiziarie suggeriscono una qualificazione rafforzata dell’associazione mafiosa (ne è, ancora una volta, esempio lampante il filone di Mafia Capitale), che deve in qualche modo manifestarsi, sia nel suo aspetto interno che esterno. Ed è qui che il momento riciclatorio subisce – a cascata – una diversa impostazione applicativa, a seconda che si tratti di associazione semplice o di associazione mafiosa: diverso sarebbe il titolo di reato se il riciclatore sia partecipe all’associazione – partecipazione da accertare secondo rigidi schemi probatori ossequiosi del principio di materialità e offensività – ovvero sia estraneo; e ci si chiede, infine, se il delitto di riciclaggio, qualora commesso da affiliati e in relazione a ricchezze generate dall’associazione mafiosa stessa, sia esso stesso caratterizzato dal metodo mafioso e, in tal senso, secondo Apollonio, “appuntare sulla condotta riciclatoria il metodo mafioso può costituire un ottimo viatico per la piena prova della derivazione del bene dall’associazione”, con la conseguenza di un necessario quid pluris di onere probatorio per la riconducibilità della condotta di riciclaggio alla mafia, che garantisce, però, in ultima istanza, un “più saldo legame tra l’una e l’altra” (p. 281).
4.2. Il fine di agevolazione mafiosa come volto soggettivo del riciclaggio
Se, tuttavia, il metodo rimane un predicato soltanto eventuale alla condotta di riciclaggio, il fine dell’agevolazione si delinea come predicato necessario, secondo le indicazioni offerte dalla sentenza delle Sezioni Unite “Chioccini” in ordine alla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1. A tal proposito, vi sarebbe “una coincidenza quasi perfetta tra alcuni elementi di struttura della circostanza aggravante e delle fattispecie riciclatorie, ed in particolare con il requisito dell’oggettiva idoneità della condotta e della partecipazione psicologica al reato”, se è vero, come è vero, che il delitto di riciclaggio gemma da quella condotta di favoreggiamento (una sorta di Anschlussdelikt, come nel sistema tedesco) che il legislatore storico aveva inteso reprimere con la formulazione dell’art. 648-bis.
Ulteriori analogie sono evidenziate dall’Autore, il quale – nel richiamare la sentenza “Chioccini” che stabilisce che la circostanza di cui all’art. 416-bis.1 richiede un dolo intenzionale, pur potendosi comunicare ai correi, se “consapevoli” del fine agevolativo perseguito dal concorrente – ritiene che il dolo del riciclaggio sia, a tal fine, “speculare” in quanto “importa la rappresentazione e volontà di compiere operazioni idonee al concreto occultamento dell’origine delittuosa del bene, accompagnata alla consapevolezza dell’origine delittuosa; la condotta del riciclatore non può che essere tesa a favorire l’occultamento e l’impunità per il reato-presupposto. Rassegnando alcune conclusioni ancora interlocutorie, l’Autore precisa che “il riciclaggio di capitali, quando entra in contatto con beni d’origine mafiosa, e per essere marchiato con la circostanza del fine […] vede arricchirsi il proprio gradiente soggettivo: dall’abbracciare genericamente la provenienza delittuosa (senza che debba esservi la piena cognizione dello specifico reato-presupposto) si passa – più selettivamente – alla necessaria consapevolezza dell’origine mafiosa del bene, sia per l’agente principale sia per il correo, che si deve – anch’esso – rappresentare gli esiti dell’azione riciclatoria”.
4.3. Riciclatore o mafioso?
L’apice del ragionamento avviene allorché l’Autore pone l’attenzione sulla posizione giuridica del riciclatore – passando dal piano criminologico a quello normativo – rispetto al delitto associativo mafioso. D’altronde, evidenti sono le ricadute in termini di trattamento sanzionatorio che, a ben vedere, varia notevolmente a seconda che il riciclatore sia intraneo o estraneo alla mafia, e che si versi nel campo del riciclaggio o dell’autoriciclaggio, oppure di altre norme, solo apparentemente più marginali. Ed è questo il quesito che stimola l’indagine, che – lungi da avere mere finalità speculative – intende chiarire, a valle, quale sia l’accertamento da condurre in sede giudiziaria.
A fronte di una polarizzazione esegetica – che contrappone una tesi autonomistica, secondo cui la condotta di riciclaggio non implica alcuna forma di compartecipazione alla consorteria mafiosa e una diversa tesi che sottenda una funzionalità sistemica del riciclaggio rispetto alla perpetuazione dell’attività mafiosa – l’Autore invita ad una lettura prudente, fondata su una chiara distinzione tra le diverse figure soggettive che possono interagire con l’associazione mafiosa: il partecipe, il concorrente esterno e il semplice contiguo. Egli segnala i rischi insiti in una espansione incontrollata dell’ambito applicativo dell’art. 416-bis, che rischierebbe di produrre effetti ipertrofici e lesivi dei principi costituzionali di legalità, tipicità e offensività. Solo una prova effettiva, puntuale e rigorosa di una partecipazione consapevole, stabile e funzionale al sodalizio mafioso può giustificare il superamento della linea di demarcazione tra riciclaggio e associazione mafiosa. In assenza di tale prova, l’inquadramento del riciclatore come partecipe o concorrente sarebbe frutto di una forzatura interpretativa inammissibile in un ordinamento di diritto penale liberale, fondato sul principio del divieto di analogia in malam partem.
Sul crinale delle tesi antitetiche circa l’intraneità del riciclatore si innesta, dunque, la tesi secondo cui bisognerebbe muovere dalla constatazione che i proventi dei delitti-scopo sarebbero elementi integranti del patrimonio associativo, attesa “l’impossibilità di distinguere, tra tutte le ricchezze dell’associazione riciclate o reimpiegate, quelle riconducibili ad essa direttamente o per il tramite dei delitti-fine” (p. 331). Ne conseguirebbe una imputazione per autoriciclaggio per colui il quale è partecipe al sodalizio e pone in essere quelle attività decettive di investimento finanziario (i.e. infiltrazione criminale nell’economia). Ciò in quanto l’art. 648-ter.1 non contempla alcuna clausola di riserva ed è “destinato principalmente proprio al contenimento dei processi riciclatori posti in essere dalle mafie”, anche se, per quanto affascinante, tale ricostruzione stride con la ratio legis della riforma del 2014, che sottendeva la necessità contingente di recuperare i capitali illeciti detenuti all’estero.
5. Riciclaggio, cyberlaundering e cripto-denaro: l’Europa alza l’asticella
La dimensione transnazionale del fenomeno non può, tuttavia, essere trascurata e ne è testimonianza l’attenzione dell’Autore, il quale – con il desiderio di imprimere massima concretezza alla sua opera – tratta l’argomento nel capitolo finale, facendo opportuni riferimenti all’evoluzione legislativa euro-unitaria.
La tematica del contrasto al fenomeno riciclatorio è ormai stabilmente tra le priorità nell’agenda del legislatore europeo e la ricognizione normativa del libro andrebbe ulteriormente ampliata, laddove ci si avvede che l’intera disciplina è stata ulteriormente riformata e aggiornata con il c.d. AML Package, che contiene la Sesta Direttiva Antiriciclaggio (AMLD6), nonché un Regolamento (AMLR), che ha l’ambizioso progetto di creare una regia unitaria nel contrasto al riciclaggio con il compito di coordinare e governare tutti i compiti e i poteri delle FIU nazionali (ossia delle Unità di informazione finanziaria nazionali; autorità, che, in Italia, opera presso la Banca d’Italia) e ciò attraverso l’istituzione di una nuova Autorità europea antiriciclaggio (AMLA), con sede a Francoforte, che sta per diventare operativa proprio in queste settimane.
Tra le maggiori preoccupazioni che hanno spinto il legislatore europeo ad innovare la disciplina vi è l’espansione dei mercati virtuali, delle cripto-attività e del connesso cyberlaundering – su cui, su uno speculare versante, è stato da ultimo introdotto il Regolamento MiCA (Market in Crypto Asset Regulation) – alla luce del fatto che “i fornitori di servizi di cripto-attività e le piattaforme di crowdfunding sono esposti all’uso improprio di nuovi canali per la circolazione di denaro illecito e si trovano nella posizione ideale per individuare tali movimenti e mitigare i rischi. L’ambito di applicazione della legislazione dell’Unione dovrebbe pertanto essere esteso a tali soggetti, in linea con le norme del GAFI in materia di obblighi di segnalazione” (considerando 13, AMLR). All’intero quadro regolatorio di matrice sovranazionale bisogna, in definitiva, ‘appoggiarsi’ per sviluppare l’indagine penalistica, che non può più prescindere dalle misure amministrative rivolte a istituti bancari e finanziari, ormai ampiamente sviluppate e adesso rafforzate con la creazione di nuove autorità europee.
6. Diritto e politica criminale nel contrasto al riciclaggio dei capitali mafiosi
Adeguamenti domestici e risposte emergenziali a fenomeni mafiosi e cross-border hanno consegnato un quadro repressivo sui generis rispetto alle proprie tradizioni dogmatiche nel segno di una costante erosione del principio di legalità. Il quadro normativo di contrasto ai capitali mafiosi si è orientato verso un c.d. case law in cui il legislatore interviene attraverso nuove tecniche legislative in maniera espansiva e nei sistemi di civil law affida al giudice l’individuazione dell’ambito realmente appropriato di applicazione della legge. È difficile accettare, sul piano dei principi, che il giudice diventi co-creatore della norma, ma è altrettanto difficile ignorare che l’elasticità interpretativa sia oggi spesso l’unica via per contrastare condotte sofisticate e sistemiche, come quelle mafiose. È un equilibrio instabile tra legalità ed effettività, ma è un equilibrio che occorre presidiare.
La rivisitazione della materia appare necessitata, attesa l’assenza di una logica di coordinamento tra le norme. In tal senso, l’introduzione dell’autoriciclaggio – sulla cui inadeguatezza a fronteggiare i meccanismi più penetranti del riciclaggio mafioso, Apollonio si sofferma ampiamente – sarebbe stata un’occasione sprecata per costruire un sistema organico, capace di prevenire e punire in modo proattivo i fenomeni di riciclaggio interno. La lamentata inadeguatezza consiste, da un lato, nella difficoltà di collegare la condotta di autoriciclaggio alla sistematicità e serialità che caratterizza le condotte associative mafiose, dall’altro, nella difficoltà di includere organicamente questa figura nel novero dei delitti fine delle associazioni criminali. Nella prospettiva de iure condendo, si propone una figura criminosa speciale integrativa, tramite l’introduzione dell’art. 416-bis.2 dalla rubrica “Il riciclaggio dei capitali mafiosi” complementare rispetto a quella generale dell’autoriciclaggio, capace di colpire le attività di reimpiego e reinvestimento delle ricchezze mafiose e funzionali al suo rafforzamento economico. Tale proposta si fonda, tra le altre cose, sulla necessità di colmare le difficoltà esegetiche ereditate dalla giurisprudenza in merito alla qualificazione dei comportamenti di soggetti apparentemente neutrali (i cc.dd. white collars) che agevolano sistematicamente la criminalità mafiosa attraverso l’impiego di capitali illeciti in circuiti economici leciti (“in esecuzione del programma criminoso”, come reciterebbe il proposto art. 416-bis.2).
La prospettiva avanzata richiama una figura che, pur formulata alla stregua di reati contro il patrimonio o l’economia pubblica, mantenga una dimensione funzionale all’organizzazione mafiosa e, pertanto, giustifichi una risposta penale autonoma. L’Autore esamina altresì l’ipotesi di configurare una circostanza aggravante specifica per i reati di riciclaggio e autoriciclaggio, fondata sull’appartenenza dell’agente a un contesto associativo mafioso o sul legame funzionale della condotta rispetto alle finalità associative. Tale aggravante risponderebbe all’esigenza di graduare l’intervento punitivo sulla base della pericolosità effettiva della condotta, riconoscendo la maggiore offensività delle condotte sistematiche e strutturate poste in essere nel quadro di un programma criminale mafioso.
In conclusione, si staglia nitidamente una considerazione: non è più sufficiente aggiornare singole norme per contrastare un fenomeno che si è fatto sistema. Occorre un ripensamento complessivo, capace di ricostruire un’architettura penalistica coerente, che non sia solo reattiva ma anche anticipatoria, come suggerito dal nuovo quadro regolatorio del c.d. AML Package. In tal senso, le proposte dell’Autore offrono una nuova chiave di lettura. Credo però che il vero salto di qualità si compirà quando il diritto, anche quello di matrice giurisprudenziale, non sarà il baluardo solitario contro le mafie, ma saprà integrarsi con una politica criminale lungimirante, capace non solo di reagire, ma di anticipare e prevenire la loro capacità di metamorfosi. Forse, è proprio questa la sfida che ci attende. Una sfida che Andrea Apollonio sembra già pronto a raccogliere.
Andrea Apollonio, Il riciclaggio dei capitali mafiosi, Giuffrè, 2024.

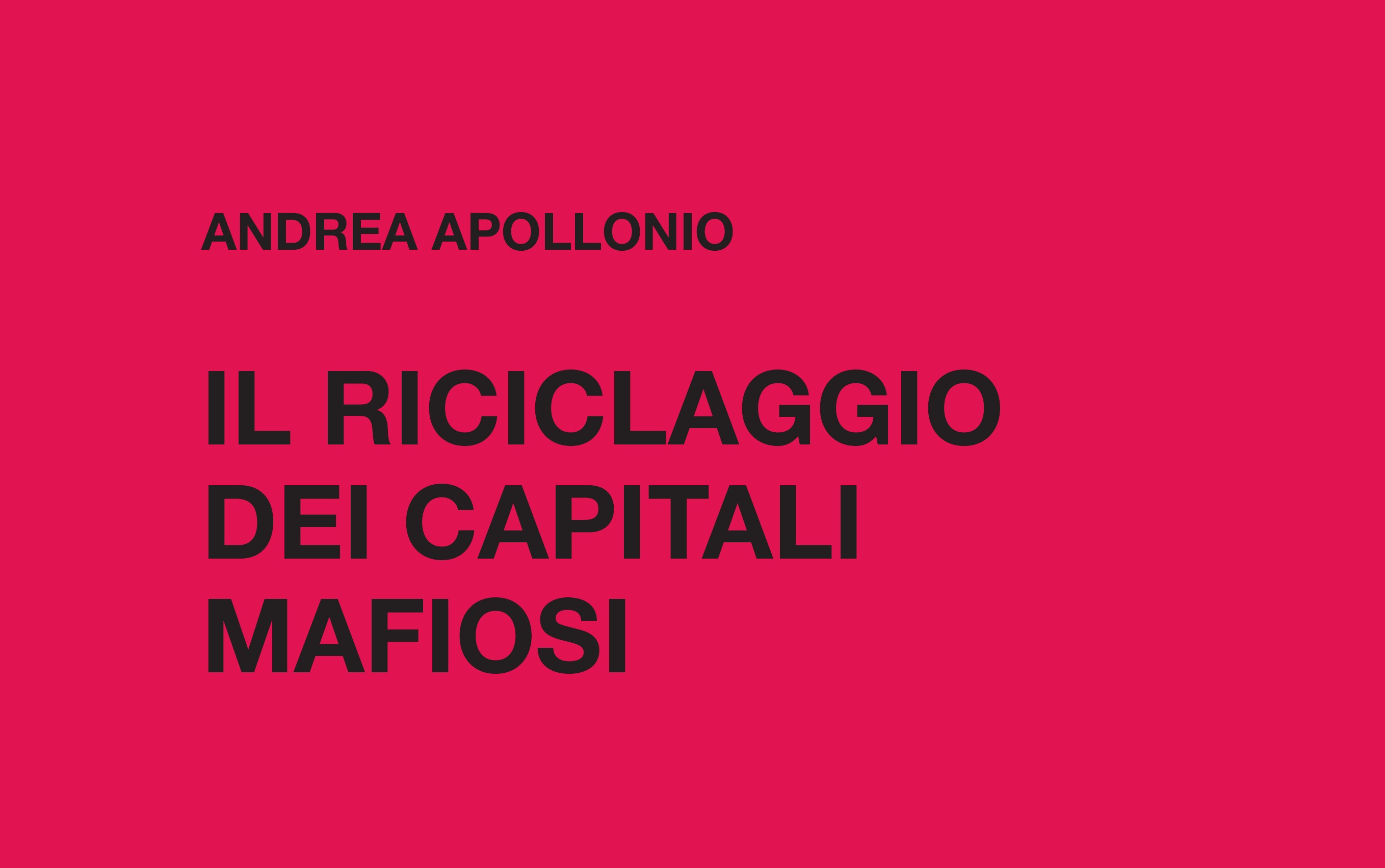

 E poi Aggiungi alla schermata principale.
E poi Aggiungi alla schermata principale.