Sommario: 1. Insistere insistere insistere - 2. Un po' di contesto dell’innominato CBD - 3. Presenza, soglie di rilevanza e normativa di THC e CBD - 4. La nuova legge: il presupposto è che il CBD fa male, come il THC - 5. Le modifiche alla legge 2 dicembre 2016 n. 242 - 6. La portata della riforma - 7. La disciplina dei semi di cannabis- 8. Le questioni di legittimità.
1. Insistere insistere insistere
Così, al quarto tentativo, e nientemeno che con decreto legge (d.l. 11 aprile 2025, n. 48, convertito, senza modificazioni, dalla legge 9 giugno 2025, n. 80[1]), le forze politiche che hanno dichiarato guerra al cannabidiolo - CBD - sono riuscite, senza mai nominarlo, come si vedrà, a renderlo illegale, con conseguenze penali pesanti, quelle del T.U. n. 309/1990. E ben si può dire “il Governo”, e non il legislatore, perché è stato “il Governo” a intervenire d’urgenza con decreto legge, impedendo poi al Parlamento di interloquire.
C’era stato un primo intervento del Ministero della Salute, con il decreto 1 ottobre 2020; poi con un secondo decreto, il 7 agosto 2023; e ancora con il decreto dello scorso 27 giugno 2024. Tutti interventi basati – in vario modo - sull’espresso inserimento del CBD fra le sostanze stupefacenti; tutti stoppati bruscamente dal TAR, direttamente in sospensiva, per la incoerenza con le motivazioni sbandierate e per la mancanza di presupposti.
Questa tenacia proibizionista merita un approfondimento: il cannabidiolo è un principio attivo della cannabis, ma è stato considerato per oltre un secolo irrilevante, e mai normativa primaria o secondaria lo avevano menzionato nelle varie leggi sulle droghe. Solo nel 2020 il CBD è diventato oggetto di un decreto ministeriale che, in sede del periodico aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, dispone “l’inserimento nella tabella dei medicinali, sezione B, delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis”[2].
Per contestualizzare gli effetti del decreto, occorre ricordare che in Italia le sostanze stupefacenti sono classificate in cinque tabelle, denominate Tabelle I, II, III e IV e, per ultima, Tabella dei medicinali. Nelle prime quattro trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto di abuso, mentre nella tabella dei medicinali sono indicati i farmaci a base di sostanze attive stupefacenti di corrente impiego terapeutico. La tabella dei medicinali a sua volta è suddivisa in cinque sezioni indicate con le lettere A, B, C, D ed E, dove nella sezione B si trovano i medicinali di origine vegetale a base di Cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture), con relativo regime di fornitura con ricetta non ripetibile (Rnr). Essi richiedono, cioè, la presentazione di una ricetta per essere acquistati (previa consulenza di un medico) e possono essere venduti solo in farmacia.
Il motivo dell’inserimento del CBD nelle tabelle, per come riportato nel decreto, è che si preparava l’inserimento di un medicinale contenente cannabidiolo, già autorizzato dalla Agenzia Europea del farmaco, per un uso compassionevole[3]. Quindi è necessario, spiegava il ministero, collocare il CBD nella tabella dei medicinali, tanto più che nell'elenco "sono indicati i medicinali a base di sostanze attive stupefacenti ivi incluse le sostanze attive ad uso farmaceutico". Nel 2020, quindi, il CBD diventò “ufficialmente” una sostanza stupefacente
La decisione suscitò immediatamente delle perplessità[4], per i (probabilmente) non previsti effetti sulla tormentata normativa sulla cannabis, che aveva appena trovato pace con la legge n. 242/2016 sulla canapa industriale; tanto da indurre il Ministero con Decreto ministeriale 28.10.2020 a prendere atto che l'inserimento nella citata Sezione “è questione che necessita di ulteriori approfondimenti di natura tecnico-scientifica”, che vennero richiesti all'Istituto superiore di sanità e al Consiglio superiore di sanità, procedendo nelle more del pronunciamento alla sospensione dell'entrata in vigore del citato DM 1° ottobre 2020.
Ma di nuovo il Ministero della salute, pur senza aver avuto gli approfondimenti che voleva, intervenne con il decreto 7 agosto 2023 con il quale disponeva di nuovo l’inserimento delle “composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis” nella Tabella dei medicinali, di cui alla sezione B, del DPR 9.10.1990, n. 309, sempre con regime di fornitura con ricetta non ripetibile. E di nuovo il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio il 9 Ottobre 2023 accolse il ricorso presentato dall'Associazione ICI -Imprenditori Canapa Italia per l’annullamento del Decreto Ministeriale del 7.08.2023 e ne sospese l'efficacia. E ancora l’11 settembre 2024 il Tar del Lazio accoglieva l'istanza cautelare presentata dai legali degli Imprenditori canapa Italia (Ici) contro il decreto del ministero della Salute dello 27 giugno 2024, che aveva – ancora - inserito le composizioni orali contenenti cannabidiolo nella tabella dei medicinali contenenti sostanze psicotrope o stupefacenti[5].
Alla fine il Governo, per raggiungere il risultato, nel 2025 ha abbandonato la via della normazione secondaria ed è intervenuto sulla normativa primaria, e non su quella sulle sostanze stupefacenti ma su quella sulla canapa industriale. Ora, quanto alla ostinazione, ben si può dire che il Governo abbia dimostrato che di fronte agli ostacoli, se si detiene il potere, si deve (si scusi il richiamo a esortazioni più nobili) insistere insistere insistere. Quanto all’urgenza, che essa sia manifestamente inesistente emerge chiaramente dal fatto che erano ben cinque anni che il Governo ci provava, cosa che di per sé dimostra che non era quello un problema nuovo. Ed è curioso che tale risultato sia stato raggiunto senza mai citare nel testo il CBD, ma non vi è dubbio che questo fosse l’obbiettivo.
2. Un po' di contesto dell’innominato CBD
Per meglio comprendere le caratteristiche dell’intervento legislativo e il macchinoso aggiornamento normativo, è bene ricordare alcuni concetti che forse sono ormai nozioni ordinarie, ma è opportuno premettere.
THC e CBD sono i due principali fitocannabinoidi della cannabis, dalla cui presenza e dalla cui combinazione deriva la distinzione fra la pianta ad effetto stupefacente, quella ad uso medico, quella ad uso industriale e ora anche quella a uso ricreativo non stupefacente. Le loro caratteristiche sono ben descritte nel Decreto del Ministero della salute 9 novembre 2015[6], ove si specificano la presenza e gli effetti dei due elementi. E si perdoni l’apparente tecnicismo, ma è necessario tenere presente che i due cannabinoidi sono molto diversi:
“Dei diversi fitocannabinoidi presenti nella pianta di cannabis, soltanto alcuni sono capaci di interagire in misura differente con i recettori cannabinoidi endogeni CB1 e CB2. … Il tetraidrocannabinolo (THC) è un agonista parziale di entrambi i recettori CB ed è il responsabile degli effetti psicoattivi della cannabis per la sua azione sul recettore CB1… Il cannabidiolo (CBD) manca di psicoattività poiché sembra non legarsi né ai recettori CB1 né ai recettori CB2 in concentrazioni apprezzabili, ma influenza l’attività di altri target quali canali ionici, recettori ed enzimi con un potenziale effetto antinfiammatorio, analgesico, anti nausea, antiemetico, antipsicotico, anti ischemico, ansiolitico e antiepilettico”.
Diversi anche gli effetti, ormai studiati, del consumo a lungo termine dei due fitocannabinoidi: l’utilizzo di marijuana con rilevante THC può influire sullo sviluppo cerebrale, specie quando assunta dall’adolescenza, alterando la funzionalità delle aree che regolano la concentrazione, la memoria, la capacità di pensare e di apprendere. Il CBD, allo stato attuale delle conoscenze, non presenta significativi effetti collaterali negativi, non dà dipendenza e non causa astinenza. Recentemente è emerso anzi come il CBD possieda un (potenzialmente grande) valore medicinale.
3. Presenza, soglie di rilevanza e normativa di THC e CBD
Relativamente al contenuto di cannabinoidi della Cannabis, originariamente il THC nelle piante di canapa (detta Sativa) coltivate in occidente si limitava allo 0,2 % circa; mentre nella cannabis coltivata in oriente (detta appunto Indica)[7] si raggiungevano percentuali più alte, intorno al 2%. Oggi non è difficile trovare sul mercato illegale varietà con un livello di THC oltre il 20%, ma i picchi raggiungono orma il 35% (travolgendo ogni effetto mitigatore del CBD)[8]. Per quanto riguarda invece il CBD, era in origine usuale una percentuale dell'1%; oggi in commercio sono disponibili varietà con un contenuto di CBD che va dall'8% al 12%, con varietà che – in recenti sequestri - arrivano a toccare il 18%[9].
Per quanto riguarda il THC, non vi sono nel T.U. n. 309/1990 limiti legali, né come minimi né come massimi, riguardanti la concentrazione del principio attivo per considerarla sostanza stupefacente. Le leggi sugli stupefacenti, mentre hanno sempre tabellato le quantità di principio attivo di eroina, cocaina, allucinogeni, anfetamine etc., con soglie di rilevanza penale, per il THC hanno dato soluzioni diverse. Vero che nel 1990 si diede una indicazione descrittiva (in pratica, diceva la legge n. 162: è marijuana quella che ha il 2%, è hashish quello che ha il 10%, è olio di hashish quello che ha il 50% di THC) ma questa indicazione però non è stata ripresa dalle leggi del 2006 e del 2014.
Un’indicazione sulla concentrazione del THC è contenuta invece nella legge 2 dicembre 2016 n. 242, che dopo una lunga peripezia ufficializzò la legalità della canapa industriale, considerando tale (in sintesi, ma si preciserà meglio più avanti) la cannabis avente THC inferiore allo 0,2%, con tolleranza sino allo 0,6%.
Successivamente, il Ministero della Salute, con decreto del 04 novembre 2019, ha definito i limiti massimi di concentrazione di THC negli alimenti come i semi o i vari estratti di cannabis. In particolare, per gli oli la concentrazione massima di THC ammessa è 0,5%, mentre per semi e farine è 0,2%.
Per quanto riguarda il CBD, non vi era nelle leggi dal 1923 ad oggi disciplina alcuna, essendo considerata una sostanza di poco rilievo, che si riteneva agisse solo per regolare e smorzare alcuni effetti del THC[10].
L’attenzione al CBD come sostanza a parte e ai suoi effetti specifici comincia ad essere posta con rilevanza intorno al 2010; è da allora che vengono selezionate e prodotte varietà di cannabis assai diverse (e comunque sempre legali secondo la normativa europea perché con una percentuale di THC inferiore allo 0.2%) per ottenere una percentuale molto maggiore del principio attivo di CBD. La cannabis sativa L. con queste caratteristiche è la cosiddetta Cannabis light: contiene poco THC e molto CBD; e viene usata per uso ricreativo nelle stesse modalità di utilizzo della canapa per stupefacenti; e cioè trinciando le infiorescenze, facendone oli e resine etc.: è quella che viene chiamata marijuana light.
In tutto questo, si coltivava (e quindi si commerciava) da millenni in Italia la canapa (oggi detta industriale), per la quale nessuna rilevanza avevano THC e CBD, che erano comunque presenti nelle piante ma in misura ininfluente.
In sintesi: la c.d. cannabis light è dunque botanicamente diversa dalla canapa per marijuana; è diversa dalla canapa per filiera agroindustriale; è (più affine ma comunque) diversa anche dalla canapa per uso medico terapeutico.
Per quanto riguarda la normativa, come detto, il principio attivo CBD non era compreso fra le sostanze previste nelle tabelle allegate al D.P.R. n. 309/1990; e non risultando avere effetto “stupefacente” non poteva rientrarvi neppure in via indiretta. Ma assai maggiori problemi (economici ma anche di rilevanza penale) erano causati in quegli anni e da ben più tempo dall’assenza di una normativa specifica riguardante la canapa industriale.
Caso o sfortuna che sia, il fenomeno della “scoperta” del CBD e la tanto attesa disciplina della canapa industriale, furono coevi. E un imprevisto effetto della normativa sulla canapa industriale è stato che la questione della presenza del CBD come principio attivo alternativo al THC non è stata dibattuta di per sé: ma la sua liceità è stata contrabbandata (dai suoi sostenitori) come conseguenza della legge sulla canapa industriale[11].
In sintesi: si coltivano principalmente tre tipi diversi di canapa (cui corrispondono tre tipi di produzione, tre tipi di diffusione, tre tipi di consumo), ma sono solo due leggi le disciplinano, una per la cannabis stupefacente e una per la canapa industriale; per cui la disciplina della cannabis light si ricava da un complicato puzzle di detti, non detti e di norme in deroga.
E’ necessario un primo accenno alla giurisprudenza, incastrata in questa impropria catalogazione di tre tipi di piante ma in sole due normative. La giurisprudenza ha a lungo oscillato fra un orientamento restrittivo, sostenendo che la legge n. 242 non consente comunque la commercializzazione dei derivati della canapa da essa non previsti, e un orientamento estensivo, convinto che dalla l. n. 242 derivasse la liceità della commercializzazione dei prodotti contenenti un principio attivo inferiore allo 0,6%; contrasto affrontato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, con sentenza n. 30475 del 30.5.2019, imp. Castignani. Questi i principi sanciti:
“la commercializzazione di cannabis sativa L. e, in particolare, di foglie, infiorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 242 del 2016”.
integrano il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, le condotte di cessione, di vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L., salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante”.
È questo il contesto botanico, merceologico e normativo in cui, anziché procedere per la strada maestra della normazione diretta, proseguendo nella confusione, chi voleva e vuole vietare l’uso del CBD, cioè il Governo, ha modificato non il T.U. n. 309/1990 - che contiene la disciplina sulle sostanze stupefacenti – ma la legge 2 dicembre 2016, n. 242 – che riguarda la canapa industriale…
4. La nuova legge: il presupposto è che il CBD fa male, come il THC
“Art.1. Al fine di evitare che l’assunzione di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa (Cannabis sativa L.) o contenenti tali infiorescenze possa favorire, attraverso alterazioni dello stato psicofisico del soggetto assuntore, comportamenti che espongano a rischio la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la sicurezza stradale, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni…”.
L’esordio della legge n. 80/2025, con l’inserimento dei fini come in una norma programmatica, è anomalo. Ma già la premessa è una contraddizione, perché se la sostanza dovesse avere la capacità di alterare lo stato psicofisico del soggetto, la sua disciplina naturale sarebbe il T.U. n. 309/1990.
E, lo si deve ripetere, bersaglio della nuova legge non dovrebbe essere il CBD, perché non vi sono evidenze scientifiche che l’assunzione di CBD – come invece è provato per il THC - cagioni alterazioni dello stato psicofisico del soggetto; e di conseguenza non vi è evidenza scientifica che chi lo ha assunto possa porre in essere comportamenti che espongano a rischio la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la sicurezza stradale (chi sponsorizza maggiormente la legge è il ministro dei trasporti).
Questo dato non è opinabile: nella sua riunione del giugno 2019 l’ECDD - il comitato di esperti sulle droghe e le dipendenze dell’Organizzazione mondiale della Sanità - aveva esaminato i preparati a base di cannabidiolo con il fine di predisporre una valutazione del CBD rispetto alla Convenzione dell’Onu del 1961. In particolare nel documento si legge che “il cannabidiolo si trova nella cannabis e nella resina di cannabis ma non è dotato di proprietà psicoattive e non ha potenziale di abuso né potenziale di produrre dipendenza. Esso non ha effetti negativi significativi. Il cannabidiolo ha dimostrato di essere efficace nella gestione di alcuni disturbi epilettici resistenti al trattamento, in particolare infantile. È stato approvato per questo uso terapeutico negli Stati Uniti nel 2018 ed è attualmente all’esame per l’approvazione da parte dell’UE.”
Più recente la commissione dei medici di Roma scrive che “è scientifico un dato che arriva dalle evidenze della ricerca e in particolare in medicina ancora di più ciò che arriva dall'esperienza condivisa dei clinici in ogni parte del mondo… Nulla di scientifico emerge dall'utilizzo non controllato ('fai da te') del Cbd da parte della popolazione generale"[12].
Quindi: se il presupposto per vietare il CBD è l’equiparazione quanto agli effetti al THC, ciò è scientificamente errato. Se l’obbiettivo è vietare comunque il CBD, occorreva dire quali fossero i motivi e fare una legge che – per quei motivi – lo disciplinasse e lo vietasse. A maggior ragione se il presupposto evoca conseguenze e danni psicofisici scientificamente non provati.
5. Le modifiche alla legge 2 dicembre 2016 n. 242
Si è detto perché il Governo, una volta esclusa una (opportuna) regolamentazione diretta del CBD, intervenga sulla legge 2 dicembre 2016 n. 242. Il percorso scelto per questo intervento è ribadire che “la promozione della coltivazione della canapa è ammessa soltanto a livello di filiera industriale”; ne consegue che la legittimità di tale coltivazione è connessa alle “finalità espressamente previste dalla legge, senza possibilità di interpretazioni estensive”[13].
Per questo la lettera a) dell’art. 18 della legge n. 80/2025[14] interviene sull’articolo 1 della legge 242/2006: si specifica che la legge sostiene la filiera industriale, non qualsiasi coltivazione (in translucenza: quella del CBD); che il sostegno riguarda «in via esclusiva la coltura della canapa comprovatamente finalizzata», per cui nel dubbio riguardante la finalità (di chi in realtà vuole produrre CBD), la legittimità della coltivazione viene meno; che l’incentivazione alla canapa industriale riguarda la realizzazione di semilavorati di canapa, non l’impiego e il consumo finale (locuzione che era ambigua, si ritiene); che la realizzazione deve avvenire per gli usi consentiti dalla legge, cioè per quelli che la legge enuncia, senza (appunto) interpretazioni estensive.
Quindi, afferma la nuova legge, la normativa sulla canapa industriale non si applica alle infiorescenze femminili della “Cannabis sativa L.” (le piante maschili non formano infiorescenze profumate o resinose) che producono i due cannabinoidi. Concetto chiaramente ribadito per quanto necessario dal comma 3 -bis dell’art. 1 e dal comma 3 .bis dell’art. 2. di nuovo inserimento: “le disposizioni della presente legge non si applicano ai prodotti costituiti da infiorescenze di canapa,” dei quali “sono vietati l’importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l’invio, la spedizione e la consegna” in qualsiasi forma le si volesse produrre e commercializzare: anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, o contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati.
In sintesi: la motivazione della riforma è che il CBD che si trova nelle infiorescenze fa male perché è come il THC, provoca alterazioni psicofisiche, e quindi va vietato. Si tratta di un divieto penale: alle infiorescenze – ammesso che già non si potesse fare contenendo troppo THC – “si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309”.
Ambiguo, ritiene il nuovo legislatore, era anche il riferimento al florovivaismo, che era uno dei principali appoggi dell’interpretazione estensiva: dalla canapa legittimamente coltivata, chiarisce la legge, è possibile ottenere solo coltivazioni destinate al florovivaismo professionale (qualsiasi cosa esso sia, peraltro), escludendo coltivazioni che vengono abitualmente definite domestiche (la definizione è usata anche dalla citata sentenza Castignani) e che sono solitamente destinate al consumo personale o al piccolo o piccolissimo spaccio.
6. La portata della riforma
Riassumendo: il combinato disposto dei due nuovi commi 3.bis (dell’art. 1 e dell’art. 2), vieta con l’applicazione delle misure penali del T.U. n. 309/1990 le attività di produzione, commercializzazione etc. (con parziale ricalco dell’art. 73 comma 1 del testo unico) delle infiorescenze di canapa e dei prodotti che le contengono. Il divieto ha effetti dalla data del decreto legge, cioè dal 12.4.2025, senza che su questo abbia influito la legge di conversione. Fin qui la novella legislativa; che come si vede - al di là della contorta modalità di intervento – non è una riforma rivoluzionaria nel sistema della normativa sulle sostanze stupefacenti, ma un intervento di allargamento della normativa penale.
Il Governo più volte ha sostenuto che il suo intervento in sostanza altro non è che l’applicazione pratica dei principi della sentenza Castignani; ma sembra ispirarsi, più che alla sentenza, all’orientamento restrittivo sopra ricordato[15], affermando che quella era l’interpretazione giusta. Si può parlare di scelta del legislatore di chiarire la sua intenzione, già manifestata? Anche no, perché tutto voleva il legislatore della l. n. 242/2016 tranne che disciplinare – vietandola o permettendola - la coltivazione e il commercio della cannabis light e, a valle, della marijuana light: ciò che si voleva era solo sottrarre alla normativa penale l’attività tradizionale – diffusa e di risultati pregevoli in Italia - di coltivazione della canapa una volta tessile (chiamata nel tempo con vari nomi[16]) e ora industriale.
Ampliando lo sguardo sulla normativa, si evidenzia che la riforma non interferisce sugli altri aspetti della coltivazione e utilizzo dei prodotti della canapa. Come si è detto, la legge vieta specificamente le infiorescenze e i loro derivati; perciò rimane salva la possibilità di ottenere CBD in altre forme, in particolare da altre parti della pianta, come foglie e fusti, anche se è tecnicamente più difficile e costoso. E’ possibile produrre oli o cosmetici contenenti CBD utilizzando le parti della pianta diverse dalle infiorescenze, acquisendole dalla filiera agroindustriale (e sempre va fatto salvo il CBD sintetico).
La legge non interviene sulla normativa sulla cannabis terapeutica, che è stata espressamente esclusa dalle nuove limitazioni e dunque il CBD ottenuto da infiorescenze rimane disponibile per scopi medici; la differenza è che chi lo utilizza potrà continuare a farlo solo attraverso la prescrizione medica, mentre non è più possibile l’acquisto legale di prodotti a base di CBD per auto-medicazione dai c.d. cannabis shop o online[17].
Quanto agli usi più propriamente industriali, l’uso della canapa come biomassa, contenente anche inflorescenze, è consentito per autoproduzione energetica industriale (non è modificato l’art. 2 comma 3 l. n. 242/2016); probabilmente la vendita delle rotoballe di steli etc. è problematica, in quanto comunque potrebbero rimanere delle infiorescenze dopo la raccolta; le fibre per impiego tessile vengono ricavate dalla lavorazione del fusto e dei rami della pianta, per cui l’impiego non è compromesso; dalla lavorazione dei semi della Cannabis Sativa L. si possono continuare a produrre gli alimenti, le bevande, i cosmetici, gli olii derivanti sempre dalla lavorazione dei semi (anche se forse sarà più complicato).
7. La disciplina dei semi di cannabis
La pianta della cannabis è composta di più parti: steli, foglie, infiorescenze maschili e femminili, che producono i cannabinoidi, semi. I semi della cannabis contengono una quantità irrilevante di THC (quasi pari a zero) e che comunque non deve superare i 2 mg/kg (0.0002%)
Ora, la questione della disciplina dei semi è sempre stata spinosa. La detenzione e la vendita di semi di cannabis può essere (e normalmente è nelle transazioni non industriali) un’attività finalizzata alla diffusione di sostanze stupefacenti, costituendo un antecedente necessario del delitto di coltivazione (fatto salvo quanto precisato con l’intervento delle Sezioni Unite n. 12348 del 19 dicembre 2019, Caruso). Tuttavia è possibile che l’acquisto avvenga per mera curiosità o che l’acquirente desista poi dalla coltivazione, per cui la detenzione in sé non è illecita. Un lungo contrasto di giurisprudenza riguardo alla liceità del commercio, nella forma della offerta in vendita dei semi, è stato risolto dalle Sezioni Unite nel 2012, con pronuncia che ha affermato che l’offerta in vendita dei semi non integra il reato di cui all’articolo 82 T.U. n. 309/1990, ma la condotta può integrare ricorrendone i presupposti, il reato di istigazione alla coltivazione di sostanze stupefacenti, ex articolo 414 c.p. [18].
La possibile destinazione dei semi alla coltivazione di cannabis light, nel presupposto che questa fosse legale, ha determinato il Governo a intervenire anche in questo settore. Mentre il disegno di legge colpiva troppo genericamente ogni attività e produzione diversa da quelle previste dall’art. 2 comma 2 (con la conseguenza che non si capiva come si potessero proseguire le coltivazioni legittime se non si potevano produrre i semi) si è corretta la riforma introducendo due nuove disposizioni: alle attività autorizzate dall’art. 2 comma 2 viene aggiunta – alla lettera g -bis - la produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla legge, entro i limiti di contaminazione stabiliti dal Ministero della salute; e nell’elenco delle attività vietate dal comma 3-bis è inserita l’eccezione della lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola dei semi di cui alla lettera g -bis ) del comma 2.
Non vi è dubbio che l’introduzione di quella che è una clausola derogatoria di liceità crei qualche problema, in quanto per la tecnica legislativa utilizzata, in sede del controllo sulle coltivazioni è a carico dell’agricoltore la prova della esclusiva finalità alla produzione lecita di semi[19]. In secondo luogo, il contestuale divieto delle infiorescenze e liceità dei semi pone il problema tecnico della estrazione dei semi dalle infiorescenze, estrazione complicata e costosa, che potrebbe scoraggiare ulteriormente i produttori di canapa industriale.
Conclusivamente, si precisa che, in coerenza e a completamento della novella, all’art. 4 comma 1, nuova formulazione, della legge 2 dicembre 2016 n. 242, i necessari controlli delle forze dell’ordine[20], che consistono in prelevamenti e analisi di laboratorio, riguardano non solo le coltivazioni di canapa, ma anche la produzione agricola dei semi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera g -bis). Rimane fermo che si parla dei controlli finalizzati al rispetto della l. n. 242 (quindi ai fini dell’erogazione degli incentivi), fatto salvo ogni altro tipo di controllo eseguito nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie.
8. Le questioni di legittimità.
La legge non può non suscitare dubbi e tentativi di cogliere il punto in cui il suo stridere con buon senso e sistematicità possa diventare un profilo di illegittimità. E questi profili di illegittimità sono stati cercati da molti, anche con una certa fantasia, ma alcuni profili hanno fondamento.
Per primo, ha fondamento il dubbio sull’utilizzo dello strumento del decreto legge, ovvero se nel caso di specie possano ravvisarsi gli estremi della straordinaria necessità ed urgenza di cui all’art. 77 co. 2 Cost. Ora, se questo dubbio riguarda in generale il “Decreto sicurezza”, in relazione ad alcuni punti del decreto la criticità è maggiore. Fra questi vi è certamente l’intervento nella materia degli stupefacenti: se è vero che la Corte costituzionale ha affermato più volte che il suo sindacato sulla legittimità del ricorso al decreto-legge deve limitarsi alla “evidente mancanza” dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza, credo che nell’intervento in esame non vi sia neppure un appiglio per affermare che i presupposti vi sono.
Venendo ai profili specifici riguardanti l’art. 18 della legge, quello davvero concreto è il rispetto del principio costituzionale di offensività. La decisione di vietare le infiorescenze per rendere illegale il CBD si scontra palesemente contro l’inesistenza di una prova scientifica della sua nocività alla salute. Ora, già è particolarmente complicata la valutazione dei limiti quantitativi e dei livelli qualitativi del cannabinoide THC[21]; per il CBD la questione è aggravata non essendovi nella legge una clausola di salvezza nei casi di inoffensività, non essendovi una pronuncia giurisdizionale che in supplenza la enunci, non essendoci nemmeno lontanamente una pronuncia scientifica sugli effetti dannosi; ed essendovi al contrario una serie di pronunce che ne attestano l’inoffensività. In questa situazione, il divieto di utilizzo delle infiorescenze che non contengano THC in modo superiore ai miti di legge e contengano valori di CBD da ritenersi scientificamente ininfluenti sullo stato psicofisico del soggetto, porterà ben presto, di fronte ad una condanna ex art. 73 T.U. n. 309/1990 ai danni di chi possieda marijuana light, a proporre la valutazione di costituzionalità.
Diversi sono invece i profili di possibile contrasto con la normativa eurounitaria. Balza agli occhi subito l’esistenza di una normativa europea di sostegno della coltura della canapa (che indica i limiti di ammissibilità al contributo comunitario basati sulla precisa limitazione della presenza di THC) rispetto alla quale la disciplina italiana è ora in palese contraddizione. Così come la normativa italiana sembra cagionare la limitazione di alcuni principi europei: in particolare, la libera circolazione delle merci e la libera produzione di merci e servizi. Si tratta di contrasti seri, che non è difficile prevedere che, per il risvolto economico, saranno presto sollevati dalle categorie professionali.
[1] “Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”; in Gazzetta Ufficiale 9.6.2025. Rileva qui l’art. 18.
[2] Ministero della Salute - Decreto 1 ottobre 2020. Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni ed integrazioni. (GU Serie Generale n.255 del 15-10-2020).
[3] Afferma il decreto 1.10.2020 che "attualmente è in corso di valutazione presso l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) una richiesta di autorizzazione all'avvio della commercializzazione di un medicinale, in soluzione orale contenente cannabidiolo, che ha già ricevuto l'autorizzazione all'immissione in commercio centralizzata da parte dell'European Medicines Agency (EMA)" e che lo stesso medicinale "è controllato attraverso un programma di uso compassionevole, notificato all'AIFA, per i pazienti in trattamento con sindrome di Dravet e sindrome di Lennox-Gastaut".
[4] Ad esempio Federcanapa decise di impugnare insieme ad EIHA (l’Associazione Europea della Canapa Industriale) il decreto dinanzi al TAR al fine di evidenziare il palese contrasto con la normativa comunitaria e con l’intento di definire la netta distinzione che sussiste tra canapa industriale-prodotto agricolo e canapa stupefacente.
[5] Va però precisato che con riferimento al CBD estrattivo, il TAR Lazio – sez. Terza Quater, con la sentenza n. 7509 pubblicata il 16 aprile 2025 – ha respinto il ricorso avverso il Decreto del Ministero della salute del 27 giugno 2024, anche se tale pronuncia non ha influito sull’iter del decreto legge ormai avviato.
[6] Più precisamente nell’ “Allegato tecnico per la produzione nazionale di sostanze e preparazioni di origine vegetale a base di cannabis”, punto 4.2 - Proprietà farmacodinamiche.
[7] Queste denominazioni erano quelle usate dalla legge n. 162/1990, base del T.U. n. 309/1990 cui oggi si fa comunemente riferimento. Dopo varie peripezie, ora si indicano tutte le specie di cannabis come Sativa L, che ha ormai migliaia di sottospecie.
[8] “L’evoluzione della marijuana: dal 4% al 35% di THC in meno di 30 anni” - Pubblicato su Luglio 10, 2025 da Daniela Vergara - https://cannactiva.com/it/evoluzione-della-marijuana/. Il commento aggiunge: “Purtroppo, le varietà di marijuana molto ricche di THC sono anche povere di CBD. Il CBD è un componente non psicoattivo della cannabis che interagisce con il THC e ne attenua gli effetti negativi”.
[9] Una specie di marijuana in vendita, la Pineapple Express, raggiunge la percentuale di CBD pari al 16,2% e secondo il sito: https://www.sensimilla.shop/it/blog/cannabis-terapeutica/le-4-varieta-di-cannabis-con-il-piu-alto-contenuto-di-cbd? - “si aggiudica il primo posto nella classifica”.
[10] “Una presenza di CBD e THC in egual misura (rapporto 1:1) produce tipicamente effetti psicotropi molto blandi. La ratio 1:1 è stata identificata come la migliore nel trattamento di determinate patologie come cancro, insonnia, autismo, fibromialgia e disturbi neurologici come la sclerosi multipla”: https://sicamweb.it/il-rapporto-cbdthc-terapeuticita-ed-effetti-avversi/.
[11] La confusione è tale da indurre il governo (in: https://www.politicheantidroga.gov.it/it/DDL Sicurezza: chiarimenti sull’emendamento “cannabis”) a ritenere “opportuno evidenziare che il nome scientifico di tale varietà di pianta è “Cannabis Sativa Linnaeus”, e pertanto l’abbreviazione “L.” non significa “light””...
[12] Così la Commissione dell’Ordine dei medici di Roma nel commento al decreto del ministro della Salute 7 agosto 2023.
[13] Relazione illustrativa al d.d.l. di conversione A.C. 2355.
[14]Art. 18: 1) al comma 1, dopo le parole: «della filiera» è inserita la seguente: «industriale»; 2) al comma 3, alinea, le parole: «la coltura della canapa finalizzata» sono sostituite dalle seguenti: «in via esclusiva la coltura della canapa comprovatamente finalizzata»; 3) al comma 3, lettera b), le parole: «dell’impiego e del consumo finale» sono sostituite dalle seguenti: «della realizzazione» e dopo la parola: «locali» sono aggiunte le seguenti: «, per gli usi consentiti dalla legge»
[15] Orientamento che affermava che la legge n. 242 non consente comunque la commercializzazione dei derivati della canapa da essa non previsti (hashish e marijuana light), in quanto la normativa disciplina esclusivamente la coltivazione della canapa, consentendola, alle condizioni ivi indicate, soltanto per i fini commerciali elencati dall'art. 1, comma 3, tra i quali non rientra la commercializzazione al dettaglio dei prodotti costituiti dalle infiorescenze e dalla resina. Quindi la detenzione e commercializzazione di questi derivati rimangono sottoposte alla disciplina di cui al d.P.R. n. 309 del 1990. Cfr. in tal senso Cass. pen., sez. VI, 27 novembre 2018, n. 56737, imp. Ricci; Cass. pen., sez. VI, 10 ottobre 2018, n. 52003, imp. Moramarco; Cass. pen., sez. IV, 13 giugno 2018, n. 34332, imp. Durante.
[16] Ad esempio Canapa da tiglio
[17] “CBD in Italia nel 2025: cosa cambia con il Decreto Sicurezza? Prima buona notizia: nulla cambia per l'uso medicale”, Clinn: https://www.clinn.it/it/cbd-italia-2025-decreto-sicurezza.html
[18] Per evitare problemi legali associati alla vendita di prodotti destinati alla coltivazione di piante di cannabis, le aziende che vendono questi prodotti spesso utilizzano la denominazione "semi da collezione" (destinati a essere collezionati come souvenir o pezzi da esposizione).
[19] Che non discende automaticamente dall’utilizzo – accertabile con l’esibizione della documentazione dei lotti di acquisto – di sementi lecite.
[20] Nella dizione aggiornata dalla legge di Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri.
[21] Come già si è detto, rispetto al THC esiste una molteplicità di soglie, senza che si sia mai arrivati ad una identificazione almeno approssimativa di una soglia scientifica. Ed esiste anche una profonda diversità fra gli ambiti disciplinati: l’uso ricreativo, l’uso medico, l’uso industriale, le modalità di controllo etc. L’esistenza di una problema di offensività anche per il THC è stato espressamente evidenziato dalla sentenza delle Sezioni Unite Castignani (“integrano il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, le condotte di cessione, di vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L., salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante”).

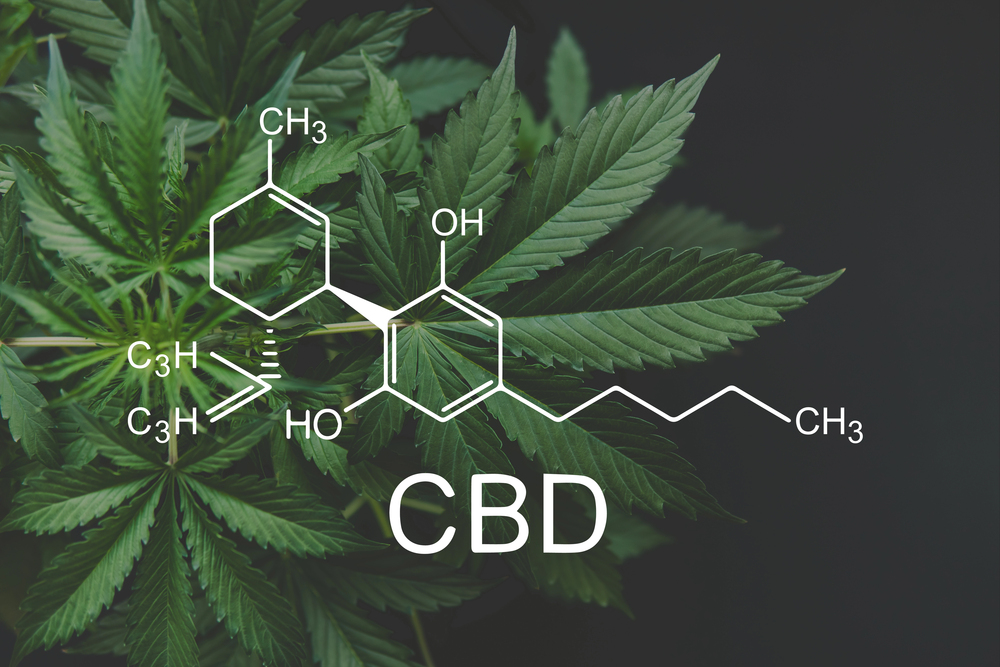

 E poi Aggiungi alla schermata principale.
E poi Aggiungi alla schermata principale.