
GIUSTIZIA INSIEME
ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma
ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma
Violenza sessuale mediante “abuso di autorità”: il revirement delle Sezioni Unite
(nota a Cass., Sez. un., sent. 16 luglio 2020, n. 27326, Pres. Fumu, Est. Ramacci)
di Francesca Vitiello
Sommario: 1. Premessa – 2. L’abuso costrittivo e le possibili interferenze con la violenza presunta di cui al 609-quater c.p. – 3. Sul concetto di «abuso di autorità»: gli orientamenti contrapposti – 3.1. La decisione delle Sezioni Unite – 4. Conclusioni.
1. Premessa
Le Sezioni unite penali con la pronuncia n. 27326 del 16 luglio 2020 (dep. il 1° ottobre 2020) hanno posto fine alla vexata quaestio delineatasi in tema di violenza sessuale sull’esatta interpretazione del sintagma “abuso di autorità”, di cui all’art. 609-bis, co. 1, c.p., da sempre oggetto di letture difformi nella giurisprudenza di legittimità.
Nonostante una – ormai risalente – pronuncia sulla materia de qua[1], sempre ad opera della Cassazione nella sua più autorevole composizione, la sezione rimettente aveva rilevato la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla natura eminentemente pubblicistica o anche privatistica della posizione di autorità di cui il soggetto agente abusa per costringere la persona offesa a compiere o subire atti sessuali. Invero, nell’ordinanza di rimessione, la terza sezione aveva posto in evidenza due differenti indirizzi interpretativi: il primo, “pubblicistico”, di carattere restrittivo e tassativizzante, speculare rispetto al secondo, anche detto “privatistico”, maggiormente estensivo.
Tuttavia, prima di soffermarsi sulla soluzione interpretativa cui sono pervenute le Sezioni Unite, appare opportuno, preliminarmente, comprendere agevolmente le dinamiche che hanno caratterizzato l’evoluzione giurisprudenziale del concetto di “abuso di autorità” nel delitto di violenza sessuale mediante costrizione. Funzionale a tal fine è la disamina della relativa normativa, oggetto di una profonda metamorfosi a livello legislativo e applicativo in virtù dei mutamenti registratesi nel contesto storico-culturale di riferimento.
Sulla base di tali premesse, profonda è la convinzione che solo un’analisi trasversale e comparativa della fattispecie in esame con quelle “pregresse” e “contigue”, unita ad un’indagine sulla sua ratio legis, consentirà di cogliere quegli elementi – dirimenti – che hanno orientato la decisione dell’organo di suprema nomofilachia, il cui approdo ermeneutico, per quanto condivisibile, consente qualche residua perplessità.
2. L’abuso costrittivo e le possibili interferenze con la violenza presunta di cui al 609-quater c.p.
Il reato di violenza sessuale è previsto dall’art. 609-bis c.p., introdotto dalla l. 15 febbraio 1996, n. 66 all’esito di una lunga e articolata gestazione parlamentare che ha costituito un punto di svolta per la normativa penale sul tema. La legge n. 66/1996, infatti, ha riplasmato la collocazione dei c.d. reati sessuali, inserendoli nell’ambito dei «delitti contro la persona» e, in particolare, fra quelli contro la libertà individuale (e non più tra quelli contro «la moralità pubblica e il buon costume»).
Si tratta di una novità, quest’ultima, che riflette un sensibile mutamento nella percezione dei valori[2] e del bene giuridico tutelato, ora inequivocabilmente costituito dalla libertà sessuale quale una delle estrinsecazioni fondamentali della libertà umana, e non già dai valori morali della collettività.
La novità più significativa dell’art. 609-bis, così come introdotto dalla riforma del ’96, è stata la tipizzazione dell’abuso di autorità, quale mezzo di coartazione dell’altrui volontà, alternativo alla violenza o alla minaccia[3]: mediante tali modalità il soggetto attivo costringe la persona offesa a compiere o subire atti sessuali.
Gli elementi costitutivi sono la costrizione (chiaramente psichica)[4] e gli atti sessuali. In questo senso, l’abuso costrittivo viene inteso dalla dottrina come una pressione effettuata strumentalizzando la propria posizione di supremazia, meno “forte” sulla vittima di quanto non lo sarebbe una minaccia o una violenza, ma con una consistenza maggiore in termini di coartazione della volontà, rispetto alla persuasione che integra l’induzione[5]. Se la ratio dell’innovazione è piuttosto trasparente, risulta comunque non agevole stabilire a quale casistica concreta la disposizione in esame possa essere specificamente riferita.
Il concetto di abuso di autorità resta connotato da contorni incerti e non determinabili, che pongono la sotto-fattispecie normativa ai limiti del rispetto del principio di tipicità.
Il problema – che si interseca con quello oggetto della rimessione – attiene, nello specifico, all’esatta individuazione della tipologia di autorità (pubblica o anche privata) il cui abuso diventa penalmente rilevante. La riforma del 1996, infatti, ha utilizzato il sostantivo senza prevedere accanto ad esso alcun attributo che ne riesca a connotare il carattere, lasciando, di fatto, questo non semplice compito agli interpreti.
La decodificazione di tale formula comporta, sul versante sostanziale, implicazioni di non poco conto circa l’ambito di applicazione della fattispecie, soprattutto quando la persona offesa sia minorenne e legata all’autore del reato da un particolare tipo di rapporto. In tali casi – come dimostra la vicenda oggetto della sentenza in commento – si può porre un problema di interferenza tra la sotto-fattispecie di abuso costrittivo di cui al 609-bis e alcune ipotesi, sotto molti aspetti ritenute “contigue”, di violenza cd. presunta, punita dall’art. 609-quater. Le possibili interferenze riguardano, in particolare, le ipotesi di cui all’art 609-quater, comma 1 n. 2) e comma 2, nelle quali ad essere sanzionato è l’abuso di una posizione di supremazia i cui effetti negativi sulla volontà della vittima nel primo caso vengono presunti in ragione del particolare rapporto che lo lega al soggetto attivo; nel secondo, invece, in relazione della diversa età del minore e della ritenuta diversa maturità, è necessario conseguano da un effettivo comportamento di strumentalizzazione dei poteri[6].
Queste due situazioni possono, almeno in apparenza, essere sovrapponibili con l’abuso di autorità, soprattutto se si ritiene di leggere quest’ultima endiadi come riferita anche ad autorità di natura privatistica, quando chi abusi, ad esempio, eserciti poteri di supremazia connessi a rapporti familiari, di cura o di istruzione.
Individuare quale delle due norme sia applicabile non è, del resto, solo un’operazione di mera correttezza ermeneutica ma ha rilevanza per conseguenze di vario tipo che ne derivano.
Sotto quest’ultimo profilo, è agevole ricordare che, benché le fattispecie di cui agli artt. 609-bis e 609-quater co. 1 c.p. siano sanzionate in modo identico quoad poenam, si differenziano per il regime delle aggravanti configurabili, essendo applicabili alla sola fattispecie di cui al 609-bis c.p. quelle di cui all’art. 609-ter. Inoltre, fino alla modifica prevista dalla l. 69 del 2019 era dissimile il regime di procedibilità ex art. 609-septies c.p.; mentre resta tutt’oggi differente – e in modo significativo – il regime sanzionatorio per il reato di cui al 609-bis c.p. (reclusione da 6 a 12 anni) da quello di cui al 609-quater co. 2 c.p. (reclusione da 3 a 6 anni).
Da tali rilievi si evince il peso che l’esatta perimetrazione del sintagma “abuso di autorità” assume ai fini del giudizio di responsabilità penale, incidendo sull’esatta qualificazione giuridica e, conseguentemente, a seconda del concreto atteggiarsi dei fatti, anche sulla relativa cornice edittale.
Infatti, come emerge dal caso oggetto della pronuncia in commento, qualora la vittima del reato sia una persona infraquattordicenne legata al colpevole da un particolare rapporto, il pendolo della risposta punitiva oscilla tra la più pesante cornice edittale prevista per la forma aggravata del reato di violenza sessuale, giusto disposto degli agli artt. 609-bis e 609-ter co. 2 (rectius 609-ter co. 1 n.1)[7], e quella più lieve riferibile al 609-quater co.1 n. 1) e 2).
3. Sul concetto di «abuso di autorità»: gli orientamenti contrapposti
Venendo all’esame del tema posto al vaglio delle Sezioni Unite, il quesito di diritto oggetto di rimessione era così formulato: «Se, in tema di violenza sessuale, l’abuso di autorità di cui al’art. 609-bis, primo comma, cod. pen. presupponga nell’agente una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico o, invece, possa riferirsi anche a poteri di supremazia di natura privata di cui l’agente abusi per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali»[8].
La vicenda che aveva dato origine alla valutazione giudiziale riguardava le plurime condotte tenute da un insegnante di ripetizioni private nei confronti di due alunne minori degli anni quattordici, sicché un’interpretazione restrittiva dell’art. 609-bis c.p. avrebbe imposto una riqualificazione del fatto nel meno grave reato di atti sessuali con minorenne di cui all’art. 609-quater c.p. (con le già viste differenze sanzionatorie).
Al fine risolvere la questione, relativa, appunto, alla corretta interpretazione dell’endiadi “abuso di autorità”, i giudici di legittimità hanno ripercorso i due difformi orientamenti giurisprudenziali maturati sul punto.
Il primo, di tipo restrittivo, si è affermato quasi all’indomani dell’entrata in vigore della l. n. 66/1996 e sostiene la tesi della natura pubblicistica e formale della posizione di autorità del soggetto agente[9]; dunque, non vi rientrerebbe l’insegnante privato.
Su tale presa di posizione ha indiscutibilmente inciso un precedente autorevole delle Sezioni Unite. Invero, con sentenza n.13/2000 si era affermato, se pure in via incidentale, che l’abuso di autorità di cui all’articolo 609-bis, co. 1, c.p., presuppone nell’agente una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico. Pertanto, ne avevano escluso la configurabilità nei confronti di un insegnante privato che aveva compiuto atti sessuali con un minore di anni sedici, a lui affidato per ragioni di istruzione ed educazione. Di contro, avevano ritenuto corretta la qualificazione del fatto – operata dai giudici di merito – in atti sessuali con minorenne di cui all’articolo 609-quater c.p.
Tale pronuncia ha contribuito a consolidare, negli anni, quell’indirizzo restrittivo[10] che avvalora la propria teoria con un doppio argomento, uno di carattere storico e l’altro di tipo sistematico.
Quanto all’argomento storico, esso prende le mosse dalla constatazione di un “rapporto di filiazione” tra l’attuale sotto-fattispecie di cui al 609-bis, co.1, e quelle precedentemente previste dagli abrogati artt. 519, co.1, 520 e 521 c.p., ritenendo l’abuso di autorità coincidente con l’abuso della qualità di pubblico ufficiale già contemplato dall’art. 520.
A livello sistematico, invece, tale orientamento osserva che, considerando l’abuso di autorità riferibile anche a poteri di carattere privatistico, verrebbe meno la possibilità di distinguere l’ipotesi di reato contemplata dall’art. 609-bis, co.1, c.p., dall’ipotesi di rapporto sessuale con abuso di potere parenterale o tutorio ora previsto dall’art. 609-quater, co. 2, c.p. Invero, intendendo come autorità ogni posizione sovraordinata pubblicistica o privatistica, l’art. 609-quater co.2 resterebbe praticamente privo di effetti, atteso che la clausola di riserva contenuta nel suo incipit («fuori dei casi di cui all’art. 609-bis») farebbe confluire anche l’abuso del potere parenterale in quello di autorità. Tale argomentazione intesa a salvaguardare la coerenza normativa del sistema, individua come unica strada percorribile la qualificazione dell’autorità menzionata nell’art. 609-bis come avente natura pubblicistica e riconoscere al potere di cui al 609-quater, invece, connotazione privatistica.
La giurisprudenza di legittimità è rimasta impermeabile a questa lettura dell’espressione abuso di autorità per oltre un decennio dall’entrata in vigore della legge del 1996. Solo dal 2008 si fa strada una corrente giurisprudenziale di più ampio respiro, che trova terreno fertile in un’evoluzione, già da tempo in atto, del sentire sociale protesa ad ampliare la sfera di tutela del soggetto passivo.
Il secondo orientamento pretorio, avallato dalla dottrina prevalente[11], dilata la portata del significato di autorità di cui al 609-bis c.p. sino a farvi rientrare «ogni relazione, anche di natura privata, in cui l’autore del reato riveste una posizione di supremazia della quale si avvale per coartare la volontà della persona offesa». È quanto affermato dalla Cassazione nel 2009[12], con un primo (molto timido) cambio di rotta rispetto al passato, senza, tuttavia, manifestare un esplicito dissenso rispetto alle precedenti decisioni. Bisognerà attendere il 2012 per la sentenza[13] che traccerà, in modo specifico, un primo effettivo confronto con l’opposto orientamento. Ad essa faranno seguito altre pronunce[14] che si pongono in linea con quest’ultima decisione e che contribuiranno, in maniera decisiva, a delineare le coordinate della opzione interpretativa alternativa, che muove dalla confutazione dei principali argomenti adottati dal primo indirizzo esposto.
In primo luogo, tale filone giurisprudenziale smentisce la prospettata continuità normativa tra la nuova fattispecie recata nell’art. 609-bis e quella dell’abrogato art. 520 c.p., assumendo a fondamento del proprio ragionamento il concetto di “autorità” così come espresso dall’articolo 61 n. 11 c.p. Detta disposizione, che include tra le aggravanti comuni il fatto di realizzare la condotta criminosa con abuso di autorità, è sempre stata interpretata dalla giurisprudenza in modo molto ampio, tale da ricomprendere sia posizioni autoritative pubblicistiche sia posizioni di natura privata. Peraltro, laddove il legislatore ha voluto qualificare come pubblica una posizione autoritativa, lo ha indicato expressis verbis, come era accaduto nell’art. 520 e come oggi accade nel caso del 608 c.p. (che fa esplicito riferimento al “pubblico ufficiale”).
In secondo luogo, avverso le argomentazioni secondo le quali l’interpretazione estensiva del concetto di autorità di cui all’articolo 609-bis c.p. porterebbe all’abrogazione implicita dell’articolo 609-quater, co.2, c.p., si è evidenziato non solo l’utilizzo di formule diverse – “abuso di autorità” nel primo caso, “abuso di poteri” nel secondo – ma anche, soprattutto, la diversità ontologica tra le due fattispecie, che vale a conferire loro un distinto ambito di operatività. Viene fatto rilevare, a tale proposito, che mentre nell’abuso di autorità l’atto sessuale è frutto di «costringimento», nell’ipotesi di cui al 609-quater, l’atto è viceversa consensuale, ancorché il legislatore presuma tale consenso viziato ex ante per l’esistenza di particolari circostanze[15]. Non a caso, il bene giuridico tutelato da quest’ultima fattispecie non è la libertà di autodeterminazione del minore bensì la sua integrità fisico-psichica nella prospettiva di un corretto sviluppo della sua sessualità.
3.1. La decisione delle Sezioni Unite
Al termine della disamina giurisprudenziale sopra sintetizzata, e tenuto conto delle argomentazioni poste a sostegno dei due orientamenti, le Sezioni Unite, con la sent. 27326/2020, hanno ritenuto non (più)[16] condivisibile un’interpretazione restrittiva del concetto di abuso di autorità.
I giudici di legittimità, recependo e in parte arricchendo le ragioni addotte dall’orientamento estensivo, hanno formulato il seguente principio di diritto: «l’abuso di autorità cui si riferisce l’art. 609-bis co.1 c.p. presuppone una posizione di preminenza, anche di fatto e di natura privata, che l’agente strumentalizza per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali».
Più nello specifico, l’opera ermeneutica del quid consistam l’abuso di autorità si snoda attraverso due successivi passaggi argomentativi: il primo volto a stabilire se l’autorità rilevante ai sensi dell’art. 609-bis c.p. debba avere natura esclusivamente pubblica o anche privata; il secondo concernente la fonte, necessariamente legale o anche fattuale, da cui l’autorità discende.
Sotto il primo profilo, le Sezioni Unite muovono dall’effetto, ossia la costrizione promanante dalle condotte (violenza, minaccia, abuso di autorità) tipizzate al comma 1 del 609-bis c.p., per poi risalire alla causa, individuandola, per quanto attiene all’abuso di autorità, in una «vera e propria condizione di sudditanza materiale o psicologica ma non psichica e, quindi, di origine patologica in senso stretto»[17]. In questo senso, deve ritenersi riconducibile all’abuso di autorità qualsiasi posizione di supremazia, pubblica o privata, causalmente efficiente a realizzare il risultato coercitivo.
Ciò pare confermare una prassi interpretativa orientata, ormai, a dilatare il concetto di violenza, polarizzandolo più sul risultato della condotta (lo stato di coazione) che sulle modalità violente, sì da valorizzare anche le ipotesi di dissenso implicito o addirittura meramente potenziale della parte offesa[18], come pure di giungere all’affermazione di responsabilità nel caso in cui intervenga una revoca del consenso, qualora il soggetto attivo non interrompa l’atto sessuale divenuto non consensuale.
Tale risultato, seppur meritorio in termini di effettività della tutela, consentirà di sollevare qualche dubbio nelle considerazioni conclusive in ordine al rischio, verosimile nei fatti, di trasformare la figura delittuosa in commento in un reato a condotta libera.
Nel prosieguo del ragionamento della Corte viene poi richiamato l’argomento storico, incentrato sul confronto con le disposizioni abrogate di cui agli artt. 519 e 520 c.p.[19], impiegate dalle Sezioni Unite del 2000 per sostenere esattamente la tesi opposta (cioè che per autorità si intende quella di stampo pubblicistico). L’odierna sentenza smentisce quella vecchia lettura, accentuando che il nuovo art. 609-bis non è parente prossimo, né deve esserlo, delle disposizioni previgenti. Invero, la collocazione del nuovo art. 609-bis tra i reati contro la libertà personale e la sua qualificazione come delitto comune starebbero ad indicare – secondo i giudici di legittimità – la volontà legislativa di ampliare le maglie della punibilità del reato in esame, svincolandolo dal riferimento alla figura del pubblico ufficiale, di cui al previgente art. 520 c.p.
Dopo il richiamo al dato storico, la Corte procede su un piano letterale e sistematico. In primo luogo, osserva che se il legislatore del ’96 all’art. 609-bis avesse voluto riferirsi alla sola autorità pubblica avrebbe dovuto espressamente dirlo, come ha fatto nel caso dell’art. 608 c.p. concernente “abuso di autorità contro arrestati o detenuti” il quale richiede in capo all’agente la qualifica di pubblico ufficiale. Successivamente, la Corte rimanda ad altre disposizioni penali – artt. 61 n. 11) c.p., 571, 600-octies, 600 e 601 – onde evidenziare come il concetto di autorità sia altrove già inteso in senso ampio, come pacificamente comprensivo anche di posizioni di preminenza non pubblicistica.
Quanto alla paventata sovrapposizione tra 609-bis e la fattispecie di cui all’art. 609-quater co. 2 c.p., i giudici di legittimità fondano la loro confutazione, oltre che sulla presenza della clausola di riserva espressa, contenuta nel co. 1 e ribadita nel co. 2 del 609-quater, sulla diversità delle azioni punite dalle due norme incriminatrici: l’art 609-bis si riferisce all’abuso di autorità; l’art 609-quater co. 2 all’abuso di poteri. Tali locuzioni, lungi dall’essere equipollenti, avrebbero, infatti, un proprio e distinto significato semantico, rievocando quella ricostruzione giurisprudenziale[20] secondo cui l’abuso di autorità consiste in una strumentalizzazione della dimensione soggettiva dell’autorità; l’abuso di potere, invece, in una strumentalizzazione della dimensione oggettiva, funzionale dei poteri connessi alla posizione.
Quest’ultima argomentazione, benché autorevolmente sostenuta, non sembra cogliere al meglio l’essenza della distinzione, giacché il concetto di abuso di autorità, proprio per l’effetto costrittivo che ingenera nella vittima, ingloba di per sé anche l’abuso di potere, declinandosi in concreto in un esercizio distorto dei poteri connessi alla posizione di supremazia. Piuttosto, il riferimento alla strumentalizzazione della dimensione soggettiva appare maggiormente pertinente all’ultronea espressione “abuso della qualità”[21].
Quanto detto sembra essere ulteriormente avvalorato dalla stessa sentenza allorché, ai fini del perfezionamento della fattispecie, impone la concreta dimostrazione di un’«arbitraria utilizzazione del potere»[22] confutando, così, a distanza di pochi capoversi, l’affermata diversità semantica e applicativa delle due formule.
Aderendo alla tesi più ampia per cui l’abuso è configurabile anche in presenza di un’autorità privata, resta da capire quale sia la fonte da cui il soggetto attivo deve attingere la propria autorità.
In altri termini: è necessario che tale autorità abbia una derivazione giuridica o è sufficiente una mera autorità di fatto sul soggetto passivo?
È questo il secondo passaggio argomentativo con cui la Corte si confronta. Ebbene, in chiusura, le Sezioni Unite precisano il loro approdo ermeneutico, affermando che l’autorità privata il cui abuso integra la condotta sanzionata dall’art. 609-bis c.p. può anche non derivare da una espressa previsione di legge ed essere, dunque, un’autorità di fatto, comunque determinatasi. La conclusione, a detta della corte, risulta coerente con le premesse in quanto, se ad avere rilevanza è la «coartazione della volontà della vittima, posta in essere da una posizione di preminenza, la specifica qualità del soggetto agente resta in secondo piano rispetto alla strumentalizzazione di tale posizione, quale ne sia l’origine».
La Corte, sciogliendo il nodo interpretativo sottoposto alla sua attenzione, conclude quindi per la configurabilità in capo all’imputato del reato di violenza sessuale con abuso di autorità, aggravato dall’età inferiore ai quattordici anni delle due vittime.
4. Conclusioni
Le Sezioni Unite, con la sentenza in commento, accolgono una nozione estremamente ampia di abuso di autorità, richiamando un iter interpretativo-motivazionale che, pur astrattamente convincente sul piano logico, non dissipa in concreto ogni perplessità.
Più nello specifico, del tutto condivisibile appare l’opzione per un’accezione lata del concetto di autorità non circoscritta esclusivamente a quella pubblica. Militano, in questa direzione, una pluralità di argomenti, a partire dalla ratio legis. Invero, dai lavori preparatori della riforma del ’96 emerge chiaramente che l’obiettivo politico-criminale perseguito dal legislatore era quello di apprestare un’ampia tutela ai soggetti in posizione di debolezza rispetto a chi possa esercitare nei loro confronti un potere di supremazia, al fine di indurli all’atto sessuale[23]. In secondo luogo, a confortare tale interpretazione estensiva si aggiungerebbe il dato normativo: la mancata previsione di alcun attributo alla tipologia di autorità è, già di per sé, elemento escludente della volontà legislativa di porre un limite. Si potrebbe a ciò obiettare che l’autorità è, par excellence, quella statuale di stampo pubblicistico; nondimeno, tale circostanza nulla toglie alla possibilità di ricomprendere sotto l’ampio ombrello del concetto di autorità anche relazioni che, pur avendo natura eminentemente privatistica, replicano quel rapporto di potestà-soggezione che costituisce essenza stessa di autorità. Del resto, ciò che rende un’autorità tale sono «l’insieme dei poteri, conferiti dalla legge ad un soggetto, che lo pongano in una situazione giuridica di preminenza nei confronti di altro soggetto»[24]. Ecco allora che autorità ben può essere anche quella privata, ma a condizione che sia munita di poteri giuridicamente fondati, delimitati e apprezzabili, e non fattuali, idonei a determinare un rapporto asimmetrico tra le parti. Si pensi, al riguardo, alla condizione di supremazia del datore di lavoro, del responsabile di un pool aziendale o comunque del superiore in ambito lavorativo e ai connessi poteri disciplinati dal codice civile, dalla contrattazione collettiva e da quella individuale[25]. Come pure alla condizione di sovra-ordinazione del direttore penitenziario o del cappellano nei confronti del detenuto; o ancora, al ruolo rivestito dall’allenatore di una squadra sportiva che, sulla base delle regole previste dalla federazione di appartenenza e dalla l. 91/1981, vanta poteri di direzione, di controllo tecnico e di valutazione nei confronti dell’atleta professionista. Analogamente a quanto accade in relazione all’abuso di autorità del pubblico ufficiale, anche qui potranno configurarsi ipotesi di costrizione abusiva. Infatti, la paura del lavoratore di perdere il posto o la disperata speranza del detenuto di essere trasferito in una cella migliore possono in certi casi essere assimilabili al timore della prostituta di essere denunciata dal poliziotto o alla preoccupazione dell’alunno di essere valutato negativamente, financo bocciato, dall’insegnante scolastico.
Di converso, affermare – come la Corte ha fatto – che l’autorità privata di cui il soggetto abusa può promanare anche da una mera posizione de facto sbilanciata, quale sarebbe quella assunta dall’insegnante privato[26], indurrebbe a ravvisare l’autorità ovunque, persino nella posizione (per nulla apprezzabile) del capo mafioso, conducendo verosimilmente ad una confusione tra i concetti di “abuso di autorità” di cui al 609-bis c.p. e “abuso di poteri” di cui al 609-quater c.p., dalla stessa Corte ritenuti etimologicamente differenti.
È indubbio che la Corte, nell’elaborazione di tale segmento motivazionale, si sia ispirata alle intenzioni più nobili: polarizzare il disvalore sul solo effetto costrittivo dell’abuso, prescindendo dall’origine del potere, significa massimizzare la tutela della libertà sessuale della persona che la legge persegue. Eppure, sembra aver sottovalutato la circostanza che se è vero che non può esistere un’autorità senza poteri, non è, però, vero il contrario[27].
Il possesso di meri poteri fattuali, non giuridicamente conferiti, posizionerebbe il soggetto titolare dei medesimi in una posizione di autorevolezza più che di autorità strictu sensu, il cui abuso striderebbe con la tipicità delle condotte modali costrittive richieste per la configurazione della fattispecie di violenza sessuale.
Il confine è labile, ma esiste e va tracciato, al fine di evitare una lettura ablativa della tipicità del reato di cui 609-bis c.p. che porterebbe ad interpretarlo come se punisse «chiunque costringe taluno a compiere o subire atti sessuali». È questo, forse, l’aspetto più critico del ragionamento della Corte, che restituisce una fattispecie incriminatrice non diminuita di quel coefficiente di indeterminatezza e genericità con cui è nata[28].
Auspicabile, pertanto, è un intervento legislativo che miri a chiarire la fonte da cui il soggetto attivo debba attingere la propria autorità, tanto più necessario e urgente in una materia – quale quella sessuale – così delicata e complessa che giammai può lamentare un tale vulnus.
Del resto, dire che per la configurazione dell’abuso è necessaria un’autorità che abbia derivazione giuridica o è sufficiente una mera autorità di fatto sul soggetto passivo, comporta una consistente variazione dei comportamenti penalmente rilevanti e, invero, non spetterebbe all’ordine giudiziario in sede di interpretazione ed applicazione della norma operare tali importanti scelte di politica criminale.
[1] Cass., Sez. Un., 31.05.2000, n. 13, in Cass. pen., 2001.
[2] Tale mutamento è da ricondurre sostanzialmente al movimento del ’68 e al sorgere del c.d. femminismo. In questi termini: Mulliri, Le legge sulla violenza sessuale. Analisi del testo, primi raffronti e considerazioni critiche, in Cass. pen., 1996, pp. 734 e ss.
[3] Alla violenza e alla minaccia facevano già espressamente riferimento gli abrogati artt. 519 e 521 c.p.
[4] Come evidenziato da Palumbieri, Violenza sessuale, in Cadoppi-Canestrari-Papa, I reati contro la persona, vol.III, 2006, p. 74: la costrizione psichica «non deve trasmodare nella minaccia, altrimenti non saremmo in presenza di una modalità alternativa alla stessa».
[5] Così, Cadoppi, Art. 609 bis, in Cadoppi (a cura di), Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia, Padova, 2006, p. 512; in termini analoghi Palumbieri, Violenza sessuale, ibidem.
[6] Beltrani – Marino, Le nuove norme sulla violenza sessuale, Napoli, 1996, p. 40; Borgogno, Il delitto di violenza sessuale, in Coppi (a cura di), I reati sessuali. I reati di sfruttamento dei minori e di riduzione in schiavitù per fini sessuali, Torino, 2007, p. 120.
[7] Per quel che riguarda la vicenda oggetto di rimessione non bisogna trascurare che, poiché il fatto è stato commesso prima dell’inasprimento delle sanzioni previste dalla l. 69/2019 (c.d. “Codice rosso”), al reo deve essere applicata la disciplina più favorevole vigente al momento del fatto, ai sensi dell’art. 2, co. 4, c.p. Pertanto, secondo la valutazione che fa leva sulla fattispecie dell’art. 609-bis c.p., aggravato dal dettato dell’art.609-ter c.p., la pena sarebbe stata della reclusione da sei a dodici anni, mentre facendo leva sulla fattispecie di cui all’art. 609-quater, la pena sarebbe stata della reclusione da cinque a dieci anni. Cfr., sul punto, Pittaro, Le Sezioni Unite definiscono l’abuso di autorità nel reato di violenza sessuale, in http://ilpenalista.it/, 2 novembre 2020.
[8] Cass., Sez. III, ord. 4.10.2019 (dep. 24 gennaio 2020), n. 2888, in Sistema penale, con nota di Finocchiaro, L’abuso di autorità dell’insegnante privato tra violenza sessuale (art. 609-bis) e atti sessuali con minorenne (art. 609-quater): la parola alle Sezioni unite, 20 febbraio 2020.
[9] Cass., Sez. III, 07.10.1999, Colafemmina, in Giust. Pen., 2000, p. 557, ed in Cass. pen., 2001, p. 1224, con nota di De Amicis, Sulla configurabilità del concorso fra i delitti di concussione e violenza sessuale con abuso d’autorità: in cui, costituisce abuso di autorità la condotta di un ufficiale comandante di un battaglione dell’esercito, il quale strumentalizzi la sua posizione di preminenza nella gerarchia militare. In senso restrittivo, anche parte (minoritaria) della dottrina: v. Borgogno, Il delitto di violenza sessuale, cit., pp. 121 e ss.
[10] Ex multis: Cass., Sez. III, 19.06.2002, n. 32513, in CED, N. 223101; Cass., Sez. III, 11.10.2011, n. 2681; Cass., Sez. IV, 19.01.2012, n. 6982; Cass., Sez. III, 04.10.2012, n. 47869, in Cass. pen., 2013, p. 3996; Cass., Sez. III, 24.03.2015, n. 16107, in Cass. pen., 2015, p. 4476.
[11] In tal senso, ex multis: Antolisei, Diritto penale, Parte speciale, I, Milano, 2016; Mantovani, in Diritto penale, Parte speciale, Milano, 2019, p. 454; Romano, Delitti contro la sfera sessuale della persona, Padova, 2009, p. 106; Cadoppi, Art. 609 bis, cit., p. 507-509; Fiandaca, Violenza sessuale, in Enc. dir., Agg. IV, cit., p. 1159; Mattencini, I reati contro la libertà sessuale, Milano, 2000, p. 69; Balbi, voce Violenza sessuale, in Enc. Giur., agg 1999, p. 10.
[12] Cass., Sez. III, 03.12.2008 (dep. 2009), n. 2119, M., Rv 242306 – 01.
[13] Cass., Sez. III, 19.04.2012, n. 19419, S, Rv. 252768 – 01.
[14] Cass., Sez. III, 27.03.2014, n. 36704, A, Rv. 260172 – 01; Sez. III, 30.04.2014, n. 49990, G, Rv. 261594 – 01.
[15] La minore età (609-quater co. 1 n.1); i particolari rapporti con il colpevole (609-quater co. 1 n.2).
[16] Ponendosi in netta antitesi con la precedente citata decisione n. 13/2000.
[17] Cass., Sez. Un., 16.07.2020, n. 27326, p. 12.
[18] Mattencini, I reati contro la libertà sessuale, cit., p. 66; v. anche Cass., Sez. III, 5.10.15, n. 39865, in Cass. pen., 2016, p. 771.
[19] Ove si faceva espresso riferimento al pubblico ufficiale quale soggetto attivo del reato.
[20] Cass., Sez. III, 08.03.2016, n. 33042, Rv. 267453.
[21] Sul punto, Mantovani, in Diritto penale, Parte speciale, cit., p. 454.
[22] Cass., Sez. Un., 16.07.2020, n. 27326, p. 15.
[23] A cominciare dai contesti segnatamente privatistici, quali i rapporti di lavoro e di famiglia. Così: Palumbieri, Violenza sessuale, cit., p. 7.; Musacchio, Il delitto di violenza sessuale, Padova, p. 46.
[24] Il passo tra virgolette è tratto da Mantovani, Diritto penale, Parte speciale, cit., p. 454;
[25] Poteri leciti, quando non addirittura doverosi, che vanno dal richiamo formale al licenziamento. In proposito, si è anche affacciata l’ipotesi che la nuova fattispecie possa fungere da strumento normativo surrettizio per punire almeno le più gravi forme di molestie sessuali, il cui ambiente tipico è proprio il mondo del lavoro. Cfr. sul punto: Cadoppi, Art. 609 bis, cit., p. 511.; concorda Proverbio, in Marinucci-Dolcini (a cura di), Codice penale commentato, p. 3173.
[26] Ruolo che non sembra conferirgli alcun potere disciplinare o valutativo tale da renderlo, diversamente dai docenti scolastici, un’autorità agli occhi degli alunni.
[27] Balbi, voce Violenza sessuale, cit., p. 11.
[28] Particolarmente dure le critiche di Pecoraro-Albani, Violenza sessuale e arbitrio del legislatore, Napoli, 1997, p. 92 e p. 126, il quale ritiene la presente ipotesi criminosa - definita un «non senso giuridico» - un vacuum che non consente di cogliere la voluntas legis.
Il fenomeno dei non performing loans in Italia, i tempi della giustizia e l'impatto del Covid-19
di Francesco Passaretti
Sommario: 1. Premessa - 2. Definizione di Non Performing Loans - 3. Evoluzione dei Non Performing Loans in Italia - 4. La cartolarizzazione e la GACS - 5. I tempi della giustizia - 6. L’impatto del Covid-19 - 7. Conclusioni.
1. Premessa
“Eba: «Banche più solide e con meno Npl» (prima del Covid-19)”, così titola un articolo de “Il Sole 24 Ore” dell’8 giugno 2020.
Il fenomeno dei Non Performing Loans, o credito deteriorato, è stato a lungo al centro del dibattito sui problemi dell’Eurozona: nel momento di maggior picco si registravano oltre 1000 miliardi di NPL in Europa, oltre 300 miliardi solamente in Italia.
All’esito dei molti studi ed analisi che hanno riguardato il fenomeno, è emersa la stretta correlazione tra la qualità del credito (e quindi livello di NPL) e le performance economiche di una dato Paese.
A partire dalla crisi economica mondiale del 2008, il tema della qualità del credito è stato oggetto di numerosi interventi normativi sia a livello comunitario che statale di recepimento, ma ancora oggi la questione ad esso sottesa si mostra nodale ai fini di una solida ripresa economica su vasta scala.
Come si evince dalla lettura del prefato articolo de “Il Sole 24 ore”, la problematica dei Npl, dopo svariati anni di normative e interventi volti a contenere e a ridurre l’eccessivo stock di Npl ‘in pancia’ agli istituti finanziari si andava numericamente ridimensionando.
L’esplosione della pandemia da Covid-19, l’insorgenza di uno stato generale di emergenza, la conseguente crisi economica causata dalla chiusura delle attività produttive e commerciali del Paese, l’abbattimento dei consumi per il ben noto lockdown totale, l’insorgenza della seconda ondata della malattia che ha inesorabilmente contratto la ripresa economica che si andava registrando, sta portando e porterà senza nessun dubbio a una crescita importante dei Npl.
Arduo è il compito che aspetta il Governo Centrale Europeo e le Autorità Nazionali nella gestione della nuova crisi economica. Tutti insieme chiamati a scongiurare, tra l’altro, i rischi connessi all’appesantimento dei bilanci delle banche con le partite del credito deteriorato, grande ostacolo alla ripresa economica e alla crescita di un Paese.
2. Definizione di Non Performing Loans
L’articolo 10 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.) definisce l’attività bancaria come segue:
“1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito costituiscono l’attività bancaria. Essa ha carattere d’impresa.
2. L’esercizio dell’attività bancaria è riservato alle banche.
3. Le banche esercitano, oltre all’attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.”[1]
Una delle attività ‘core’ delle banche per la generazione di reddito è l’erogazione di prestiti, che rappresenta uno dei maggiori indicatori del loro sviluppo dimensionale. Di contro, però, l’esercizio di tale attività creditizia configura un rischio tipico d’impresa. Motivo per il quale è necessario un monitoraggio dell’andamento dei finanziamenti costante da parte della banca per verificare lo stato di salute dei suoi crediti.
Secondo una prima e generica classificazione, i crediti possono essere suddivisi in due categorie:
- Crediti in bonis (positivi): caratterizzati da una elevata sicurezza di puntuale adempimento da parte del debitore.
- Crediti deteriorati o Non performing loans (negativi): per i quali, invece, la riscossione è incerta e causata da un costante stato di instabilità finanziaria e patrimoniale del debitore. Incertezza sia in merito al rispetto della scadenza, sia in merito all’ammontare dell’esposizione.
Il credito deteriorato è una macrocategoria che racchiude in sé stessa diverse tipologie e definizioni di crediti ai quali pertengono diversi gradi di deterioramento in base a scadenza, difficoltà del debitore e ammontare dell’esposizione.
La definizione regolamentare di credito deteriorato è attualmente disciplinata dalle disposizioni introdotte a livello comunitario dall’European Banking Authority (EBA). Il processo di omogeneizzazione condotto dell’EBA risale al 2013 e culmina con la pubblicazione del documento EBA «Final Draft Implementing Technical Standards On Supervisory reporting on forbearance and non-performing exposures under article 99(4) of Regulation (EU) No 575/2013».
La ratio sottesa all’intervento adottato a livello comunitario dall’EBA è stata quella di rendere i bilanci delle Banche europee, e nello specifico l’attivo patrimoniale, comparabili tra di loro. Prima dell’intervento dell’EBA, infatti, era impraticabile non solo il confronto tra i volumi di NPL, ma anche il raffronto e l’analisi tra banche dei diversi Paesi.
Per rendere omogenea la valutazione approfondita della qualità degli attivi bancari attraverso l’Asset Quality Review, l’European Banking Authority (EBA) ha elaborato degli Implementing Technical Standard (ITS) relativi agli NPLs, successivamente adottati dalla Commissione europea con il regolamento UE n. 227/2015.
Secondo la definizione introdotta dall’EBA, le attività finanziare deteriorate sono suddivise in due principali categorie:
- Non-Performing Exposures (NPEs), ossia le esposizioni creditizie deteriorate che si suddividono in: sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.
- Non-Performing Exposures with forbearance measures, ossia le esposizioni oggetto di concessioni. Le concessioni forbearance sono delle modifiche alle condizioni del contratto originale della linea di credito concessa dalla banca al suo cliente. Per esempio, una modifica può essere l’abbassamento degli interessi del finanziamento, oppure un allungamento del periodo di ammortamento del prestito. In tal caso la controparte è già classificata in una delle sottocategorie di crediti deteriorati al momento della concessione o la concessione comporta una classificazione della controparte tra i crediti deteriorati.
Tali novità introdotte dall’EBA sono state recepite da Banca d’Italia con la circolare n.272 del 30 luglio 2008 (Fascicolo «Matrice dei conti») - 7° aggiornamento del 20 gennaio 2015.
Esistono quindi due condizioni necessarie che un’esposizione deve soddisfare per essere inserita all’interno delle NPEs (ovviamente l’esposizione può soddisfare entrambe ma anche una sola condizione):
1) Il perdurare di uno scaduto (past due) per oltre 90 giorni – da intendersi continuativo e non cumulabile per periodi intermedi parziali;
2) il soggetto finanziato non è in grado di fare fronte integralmente agli obblighi assunti, indipendentemente dal ritardo nel pagamento, a prescindere se si decida o meno di rifarsi sul collaterale[2].
3. Evoluzione dei Non Performing Loans in Italia
Il tema dei Non Performing Loan è fondamentale per l’economia dell’intero Paese: livelli elevati di crediti deteriorati hanno impatti negativi sul clima generale di fiducia nei confronti del sistema bancario, causando un incremento del costo della raccolta e del capitale per gli istituti di credito. Inoltre, tanto più sono elevati gli stock di NPL, tanto più gli istituti finanziari devono predisporre accantonamenti a bilancio elevati volti a coprire le perdite attese (il principio contabile in vigore dal 1 gennaio 2018 è l’IFRS 9, International Financial Reporting Standard 9, basato sulle Expected losses). Accantonamenti troppo elevati possono ridurre la liquidità delle banche, e quindi la loro capacità di perpetuare l’attività di lending, ovvero di concessione di prestiti, generando quindi il cosiddetto fenomeno del credit crunch, con annessa contrazione dei consumi e degli stimoli alla crescita.
L’Italia è il paese il cui sistema bancario detiene e ha detenuto lo stock di Non Performing Loans più elevato d’Europa. Tra il 2015 e il 2016, periodo in cui si è toccato il massimo picco, degli oltre 1000 miliardi di NPLs presenti in Europa, oltre 300 miliardi erano detenuti dall’Italia.
L’impatto della crisi economica, intervenuta in due momenti distinti nell’Unione Europea, è stato assorbito dall’apparato bancario italiano in maniera differente: la prima crisi mondiale (2007-2009) è stata gestita con successo, avendo il nostro sistema retto rispetto a quello degli altri Paesi, grazie probabilmente alla scarsa propensione degli intermediari a sottoscrivere ‘Asset Backed Securities’[3] o altri titoli derivanti da cartolarizzazione, prediligendo invece attività di prestito più tradizionali. Nonostante ciò, i problemi stutturali del “Bel Paese”, congiuntamente al protrarsi della recessione, hanno portato ad un graduale accumulo di NPLs fino a raggiungere nel 2014 il punto massimale del NPL ratio (NPL ratio = Volume di Npl/Volume totale di prestiti erogati) del 17% (media europea: 6,5%). La seconda ondata della crisi economica è riconducibile alla struttura e mole del debito pubblico (crisi dei debiti sovrani dei PIIGS) che ha generato un rallentamento generale dell’economia e dunque un incremento dell’insolvenza, con influenze negative sul sistema bancario nel suo complesso.
Osserviamo quindi l’andamento dello stock di NPL in Italia:
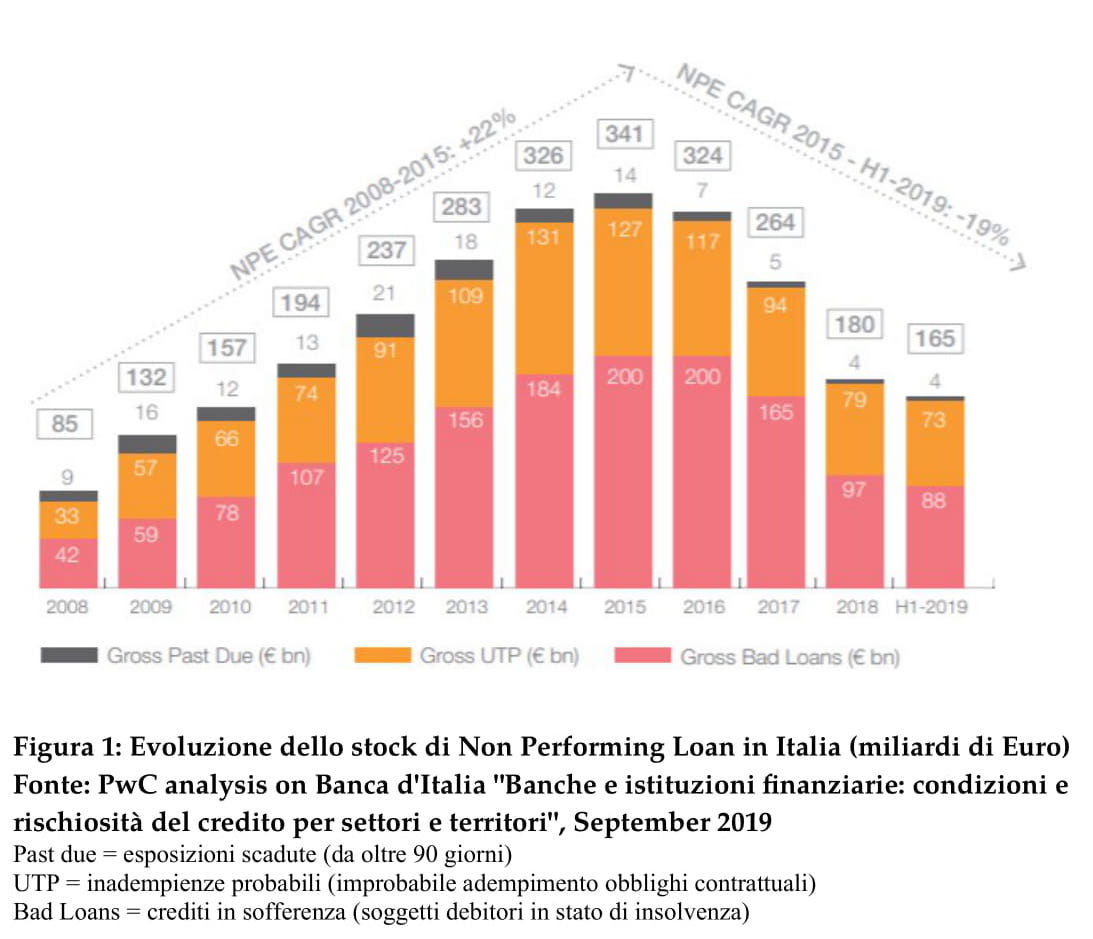
Nel corso del 2016, per la prima volta dopo diversi anni, gli istituti di credito italiani hanno ridotto lo stock dei Non Performing Loan detenuti in portafoglio, trend proseguito poi nel corso del 2017. Tale tendenza è stata principalmente sostenuta da importanti piani di deleveraging intrapresi dalle principali banche italiane per soddisfare le richieste delle autorità di vigilanza e le aspettative degli investitori. Volume di Npl/Volume totale di prestiti erogati.
4. La cartolarizzazione e la GACS
Lo strumento della cartolarizzazione, o securisation, dopo essere stato individuato come uno dei principali responsabili della crisi economica mondiale in ragione dell’utilizo sconsiderato che se ne fece, è oggi nuovamente apprezzato in maniera positiva, come un meccanismo potenziale per favorire il trasferimento dei rischi e per incrementare la capacità delle banche di liberare risorse ulteriori da destinare al finanziamento dell'economia, ossia, di fatto, un “ponte” naturale tra il credito di origine bancaria e la finanza basata sul mercato.
Per favorire lo smobilizzo di NPLs e incentivare il mercato delle cartolarizzazioni di crediti deteriorati è stato approvato, nel febbraio 2016, un provvedimento riguardante la disciplina in materia di garanzia pubblica per le cartolarizzazioni (GACS). Le GACS sono garanzie concesse dallo Stato, in conformità a decisioni della Commissione europea, finalizzate ad agevolare lo smobilizzo dei crediti in sofferenza dai bilanci delle banche e degli intermediari finanziari aventi sede legale in Italia. La garanzia è concessa dal Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) sulle passività emesse nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione (art. 1 L. 130/1999), a fronte della cessione da parte delle banche dei crediti in sofferenza a una Società veicolo (“SPV”). La GACS - incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta – copre i detentori dei Titoli “senior” per l’ipotesi di mancato pagamento delle somme dovute per capitale e interessi.
Il decreto-legge 14 febbraio 2016, n.18, convertito, con modificazione, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, recante disciplina in materia di garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS), è stato introdotto per incentivare il mercato delle classi senior derivanti da operazioni di securisation e per ridurre il bid/ask spread delle cessioni di crediti.
Il tenore testuale del Decreto è chiaro e lascia quindi poco spazio all’interpretazione (in claris non fit interpretatio), dettando criteri precisi riguardanti struttura, tranching, rating, attività di servicing, caratteristiche dei titoli e prezzo di cessione, così da rendere rapido il processo di analisi per una più celere concessione della garanzia statale.
Il funzionamento di una cartolarizzazione con GACS procede in maniera identica rispetto a un’operazione di cartolarizzazione tradizionale, con l’unica peculiarità della presenza di un nuovo ‘attore’, il MEF, il quale concede la garanzia sulla tranche senior, a fronte di una commissione annua.
Entrata in vigore il 3 agosto 2016, la GACS ha contribuito allo smaltimento di portafogli NPL per un valore cumulato di 73 miliardi di euro tramite, ad oggi, 27 operazioni. La GACS può essere definita come lo strumento principale implementato dal governo italiano per favorire lo smaltimento di NPL; a tale rigiuardo si può chiaramente osservare, nella precedente Figura 1, come l’introduzione della GACS coincida con il turning point e con l’inversione della tendenza del grafico in analisi .
5. I tempi della giustizia
In Italia i tempi estremamente dilatati della Giustizia costituiscono una tra le principali determinanti di un tale aumento incontrollato dei NPL: tempi di giustizia lunghi riflettono un rallentato recupero dei crediti in sofferenza[4], costi maggiori ma anche effettive possibilità di recupero più basse. Il caso italiano è emblematico: secondo i dati riportati nel rapporto della Banca Mondiale, l’Italia occupa la posizione 108 del ranking in tema di ‘recupero del credito per via giudiziaria’. In Italia sono necessari 1.120 giorni per la riscossione coattiva di un credito, a fronte dei 395 giorni della Francia, dei 437 giorni del Regno Unito e dei 499 giorni della Germania.
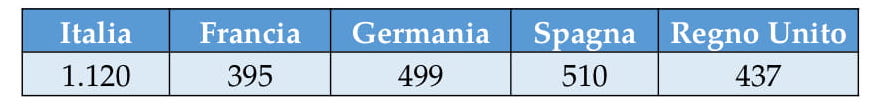
Figura 2: Tempo recupero crediti (giorni necessari)
Fonte: elaborazione personale su dati Banca Mondiale ‘Doing Business 2018’
Secondo stime della Banca d’Italia, a parità di flussi di nuovi crediti deteriorati sottoposti a procedure giudiziali, la lentezza dei procedimenti causa in Italia una crescita anomala dei Non Performing Loan e uno stock quasi doppio di NPL rispetto alla media europea. Una riduzione significativa dei tempi della giustizia civile potrebbe favorire l’accelerazione dello smaltimento dello stock dei crediti deteriorati e il miglioramento dell’andamento dei Non Performing Loan. La riduzione dei tempi delle procedure esecutive porterebbe a un più rapido smaltimento di NPL ed è un driver fondamentale su cui intervenire. Si prenda a confronto il sistema-Paese Spagna, ove si sono portate a compimento procedure di sfratto, con relativo rilascio degli immobili, prescindendo totalmente da logiche di salvaguardia sociale delle categorie di debitori più deboli (famiglie con bambini con handicap, anziani, letteralmente lasciati per strada) ed ancor prima che che fosse concluso il processo esecutivo (separato giudizio di merito). Se da un lato tale modus operandi spagnolo è stato sanzionato dalla Corte di Lussemburgo e ha causato gravi ripercussioni sociali (oltre 400.000 pignoramenti tra il 2008 e il 2012 che hanno portato a un’ondata di suicidi che scosse l’opinione pubblica), dall’altro tale strategia ha permesso un rapido recupero degli NPL che non hanno più pesato sulle performance dello Stato, che infatti è tornato a crescere su livelli notevoli, con picchi oltre il 4% di crescita del PIL, già dal 2014. Per capire meglio questo dato si consoderi che la variazione del PIL italiano è stata del +0,8% nel 2018, +0,2% nel 2019)
6. L’impatto del Covid-19
L’Emergenza Coronavirus è scoppiata in Italia lo scorso 21 Febbraio con l’individuazione del primo focolaio di Covid-19 in Italia, a Codogno. Si è sperato in un primo momento di poter arginare l’epidemia isolando la zona interessata. Ben presto si è visto che intere Regioni, specialmente la Lombardia, stavano per essere travolte da un vero e proprio tsumani sanitario. A marzo 2020, l'Italia è risultata essere colpita più duramente che qualsiasi altro paese in Europa dalla pandemia di Covid-19. Dopo un rigido lockdown, la pandemia sembrava domata seppure non sconfitta. A seguito di una estate, durante la quale i comportamenti di molti, in tutta Europa, si sono attestati su comportamenti poco improntati alla prudenza, già da settembre 2020 si è assisitito ad una graduale recrudescenza del virus, queta volta, prima in Francia, Spagna, Inghilterra e successivamente anche in Italia. Con il Dpcm del 13 ottobre si apre la stagione normativa inerente la “seconda ondata”: mascherine obbligatorie e alcune chiusure fanno da preludio al coprifuoco e a una massiccia chiusura di attività sancite con il diciannovesimo Dpcm entrato in vigore il 6 novembre.
Alla data del 20/11/2020 in Italia sono stati registrati 1.345.767 casi positivi di coronavirus, di cui 520.022 persone guarite e 48.569 persone decedute. L’incremento dei contagi giornalieri supera costantemente i 30.000 casi e le strutture ospedaliere stentano ad assorbire l’enorme numero di richieste di ricovero nei reparti ordinari, sub-intensivi e di terapia intensiva, ormai ad un livello di saturazione preoccupante.
La situazione economica del nostro Paese è drammatica. Studi sul PIL atteso sono stati fatti da varie istituzioni ed agenzie. Mentre le previsioni sono varie (-9,9% del PIL nel 2020 stimato dalla Commissione UE nelle previsioni economiche di autunno pubblicate il 5 novembre, -8,9% previsto da S&P, -10% anticipato da Fitch) il trend atteso è ben definito: a una fase di forte crisi (2020), seguirà un proporzionale e fisiologico rimbalzo nel 2021. Rimbalzo che, tuttavia, a causa del forte impatto della seconda ondata, è stato ridimensionato intorno al 4% (contro l’8% previsto durante la fase di primo lockdown).
Per arginare la crisi, i Governi dei grandi Paesi, e tra questi anche quello italiano mirano a creare un ‘ponte temporale finanziario’ tramite il quale fornire liquidità alle imprese e al settore imprenditoriale (si è sentito spesso parlare di ‘bazooka’ di liquidità) per impedirne il fallimento e per creare resilienza fino all’uscita della crisi sanitaria e fino all’agognato rimbalzo.
In tale prospettiva, il Governo italiano ha adottato numerose misure straordinarie dirette a prevenire ed arginare l'espansione e gli effetti della crisi sul sistema economico. Si tratta di provvedimenti d'urgenza emanati tra marzo e novembre: il decreto-legge n. 9 del 2020, le cui misure sono poi confluite nel successivo più ampio intervento legislativo contenuto nel decreto-legge n.18 del 2020 Cura Italia (L. n. 27/2020), il decreto-legge n. 23 del 2020 Liquidità (L n. 40/2020), il decreto-legge n. 34 del 2020 Rilancio ( L. n. 77/2020), il decreto-legge n. 104 del 2020, decreto-legge Agosto, e, da ultimo, il decreto legge n. 137 del 2020 Ristori (A.S. 1994) e il decreto legge n. 149 del 2020 Ristori-bis (A.S. 2013).
Tra le numerose forme di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese, particolare rilievo assumono le misure per la liquidità previste dal decreto legge n. 23 del 2020 - Liquidità (400 miliardi di stanziamento proposti), come disciplinato agli articoli 1 e 13 a mente dei quali lo Stato si impegna a fornire garanzie (fino al 100% del capitale finanziato per le PMI e sino al 70-90% per tutte le altre,anche PMI oltre al plafond del fondo centrale di garanzia, e possibilità di preammortamento) nonchè dal decreto legge n. 34 del 2020 - Decreto Rilancio con cui si stanziano 55 miliardi di euro volti a fornire aiuti tanto alle famiglie quanto alle imprese.
Le misure di sostegno adottate potranno essere efficaci solo se i beneficiari ne potranno rapidamente usufruire. Occorre quindi anzitutto vincere le endemiche difficoltà del sistema paese Italia che troppo spesso si dibatte tra le lentezze e diffcoltà determinate, in fase attuativa, da una farraginosa macchina statale e burocratica.
Nell’ambito dell’attuale congiuntura, gli istituti finanziari, nonché gli istituti di vigilanza, si trovano di fronte a una difficile gestione delle perdite attese, dato il clima di totale incertezza nel quale si versa. Come precedentemente detto, il principio che regolamenta gli accantonamenti contabili è l’IFRS 9, modello basato sulle Expected losses, che in questo periodo, in base a come si interpreta il principio, possono essere di gran lunga più elevate.
La possibilità che gli istituti finanziari assegnino a certe linee di credito un rischio maggiore, con il relativo passaggio da Stage 1 a Stage 2, con il conseguente accantonamento di un maggior numero di risorse, potrebbe generare effetti prociclici e credit crunch, ossia difficoltà nel perpetuare attività di lending, un’attività di fondamentale importanza in questo periodo.
Per questa ragione le principali autorità italiane ed europee (EBA, ESMA, BCE, IASB, OIC, CONSOB, BIS) si sono allineate su una posizione comune e nei rispettivi statement hanno suggerito linee guida volte allo sfruttamento della flessibilità concessa dal principio IFRS 9 per contrastare effetti prociclici. Si sostiente, inoltre, che: (i) l'applicazione di moratorie non dovrebbe essere considerata da sola come un trigger automatico per la valutazione di un aumento significativo del rischio di credito, (ii) si dovrebbe accordare, da parte degli emittenti, un maggior peso alle assunzione del passato, attesa la difficolta di ottenere informazioni ragionevoli sulle stime future, (iii) si dovrebbe prendere in considerazione le garanzie reali o pubbliche concesse, nel determinare l'impatto sul conto economico delle banche derivante dalla rilevazione delle perdite attese su crediti
Anche il recente monito alle banche di Christine Lagarde, presidente della Bce, arrivato durante il forum annuale di Sintra in Portogallo del 12 novembre u.s. si allinea su tali posizioni: "Nelle circostanze attuali è necessario che (le banche) stiano molto attente ai loro bilanci" e alle entità a cui hanno erogato credito "perché è chiaro che in alcuni settori ci saranno fallimenti e ci vorrà tempo per rientrare dalle difficoltà". Del resto, per gli istituti di credito "agire in modo ragionevole è anche nel loro interesse". La Lagarde ha poi sottolineato che è di "cruciale importanza mantenere le condizioni finanziarie che hanno operato bene per sostenere finora l'economia, per stabilizzarla e consentire alle imprese di rifinanziarsi e alle famiglie di trovare mutui”, ribadendo la volontà di "continuare ad assicurare queste condizioni per un periodo sufficientemente lungo. Il livello conta ma anche la durata è critica".
7. Conclusioni
Prima della crisi derivata dalla pandemia da SarsCoVid2, il fenomeno degli Npls, a seguito delle massicce azioni che a livello statuale ed europeo erano intervenute nell’ultimo decennio, poteva a ragione considerarsi una problematica destinata a ritornare su valori ‘fisiologici’, dopo anni di volumi eccessivi e di effetti negativi sui bilanci degli istituti finanziari e sull’economia reale.
Purtroppo, alla luce dei nuovi tragici eventi, il lungo processo, fatto di regolamentazioni e di nuovi strumenti, è stato repentinamente compromesso.
L’atteso incremento del volume di Npl, che sarà causato da una maggior difficoltà che i debitori incontreranno ad adempiere agli obblighi restitutori assunti, in virtù della avversa congiuntura economica, dovrà trovare adeguate soluzioni. In una prima fase, le misure dovranno avere anzitutto finalità di contenimento, onde consentire di giungere al momento in cui la crisi sanitaria sarà finalmente superata; da lì in poi dovrà farsi tesoro degli anni di esperienza acquisita nella materia adottando gli strumenti idonei alla prosecuzione di quel cammino, bruscamente interrotto dalla insorgenza della pandemia volto alla normalizzazione del livello di crediti deteriorati.
Non sarà facile tornale alla ‘normalità’, né da un punto di vista umano né da un punto di vista economico (intendendo con normalità il periodo pre-Covid). Viviamo in momenti delicatissimi per la futura sopravvivenza del nostro Paese. Se però dalla drammatica esperienza che stiamo vivendo potessimo trarre i dovuti insegnamenti, se, al di là dei lutti patiti e delle difficoltà che stiamo incontrando, potessimo intervenire, anche con le risorse che a livello europeo saranno messe a disposizione del nostro Paese, mettendo da parte conflitti e distorte logiche partitiche, per cambiare in profondità l’apparato statale, nelle parti che si sono dimostrate vulnerabili, investendo nel futuro dei giovani, nell’istruzione, nella ricerca, nella sanità, nella Giustizia, per rendere l’Italia un paese più civile, ecco, allora, non sarà stato del tutto inutile soffrire.
Indice delle figure:
Figura 1: Evoluzione dello stock di Non Performing Loan in Italia (miliardi di Euro)................ - 5 -
Figura 2: Tempo recupero crediti (giorni necessari) - 8 -
Bibliografia:
Banca d’Italia, Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 (Fascicolo «Matrice dei conti») – 8° aggiornamento del 15 marzo 2016
Banca d’Italia, Note di stabilità finanziaria e vigilanza N.18, 12 Dicembre 2019
Bofondi M., Ropele T. (2011), Macroeconomics determinants of bad loans: evidence from Italian banks, Banca d'Italia Occasional Paper
European Banking Authority (EBA), Recommendations on asset quality reviews, ottobre 2013
European Banking Authority (EBA), EBA FINAL draft Implementing Technical Standards, On Supervisory reporting on forbearance and non-performing exposures under article 99(4) of Regulation (EU) No 575/2013, revision del luglio 2014
ISTAT, Le prospettive per l’economia italiana nel 2020-2021, Comunicato Stampa, 8 giugno 2020
OECD, Economic Forecast Summary, June 2020
Testo Unico Bancario (TUB), Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, Versione aggiornata al decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41
World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2017-2018
[1] Testo Unico Bancario, Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, Versione aggiornata al decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41
[2] collaterale: Bene reale o finanziario concesso in garanzia del puntuale pagamento di un debito. Se alla scadenza, il debitore non è in grado di pagare quanto previsto, il creditore può rivalersi sul bene, per es. vendendolo, e utilizzando tutto o parte del ricavato per soddisfare il suo credito.
[3] ABS (Asset Backed Securities) Titoli garantiti da collaterali (➔ collaterale) che sono a loro volta attività finanziarie o reali. I collaterali sono attività di importo relativamente esiguo e illiquide, che singolarmente non si presterebbero a essere negoziate..
[4] EUROPEAN BANKING AUTORITY, cit., p. 8: “One of the major impediments to a reliable and fast insolvency procedure is the slow process and significant work‐overload of the judicial system in most countries, especially in those with high NPL ratios. Indeed, data indicate that the level of provisions is higher in countries where the duration of legal proceedings is longer.”
Il rinvio della Corte di Cassazione alla Corte di giustizia: violazioni gravi e manifeste del diritto dell’Unione europea?[1]
di Bruno Nascimbene* e Paolo Piva**
Sommario: 1. Considerazioni introduttive - 2. Il rinvio per presunta “incompatibilità comunitaria”: la questione all’origine e il diritto ad un ricorso effettivo in materia di appalti pubblici - 3. Il difetto di giurisdizione ex art. 111 Cost. con riferimento alle pronunce del Consiglio di Stato - 4. La sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2018 e le sue conseguenze - 5. Autonomia procedurale, equivalenza ed effettività della tutela giurisdizionale - 6. L’obbligo di rinvio pregiudiziale e l’effettività della tutela. Il possibile rimedio “alla Köbler” - 7. Considerazioni conclusive e prospettive.
1. Considerazioni introduttive
Con ordinanza del 18 settembre 2020, n. 19598 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione chiedono alla Corte di giustizia di pronunciarsi su un tema cruciale di effettività e primato del diritto dell’Unione europea nel contesto del corretto dialogo fra Corti “superiori” nazionali e Corte di giustizia[2].
La problematica, peraltro, è stata ben illustrata da una recente pronuncia della Corte di giustizia, Commissione c. Polonia, C‑619/18, che richiama non solo la necessità della coerenza fra ordinamenti nazionali e ordinamento dell’Unione, nonché il principio dello Stato di diritto, ma soprattutto lo stretto collegamento con il principio della tutela giurisdizionale, garantito dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, oltre che dall’art. 6 CEDU: un “principio generale […] che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri […] sancito dagli articoli 6 e 13” della CEDU e “attualmente affermato dall’art. 47 della Carta”[3] .
Il primo dei tre quesiti dell’ordinanza si incentra su un tema su cui si erano a più riprese confrontate le supreme Corti italiane, con esito sino ad oggi per lo più negativo in termini di tutela del c.d. droit au juge, per usare un’espressione cara alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Vale la pena riprendere le parole delle Sezione Unite nel porre il quesito alla Corte di giustizia: “Se gli articoli 4, paragrafo 3, 19, paragrafo 1, del TUE e 2, paragrafi 1 e 2, e 267 TFUE, letti anche alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ostino ad una prassi interpretativa come quella concernente gli articoli 111, ottavo comma, della Costituzione, 360, primo comma, n. 1, e 362, primo comma, del codice di procedura civile e 110 del codice del processo amministrativo – nella parte in cui tali disposizioni ammettono il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato per «motivi inerenti alla giurisdizione» – quale si evince dalla sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2018 e dalla giurisprudenza nazionale successiva che, modificando il precedente orientamento, ha ritenuto che il rimedio del ricorso per cassazione sotto il profilo del cosiddetto «difetto di potere giurisdizionale», non possa essere utilizzato per impugnare sentenze del Consiglio di Stato che facciano applicazione di prassi interpretative elaborate in sede nazionale confliggenti con sentenze della Corte di giustizia, in settori disciplinati dal diritto dell’Unione europea (nella specie. in tema di aggiudicazione degli appalti pubblici) nei quali gli Stati membri hanno rinunciato ad esercitare i loro poteri sovrani in senso incompatibile con tale diritto, con l‘effetto di determinare il consolidamento di violazioni del diritto comunitario che potrebbero essere corrette tramite il predetto rimedio e di pregiudicare l’uniforme applicazione del diritto dell’Unione e l’effettività della tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive di rilevanza comunitaria, in contrasto con l’esigenza che tale diritto riceva piena e sollecita attuazione da parte di ogni giudice, in modo vincolativamente conforme alla sua corretta interpretazione da parte della Corte di giustizia, tenuto conto dei limiti alla «autonomia procedurale» degli Stati membri nella conformazione degli istituti processuali”[4] .
Il primo quesito, come qui riprodotto, rappresenta icasticamente e realisticamente il punctum dolens di una prassi avallata in passato dalla stessa Corte di cassazione[5], oggi rafforzata da una pronuncia della Corte costituzionale, la n. 6 del 18 gennaio 2018[6], volta ad impedire -in omaggio al principio dell’autonomia procedurale degli Stati membri[7]- l’impugnazione ex art. 111 Cost. delle decisioni del Consiglio di Stato confliggenti in modo grave e manifesto con il prevalente diritto dell’Unione europea, nella specie con pronunce della Corte di giustizia fondate sul principio della tutela giurisdizionale effettiva.
Si può sin d’ora osservare che, nonostante le Sezioni Unite segnalino una sorta di “revirement necessitato” della giurisprudenza di Cassazione in virtù dell’intervento del Giudice delle leggi (in particolare, la pronuncia Cass. S.U. del 29 dicembre 2017, n. 31226), a ben vedere, l’ammissibilità di azioni volte a contestare presunti straripamenti del giudice amministrativo in ragione di violazioni del diritto dell’Unione europea è sempre stato un fatto eccezionale, se non già un vero e proprio hàpax legòmenon, stante il richiamo, anche da parte della Cassazione, delle sole pronunce S.U. del 6 febbraio 2015, n. 2242 e n. 31226.
È invece vero che, almeno teoricamente, si potesse in precedenza ammettere che uno stravolgimento della norma in modo del tutto arbitrario da parte del giudice amministrativo di ultima istanza fosse possibile anche in riferimento a fattispecie aventi causa petendi comunitaria e non solo a fattispecie di “travisamento di norma interna”. L’aspetto, come si osserverà, è significativo, rilevando immediatamente per il diritto dell’Unione che il giudice nazionale, nel tutelare le situazioni giuridiche soggettive azionate alla stregua di norme comunitarie, debba sempre rispettare, oltre che il principio dell’effettività, anche il connesso principio dell’equivalenza. Due principi, questi, strettamente connessi nella valutazione della Corte di giustizia[8].
Gli altri due quesiti, infine, si incentrano, il secondo[9] (par. 60 dell’ordinanza), sul dubbio relativo al se un’applicazione combinata degli artt. 4.3 TUE, 267 TFUE e 47 della Carta dei diritti fondamentali impongano alla Corte di nomofilachia il superamento della nozione restrittiva di difetto di giurisdizione quale ricavabile dalla pronuncia della Corte costituzionale, allorquando in particolare il Consiglio di Stato abbia omesso -quale giudice di ultima istanza- il rinvio nelle condizioni processuali così come illustrate in CILFIT[10] (cioè sussistenza di un dubbio interpretativo rilevante); il terzo, infine, sulla specifica fattispecie sub judice, ovvero sul dubbio che sia compatibile con il prevalente diritto dell’Unione la prassi interpretativa del Consiglio di Stato secondo cui il concorrente escluso da una gara d’appalto non sia legittimato ad impugnare l’aggiudicazione finale, alla stregua della linea giurisprudenziale della Corte in Fastweb[11]-Puligienica[12]-BTG[13]-Lombardi[14].
In questa prima “delibazione”, si può certamente affermare che il diritto dell’Unione è a favore di un’interpretazione che, pur nel rispetto del principio dell’autonomia procedurale degli Stati membri, garantisce una più effettiva tutela giurisdizionale. Tuttavia, se il diritto dell’Unione europea e la giurisprudenza della Corte non impongono sicuramente un “terzo grado di giudizio” (mancante, quanto meno pleno jure, rispetto alle pronunce del giudice amministrativo), non si può negare, come già anticipato, che l’ordinamento dell’Unione europea non tolleri prassi differenziate rispetto ad identiche o analoghe violazioni di legge, l’una per il diritto interno e l’altra per il diritto dell’Unione. Se si può, altrettanto ragionevolmente, ammettere che il diritto dell’Unione non imponga un intervento riparatore (nel caso di specie, dalla Corte della nomofilachia) in qualunque caso di violazione del diritto dell’Unione, non si può nemmeno negare che la violazione grave e manifesta del diritto dell’Unione -suscettibile di condanna al risarcimento del danno- possa e debba integrare il caso dello stravolgimento grave del diritto idoneo ad abilitare la parte al ricorso ex art. 111 Cost e/o art. 360, n. 1 c.p.c.
Da ultimo, il che rileva anche per il terzo quesito, si deve segnalare che l’aver omesso un rinvio in una fattispecie che palesemente lo imponeva integra una violazione grave e manifesta del diritto dell’Unione, in virtù della giurisprudenza Köbler[15]-Traghetti del Mediterraneo[16] e della legge sulla responsabilità dei magistrati (legge 117/88), così come novellata dalla legge 18/2015[17].
In altre parole, anche ammettendo che la pronuncia del Consiglio di Stato in punto di legittimazione non fosse del tutto distonica rispetto alla giurisprudenza (non sempre così lineare) della Corte, non c’è dubbio che il caso meritasse quanto meno una “rilettura” autorevole da parte della Corte stessa e, quindi, onerasse il massimo organo di giustizia amministrativa al rinvio ex art. 267, n. 3, TFUE.
2. Il rinvio per presunta “incompatibilità comunitaria”: la questione all’origine e il diritto ad un ricorso effettivo in materia di appalti pubblici
La questione in concreto riproposta alla Corte di Cassazione in sede di ricorso ex art. 111 Cost. per difetto di giurisdizione riguardava la nota problematica di ricorsi incrociati, in sede giurisdizionale amministrativa, volti ciascuno -rispettivamente, ricorso principale ed incidentale- a negare il diritto dell’altro candidato per le più diverse ragioni di partecipare alla gara, con la conseguenza che l’aggiudicazione, secondo la prassi avallata dalle pronunce dell’Adunanza Plenaria n. 4 del 7 aprile 2011 e n. 9 del 25 febbraio 2014, rimarrebbe sostanzialmente priva di contestazione.
Secondo i giudici amministrativi, in effetti, vi sarebbe una sorta di poziorità logico-processuale nell’esame del ricorso incidentale che, se fondato, farebbe venir meno l’interesse alla decisione del ricorso principale, con la naturale conseguenza di lasciare inalterato il provvedimento amministrativo di aggiudicazione.
Questo tipo di situazione processuale (ovvero, ricorsi incrociati egualmente paralizzanti) è stato oggetto di plurimi interventi ex art. 267 TFUE dalla Corte di giustizia[18].
In una prima causa austriaca, Hackermüller, piuttosto risalente e comunque precedente alla Direttiva 66/2007, in un contesto in cui un offerente aveva indicato il proprio nome violando il principio di segretezza dell’offerta, la Corte ha affermato che la prima Direttiva ricorsi (la n. 665/1989/CE, art. 1, n. 3) “non obbliga gli Stati membri a rendere dette procedure di ricorso accessibili a chiunque voglia ottenere l'aggiudicazione di un appalto pubblico, ma che essa consente loro di esigere, inoltre, che la persona interessata sia stata o rischi di essere lesa dalla violazione da essa denunciata” [19].
In sostanza, a fronte di un motivo di esclusione del candidato ma in assenza di una decisione in tal senso dell’autorità amministrativa in sede procedimentale, per la Corte non si può negare al candidato il diritto di impugnare, in una con la contestazione del motivo di esclusione (rilevato peraltro solo dall’organo di decisione in sede di ricorso amministrativo) anche la decisione di aggiudicazione a favore di altro candidato.
Si deve tuttavia osservare che un obiter dictum della Corte aveva lasciato un profilo irrisolto: “non si può escludere che, al termine di tale procedura, l'autorità adita pervenga alla conclusione che detta offerta avrebbe dovuto effettivamente essere esclusa in via preliminare e che il ricorso dell'offerente debba essere respinto in quanto, tenuto conto di tale circostanza, egli non è stato o non rischia di essere leso dalla violazione da lui denunciata”[20].
Vi è da osservare poi che l’introduzione, da parte della II Direttiva ricorsi, della nozione di “offerente interessato” (art. 1, par. 3 novellato), ha dato alla Corte la possibilità di affinare il proprio punto di vista, osservando, nella nota pronuncia Fastweb, che “tale insegnamento è applicabile, in linea di principio, anche qualora l’eccezione di inammissibilità non sia sollevata d’ufficio dall’autorità investita del ricorso, ma in un ricorso incidentale proposto da una parte nel procedimento di ricorso, come l’aggiudicatario regolarmente intervenuto nello stesso”, con la conseguenza che, ove “ l’aggiudicatario che ha ottenuto l’appalto e proposto ricorso incidentale solleva un’eccezione di inammissibilità fondata sul difetto di legittimazione a ricorrere dell’offerente che ha proposto il ricorso, con la motivazione che l’offerta da questi presentata avrebbe dovuto essere esclusa dall’autorità aggiudicatrice per non conformità alle specifiche tecniche indicate nel piano di fabbisogni, tale disposizione osta al fatto che il suddetto ricorso sia dichiarato inammissibile in conseguenza dell’esame preliminare di tale eccezione di inammissibilità senza pronunciarsi sulla compatibilità con le suddette specifiche tecniche sia dell’offerta dell’aggiudicatario che ha ottenuto l’appalto, sia di quella dell’offerente che ha proposto il ricorso principale”[21].
Nel successivo caso BTG, la Corte ha avuto modo di distinguere la fattispecie in Fastweb (e nell’analoga Puligienica) dalla situazione procedurale in cui vi fossero solo due offerenti e il concorrente escluso dalla gara d’appalto con provvedimento divenuto definitivo ambisse, in qualche modo, a riazzerare la gara (c.d. interesse strumentale), contestando la decisione di aggiudicazione in favore del suo unico concorrente.
La Corte, valorizzando la nozione di “offerente interessato”, e dunque di interesse ad agire dell’offerente, ha disconosciuto la legitimatio ad causam del concorrente escluso precisando che è consentito “a qualsiasi offerente escluso di impugnare non solo la decisione di esclusione, ma anche, fino a quando tale impugnazione non è stata risolta, le decisioni successive che la danneggerebbero se la sua esclusione fosse annullata” (grassetto aggiunto) [22].
In Lombardi , più recentemente, la Corte di giustizia ha avuto modo di ribadire il proprio orientamento anche in una fattispecie caratterizzata dall’impugnativa del concorrente, risultato terzo nella gara d’appalto, che contesti la propria esclusione in vista ed in funzione dell’esclusione dell’aggiudicatario e del secondo in graduatoria, “in quanto non si può escludere che, anche se la sua offerta fosse giudicata irregolare, l’amministrazione aggiudicatrice sia indotta a constatare l’impossibilità di scegliere un’altra offerta regolare e proceda di conseguenza all’organizzazione di una nuova procedura di gara” [23] .
In quest’ultima pronuncia (val la pena sottolinearlo) la Corte interpreta l’art. 1, par. 1, terzo comma, e par. 3 della Direttiva n. 89/665/CEE, come modificata dalla Direttiva 2007/66/CE affermando che osta che un ricorso eiusdem generis “venga dichiarato irricevibile in applicazione delle norme o delle prassi giurisprudenziali procedurali nazionali disciplinanti il trattamento dei ricorsi intesi alla reciproca esclusione, quali che siano il numero di partecipanti alla procedura di aggiudicazione dell’appalto e il numero di quelli che hanno presentato ricorsi”[24].
E pur tuttavia, alcuna dottrina amministrativistica ha evidenziato che “profonda e irriducibile appare la contraddizione tra le sentenze BTG e Archus”, nella misura in cui quest’ultima, surrettiziamente, “sulla scia di Fastweb, determina l’impropria soppressione, ai fini dell’accesso alle procedure di ricorso, della qualità di soggetto leso o che rischia di esserlo a causa dell’illegittimità denunciata (art. 1, par. 3, dir. 92/13/CEE), qualifica confermata dall’introduzione, con la dir. 2007/66/CE, della nozione normativa di «offerenti interessati»[25].
A prescindere dal fatto che in Archus il requisito soggettivo non pare propriamente mancare[26], il discrimine fra BTG e Fastweb-Archus sembra, piuttosto, rinvenibile nel carattere definitivo, o non, dell’esclusione, definitività per inoppugnabilità della decisione amministrativa e/o giurisdizionale.
Nel caso analizzato dal Consiglio di Stato, dunque, anche richiamando la pronuncia dell’Adunanza n. 4/2011, sembra potersi affermare che la ragione dell’esclusione (cioè il mancato superamento della soglia di sbarramento) non sia diversa da altre forme di esclusione. Secondo la Sezione, infatti, “per poter delibare la carenza di legittimazione, rileva ogni forma di estromissione dalla gara, anche se disposta in fasi successive all’atto iniziale di ammissione, ma comunque deputate (anche solo in senso logico) all'accertamento della regolare partecipazione del concorrente, anche sotto il profilo dei requisiti oggettivi dell’offerta (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 9/2014)”[27].
Tale pronuncia di difetto della legittimazione in capo al ricorrente ad impugnare l’esclusione e/o l’aggiudicazione altrui sembra in effetti emessa per le stesse ragioni che avevano dato origine a suo tempo a Fastweb[28]: di qui il ricorso per Cassazione e la reazione di quest’ultima Corte tendente a ravvisare un caso eclatante di “disobbedienza” ai dicta della Corte di giustizia.
In effetti, anche ammesso che si possa distinguere la situazione da quella occorrente in Fastweb-Puligienica o che queste ultime pronunce contrastino con i precedenti Hackermüller-Archus, non può revocarsi in dubbio che il Consiglio di Stato avrebbe fatto certamente meglio a chiedere lumi alla Corte ex art. 267 TFUE affinché chiarisse il significato dei propri precedenti, talora per vero non così perspicui anche per la discutibile abitudine della Corte a non ammettere le parti alla discussone orale, con ogni naturale conseguenza sulla migliore comprensione dei fatti di causa.
Ad ogni buon conto, non sembra proprio che si possa concludere nel senso che le Sezioni Unite sarebbero incorse in una sorta di freie Rechtsschöpfung, mentre il giudice amministrativo avrebbe applicato nitidamente la giurisprudenza della Corte o, comunque, la “preferibile” giurisprudenza in materia.
A fronte di un contrasto (quanto meno apparente) fra il pronunciamento del Consiglio di Stato e la giurisprudenza (o qualche precedente) della Corte di giustizia, bene ha fatto la Corte di cassazione a ritenere che la prospettiva di negare accesso al ricorso ex art. 111 Cost. o 360, n. 1 c.p.c. “avrebbe l’effetto di fare consolidare una grave violazione del diritto dell’Unione in un momento in cui essa è ancora rimediabile”.
In effetti, sembra evidente la volontà del Consiglio di Stato di imporre il proprio punto di vista tradizionale su quello della Corte di giustizia, nonostante la norma da interpretarsi per risolvere il dubbio interpretativo sul punto della legittimazione fosse, e sia, una norma dell’Unione e le pronunce della Corte di giustizia notoriamente abbiano effetto erga omnes (così Corte Cost., 23 aprile 1985, n. 113). Sembra quasi di essere di fronte ai modi con cui il Conseil d’Etat francese invocava la propria teoria dell’acte clair al fine di sottrarsi al doveroso rinvio, prassi che ha poi provocato la forte risposta della Corte nella ricordata sentenza CILFIT [29].
Come ebbe modo di precisare la Corte in quell’ultima occasione, è possibile, in effetti, un’attenuazione dell’obbligo del rinvio a carico dei Giudici nazionali di ultima istanza, laddove “la corretta applicazione del diritto comunitario può imporsi con tale evidenza da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio sulla soluzione da dare alla questione sollevata. Prima di giungere a tale conclusione, il giudice nazionale deve maturare il convincimento che la stessa evidenza si imporrebbe anche ai giudici degli altri Stati membri ed alla Corte di giustizia. Solo in presenza di tali condizioni il giudice nazionale può astenersi dal sottoporre la questione alla Corte risolvendola sotto la propria responsabilità”[30].
Né si tratta, a ben vedere, di una “dequotazione” dell’autonomia procedurale degli Stati membri: il tema vero è quello del primato della lex communis e dell’effettività della tutela giurisdizionale che i Giudici nazionali (juges communautaires de droit commun) devono garantire (artt. 19, par.2 TUE).
Il problema, sotto questo profilo, va ben oltre il problema specifico della soluzione processuale ai ricorsi reciprocamente escludentisi e alla poziorità dell’esame dell’uno rispetto all’altro, riguardando piuttosto l’uso della nomofilachia della Corte di cassazione in un senso idoneo a valorizzare, nel massimo grado, l’effettività del diritto comprensivo anche del diritto dell’Unione che si integra in quello degli Stati membri e alla cui osservanza è posta, al vertice, la Corte di giustizia.
3. Il difetto di giurisdizione ex art. 111 Cost. con riferimento alle pronunce del Consiglio di Stato
Tradizionalmente, la prassi della Corte di cassazione è sempre stata piuttosto rigorosa, per ovvie ragioni, nell’interpretare la categoria di “difetto di giurisdizione” idonea a dare origine ad un ricorso avanti alla Corte di cassazione ex art. 360, n. 1 ovvero art. 111, n. 8, Cost. avverso le pronunce del Consiglio di Stato, in thesi, abnormi.
Era piuttosto ricorrente, in effetti, l’affermazione giurisprudenziale secondo cui, in tema di limiti al sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato, l'eccesso di potere giurisdizionale per “invasione” della sfera di attribuzioni riservata al legislatore non ricorre quando il giudice amministrativo si sia limitato ad interpretare la legge oggetto delle opzioni contrastanti da parte dei contendenti. Si osservava tuttavia che “la figura dell'eccesso di potere giurisdizionale per invasione nelle attribuzioni di spettanza del legislatore può verificarsi solamente quando il giudice applichi non già una norma esistente bensì una norma da lui creata, a condizione che si possa distinguere tra un’attività di formale produzione normativa - inammissibilmente esercitata dal giudice - da un’attività interpretativa che si sostanzia invece in un'opera creativa della volontà di legge nel caso concreto”[31].
In una prospettiva storica, tuttavia, ha segnato una sorta di “rivoluzione copernicana” la pronuncia del 23 dicembre 2008, n. 30254 con cui la Corte di Cassazione è giunta ad una “lettura” più evoluta e rispondente alle odierne esigenze dell’ordinamento della nozione di “giurisdizione”[32].
In questa pronuncia, in effetti, la Corte ha elaborato “nuovi” presupposti per apprezzare i limiti esterni della giurisdizione amministrativa.
In quel caso, peraltro e notoriamente, si discettava di pregiudizialità amministrativa, ma si può senz’altro affermare che i dicta espressi dalla Corte nella pronuncia possano avere una portata generale come una sorta di guideline per il futuro.
Si legge, infatti, in essa: “ai fini dell’individuazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, che tradizionalmente delimitano il sindacato consentito alle sez. un. sulle decisioni del Consiglio di Stato che quei limiti travalichino, si deve tenere conto dell'evoluzione del concetto di giurisdizione - dovuta a molteplici fattori: il ruolo centrale della giurisdizione nel rendere effettivo il primato del diritto comunitario; il canone dell'effettività della tutela giurisdizionale; il principio di unità funzionale della giurisdizione nella interpretazione del sistema ad opera della giurisprudenza e della dottrina, tenuto conto dell'ampliarsi delle fattispecie di giurisdizione esclusiva; il rilievo costituzionale del principio del giusto processo, ecc. - e della conseguente mutazione del giudizio sulla giurisdizione rimesso alle sez. un., non più riconducibile ad un giudizio di pura qualificazione della situazione soggettiva dedotta […] ma nel senso di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi, che comprende, dunque, le diverse tutele che l’ordinamento assegna a quei giudici per assicurare l’effettività dell’ordinamento. rispettandone il contenuto essenziale, così esercitando il sindacato per violazione di legge che la S.C. può compiere anche sulle sentenze del giudice amministrativo”[33].
Si aggiunga che, su questa linea giurisprudenziale, le S.U. avevano già accolto un analogo ricorso a quello oggetto del ricorso in Corte di cassazione in questi termini: “è affetta da vizio di difetto di giurisdizione e per questo motivo va cassata la sentenza del Consiglio di Stato che, in sede di decisione su ricorso per cassazione, è riscontrata essere fondata su interpretazione delle norme incidente nel senso di negare alla parte l'accesso alla tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo; accesso affermato con l'interpretazione della pertinente disposizione comunitaria elaborata dalla Corte di giustizia”[34] .
Ancora, va ricordata una successiva pronuncia secondo cui “non costituiscono diniego di giurisdizione, da parte del Consiglio di Stato (o della Corte dei conti), gli errori in procedendo o in giudicando, ancorché riguardanti il diritto dell’Unione europea, salvo i casi di radicale stravolgimento delle norme di riferimento (nazionali o dell’Unione) tali da ridondare in denegata giustizia, e in particolare il caso, tra questi, di errore in procedendo costituito dall’applicazione di regola processuale interna incidente nel senso di negare alla parte l’accesso alla tutela giurisdizionale nell’ampiezza riconosciuta da pertinenti disposizioni normative dell’Unione europea, direttamente applicabili, secondo l’interpretazione elaborata dalla Corte di giustizia”[35].
Dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 6/2018 (vera e propria pierre d’achoppement), tuttavia, la Corte di Cassazione è ritornata a formule “ante-2008”, ribadendo che “non sussiste eccesso giurisdizionale quando il giudice svolge attività interpretativa delle norme; il sindacato delle Sezioni Unite della Cassazione sulle decisioni del giudice amministrativo è, infatti, circoscritto ai motivi inerenti alla giurisdizione, ossia ai vizi concernenti l'ambito della giurisdizione in generale o il mancato rispetto dei limiti esterni della giurisdizione, con esclusione di ogni sindacato sul modo di esercizio della funzione giurisdizionale, cui attengono invece gli errori «in iudicando», o anche «in procedendo» […] quale che sia la gravità della violazione, anche ove essa attinga alla soglia del c.d. stravolgimento delle norme di riferimento, sostanziali o processuali, applicate; infatti, in linea di principio, l'interpretazione della legge (e perfino la sua disapplicazione) non trasmoda di per sé in eccesso di potere giurisdizionale, perché essa rappresenta il proprium della funzione giurisdizionale e non può, dunque, integrare di per sé sola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione da parte del giudice amministrativo, così da giustificare il ricorso previsto dall'art. 111, comma 8, Cost.”[36].
Sulla scorta di queste considerazioni, pare proprio che la scelta della Corte di cassazione di consentire, sia pure eccezionalmente, un sindacato sull’esercizio concreto della giurisdizione da parte del G.A. sia non soltanto da accogliere favorevolmente, ma sia in linea con i dettami della Costituzione che “deve fare i conti” con l’essere, l’ordinamento italiano, parte integrante di un ordinamento sovranazionale (art. 11 Cost.), alla cui fedeltà e primato la Carta fondamentale ha riaffermato la propria adesione (art. 117 Cost. novellato).
In questa prospettiva, dunque, appare condivisibile che il sindacato della Corte di cassazione sulla giurisdizione amministrativa debba essere inteso come uno scrutinio sull’effettività della stessa, così che laddove il giudice amministrativo, nell’erogare in concreto la propria giurisdizione, non risponda a standard di effettività della tutela (anche imposti dal diritto dell’Unione), il suo operato sia suscettibile di censura in sede di ricorso ex art. 111 Cost.
Ma, per l’appunto, vi era (vi è) la “pietra d’inciampo” di Corte cost. n. 6 del 2018.
4. La sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2018 e le sue conseguenze
La pronuncia del Giudice delle leggi che ha condotto ad una “rilettura” della nozione di giurisdizione e dei suoi limiti veniva pronunciata, su rinvio delle S.U., con riferimento ad una questione di legittimità avente ad oggetto l’art. 69, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), “nella parte in cui prevede che le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30.06.98 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000”.
La Cassazione deduceva in particolar modo la violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione ai parametri interposti dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e dell’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione stessa.
Il Giudice rimettente, peraltro, aggiungeva che si era affermata recentemente nella sua giurisprudenza una interpretazione “evolutiva” e “dinamica” del concetto di giurisdizione, che consentirebbe di sindacare non solo le norme che individuano “i presupposti dell’attribuzione del potere giurisdizionale”, ma anche quelle che stabiliscono “le forme di tutela” attraverso cui la giurisdizione si estrinseca.
Si precisava, altresì, che tanto aveva consentito la cassazione di una sentenza del Consiglio di Stato che aveva interpretato le norme di diritto interno in termini contrastanti con il diritto dell’Unione europea, così come acclarato da una pronuncia della Corte di giustizia successivamente intervenuta.
Dopo aver ricordato la propria sentenza del 6 luglio 2004, n. 204, che si esprime in termini di unità funzionale e non già organica delle giurisdizioni, e dopo aver ricordato i lavori dell’Assemblea Costituente escludenti la “soggezione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti al controllo di legittimità della Corte di cassazione”, salvo il solo “eccesso di potere giudiziario”, in virtù di “una divisione dei vari ordini di giudici in sistemi diversi, in sistemi autonomi, ognuno dei quali fa parte a sé (così Mortati, seduta pomeridiana del 27 novembre 1947)”, la Corte giunge alla conclusione che l’intervento delle S.U. “nemmeno può essere giustificato dalla violazione di norme dell’Unione o della CEDU, non essendo peraltro chiaro, nell’ordinanza di rimessione e nella stessa giurisprudenza ivi richiamata, se ciò valga sempre ovvero solo in presenza di una sentenza sopravvenuta della Corte di giustizia o della Corte di Strasburgo”[37].
Secondo la Corte costituzionale, insomma, “L’«eccesso di potere giudiziario», denunziabile con il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, come è sempre stato inteso, sia prima che dopo l’avvento della Costituzione, va riferito, dunque, alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, e cioè quando il Consiglio di Stato o la Corte dei conti affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all’amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento); nonché a quelle di difetto relativo di giurisdizione”, rispetto ad altri giudici.
Ma quel che preme segnalare, in questo contesto, è come la pronuncia abbia, per così dire, fatto strame non solo della nozione evolutiva di giurisdizione di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 30254/2008 già ricordata, ma anche di alcune acquisizioni giurisprudenziali divenute sin qui jus receptum, in virtù delle quali, allorquando lo stravolgimento della norma sia tale da comportare, sostanzialmente, l’applicazione di una norma inesistente o esistente solo, per così dire, in mente dei, si possa dar adito ad un ricorso ex art. 111 Cost.[38].
Sottolinea, invero, la sentenza che “il concetto di controllo di giurisdizione, così delineato nei termini puntuali che ad esso sono propri, non ammette soluzioni intermedie, come quella pure proposta nell’ordinanza di rimessione, secondo cui la lettura estensiva dovrebbe essere limitata ai casi in cui si sia in presenza di sentenze «abnormi» o «anomale» ovvero di uno «stravolgimento», a volte definito radicale, delle «norme di riferimento». Attribuire rilevanza al dato qualitativo della gravità del vizio è, sul piano teorico, incompatibile con la definizione degli ambiti di competenza e, sul piano fattuale, foriero di incertezze, in quanto affidato a valutazioni contingenti e soggettive”[39].
Non attribuire rilevanza al dato qualitativo della gravità del vizio posto in essere dallo Stato-Giudice, d’altra parte, si pone in netto contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui “al fine di stabilire un'eventuale responsabilità dello Stato per una decisione di un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado, occorre tener conto della specificità della funzione giurisdizionale nonché delle legittime esigenze della certezza del diritto […]. La responsabilità dello Stato a causa della violazione del diritto comunitario in una tale decisione può sussistere solo nel caso eccezionale in cui il giudice abbia violato in maniera manifesta il diritto vigente” [40].
In proposito, non si può non dar ragione alla dottrina processualcivilistica secondo cui “è singolare che la pronuncia dei giudici costituzionali, pur riconoscendo che l’eventuale contrasto fra le sentenze del Consiglio di Stato e il diritto dell’Unione o la giurisprudenza della Corte di giustizia pone un problema di effettività della tutela, continui a declinare il principio di effettività e il problema della sua garanzia in termini esclusivamente «domestici» e non in confronto all’impianto normativo sovranazionale. Infatti, sostenere che – come si legge nella motivazione della sentenza n. 6 del 2018 – «quanto all’effettività della tutela e al giusto processo, non c’è dubbio che essi vadano garantiti, ma a cura degli organi giurisdizionali a ciò deputati dalla Costituzione e non in sede di controllo sulla giurisdizione», significa sottrarsi al necessario confronto fra la soluzione che sembrerebbe emergere dal dettato costituzionale per come interpretato dai giudici costituzionali e gli standards di effettività imposti dall’ordinamento sovranazionale”[41]. Anche la migliore dottrina del passato aveva correttamente rilevato, dando per scontato l’impugnabilità per eccesso di potere giurisdizionale delle pronunce dei giudici speciali, che “l’art. 111 Cost. ha tendenzialmente ampliato e non limitato le attribuzioni della Cassazione vuoi perché l’eccesso di potere giurisdizionale si risolve nella violazione delle norme costituzionali, che presiedono alla suddivisione dei poteri tra gli organi dello Stato, cui sono commesse la funzione legislativa, esecutiva e giurisdizionale”.
Con la conseguenza che, anche alla luce della novella dell’art. 111 Cost. con l. cost. 23 novembre 1999, n. 2, “va rigettata in radice, perché incompatibile con il sistema, l’idea secondo la quale qualsiasi estensione dei motivi di ricorso per cassazione oltre l’ambito tradizionalmente assegnato al ricorso ex art. 362, comma 1, c.p.c. e/o coincidente con le questioni di giurisdizione di cui all’art. 37 c.p.c. comporti una indebita parificazione tra i rimedi contemplati nei commi 7° e 8° dell’art.111 Cost.”[42].
In definitiva, anche a tacere dalle (invero) non perspicue considerazioni ricavabili da Corte cost. n. 6/2018 in tema di effettività della tutela giurisdizionale e/o di mancato apprezzamento delle pronunce n. 348 e n. 349 del 2007 della stessa Corte in tema di differenze fra norme CEDU e norme UE, la pronuncia della Corte (pur essendo a rigore irrilevante per qualunque giudice nazionale -e dunque anche per la Cassazione- che si muova sulla via indicata dalla Corte di giustizia in termini di disapplicazione e interpretazione comunitariamente conforme)[43], potrebbe ragionevolmente dare origine ad una “remora” o “disagio” che la Corte di giustizia dovrebbe comunque essere in grado di affrontare e risolvere[44].
5. Autonomia procedurale, equivalenza ed effettività della tutela giurisdizionale
La soluzione della Corte di cassazione, peraltro, così come prospettata nell’ordinanza oggetto di esame, appare coerente con la giurisprudenza anche risalente della Corte di giustizia, essendo pacifico che “secondo il principio di collaborazione, enunciato dall’art. 5 del Trattato [poi art. 4.3, TUE], è ai giudici nazionali che è affidato il compito di garantire la tutela giurisdizionale spettante ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario aventi diretta efficacia”[45].
Si può, del resto, ricordare che, con le sentenze “gemelle” Rewe-Comet, si sono introdotti, per la prima volta, dei precisi e rigorosi limiti all’autonomia procedurale degli Stati membri. Con riguardo alla concreta questione dei termini processuali di decadenza e prescrizione, ad esempio, si precisa che “allo stato attuale del diritto comunitario, questo non vieta di opporre, a coloro che impugnano dinanzi ai giudici nazionali, per incompatibilità col diritto comunitario, il mancato rispetto di un termine contemplato dalle norme interne, a condizione che le modalità procedurali dell’azione giudiziale non siano meno favorevoli di quelle relative ad analoghe azioni del sistema processuale nazionale” [46].
Il punto della sollevabilità di eccezioni di prescrizione e decadenza ex parte publica è stato con il tempo affinato dalla Corte, avendo la stessa precisato, fra l’altro, che la Direttiva n. 665/89 dev’essere interpretata nel senso che essa (una volta accertato che un’autorità aggiudicatrice con il suo comportamento ha reso impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario a un cittadino dell’Unione leso da una decisione di tale autorità che lo esclude da una gara d’appalto) impone ai giudici nazionali competenti l’obbligo di dichiarare ricevibili i motivi di diritto basati sull'incompatibilità del bando di gara con il diritto comunitario, dedotti a sostegno di un ricorso proposto contro la detta decisione: avvalendosi, se del caso, della possibilità prevista dal diritto nazionale di disapplicare le norme nazionali di decadenza in forza delle quali, decorso il termine per impugnare il bando di gara, non è più possibile invocare tale incompatibilità”[47].
Il che, evidentemente, non potrebbe non rilevare anche ex art. 111 Cost., laddove ignorato dal Consiglio di Stato.
Più precisamente, come si desume dall’iter argomentativo della Corte, i limiti posti all’operatività delle norme processuali interne sono, sostanzialmente, tre.
a) Non deve esistere una specifica disciplina dell’Unione. Ciò significa che, qualora siano previste norme procedurali per l’esercizio concreto dei diritti derivanti da norme comunitarie, sono queste ultime ad applicarsi con conseguente prevalenza sulle norme processuali interne di contenuto contrastante. Anche questo aspetto non è irrilevante nel caso sub judice, posto che, com’è stato correttamente osservato, con l’adozione delle direttive ricorsi (n. 665/89 e 66/2007) “l’autonomia dei singoli Stati membri, nella definizione delle controversie concernenti l’affidamento dei contratti pubblici, è stata limitata in alcuni punti significativi, avviando un percorso di avvicinamento tra tradizione processuali, dei diversi Stati membri, in origine sensibilmente differenti”[48].
b) Le modalità procedurali delle azioni giudiziali miranti a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme UE non possono essere meno favorevoli di quelle relative ad analoghe azioni del sistema processuale nazionale (c.d. criterio dell’equivalenza o dell’assimilazione). In tal senso, ad esempio, qualora al diritto dei privati al risarcimento dei danni causati da violazione di norme comunitarie ex parte publica fosse riservato un trattamento processuale più sfavorevole rispetto ad un diritto analogo basato sulla normativa interna (richiedendosi, in ipotesi, un ulteriore onere probatorio), si dovrebbe concludere per l’illegittimità delle norme del foro che sanciscono una tale “discriminazione”.
Come ricorda anche la Cassazione nell’ordinanza in esame, “la Corte ha precisato che «per quanto riguarda il principio di equivalenza, si deve ricordare che esso richiede che la complessiva disciplina dei ricorsi si applichi indistintamente ai ricorsi fondati sulla violazione del diritto dell’Unione e a quelli simili fondati sulla violazione del diritto interno” (fra le tante, Corte di giustizia 15 marzo 2017, C-3/16, Lucio Cesare Asquino, punto 50)”.
La conseguenza è che “non sembra conforme al principio di equivalenza la prassi giurisprudenziale di cui si discute, la quale, nelle controversie aventi ad oggetto l’applicazione del diritto nazionale, ammette il ricorso per cassazione per difetto di potere giurisdizionale avverso le sentenze del Consiglio di Stato, cui si imputi di aver svolto attività di produzione normativa invasiva delle attribuzioni del legislatore, mentre, nelle controversie aventi ad oggetto l’applicazione del diritto dell’Unione, dichiara pregiudizialmente inammissibili i ricorsi per cassazione”[49]. È tuttavia evidente che il principio dell’equivalenza o dell’assimilazione, che qui rileva in modo particolare, possa portare a conseguenze aberranti se non interpretato congiuntamente al principio dell’effettività[50]. Ciò è apparso manifesto (ad esempio) in casi relativi a rimborsi in materia di tasse societarie, in cui la Corte di giustizia ha avallato l’opposizione a termini di decadenza previsti per azioni analoghe di diritto interno che non potevano che apparire, a rigore, insoddisfacenti, specie se introdotti retroattivamente[51].
Per quel che qui interessa, comunque, è stato recentemente osservato che “il diritto dell’Unione, in particolare la direttiva 89/665 e la direttiva 92/13 nonché i principi di equivalenza e di effettività, deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro che non autorizza il riesame di una sentenza, passata in giudicato, di un giudice di detto Stato membro che si è pronunciato su un ricorso di annullamento avverso un atto di un’amministrazione aggiudicatrice senza affrontare una questione il cui esame era previsto in una sentenza precedente della Corte pronunciata in risposta a una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta nell’ambito del procedimento relativo a tale ricorso di annullamento. Tuttavia, qualora le norme processuali interne applicabili prevedano la possibilità per il giudice nazionale di ritornare su una sentenza passata in giudicato, per rendere la situazione derivante da tale pronuncia compatibile con una decisione giudiziaria definitiva nazionale precedente, di cui il giudice che ha emesso tale sentenza e le parti della causa che l’ha originata erano a conoscenza, tale possibilità deve prevalere, conformemente ai principi di equivalenza e di effettività, alle stesse condizioni, per ripristinare la conformità di tale situazione alla normativa dell’Unione, come interpretata da una precedente sentenza della Corte”[52].
c) Infine, modalità e termini previsti dal sistema processuale interno non devono essere tali da rendere, in pratica, impossibile o comunque molto difficile l’esercizio dei diritti con causa petendi nel diritto dell’Unione che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare (c.d. principio dell’effettività della tutela).
Si era ritenuto, in passato,[53] che quest’ultima clausola limitatrice dell’autonomia fosse pleonastica rispetto alle prime due e che fosse stata aggiunta soltanto per una qualche forma di cautela. In realtà, si può affermare, anche alla luce della copiosa giurisprudenza successiva, che questo limite all’autonomia istituzionale degli Stati membri giochi un ruolo non solo distinto ma, di regola, maggiore rispetto a quello di “equivalenza”.
Si osservi (il che pare significativo nel caso in esame) che il tema della competenza-giurisdizione interna può pacificamente concretarsi in un problema di effettività della tutela di “seconda generazione”[54]: come si è espresso puntualmente l’avvocato generale Kokott, “non sussiste alcuna differenza sostanziale fra le norme relative alla competenza e quelle relative alle regole procedurali: una cattiva gestione del procedimento, infatti, può rendere molto gravoso l’accesso del singolo alle giurisdizioni nazionali quanto una cattiva normativa sulla competenza”[55] .
Nella specificità della tutela imposta dal prevalente diritto dell’Unione e dalla Corte di giustizia, si possono elaborare dei punti fermi, coerenti con la giurisprudenza dei giudici lussemburghesi.
Il diritto dell’Unione europea di per sé non esige che vi siano tre gradi di giudizio, né che agli ordinari errori nell’interpretazione ed applicazione di quel diritto sia posto rimedio ad ogni costo dalla giurisdizione individuata come competente o da un’altra che ne sia in qualche modo superiore.
In tal senso, appare corretto affermare, senza forzature, che “il controllo del rispetto del limite esterno della giurisdizione non include anche una funzione di verifica finale della conformità di quelle decisioni al diritto dell’Unione europea”[56].
Ciò vale tuttavia solo e nella misura in cui questa forma di controllo venga riservata anche ad analoghe cause interne, aventi causa petendi nella norma nazionale. Qualora, invece, ai ricorsi interni fosse riservato un rimedio ulteriore, nelle forme dell’eccesso di potere giurisdizionale latamente inteso, cioè anche come ineffettività della giurisdizione in concreto erogata, questo genere di rimedio dovrà ineludibilmente estendersi anche ai ricorsi con base giuridica in norma di diritto dell’Unione.
Ed invero, il principio dell’equivalenza della tutela[57] che opera su un piano diverso ma è comunque strumentale al principio dell’effettività della tutela giurisdizionale, impone che ogniqualvolta l’ordinamento interno garantisca una qualche forma di tutela ad un’azione o ricorso con causa petendi basata sul diritto nazionale, identica tutela debba essere garantita ad un’azione o ricorso eiusdem generis avente causa petendi nel diritto dell’Unione europea.
In definitiva, se lo stravolgimento della norma di diritto interno può garantire all’interessato un ricorso ex art. 360, n. 1 c.p.c. e art. 111 Cost., n. 8, analogo ricorso dev’essere garantito anche a chi abbia subito un’applicazione del diritto dell’Unione stravolto nei suoi connotati propri. Il che può essere anche tradotto in termini di ricorribilità ex art. 111, n. 8, Cost. di ogni violazione grave e manifesta del diritto dell’Unione, così come declinata dalla Corte di giustizia nella propria giurisprudenza relativa all’obbligo di risarcimento del danno a carico dello Stato membro che in essa incorra.
6. L’obbligo di rinvio pregiudiziale e l’effettività della tutela. Il possibile rimedio “alla Köbler”
Il Consiglio di Stato ha violato, già si è detto in modo grave e manifesto gli obblighi derivanti dal Trattato e in particolare dall’art. 267, par. 3 TFUE.
A tal riguardo, la Corte di cassazione, dopo aver richiamato la giurisprudenza più recente in tema di rinvio pregiudiziale, ha osservato nell’ordinanza che “dubbia è la compatibilità con il diritto dell’Unione dell’orientamento interpretativo di cui si è dato conto (sub paragrafo 50) che in radice esclude la possibilità per le Sezioni Unite della Corte di cassazione, investite da un mezzo di impugnativa ordinaria, qual è il ricorso per cassazione, di esaminarlo nel merito quando sia denunciata la immotivata violazione dell’obbligo di rinvio da parte del Consiglio di Stato e di effettuare direttamente il rinvio pregiudiziale, al fine di accertare l’esatta interpretazione del diritto dell’Unione e, di conseguenza, la compatibilità della sentenza con il diritto dell’Unione”[58].
A proposito dell’importanza che riveste il comportamento del Giudice nazionale nel contesto del rinvio pregiudiziale, si può ricordare quanto già affermava l’avvocato generale Léger in Traghetti del Mediterraneo: “l’inadempimento dell’obbligo di rinvio pregiudiziale costituisce uno dei criteri da prendere in considerazione per stabilire se sussista una violazione sufficientemente caratterizzata del diritto comunitario, imputabile ad un organo giurisdizionale supremo, che si aggiunge a quelli che la Corte aveva già formulato nella citata sentenza Brasserie du pêcheur e Factortame, e nella successiva giurisprudenza, riguardo alla responsabilità dello Stato per fatto del legislatore o dell’amministrazione. Benché la Corte si sia astenuta dallo stabilire una gerarchia tra tali diversi criteri, nei confronti di alcuni dei quali nutro riserve circa la pertinenza, considero che quello riguardante l’obbligo di rinvio pregiudiziale rivesta un’importanza particolare.
Per stabilire, infatti, se l’errore di diritto di cui trattasi sia scusabile o inescusabile ( permanendo, a mio avviso, tale elemento il criterio centrale attorno al quale si dispongono gli altri criteri), occorre prestare particolare attenzione all’atteggiamento tenuto dall’organo giurisdizionale supremo considerato rispetto all’obbligo di rinvio ad esso incombente”[59].
L’orientamento del Consiglio di Stato, in quanto giudice del rinvio, non ha rispettato i propri obblighi. Si potrebbe intravvedere una qualche volontà di sottrarsi ai precisi dicta della Corte: attraverso la via della violazione manifesta degli obblighi incombenti sul Consiglio di Stato, ai sensi e agli effetti dell’art. 267 TFUE, si potrebbe, invero, giungere alla conclusione che debba ammettersi il ricorso ex art. 111 Cost., anche al fine di consentire alla Corte di cassazione di apprezzare fino in fondo la gravità della violazione e di richiedere l’intervento chiarificatore della Corte di giustizia.
Nell’ordinanza in esame si osserva, precisamente, che “La tesi secondo cui l’unico rimedio praticabile in caso di violazione del diritto dell’Unione sarebbe quello del risarcimento del danno per responsabilità dello Stato (v. sub paragrafo 31) non sembra condivisibile, trattandosi di un rimedio indiretto e succedaneo, nonché sottoposto a rigide condizioni (Corte di giustizia, 30 settembre 2003, C-224/01, Köbler; 13 giugno 2006, C-173/03, Traghetti del Mediterraneo spa; 24 novembre 2011, C-379/10, Commissione c. Repubblica Italiana)”[60].
In altre parole, all’argomento invocato in senso opposto, ovvero che vi sarebbe comunque l’ulteriore rimedio risarcitorio modellato sulle soluzioni adottate nei casi Köbler e Traghetti del Mediterraneo-Commissione c. Italia, si dovrà giocoforza rispondere che il rimedio risarcitorio per fatto dello Stato-Giudice (a prescindere dalla sua difficile azionabilità) comporterebbe comunque un vulnus al principio dell’effettività che richiede, in linea di massima (e se possibile) il soddisfacimento dell’interesse specifico azionato, ovvero il riconoscimento a favore della parte vittoriosa cui essa aspira.
Come osserva la Corte di giustizia, “il principio della responsabilità dello Stato per danni causati ai singoli da violazioni del diritto comunitario ad esso imputabili è inerente al sistema del Trattato”[61]. All’obbligo posto a carico dello Stato, corrisponde, invero, il diritto del singolo, secondo la nota impostazione espressa nella sentenza Van Gend en Loos, che ben sottolinea la natura di soggetto optimo jure del cittadino dell’Unione e l’esistenza di diritti in suo favore anche in assenza di espressa previsione normativa, come contropartita di obblighi imposti ad altri soggetti (singoli, Stati membri, istituzioni comunitarie)[62].
Il secondo aspetto, nel ragionamento della Corte, non poteva che essere quello dell’effettività della tutela di tali diritti che dev’essere garantita dai giudici nazionali. In questa prospettiva, il richiamo alla giurisprudenza Simmenthal [63] e Factortame [64] è necessario e sufficiente alla Corte per ritenere che “sarebbe messa a repentaglio la piena efficacia delle norme comunitarie e sarebbe infirmata la tutela dei diritti da esse riconosciuti se i singoli non avessero la possibilità di ottenere un risarcimento ove i loro diritti siano lesi da una violazione del diritto comunitario imputabile ad uno Stato membro”[65].
La tutela completa ed effettiva di una posizione giuridica soggettiva, insomma, presuppone sempre la risarcibilità del danno ingiusto. La capacità di reintegrare, quanto meno in via subordinata per equivalente, la posizione giuridica lesa da un comportamento illecito è propria di ogni ordinamento giuridico che possa o voglia dirsi effettivo. E posto che la garanzia della piena efficacia delle norme comunitarie spetta ai giudici nazionali, a loro incombe pure, in virtù dell’art. 4.3 TUE sul principio di leale cooperazione, l’obbligo di eliminare le conseguenze illecite di una violazione del diritto comunitario. Come osserva, precisamente, la Corte di Cassazione, il rimedio del risarcimento del danno è subordinato a condizioni e presupposti particolarmente rigorosi, di difficile azionabilità, risultando in ultima analisi “succedaneo”.
Nelle materie coperte dal diritto dell’Unione, invero, è difficile negare che vi sia una sorta di sconvolgimento nei rapporti interni fra poteri, delineati tradizionalmente in termini di separazione e di indipendenza, a favore dei giudici. Questi ultimi, infatti, in virtù del primato del diritto dell’Unione e del principio dell’effettività della tutela delle posizioni giuridiche soggettive create dallo stesso, sono legittimati a sindacare atti del legislatore e dell’amministrazione rispetto ai quali, prima, non avevano alcuna competenza e potere[66].
In quanto giudici dell’Unione di diritto comune, poi, sono investiti (conformemente a quanto previsto dall’art. 19 TUE) della fondamentale funzione di garantire la piena effettività dell’ordinamento comunitario e possono persino creare nuovi rimedi processuali o adattare quelli esistenti al soddisfacimento delle nuove esigenze imposte dal diritto UE.
L’inosservanza dell’obbligo di rinvio pregiudiziale ex art. 267, comma 3, TFUE, se di per sé non è sempre indicativa di una violazione grave e manifesta[67], può in talune circostanze essere espressione di siffatta violazione, specie nel caso in cui la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia sia (manifestamente) ignorata.
D’altro canto, lo stesso “storico” precedente CILFIT (sentenza già ricordata, resa proprio su rinvio della Cassazione) insegna che qualunque dottrina sull’acte clair non è idonea a fondare il mancato rinvio ex art. 267 TFUE in assenza di chiare indicazioni provenienti dalla stessa Corte di giustizia[68].
In determinate circostanze (assenza di adeguata motivazione alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia), il mancato rinvio assurge da solo a violazione grave e manifesta del diritto dell’Unione europea ed è suscettibile di idonea censura ex art. 111 Cost. Non è un caso, ad esempio, se la Corte europea dei diritti dell’uomo abbia contestato all’Italia l’inosservanza, senza motivazione alcuna, dell’obbligo di rinvio ex art. 267 TFUE[69].
La violazione, da parte del giudice nazionale, dell’obbligo di adeguarsi e di recepire in toto i principi affermati dalla Corte di giustizia a seguito di rinvio ex art. 267 TFUE costituisce una violazione grave e manifesta del diritto dell’Unione europea ed è in grado di mettere a repentaglio le stesse basi su cui si fonda l’ordinamento comunitario, ovvero la diretta efficacia e il primato.
Come ricorda la Corte “una violazione del diritto dell’Unione è sufficientemente qualificata allorché è intervenuta ignorando manifestamente la giurisprudenza della Corte in materia (sentenze del 30 settembre 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, punto 56; del 25 novembre 2010, Fuß, C‑429/09, EU:C:2010:717, punto 52, e del 28 luglio 2016, Tomášová, C‑168/15, EU:C:2016:602, punto 26)” [70].
In conclusione, la violazione grave e manifesta del diritto dell’UE compiuta dal Consiglio di Stato in relazione alla giurisprudenza comunitaria e all’obbligo di rinvio non può considerarsi entro i c.d. limiti interni della giurisdizione del giudice amministrativo. Oltre ad involgere la responsabilità dello Stato di fronte all'Unione e agli altri Stati membri, non può non essere sindacabile ex art. 111 Cost. sotto il profilo del diritto ad una tutela effettiva e del giusto processo.
Poiché “risulta da una giurisprudenza costante che la sentenza con la quale la Corte si pronunzia in via pregiudiziale vincola il giudice nazionale, per quanto concerne l’interpretazione o la validità degli atti delle istituzioni dell’Unione in questione, per la definizione della lite principale”[71], il Consiglio di Stato ha posto in essere una violazione grave e manifesta del diritto dell’Unione europea.
Basterebbe solo ricordare che, secondo la Corte di giustizia, “In ogni caso, una violazione del diritto comunitario è manifesta e grave quando continua nonostante la pronuncia di una sentenza che ha accertato l'inadempimento contestato, di una sentenza pregiudiziale o di una giurisprudenza consolidata della Corte in materia, dalle quali risulti l'illegittimità del comportamento in questione”[72]. Ricorda, ancora, la Corte che “una violazione manifesta del diritto comunitario vigente viene commessa, appunto, nell’esercizio di una tale attività interpretativa, se, per esempio, il giudice dà a una norma di diritto sostanziale o procedurale comunitario una portata manifestamente erronea, in particolare alla luce della pertinente giurisprudenza della Corte in tale materia”[73]. Il che, sotto altro profilo, e più propriamente sulla scorta dell’ammissibilità del ricorso ex art. 111, c. 8, Cost., dà anche la misura di quanto la decisione del Consiglio di Stato sia frutto di uno stravolgimento delle norme di riferimento e degli obblighi derivanti da quel fondamentale meccanismo di cooperazione fra giudice nazionale e Corte di giustizia, rappresentato dall’art. 267 TFUE, vera “chiave di volta” dell’intero sistema[74].
7. Considerazioni conclusive e prospettive
L’ordinanza delle Sezioni Unite di rinvio alla Corte di giustizia, senz’altro animata da un apprezzabile souci d’éfficacité in favore dell’effettività del diritto dell’Unione, è del tutto coerente e conforme agli obblighi derivanti al giudice nazionale dal Trattato (art. 19, par. 2, TUE).
L’individuazione delle ragioni in virtù delle quali deve ammettersi il ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. per violazione grave e manifesta del diritto dell’Unione europea da parte del Consiglio di Stato è perfettamente in linea con la giurisprudenza della Corte, nella quale il principio di autonomia procedurale degli Stati membri non trova applicazione nel caso in cui la norma procedurale renda impossibile o anche solo particolarmente difficile l’esercizio del diritto di derivazione UE, né tanto meno laddove la norma processuale interna riservi un diverso trattamento (sfavorevole) alla situazione giuridica con causa petendi comunitaria in violazione, come già si è ricordato, del principio dell’equivalenza.
Questo avverrebbe nel caso di una prassi giurisprudenziale in virtù della quale, nelle controversie aventi ad oggetto l’applicazione del diritto nazionale, si ammettesse il ricorso per cassazione per difetto di potere giurisdizionale avverso le sentenze del Consiglio di Stato, responsabile di aver invaso le attribuzioni del legislatore, mentre, nelle controversie aventi ad oggetto l’applicazione del diritto dell’Unione, tale straripamento sarebbe pregiudizialmente irrilevante, con violazione, pure, del diritto al giudice di cui all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali della UE.
Questa conclusione, invero, non può essere rimessa in discussione dal tradizionale principio di autonomia procedurale degli Stati membri, particolarmente in un settore in cui una specifica disciplina di diritto dell’Unione (direttive n. 665/89 e 66/77) ha inteso uniformare le condizioni processuali di tutela.
Il disconoscimento, da parte del giudice amministrativo, degli obblighi derivanti dalla giurisprudenza comunitaria e dalla sua vincolatività, estrinsecantesi nell’immotivata elusione dell’obbligo di rinvio (come nel caso di specie) costituisce una violazione grave e manifesta del diritto dell’Unione europea suscettibile di un rimedio risarcitorio “alla Köbler”.
Ciò, tuttavia, non impedisce alla Corte regolatrice, in omaggio al principio dell’effetto utile dell’effetto diretto, di fare tutto il possibile per garantire ai privati interessati il c.d. bene specifico della vita cui ambiscono, se del caso preservando l’accesso al Giudice della nomofilachia in nome del principio dell’effettività della tutela giurisdizionale.
Non resta che attendere e confidare nell’intervento chiarificatore della Corte di giustizia e seguirne il prosieguo avanti al giudice nazionale.
Il presente contributo è frutto della condivisione di opinioni dei due autori, in particolare, la premessa e le considerazioni conclusive; i paragrafi da 2 a 4 sono da attribuire a Paolo Piva, mentre i paragrafi 5 e 6 a Bruno Nascimbene (una precedente versione è stata pubblicata in Jus, n. 5/2020, qui aggiornata e modificata).
[1] Nel presente scritto l’aggettivo “comunitario” viene usato come equivalente di “dell’Unione” (secondo una prassi in uso nella dottrina).
* Già professore ordinario di diritto internazionale e di diritto dell’Unione europea.
** Professore associato di diritto dell’Unione europea.
[2] Sul tema, oltre al recente contributo di B. Nascimbene, La tutela dei diritti fondamentali in Europa: i cataloghi e gli strumenti a disposizione dei giudici nazionali (cataloghi, arsenale dei giudici e limiti o confini), in Eurojus, 2020, cfr. nella manualistica recente, L. Daniele, Diritto dell’Unione europea, 7° ed., Milano, 2020, pp. 326 ss.; G. Tesauro, Diritto dell’Unione europea, a cura di P. De Pasquale e F. Ferraro, II ed., Napoli, 2020,, pp. 231 ss.; U. Villani, Istituzioni di Diritto dell’Unione europea, 6° ed., Bari, 2020, pp. 109, 450 ss.; R. Adam, A. Tizzano, Manuale di Diritto dell’Unione europea, III ed., Torino, 2020, pp. 921 ss., nonché K. Lenaerts, I. Maselis, K. Gutman, Eu Procedural Law, Oxford, 2014, pp. 48 ss. Molto appropriate, in prospettiva storica, anche le considerazioni di F. Jacobs, The Role of National Courts and of the European Court of Justice in Ensuring the Uniform Application of Community Law, in Studi in onore di Francesco Capotorti, II Tomo, Milano, 1999, pp. 175 ss. Per i commenti all’ordinanza si vedano P. Baratta, E’ censurabile per Cassazione la violazione del diritto sovranazionale imputabile al giudice amministrativo?, in www.apertacontrada.it; S. Barbareschi, L.A. Caruso, La recente giurisprudenza costituzionale e la Corte di Cassazione «fuori contesto»: considerazioni a prima lettura di ord. Cass. SS.UU. 18 settembre 2020, n. 19598, in Federalismi.it, 2020; R.Bin, E’ scoppiata la terza “guerra tra le Corti”? A proposito del controllo esercitato dalla Corte di Cassazione sui limiti della giurisdizione, in Federalismi.it, 2020; M. Clarich, Giurisdizione: "Partita a poker" tra Cassazione e Consulta sulle sentenze del Consiglio di Stato, in Civile NTplus.ilsole24ore.com del 14 ottobre 2020; G. Costantino, A. Carratta, G. Ruffini, Limiti esterni e giurisdizione: il contrasto fra Sezioni Unite e Corte Costituzionale arriva alla Corte UE. Note a prima lettura di Cass. SS.UU. 18 settembre 2020, n. 19598, in Questione giustizia, 2020; F. Francario, Quel pasticciaccio brutto di piazza Cavour, piazza del Quirinale e piazza Capodiferro (la questione di giurisdizione), in questa Rivista, 2020; Ginevra Greco, La violazione del diritto dell’Unione europea come possibile difetto di giurisdizione ?, in Eurojus, 2020; G. Tropea, Il Golem europeo e i «motivi inerenti alla giurisdizione» (Nota a Cass., Sez. un., ord. 18 settembre 2020, n. 19598), in questa Rivista. Si vedano inoltre le relazioni di E. Cannizzaro, M. Luciani, A. Carratta, G. Ruffini, A. Travi, F. Francario tenute al webinar del 6 novembre 2020 “Limiti esterni di giustizia e rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE (a proposito di Cass. S.U. n. 19598/2020)”: la registrazione delle relazioni e interventi è in questa Rivista, 2020; le relazioni, in particolare quella di C. Curti Gialdino, al webinar del 13 novembre 2020 “Un riaccentramento del giudizio costituzionale? I nuovi spazi del Giudice delle leggi, tra Corti europee e giudici comuni” : la registrazione delle relazioni e interventi è in Federalismi.it, 2020); le relazioni di L. Daniele, B. Sassani, A. Police al webinar del 18 novembre 2020 “La «querelle» sulla definizione dei «motivi inerenti la giurisdizione» ai sensi dell’art. 111, comma 8 Cost. davanti alla Corte UE (sull’ordinanza Cass., S.U. n. 19598/2020): la registrazione delle relazioni e interventi è in https://uniroma2.sharepoint.com/sites/FormazionePostLaureamJuris/Documenti%20condivisi/General/Webinar%2018.11.2020.mp4.
[3] Sentenza del 24 giugno 2019, spec. punto 49, in ECLI:EU:C:2019:531.
[4] Cfr. il par. 46 dell’ordinanza.
[5] Anche se non sempre, come si illustrerà oltre.
[6] Sulla sentenza della Corte cost. si veda oltre, par. 4.
[7] Sul tema, si veda, fra gli altri, R. Medhi, L’autonomie institutionnelle et procédurale et le droit administratif, in J.-B. Auby, J. Dutheil De La Rochère (sous la direction de), Droit Administratif Européen, Bruxelles, 2007, pp. 685 ss ; per rilievi di carattere generale A.M. Romito, La tutela giurisdizionale nell’Unione europea: tra effettività del sistema e garanzie individuali, Bari, 2015, pp. 127 ss.
[8] Per un interessante caso di applicazione del principio di equivalenza, si vedano le sentenze del 26 gennaio 2010, Transportes Urbanos, C-118/08, ECLI:EU:C:2010:39 e del 22 giugno 2010, Aziz Melki (C-188/10) e Sélim Abdeli (C-189/10), ECLI:EU:C:2010:363. Sul tema si permette di ricordare, fra gli altri, P. Piva, Il principio dell’effettività della tutela giurisdizionale nel Diritto dell’Unione Europea, Napoli, 2012, in particolare, pp. 47 ss. Sul principio di equivalenza, si veda, fra gli altri, E. Cannizzaro, Effettività del Diritto dell’Unione e rimedi processuali nazionali, in Il Dir.Un.Eur., 3/2013, pp. 671 ss. Sul tema della leale cooperazione, si vedano, fra gli altri, P. Mori, Quelques réflections sur la confiance réciproque entre Etats membres: un principe essentiel de l’Union européenne, in Liber Amicorum Antonio Tizzano, Torino, 2018, pp. 651 ss.; U. Villani, Istituzioni cit., pp. 108 ss.
[9] Cfr. il par. 60 dell’ordinanza.
[10] Sentenza del 6 ottobre 1982, C-283/81, ECLI:EU:C:1982:335.
[11] Sentenza del 4 luglio 2013, C-100/12, ECLI:EU:C:2013:448.
[12] Sentenza del 5 aprile 2016, C‑689/13, ECLI:EU:C:2016:199.
[13] Sentenza del 21 dicembre 2016, C- 355/15, ECLI:EU:C:2016:988.
[14] Sentenza del 5 settembre 2019, C-333/18, ECLI:EU:C.2019:675.
[15] Sentenza del 30 settembre 2003, C-224/01, ECLI:EU:C:2003:513.
[16] Sentenza del 13 giugno 2006, C-173/03, ECLI:EU:C:2006:391.
[17] Per la quale, si rinvia a F. Auletta, S. Boccagna, N. Rascio (a cura di ), La responsabilità civile dei magistrati. Commentario alle leggi 13 aprile 1988, n. 117 e 27 febbraio 2015, n. 18, Bologna, 2017.
[18] Sul tema, cfr. M. Rainey, C. Dwyer , A. Rose, European Union, in J. Davey, A. Gatenby (eds.),The Government Procurement Law, 8th ed., London, 2020, pp. 74 ss. Si veda altresì C. Benetazzo, Ricorso incidentale, ordine delle questioni e principio di effettività, Torino, 2016, pp. 129 ss. Si devono segnalare anche le forti critiche della dottrina processualamministrativistica rinvenibile, fra gli altri, in R. Villata, Osservazioni in tema di incidenza del diritto comunitario sul sistema italiano di giustizia amministrativa, in Scritti di giustizia amministrativa, Milano, 2015, pp. 1217 ss.
[19] Sentenza del 19 giugno 2003, C-249/01, ECLI:EU:C:2003:359, punto 18.
[20] Sentenza Hackermüller cit., punto 27.
[21] Sentenza del 4 luglio 2013, C-100/12, ECLI:C:2013:448, punti 30-34.
[22] Sentenza BTG cit., punto 34.
[23] Sentenza Lombardi cit., punto 27.
[24] Sentenza Lombardi cit., punto 34.
[25] Così G. Tropea, Il Golem europeo cit., loc. cit. che richiama in tal senso L. Bertonazzi, La giurisprudenza europea in tema di ricorso incidentale escludente, in Dir. proc. amm., 2020, p. 543.
[26] Sentenza dell’11 maggio 2017, C-131/16, Archus, ECLI:EU:C:2017:358, punto 50 ove si afferma che “ gli Stati membri provvedono a rendere accessibili le procedure di ricorso, secondo le modalità che spetta agli Stati membri determinare, a chiunque abbia o abbia avuto interesse ad ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione”.
[27] Cons. Stato, III, sentenza del 7 agosto 2019, n. 5606.
[28] Come si è osservato puntualmente, “il caso di specie s’inscrive a pieno titolo in questo filone, in quanto il Consiglio di Stato nega la possibilità di ravvisare un interesse legittimo se l’interesse è soltanto strumentale alla ripetizione della gara e ritiene che in tal caso si sia in presenza di un interesse di mero fatto”: in questi termini F. Francario, Quel pasticciaccio brutto cit., loc. cit.
[29] Cfr. i rifer. alla nota 10.
[30] Punto 17 della sentenza CILFIT cit.
[31] Cfr. ex multis, Cass. S.U., sentenza del 15 luglio 2003, n. 11091.
[32] Si veda l’Introduzione di M. A. Sandulli, La Corte di Cassazione. Sentenza n. 30254/2008, le Sezioni Unite in tema di pregiudiziale amministrativa, in Federalismi.it, 2009. Sul tema, si veda pure F. Cortese, La questione della pregiudizialità amministrativa. Il risarcimento del danno da provvedimento illegittimo tra diritto sostanziale e processuale, Padova, 2007, passim.
[33]Cfr. la pronuncia S.U. n. 30254/08 cit.
[34] Cfr. la pronuncia S.U. n. 2242/2015 cit.
[35] Cfr. la pronuncia S.U. n. 31226/2017 cit.
[36] Cfr. fra le altre Cass. S.U., 23 aprile 2020, n. 8096, nonché S.U. 16 maggio 2019, n. 13243 in cui, analogamente, un ricorso ex art. 111 Cost. avverso la pronuncia del Consiglio di Stato che aveva accolto il ricorso incidentale escludente contro l’insegnamento della Corte di giustizia era stato respinto. Sulla tematica si veda anche G. Greco, La violazione cit., loc. cit.
[37] Cfr. il punto 12 del “Considerato in diritto”; per le citazioni successive si vedano i punti 13-17.
[38] Cfr. fra le altre Cass. S.U., 15 luglio 2003, n. 11091; S.U. 4 febbraio 2014, n. 2403 che richiama molti precedenti in materia.
[39] Cfr. il punto 16 del “Considerato in diritto”.
[40] Cfr. la sentenza Köbler cit. Si vedano pure la sentenza Traghetti del Mediterraneo cit., nonché 24 novembre 2011, C- 379/10, Commissione c. Repubblica italiana, ECLI:EU:C:2011:775.
[41] Cfr. G. Costantino, A. Carratta, G. Ruffini, Limiti esterni cit., loc. cit.
[42] In questi termini V. Andrioli, Commento al Codice di procedura civile, Vol. II, III ed. riveduta, Napoli, 1956, p. 362.
[43] Di questo profilo, peraltro, la Corte di Cassazione è perfettamente consapevole: cfr. punto 45 dell’ordinanza. Anche il tema della revocazione ex art. 395 c.p.c. viene sollevato dalla sentenza n. 6/18 in modo poco persuasivo: cfr. la stessa ordinanza, par. 37.
[44] Su una pretesa irriducibilità del contrasto, si veda F. Deodato, Nota a Corte costituzionale – Sentenza 24 giugno 2018, n. 6 e Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili, Sentenza 29 dicembre 2019, n. 31226, in Il diritto amministrativo, Rivista giuridica online; più recentemente R. Bin, E’ scoppiata cit., loc. cit.; B. Caravita, La Cassazione cit., loc. cit.; M. Clarich, Giurisdizione cit., loc. cit. (che si esprime in termini di “arbitraggio” rispetto all’invocato intervento della Corte). Sembra utile ricordare, peraltro, che già nel passato la Corte di giustizia si occupò di “effettività” della giurisdizione interna (precisamente di quella italiana, come nel caso in esame), ovvero di “tutela diretta e immediata”, venendo in rilievo la distinzione, nel diritto italiano, appunto, fra diritti soggettivi e interessi legittimi, e quindi la diversa competenza del giudice interno, civile o amministrativo. La Corte di giustizia, 19 dicembre 1968, 13-68, Salgoil, ECLI:EU:C:1968:54, osserva, precisamente, che le norme comunitarie “obbligano le autorità e in particolare i giudici competenti degli Stati membri a proteggere gli interessi dei singoli contro eventuali violazioni di dette disposizioni, garantendo loro la tutela diretta e immediata dei loro interessi, e ciò indipendentemente dal rapporto intercorrente, secondo il diritto nazionale, fra detti interessi e l’interesse pubblico a cui si riferisce la questione”, sottolineando quindi che “Spetta all’ordinamento giuridico nazionale lo stabilire quale sia il giudice competente a garantire detta tutela e, a tale effetto, il decidere come debba qualificarsi la posizione individuale in tal modo tutelata”.
[45] Cfr. il punto 5 della sentenza Rewe del 16 dicembre 1976, cit. infra.
[46]Sentenze del 16 dicembre 1976, rispettivamente 33-76, ECLI:EU:C:1976:188 e 45-76, ECLI:EU:C:1976:191.
[47] Sentenza del 27 febbraio 2003, C-327/00, Santex SpA e Unità Socio Sanitaria Locale n. 42 di Pavia, ECLI:EU:C:2003:109, punto 66, nonché più recentemente, a proposito della “saga” delle specializzazioni mediche, 19 maggio 2011, Iaia e altri, C-452/09, ECLI: EU: C: 2011: 323.
[48] In questi termini, S. Fantini, H. Simonetti, Le basi del diritto dei contratti pubblici, 2° ed., Milano,2019, pp. 153-154.
[49] Cfr. il punto 41.1 dell’ordinanza in esame.
[50] Nella giurisprudenza successiva, il principio di effettività è emerso come il limite preponderante, idoneo sia a sindacare efficacemente termini eccessivamente brevi (sentenza Grundig Italiana Spa di cui poco oltre), sia a creare veri e propri nuovi rimedi processuali (sentenze del 19 giugno 1990, Factortame, C-213/89, ECLI:EU:C:1990:257 e del 19 settembre 1996, Commissione c. Repubblica ellenica, C-236/95, ECLI:EU:C:1996:341).
[51] Sentenza del 24 settembre 2002, C-255/00, Grundig Italiana S.p.A. ECLI:EU:C:2002:525,punto 42, in cui la Corte ha osservato che “il diritto comunitario osta all'applicazione retroattiva di un termine di decadenza più breve e, eventualmente, più restrittivo per l'attore del termine di ricorso precedentemente applicabile alle domande di rimborso di imposte nazionali incompatibili con il diritto comunitario, quando non è garantito un periodo transitorio sufficiente durante il quale le domande vertenti su importi versati prima dell'entrata in vigore del testo che introduce questo nuovo termine possono ancora essere presentate in osservanza del vecchio termine. Nell’ipotesi di sostituzione di un termine di decadenza triennale a un termine di prescrizione quinquennale, un periodo transitorio di 90 giorni dev'essere considerato insufficiente e il periodo transitorio minimo tale da non rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto a un siffatto rimborso dev'essere valutato pari a sei mesi”.
[52] Sentenza del 29 luglio 2019, Hochtief Solutions, C-620/17, ECLI:EU:C:2019:630,punto 49.
[53] Cfr. J. Mertens De Wilmars, L’efficacité des différentes techniques nationales de protection juridique contre les violations du droit communautaire par les autorités nationales et les particuliers, Cah. Dr. Eur. ,1982, pp. 401 ss.
[54] Questa particolare espressione, “problèmes de la seconde géneration”, è di J. Mertens de Wilmars (già giudice e presidente della Corte di giustizia), come ricorda Th. Koopmans, Problemen van de tweede generatie, in Liber Amicorum J. Mertens de Wilmars, Antwerpen, 1982, pp. 121 ss.
[55] Conclusioni dell’avvocato generale Kokott del 9 gennaio 2008, C-268/06, Impact, ECLI:EU:C:2008:2,punto 50. Cfr. anche la sentenza della Corte del 15 aprile 2008, Impact, C-268/06, ECLI:EU:C:2008:223. È significativo, tra l’altro, come nella medesima pronuncia, con riguardo alle norme interne sulla competenza, si precisi altresì che “tali esigenze di equivalenza e di effettività, espresse attraverso l’obbligo generale per gli Stati membri di garantire la tutela giurisdizionale spettante ai singoli in forza del diritto comunitario, valgono anche quanto alla designazione dei giudici competenti a conoscere delle azioni fondate su tale diritto. Infatti, il mancato rispetto delle suddette esigenze sotto tale profilo è, al pari di un inadempimento delle medesime sotto il profilo della definizione delle modalità procedurali, tale da ledere il principio di tutela giurisdizionale effettiva” (punti 47-48).
[56] In questi termini, fra le altre, Cass. S.U., 21 marzo 2017, n. 7157.
[57] Cfr., fra le altre, le sentenze Transportes Urbanos cit., nonchè Hochtief Solutions cit., e del 6 ottobre 2015, Orizzonte Salute, C- 61/14, ECLI:EU:C:2015:655.
[58] Cfr. il par. 58 dell’ordinanza.
[59] Cfr. i punti 69-71 delle conclusioni dell’11 ottobre 2005, ECLI:EU:C:2005:602.
[60] Cfr. il par. 52 dell’ordinanza.
[61] Cfr. il punto 35 della sentenza Köbler cit.
[62] Sentenza del 5 febbraio 1963, 26/62, ECLI:EU:C:1963:1.
[63] Sentenza del 9 marzo 1978, C-106/77, ECLI:EU:C:1978:49.
[64] Sentenza del 19 giugno 1190 cit.
[65] Punto 33 della sentenza Köbler cit.
[66] Per alcuni rilievi sul principio primato, ed effetti, cfr. G. Tesauro, Diritto dell’Unione europea cit., pp. 231 ss., nonché pp. 263 ss.; R. Adam, A. Tizzano, Manuale cit., pp. 370 ss.
[67] Cfr. sentenza Köbler cit., punto 55. Precisa la Corte che si deve prendere in considerazione, in particolare, “ il grado di chiarezza e di precisione della norma violata, il carattere intenzionale della violazione, la scusabilità o l’inescusabilità dell’errore di diritto, la posizione adottata eventualmente da un’istituzione comunitaria nonché la mancata osservanza, da parte dell’organo giurisdizionale di cui trattasi, del suo obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 234, terzo comma, CE”.
[68] Cfr. i rifer. alla nota 10.
[69] Cfr. la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 21 luglio 2015, Schipani e altri c. Italia. Sul tema si veda, recentemente, F. Ferraro, Le conseguenze derivanti dalla violazione dell’obbligo di rinvio pregiudiziale, in F. Ferraro , C. Iannone (a cura di), Il rinvio pregiudiziale, Torino, 2020, pp. 139 ss. Sulla giurisprudenza della Corte EDU in argomento, con particolare riferimento al nostro Paese, cfr. B. Nascimbene, Le renvoi préjudiciel de l’article 267 TFUE et le renvoi prévu par la protocole no. 16 à la CEDH, in Annuaire de droit de l’Union Européenne, 2019, pp. 127 ss.
[70] Sentenza Hochtief Solutions cit., punto 43.
[71] Cfr. la sentenza del 5 ottobre 2010, Elchinov, C‑173/09, EU:C:2010:581, punto 29.
[72] In questi termini la sentenza del 5 marzo 1996, Brasserie du Pêcheur e Factortame, C-46/93 e C-48/93, ECLI:EU:C:1996:79, punto 57.
[73] Si veda la sentenza Traghetti del Mediterraneo cit., punto 35.
[74] Cfr. l’ordinanza in esame, par. 55, con i riferimenti alla giurisprudenza della Corte di giustizia.
Il controverso requisito della permanenza in servizio per il consigliere CSM, la decisione spetta al giudice ordinario.
(nota a T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 13 novembre 2020 n. 11814)
Enrico Zampetti
1. La vicenda in esame trae origine dalla delibera del Consiglio Superiore della Magistratura che ha dichiarato cessato dalla carica di consigliere uno dei membri togati del Consiglio in ragione del suo sopravvenuto collocamento a riposo. Il Consigliere dichiarato cessato ha così proposto ricorso avverso la suddetta delibera contestandola sotto vari profili e, in particolare, per il fatto che la cessazione sia stata dichiarata prima del decorso del termine quadriennale di durata della carica[i], pur in assenza di una previsione che includa espressamente tra le cause di cessazione il sopravvenuto collocamento a riposo del magistrato.
2. Con la sentenza in esame, il T.A.R. del Lazio dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso proposto dal consigliere togato, assumendo che sulla controversia abbia giurisdizione il giudice ordinario. A sostegno della conclusione, la decisione richiama il consolidato orientamento in materia di elezioni amministrative, secondo il quale al giudice ordinario sarebbero devolute le controversie “afferenti questioni di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità dei candidati” in quanto relative a “diritti soggettivi di elettorato”, mentre al giudice amministrativo sarebbero devolute quelle “afferenti alla regolarità delle operazioni elettorali” in quanto relative a “posizioni di interesse legittimo”[ii]. Più esattamente, una volta esauritasi la fase elettorale, all’amministrazione spetterebbe soltanto il compito di verificare la sussistenza o meno di eventuali cause d’incompatibilità, ineleggibilità o decadenza, senza alcun esercizio di poteri autoritativo-discrezionali, sicché la pretesa ad essere dichiarato eletto, ovvero a mantenere la carica, afferirebbe pacificamente ad una posizione di diritto soggettivo e non di interesse legittimo.
Tuttavia, nel richiamare il citato orientamento, la stessa sentenza sottolinea che nel caso di specie le operazioni elettorali riguarderebbero la costituzione di un organo amministrativo di rilevanza costituzionale e non di un organo politico, e che, sempre nel caso di specie, non verrebbe propriamente in rilievo un’ipotesi di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, ma soltanto un caso di “cessazione dalla carica” per il venir meno di un requisito per la conservazione dell’ufficio[iii]. Cionondimeno, il T.A.R. ritiene che i principi di riparto affermati per l’elezione degli organi politici siano applicabili anche all’elezione del Consiglio Superiore della Magistratura, in quanto, pur non venendo in considerazione un’ipotesi di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, i poteri concretamente esercitati nei confronti del ricorrente non “possono definirsi di natura autoritativa”, ma devono “ricondursi nell’ambito delle attività di verifica amministrativa della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento della carica”, con la conseguenza che “il petitum sostanziale del giudizio attiene sempre alla tutela di un diritto soggettivo, poiché la verifica svolta dal CSM non è idonea a far degradare a interesse legittimo la posizione dell’interessato”[iv].
Ad ogni modo, la decisione non chiarisce esattamente su quale norma o principio si fondi il requisito che, nell’ottica del provvedimento impugnato, andrebbe necessariamente a correlare il mantenimento della carica allo status di magistrato in servizio. Deve, pertanto, desumersi che, ai fini della questione di giurisdizione, il T.A.R. ritenga di poter prescindere dall’esatta individuazione del fondamento giuridico del requisito in esame, sul presupposto che l’esistenza o meno di un’esplicita previsione che lo contempli potrebbe soltanto implicare una diversa conformazione (dei contenuti) del diritto al mantenimento della carica, ma non mutarne la natura da diritto soggettivo a interesse legittimo.
3. Sotto altro profilo, la sentenza esclude che la sussistenza della giurisdizione amministrativa possa desumersi dall’articolo 135 del codice del processo amministrativo, il quale, nel prevedere le ipotesi di competenza funzionale del TAR Lazio, alla lettera a) vi include espressamente le “controversie relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari adottati ai sensi dell’articolo 17, primo comma, della legge 24 marzo 1958 n. 195”[v]. La decisione sottolinea al riguardo che tutte le ipotesi di competenza funzionale individuate dalla norma sono previste “nel presupposto che la relativa controversia sia comunque sottoposta, in base agli ordinari criteri, alla giurisdizione di questo giudice”. Poiché si limita a contemplare un’ipotesi di competenza inderogabile senza al contempo introdurre un caso di giurisdizione esclusiva, la norma radicherebbe la giurisdizione amministrativa solo al cospetto di provvedimenti correlati a posizioni d’interesse legittimo, con esclusione dei casi, come quello in esame, in cui il provvedimento del C.S.M. venga a incidere su un diritto soggettivo.
4. Al di là della sua incidenza o meno sul profilo della giurisdizione, l’assenza di una norma che richieda espressamente lo status di magistrato in servizio tra i requisiti per mantenere la carica di consigliere costituisce, invero, l’aspetto centrale della questione di merito sulla quale dovrà pronunciarsi il giudice provvisto di giurisdizione. Non è certamente questa la sede per affrontare una questione così rilevante e complessa, ma può osservarsi che la sua soluzione richiede essenzialmente di chiarire se, in assenza di un’apposita norma che disciplini compiutamente la fattispecie, il collegamento tra status di magistrato in servizio e mandato consiliare debba mantenersi per tutta la durata dell’incarico, alla stregua di un principio generale desumibile dall’ordinamento nel suo complesso; o se, invece, sia necessaria un’espressa previsione normativa che prescriva l’attualità del rapporto di servizio per l’intero svolgimento dell’incarico e non solo al momento dell’elezione, sul presupposto che non sia possibile desumere aliunde un principio generale che correli la cessazione della carica al collocamento a riposo. Nel merito della questione l’ulteriore aspetto rilevante riguarda l’esatta qualificazione del C.S.M., a fronte dei diversi inquadramenti che ora tendono a valorizzarne la funzione di “autogoverno” della magistratura, ora a porne in risalto quella di garanzia dell’autonomia e indipendenza della magistratura stessa[vi].
[i] È appena il caso di sottolineare che, ai sensi dell’art. 104, co.6, Cost., “i membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili” (cfr. anche art. 32 l. 24 marzo 1958 n. 195).
[ii] Ex multis, Cons. St., sez. V, 15 luglio 2013 n. 3826; Cons. St., sez. V, 11 giugno 2013 n. 3211; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, 7 novembre 2018 n. 10756.
[iii] Come noto, la legge 24 marzo 1958 n. 195 “Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura” prevede le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere. Nel recare la disciplina dell’elettorato attivo e passivo, l’articolo 24 stabilisce che non sono eleggibili i magistrati che “al momento della convocazione delle elezioni non esercitino funzioni giudiziarie o siano sospesi dalle medesime”, gli uditori giudiziari e i magistrati di tribunale che “al momento della convocazione delle elezioni non abbiano compiuto almeno tre anni di anzianità nella qualifica”; i magistrati che “al momento della convocazione delle elezioni abbiano subito sanzione disciplinare più grave dell’ammonimento, salvo che si tratti della sanzione della censura e che dalla data del relativo provvedimento siano trascorsi almeno dieci anni senza che sia seguita alcun’altra sanzione disciplinare”; i magistrati che abbiano prestato servizio “presso l’Ufficio studi o presso la Segreteria del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni”; i magistrati che “abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni”. A sua volta, nel prevedere le ipotesi di incompatibilità, l’articolo 33 sancisce che i componenti del Consiglio “non possono far parte del Parlamento, dei consigli regionali, provinciali e comunali, della Corte costituzionale e del governo”; che i componenti eletti dal Parlamento, finché sono in carica, “non possono essere iscritti negli albi professionali. Non possono essere titolari di imprese commerciali né far parte di consigli di amministrazione di società commerciali. Non possono altresì far parte di organi di gestione di unità sanitarie locali, di comunità montane o di consorzi, nonché di consigli di amministrazione o di collegi sindacali di enti pubblici, di società commerciali e di banche (…)”. Con specifico riferimento ai casi di decadenza dalla carica, l’articolo 34 prevede che “i componenti del Consiglio superiore decadono di diritto dalla carica se sono condannati con sentenza irrevocabile per delitto non colposo” e che “i magistrati componenti il Consiglio superiore incorrono di diritto nella decadenza dalla carica se riportano una sanzione disciplinare più grave dell’ammonimento”.
[iv] Più precisamente, la sentenza osserva che, nonostante la veste provvedimentale assunta dall’impugnata delibera del CSM, la relativa controversia deve essere comunque conosciuta dal giudice ordinario, in quanto, secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, devono ritenersi “devolute al giudice ordinario le controversie concernenti l'ineleggibilità, la decadenza e l'incompatibilità, in quanto volte alla tutela del diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato passivo” anche nei casi in cui “la questione di eleggibilità venga introdotta mediante impugnazione del provvedimento di decadenza, perché anche in tale ipotesi la decisione verte non sull'annullamento dell'atto amministrativo, bensì sul diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato attivo o passivo” (Cass. civ., sez. un., ord. 6 aprile 2012 n. 5574).
[v]Ai sensi dell’articolo 17, primo comma, l. n. 195 del 1958, come richiamato dall’articolo 135, lettera a), c.p.a., “tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati sono adottati, in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore, con decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Ministro, ovvero, nei casi stabiliti dalla legge, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia”.
[vi] Sui termini della questione, R. Russo, L’affaire Davigo. Semel iudex semper iudex? e S. Amore, Collocamento in quiescenza del magistrato ordinario e cessazione del mandato elettivo al C.S.M., entrambi in questa Rivista (12 ottobre 2020); N. Rossi, Sta per nascere al CSM un caso Davigo?, in questionegiustizia.it (31 luglio 2020).
Digital package: verso la regolamentazione delle piattaforme online
di Elisa Arbia
sommario: 1. Introduzione. – 2. I mercati digitali. – 3. Attuale quadro normativo. – 4. Verso una regolamentazione dei gatekeeper: il Digital Package – 4.1. Piattaforme come canali per la diffusione di contenuti, beni e servizi illeciti – 4.2. Regolamentazione ex ante – 5. Considerazioni finali
1. Introduzione
A partire dall’inizio del XXI secolo abbiamo assistito allo sviluppo e diffusione delle grandi piattaforme online quali potenti mezzi per sfruttare appieno la tecnologia internet. Attualmente più di un milione di imprese europee raggiunge i propri clienti attraverso tali piattaforme , e si stima che circa il 60% dei consumi privati e il 30% dei consumi pubblici di beni e servizi legati all'economia digitale complessiva siano processati attraverso intermediari online[1].
Se da una parte, come accade sempre nelle economie di mercato, le imprese pioniere sono state premiate con l'acquisizione di un solido potere di mercato e dei relativi profitti, dall’altra il mondo digitale presenta delle specificità che rendono tale potere difficile da contrastare. In generale, la principale peculiarità di queste piattaforme è quella di creare, a partire dalle proprie competenze di base, interi ecosistemi in cui sono in grado di controllare l’accesso e la permanenza sul mercato delle imprese e indirizzare le scelte dei consumatori.
La crescente intermediazione nelle transazioni commerciali da parte di queste piattaforme, come si vedrà nel proseguo, combinata con forti effetti indiretti di rete, e alimentata dai vantaggi competitivi estratti dallo sfruttamento dei dati, porta ad una sempre maggiore dipendenza delle imprese dalle piattaforme online, che finiscono per operare quasi come "guardiani"(c.d. gatekeepers) dei mercati e dei consumatori.
Non a caso, in dottrina, si è parlato delle piattaforme online non solo come gatekeepers ma anche di veri e propri “stati nazionali”[2]:“ Nella complessità dei problemi di governance che devono affrontare, le grandi piattaforme assomigliano agli stati nazionali. Con oltre 1,5 miliardi di utenti, Facebook supervisiona una "popolazione" più grande di quella cinese. Google gestisce il 64% delle ricerche online negli Stati Uniti e il 90% di quelle in Europa, mentre Alibaba gestisce più di 1 trilione di yuan (162 miliardi di dollari) di transazioni all'anno e rappresenta il 70% di tutte le spedizioni commerciali in Cina. Le piattaforme online di queste dimensioni controllano sistemi economici più grandi di molte economie nazionali (…)”.
È evidente, allora, come la pressione sulle autorità di concorrenza e sui legislatori europei sia sempre più forte, e i tempi potrebbero essere maturi per una prima vera regolamentazione dei mercati digitali, in linea, peraltro, con le priorità europee individuate dalle linee guida politiche tracciate dal presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen[3].
Il Digital Service Act Package[4], atteso per i primi di dicembre, è rivolto proprio a questo obbiettivo, nel tentativo di rafforzare il mercato unico per i servizi digitali e innalzare il livello di innovazione e concorrenza nell’orizzonte europeo online.
Dopo una breve disamina delle caratteristiche dei mercati digitali (paragrafo 2) il presente contributo intende fornire un quadro generale dell’attuale normativa europea (paragrafo 3), per poi illustrare la proposta al momento al vaglio della Commissione Europea (paragrafo 4).
2. I mercati digitali
I mercati digitali presentano una serie di caratteristiche comuni[5], destinate ad avere un impatto positivo su consumatori e imprese. Permettono una maggiore scelta e una più facile comparazione per i consumatori, che possono godere di prodotti innovativi; aiutano le imprese agevolando il commercio intra e transfrontaliero; facilitano l’accesso sul mercato di nuovi operatori. Senonché sono proprio queste caratteristiche a sollevare perplessità sotto un profilo concorrenziale e di tutela dei consumatori.
Si tratta, infatti, di mercati molto concentrati e trasparenti in cui è più facile monitorare le condotte dei concorrenti pervenendo a collusioni tacite e altre forme di coordinamento, facilitate altresì da un ampio uso di algoritmi che permettono l’adattamento alle condotte dei concorrenti anche attraverso meccanismi di riadeguamento automatico di prezzi.
Allo stesso tempo gli operatori dei mercati digitali possono godere di forti economie di scala ed effetti di rete alimentati dallo sfruttamento dei dati raccolti per mezzo di servizi per così dire “gratuiti”. Questi meccanismi, che in questa sede non è possibile approfondire, sono alla base di scenari c.d. “winner takes it all” o “winner takes the most”, in cui una volta acquisito il potere di mercato o, spesso, la dominanza, tale posizione è molto difficile da contrastare per gli altri operatori.
Il loop positivo è ben noto. Le piattaforme digitali collegano molte aziende con molti consumatori attraverso i loro servizi. A loro volta questi servizi permettono alla piattaforma di accedere a grandi quantità di dati, che possono essere sfruttati per migliorare ulteriormente i propri servizi o sviluppare nuovi servizi nei mercati adiacenti.
In questo scenario il successo di qualsiasi tentativo di sfidare un operatore consolidato nel mercato, c.d. incubent, dipenderà dalla capacità di un potenziale rivale di attrarre una massa critica di utenti e quindi di generare i propri effetti positivi di rete.
Alla luce del quadro sinora delineato pare lecito domandarsi in che modo sia possibile depurare le piattaforme online dei richiamati effetti distorsivi sul mercato, assicurando il corretto dipanarsi del gioco della concorrenza sia per i mercati digitali (al fine di assicurare che le piattaforme dominanti competano nel merito) che nel mercato digitale (al fine di assicurare che all’interno di queste piattaforme gli operatori non subiscano discriminazioni o limitazioni).
3. Attuale quadro normativo
Il quadro normativo attualmente in vigore è connotato da un approccio fortemente settoriale e viene lasciato agli ordinari strumenti in materia di tutela della concorrenza il compito di adattarsi ai nuovi scenari digitali.
Più nello specifico, la disciplina dei c.d. “information society service” i.e., internet service providers e intermediari online, ruota intorno alla c.d. Direttiva E-Commerce[6], adottata nel 2001 con lo scopo di rafforzare il mercato interno ponendo le basi per l’innovazione tecnologica attraverso una rafforzamento della fiducia dei consumatori nei confronti dei servizi digitali, migliorando la trasparenza e delineando i limiti alla responsabilità in capo agli information society service provider per quanto riguarda eventuali contenuti illeciti. Inoltre, la direttiva risponde alla finalità di armonizzare i principi che regolano la fornitura di servizi transfrontalieri.
Il quadro normativo è, poi, completato da una serie di strumenti legislativi, soft law non vincolanti, e forme di cooperazione facoltativa, che si rivolgono non solo alla tutela dei consumatori ma anche a profili inerenti all’utilizzo dei mercati digitali come nuovi canali per la Commissione di condotte illecite e, in particolare la diffusione di contenuti, beni e servizi illeciti[7].
Importante aggiornamento è rappresentato dal Regolamento sulla correttezza trasparenza nelle relazioni tra piattaforme online e imprese, c.d. P2B Regulation[8] in vigore da luglio 2019. Il regolamento contribuisce al corretto funzionamento del mercato interno stabilendo norme intese a garantire che gli utenti commerciali di servizi di intermediazione online e gli utenti titolari di siti web aziendali che siano in relazione con motori di ricerca online dispongano di un adeguata trasparenza, di equità e di efficaci possibilità di ricorso.
In particolare, l’ambito soggettivo del regolamento è lo stesso della richiamata Direttiva E-Commerce, essendo riferito ai servizi di intermediazione online e ai motori di ricerca online. Sono invece esclusi dall’ambito di applicazione le piattaforme che gestiscono servizi di pagamento online, strumenti di pubblicità online o scambi pubblicitari online dal momento che non perseguono l’obiettivo di agevolare l’avvio di transazioni dirette e che non implicano una relazione contrattuale con i consumatori.
La P2B Regulation fornisce obblighi di trasparenza e di informazione agli utenti, con particolare riferimento, tra l’altro, alla modalità di accesso ai dati, che deve essere descritto nei termini e nelle condizioni contrattuali, ad eventuali trattamenti differenziati applicati o applicabili, e alla formulazione di condizioni in maniera trasparente e comprensibile.
La Direttiva su una migliore applicazione e modernizzazione delle norme UE a tutela dei consumatori ha, inoltre, aggiunto requisiti di trasparenza nell’ambito dei mercati online nei confronti dei consumatori, che dovrebbero diventare applicabili nel maggio 2022[9].
Tra gli strumenti di soft law meritano invece di essere richiamati la comunicazione e la raccomandazione del 2018 della Commissione Europea destinate a piattaforme online e Stati membri per la lotta ai contenuti illegali online [10].
Diversi sono i documenti di analisi e monitoraggio della “platform economy” su iniziativa della Commissione Europea. Si tratta, in particolare, del gruppo di Esperti dell’Osservatorio sulle Piattaforme Online[11]; la Comunicazione della Commissione Europea sulle piattaforme online nel mercato unico: opportunità e sfide[12]; la consultazione pubblica lanciata sugli scenari regolatori delle piattaforme online, intermediari online, cloud computing e collaborative economy[13]; e lo Staff Working Document sulle piattaforme online[14].
Infine, su richiesta del Parlamento europeo, la Commissione sta svolgendo un'analisi approfondita della trasparenza algoritmica e della connessa responsabilità. Il progetto pilota fornirà uno studio approfondito sul ruolo degli algoritmi nell'economia e nella società digitale. In particolare, come modellano, filtrano o personalizzano i flussi di informazioni[15].
A fianco al delineato quadro normativo si pongono le prassi decisionali delle autorità europee garanti della concorrenza e della Direzione per la Concorrenza della Commissione Europea nonchè la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea e delle corti nazionali che si trovano a dover adattare gli attuali strumenti a tutela della concorrenza alle mutate esigenze dei mercati digitali.
Uno degli aspetti di maggior problematicità con il quale i public enforcers si trovano a dover fare i conti è proprio quello dominanza di queste piattaforme e della responsabilità sociale da essa derivante. Responsabilità sociale che, come proposto a più riprese a livello accademico, potrebbe sostanziarsi in veri e propri obblighi di autoregolazione all’interno del proprio microsistema, così come accade per esempio per le leghe sportive[16].
4. Verso una regolamentazione dei gatekeeper: il Digital Package
In questo contesto si inserisce il c.d. Digital Package[17] volto a rafforzare il mercato unico per i servizi digitali e innalzare il livello di innovazione concorrenza nell’orizzonte europeo online. Si tratta di un ambizioso pacchetto normativo previsto per i primi di dicembre.
Due sono i capisaldi dell’intervento, come si vedrà in maggior dettaglio nel proseguo.
Un primo focus è quello di regolare le piattaforme sotto il profilo della diffusione di beni/contenuti/servizi illeciti. In questo senso la proposta normativa si pone in continuità con l’esistente apparato normativo, fissando come obbiettivo una maggiore chiarezza nell’allocazione della responsabilità nell’ambito dei servizi digitali, nonché l’introduzione di un meccanismo che possa assicurare una migliore applicazione delle regole riguardanti i contenuti illeciti. Lo scopo è quello di proteggere in maniera più pregnante i diritti fondamentali degli utenti e limitare la diffusione di beni/contenuti e servizi illegali.
Un secondo focus, del tutto innovativo rispetto all’attuale quadro normativo, è quello volto all’individuazione di una prima regolamentazione sull’operato dei gatekeeper ai fini della tutela della concorrenza.
4.1. Piattaforme come canali per la diffusione di contenuti, beni e servizi illeciti
Sotto il primo profilo le soluzioni prese in considerazioni sono quelle di aggiornare la Direttiva E-Commerce e rendere vincolanti le richiamate Raccomandazioni 2018 sui contenuti illeciti presenti sul web, o, in alternativa, adottare un sistema efficace di supervisione, applicazione e cooperazione normativa tra gli Stati membri, supportato a livello UE.
Scopo è quello di risolvere alcune lacune della Direttiva E-Commerce. In particolare la proposta si rivolgerebbe a problematiche che, sebbene esistenti già al momento di adozione della Direttiva E-Commerce, si stanno diffondendo oggi in scala maggiore. Un esempio è rappresentato dalla maggiore diffusione di fenomeni di hate speech, ed in generale dall’utilizzo delle piattaforme per diffusione di contenuti e prodotti illegali. A fianco a queste si aprono poi nuove problematiche emergenti, sconosciute in fase di redazione della Direttiva E-Commerce. Primo fra tutti è il problema dell’accesso alle informazioni, e la diffusione di informazioni dannose e non veritiere sfruttando algoritmi per amplificare la diffusione del messaggio. La scala di impatto di questi problemi è particolarmente importante se solo si considera la portata di audience delle piattaforme online, veri e propri spazi pubblici nel mondo digitale.
Sotto questo profilo, nonostante le regolazioni di settore, alcuni aspetti rimangono scoperti, permanendo una certa frammentazione del mercato unico dal punto di vista della disciplina applicabile alle piattaforme online che evidenzia la necessità di una maggior cooperazione, e una più uniforme protezione dei diritti fondamentali online degli utenti, attraverso un aggiornamento della disciplina in vigore in materia di sicurezza dei prodotti, di profili giuslavoristici, e dei codici di condotta per il contrasto alla disinformazione e alle fake news.
4.2. Regolamentazione ex ante[18]
Come anticipato è la regolazione ex ante a rappresentare l’elemento di maggior novità della proposta della Commissione, che nei documenti di “impact assessment” allegati ha valutato una serie di opzioni configurabili per una possibile regolazione delle piattaforme gatekeepers.
L’introduzione di una regolazione sovranazionale è a maggior ragione necessaria se solo si considera che alcuni paesi europei hanno iniziato a formulare una disciplina nazionale, con un conseguente rischio di frammentazione normativa. L’articolo 114 Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) potrebbe dunque rappresentare la base giuridica su cui fondare un intervento sovranazionale volto ad affrontare in maniera armonizzata il problema della regolamentazione di servizi di intermediazione online di natura intrinsecamene e sistematicamente transnazionale, al contempo salvaguardando la contendibilità del mercato per imprese innovative e nuovi operatori del mercato2.
In particolare, questo pilastro d’azione si rivolge a problematiche quali: (i) eccessiva dipendenza delle imprese da un numero limitato di piattaforme online, con conseguente perdita del potere di contrattazione nei confronti di concorrenti e utenti; (ii) difficoltà di innovare con conseguente riduzione della concorrenza e della scelta per i consumatori; (iii) capacità da parte delle piattaforme di estendere all’infinito la propria dominanza a macchia d’olio su mercati adiacenti.
Come evidente, le strade percorribili sono di due tipi. Optare per una regolazione di dettaglio volta ad un maggior controllo delle grandi aziende tecnologiche, richiedendo, la separazione delle loro linea di business principale dalle altre attività. In questo scenario si potrebbero vietare le pratiche di c.d. self-preferencing, e Amazon non potrebbe più vendere prodotti con i suoi marchi sul suo mercato, dove presumibilmente si concede un trattamento preferenziale, ivi compreso un migliore posizionamento nei risultati di ricerca. Oppure rinunciare ad un eccessivo interventismo e limitarsi ad una modifica delle leggi antitrust esistenti, che permetterebbe di riadattare un meccanismo di controllo ex post e trasversale.
Sotto il primo profilo, per essere efficacie, una scelta regolataria deve prevedere strumenti sufficientemente elastici da potersi adattare a mercati in rapida evoluzione e cambiamento. Anche nel caso di adozione di una black-list di pratiche proibite l’approccio sarebbe dunque quello di formulare proibizioni di principio, es. divieto di pratiche di self-preferencing o il rifiuto di contrarre con imprese concorrenti, adattabili a mercati e piattaforme anche diverse tra loro.
Cionondimeno la Commissione sta valutando anche l’opportunità di adottare, caso per caso, le misure regolatorie più idonee alla luce delle specificità delle singole piattaforme. Una volta mappati i rischi potrebbero essere valutate soluzioni ad hoc. Il rischio di una simile soluzione potrebbe essere, però, quello di un’eccessiva frammentazione regolatoria – che è proprio quella che vuole evitarsi – oltre al rischio di approcci non sempre uniformi da parte dei public enforcers, che potrebbero lasciare spazio a trattamenti diversificati a seconda della classificazione della piattaforma. Nelle loro peculiarità è infatti difficile individuare canoni univoci di classificazione delle piattaforme online, e il rischio è quello di lasciare vuoti normativi.
Sotto il secondo profilo, nella proposta della Commissione emerge anche una possibile revisione delle regole di concorrenza con lo scopo di affrontare i problemi strutturali derivanti dall’ assenza o distorsione della concorrenza.
Le soluzioni prese in considerazione in questa fase iniziale sono di due tipi. Un primo strumento potrebbe essere rivolto esclusivamente ai mercati particolarmente inclini a distorsione della concorrenza; un secondo tipo di strumento sarebbe invece volto a tutti i mercati, esattamente come accade oggi per gli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). Altresì discusso è se lo strumento debba affrontare solo le problematiche di abuso di dominanza, o piuttosto identificare e affrontare tutti i problemi strutturali legati alla concorrenza.
Particolarmente interessante è poi l’opzione vagliata in sede di proposta di attribuire a specifiche autorità di regolazione la facoltà di raccogliere informazioni dai gatekeeper, relativamente a determinate pratiche commerciali e il loro impatto su consumatori e utenti, al fine di assicurare una più approfondita esamina delle dinamiche competitive ad esse associate.
5. Considerazioni finali
Se si osserva la questione in prospettiva politica pare che i tempi siano maturi per provare a seguire l’impervia strada di una regolazione ex ante [19]. In questa direzione sembrano andare gli USA, dove, il 6 ottobre 2020, una Commissione del Congresso Americano ha pubblicato un rapporto su come l'America dovrebbe aggiornare la sua legge sulla concorrenza[20].
Un primo nodo che i paesi che vorranno seguire la via della regolazione dovranno sciogliere è allora quello di identificare una definizione di gatekeeper che possa essere univocamente applicabile, e che possa affiancarsi alla tradizionale categoria di “posizione dominante”. In questo senso l’introduzione di un parametro quantitativo sicuramente potrebbe aiutare a tracciare una chiara linea di demarcazione nello scopo soggettivo della riforma, sebbene diversi potrebbero essere i valori presi in considerazione quali ad esempio il numero di utenti, le entrate, i dati accumulati (di più difficile misurazione).
Dall’altra parte, come a più riprese sollevato dai tech giants nelle loro osservazioni al progetto di regolazione europeo, il rischio da scongiurare è quello di intrappolare i gatekeeper in “una camicia di forza legale”, che potrebbe, in ultima istanza, limitare l’incentivo all’innovazione. È del resto questo il dilemma della regolazione.
Quel che è certo è che i mercati tecnologici in rapida evoluzione richiedono strumenti altrettanto rapidi ed elastici e l’elaborazione di regole efficaci richiederà tempo. Forse non meno tempo dei procedimenti antitrust. Ma come è stato correttamente osservato a più riprese sarebbe un'anomalia storica se la tecnologia non venisse regolata, come lo erano prima altri settori di importanza sistemica[21].
[1] Si veda Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on promoting fairness and transparency for business users of online intermediation services COM/2018/238, consultabile online https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-preventing-terrorist-content-onlineregulation-640_en.pdf.
[2] Parker, Van Alstyne e Choudary, Platform Revolution, richiamato in Crémer Yves, Montjoye, Schweitzer, Competition policy for the digital era, pagina 60 consultabile online https://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0419345enn.pdf
[3]Ursula von der Leyen, Political guidelines, A Union that strives for more - My agenda for Europe, consultabile online https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/political-guidelines-next-commission_en_0.pdf, pagina 13
[4]Shaping Europe’s digital future - The Digital Services Act package consultabile online https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-services-act-package
[5] Per un’analisi approfondita delle caratteristiche delle piattaforme online si rinvia a Commissione Europea, Staff Working Document on Online Platforms, accompanying the document "Communication on Online Platforms and the Digital Single Market" (COM(2016) 288) consultabile online: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-staff-working-document-online-platforms
[6] Direttiva (Ue) 2000/31/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») consultabile online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0031&from=EN
[7] Ne è un esempio la legislazione relativa a beni e contenuti illegali che comprende ad esempio il regolamento sulla sorveglianza del mercato; la direttiva sui servizi di media audiovisivi; la direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; la direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale; il regolamento sulla sorveglianza del mercato e la conformità dei prodotti; la proposta di regolamento sulla prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online; la direttiva sulla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia infantile; il regolamento sulla commercializzazione e l'uso di precursori di esplosivi.
[8] Regolamento (Ue) 2019/1150 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online consultabile online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1150&from=EN
[9] Direttiva (Ue) 2019/2161 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Novembre 2019 che modifica la Direttiva 93/13/Cee del consiglio e le Direttive 98/6/Ce, 2005/29/Ce E 2011/83/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori consultabile online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L2161&from=EL
[10] Recommendation on measures to effectively tackle illegal content online; Communication on stepping up efforts to tackle illegal content online, Settembre 2017, consultabile online https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-recommendation-measures-effectively-tackle-illegal-content-online
[11] Decision on setting up the group of experts for the Observatory on the Online Platform Economy (Aprile 2018) consultabile online https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-decision-group-experts-observatory-online-platform-economy
[12] Communication on online platforms and the Digital Single Market opportunities and challenges for Europe (Maggio 2016) consultabile online http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1466514160026&uri=CELEX:52016DC0288
[13] Public consultation on the regulatory environment for platforms, online intermediaries, data and cloud computing and the collaborative economy, Settembre 2015 - Gennaio 2016, consultabile online https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/public-consultation-regulatory-environment-platforms-online-intermediaries-data-and-cloud
[14] Commissione Europea, Staff Working Document on Online Platforms (Maggio 2016) consultabile online https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/31576
[15] Commissione Europea , Algorithmic Awareness-Building, consultabile online https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/algorithmic-awareness-building
[16] Inter alia si veda Commissione Europea, Caso AT.39740 — Google Search (Shopping), 27.6.2017, Gazzetta Ufficiale 2018/C-9/08, del 12.1.2018, p. 1; Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato caso A542 - Aperta istruttoria nei confronti di Google per abuso di posizione dominante nel mercato italiano del display advertising press release del 28 ottobre 2020
[17]Shaping Europe’s digital future - The Digital Services Act package, consultabile online https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-services-act-package
[18] Digital Services Act package: Ex ante regulatory instrument for large online platforms with significant network effects acting as gate-keepers in the European Union’s internal market, Giugno 2020
[19] Si rinvia a numerosi studi prodotti da diversi Paesi negli ultimi anni. Inter alia, UN IGF Dynamic Coalition on Platform Responsibility, United Nations Internet Governance Forum, Platform Regulations How Platforms are Regulated and How They Regulate Us Official Outcome, Ginevra 2017 consultabile online: https://juliareda.eu/wp-content/uploads/2019/09/Reda2017_Platform-regulations-how-platforms-are-regulated-and-how-they-regulate-us3.pdf; Australian Competition and Consumer Commission, Digital platforms inquiry, 2019, consultabile online https://www.accc.gov.au/focus-areas/inquiries-ongoing/digital-platforms-inquiry; French Competition Authority, Contribution to the debate on competition policy and digital challenges, 2020 consultabile online https://www.autoritedelaconcurrence.fr/sites/default/files/2020- 03/2020.03.02_contribution_adlc_enjeux_numeriques_vf_en_0.pdf; German Commission ‘Competition Law 4.0’, A new competition framework for the digital economy, 2019, consultabile online https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Publikationen/Wirtschaft/a-new-competition-framework-for-the-digital- economy.pdf?__blob=publicationFile&v=3; Stigler Committee for the Study of Digital Platforms, Market Structure and Antitrust Subcommittee 2019 consultabile online https://research.chicagobooth.edu/stigler/events/single-events/antitrust-competition-conference/digital- platforms-committee .
[20] Online Platforms and Market Power: Part 6: Examining the Dominance of Amazon, Apple, Facebook, and Google, 29 luglio 2020,
consultabile online https://judiciary.house.gov/uploadedfiles/competition_in_digital_markets.pdf .
[21] Sul punto interessante è l’articolo di approfondimento sulla situazione politica americana del The Economist, Ex-antics Google, antitrust and how best to regulate big tech, 7 ottobre 2020

To install this Web App in your iPhone/iPad press icon.
