Sommario: 1. Il volume di Lauréline Fontaine e la prefazione di Alain Supiot - 2. La funzione di un Consiglio costituzionale quale contro-potere a tutela dei diritti di libertà dei cittadini - 3. Le critiche di Lauréline Fontaine al funzionamento della giustizia costituzionale francese. I legami con il mondo politico e l’assenza di una vera indipendenza - 4. Segue: l’inadeguatezza dei membri che la compongono - 5. Segue: l’inadeguatezza dell’accertamento dei fatti rilevanti ai fini della decisione, normalmente rimesso alle indicazioni del Governo o del Parlamento - 6. Segue: l’inadeguatezza della procedura e delle motivazioni delle decisioni - 7. Osservazioni riassuntive delle questioni sollevate.
1. Il volume di Lauréline Fontaine e la prefazione di Alain Supiot
Ho avuto occasione di leggere questo libro di Lauréline Fontaine, La Constitution maltraitée, Paris, 2023, e mi fa piacere presentarlo ai lettori di Giustiziainsieme, in quanto l’ho trovato sbalorditivo, in Italia nessuno si permetterebbe di scrivere cose del genere.
Si tratta, come può comprendersi dal titolo del lavoro, di un’analisi che ella compie sul Consiglio costituzionale francese, e il suo pensiero al riguardo viene così sintetizzato nella quarta di copertina: “Lauréline Fontaine getta una luce cruda sulla realtà della giustizia costituzionale sotto la V Repubblica, ella pone una diagnosi travolgente: lontano da essere una vera Corte costituzionale, il Consiglio costituzionale resta una istanza essenzialmente politica, non costituisce un contro-potere ma una anomalia democratica”.
Questo giudizio si ha (ancora quarta di copertina): “al termine di una riflessione solidamente argomentata, tanto in fatto che in diritto”, con la quale Lauréline Fontaine “sfata, uno ad uno, i miti che circondano - les sages de la rue de Montpensier-”.
E ancora: “L’assenza di una procedura a contraddittorio paritetico tra le parti e di misure di sicurezza volte a prevenire conflitti di interesse, dimostra che il modo con il quale la giustizia costituzionale è resa in Francia è assolutamente incompatibile con i principi elementari di democrazia e di Stato di diritto”(sempre dalla quarta di copertina).
Si tratta, quindi, di una posizione gravemente critica, con un atteggiamento che, ripeto, vanamente si potrebbe ricercare negli scritti giuridici italiani; e tuttavia Lauréline Fontaine non può essere considerata ne’ una sprovveduta, ne’ un’ignorante: ella è infatti professore di diritto pubblico e costituzionale presso la Sorbonne Nouvelle à Paris, e quindi va annoverata tra gli esperti del diritto costituzionale francese, senz’altro una studiosa.
Il libro, poi, contiene una prefazione di Alain Supiot, un giurista e sociologo noto in Francia, professore emerito del Collège de France, avendo insegnato lì dal 2012 al 2019.
Alain Supiot, nella presentazione del volume, precisa che “il libro potrà sembrare a qualcuno troppo severo, a tratti brutale” (pag. 19); tuttavia esso è il frutto “di una ricerca approfondita, ricca di dati fattuali, di casi concreti” (pag. 14).
Alain Supiot ricorda il Vangelo di Matteo: “con il metro con il quale giudicate sarete giudicati” (pag. 13), e poi afferma che Lauréline Fontaine, con “una ricerca sociologica e un’analisi giuridica solidamente argomentate”, ha fatto la stessa cosa, e i risultati della ricerca sono inquietanti “sia che si tratti della composizione del Consiglio costituzionale, della motivazione delle sue decisioni, dell’equità delle sue procedure, del modo di designazione dei suoi membri, delle loro competenze giuridiche, del loro statuto materiale e deontologico o delle loro condizioni di lavoro, vanamente si potrebbe ricercare un solo registro sul quale la Francia possa dare delle lezioni al resto del mondo” (pag. 13).
E ancora Alain Supiot: “Salvo rare eccezioni, i suoi componenti non devono la poltrona a una dimostrazione d’indipendenza di spirito e di alte competenze giuridiche, ma piuttosto al favore politico”.
Egli arriva, con una espressione che a noi suona offensiva, a considerare il Conseil constitutionel una specie di “casa di riposo” (maison de retraite) “des anciens présidents de la République” e “pour les personnalités bien en cour” (pag. 14/5).
Sottolinea che lo spirito di Lauréline Fontaine è quello di “aprire un dibattito su la riforma continuamente rinviata del nostro sistema di controllo di costituzionalità delle leggi”; anche se, avverte: “Lauréline Fontaine ci chiarisce le ragioni profonde dello strano consenso che vi è presso il Conseil constitutionel per mantenere lo status quo” (pag. 16).
Nei ringraziamenti Lauréline Fontaine conclude altresì asserendo che: “Negli ultimi tempi, mi è spesso stato detto di essere coraggiosa” (pag. 271), e può apparire paradossale che nella terra di Voltaire l’esercizio del diritto di manifestazione del pensiero, sacro e inviolabile, possa considerarsi un atto di coraggio.
Ci sono quindi elementi sufficienti a giustificare una segnalazione del volume, e ciò, se si vuole, anche alla luce del dovere di diffondere, all’interno dell’unione europea, lo studio e la ricerca giuridica.
2. La funzione di un Consiglio costituzionale quale contro-potere a tutela dei diritti di libertà dei cittadini
Ciò premesso, nella introduzione l’autrice precisa che l’esistenza di una Corte costituzionale: “distingue uno Stato di diritto da uno Stato arbitrario, uno Stato liberale da uno Stato autoritario” (pag. 25).
Infatti, si può sostenere, avere una Corte costituzionale significa soprattutto avere: “la possibilità di regolare il diritto in virtù della costituzione, di limitare l’esercizio del potere politico a partire dal riconoscimento dei diritti di libertà e dell’essere umano” (pag. 25).
Lauréline Fontaine ricorda poi che il Conseil costitutionel nasceva in Francia nel 1958 “per controllare la conformità delle leggi al testo della costituzione” (pag. 26), e la sua storia ha avuto fasi diverse: nasceva nella V° Repubblica per volere soprattutto del generale De Gaulle, e, nel primo periodo, “semplicemente incaricato di proteggere il potere esecutivo, cioè il Governo e il Presidente della Repubblica dagli eccessi del parlamento”; non a caso, nei primi anni, il Conseil costitutionel taluni lo nominavamo “il cane da guardia dell’esecutivo (chien de garde de l’exécutif)” (pag. 27).
La svolta si aveva nel 1971, dopo la morte del generale De Gaulle, che già nel 1969 aveva lasciato il potere.
“Il Consiglio rende una decisione con la quale censura una legge modificante le condizioni di esercizio della libertà di associazione……….detto in altri termini, con ciò nasceva il controllo di costituzionalità di garanzia dei diritti e delle libertà. Il Consiglio non cesserà in seguito di impegnarsi in questo percorso, censurando oppure validando le leggi sottoposte al suo esame, sempre sul fondamento dei diritti di libertà protetti dalla Costituzione. I francesi avevano finalmente la loro giustizia costituzionale” (pag. 28).
Ma le cose cambiavano ancora avvicinandosi ai nostri giorni.
Lauréline Fontaine nota che “molti osservatori della vita politica e giuridica francese constatano come, da trenta anni a questa parte, le libertà siano progressivamente e rigorosamente diminuite…..le leggi adottate dal Parlamento, quasi sempre assunte ad iniziativa del Governo, hanno abbassato costantemente e sicuramente il livello di protezione dei diritti di libertà, ovvero dei diritti di libertà individuale, di libertà di circolazione, di pensiero, di espressione, di riunione e di manifestazione, di protezione della vita privata, di protezione dalle decisioni arbitrarie del potere amministrativo e giudiziario” (pag. 29).
E aggiunge: “ora, però, queste leggi sono state egualmente validate dal Conseil costitutionel, che non ha dunque niente impedito” (29); e seppur sia purtroppo questa la realtà, intorno al Conseil costitutionel si è costruito un vero catechismo (véritable catéchisme) in senso contrario dal 1970 “che gli studenti di giurisprudenza apprendono dal primo anno di studi, e che quindi in seguito è difficile smontare. Anche i più ardenti difensori dei diritti cedono sorprendentemente dinanzi a questi discorsi” (pag. 30).
Lauréline Fontaine critica duramente il Conseil costitutionel e asserisce: “i rudimenti di una giustizia indipendente, imparziale e democratica sono ignorate ad un punto tale che, alle volte, è difficile da credere” (pag. 30).
Ella rileva ciò in base a più fattori, che poi nel corso del libro cerca di spiegare e dimostrare: “à la déontologie”, a ”gli incarichi concessi come compiacimento del potere (une complaisance que le pouvoir leur a fait)”, a “les pratiques de conseil” a “la motivation de ses décisions”, ecc….(pag. 31).
In conclusione, il giudizio che Lauréline Fontaine dà del Conseil costitutionel è tranchant: “In breve” ella scrive: “il consiglio costituzionale non può essere considerato un giudice indipendente e imparziale, presenta una giustizia al ribasso, ove la riflessione costituzionale non ha quasi mai spazio” (pag. 32).
Il Consiglio costituzionale, che dovrebbe svolgere la funzione di garanzia per i cittadini e di contro-potere (contro-pouvoir) a fronte dell’esercizio del potere esecutivo e legislativo, non svolge più la sua funzione, e ciò con gravi conseguenze poiché “è in gioco la democrazia del paese……..e ciò sotto ogni livello di questioni che si voglia porre: dall’indipendenza, l’imparzialità, l’etica, la deontologia dei giudici…..Se in questo paese noi non conosciamo la giustizia costituzionale, è perché questa non è più un contro-potere e non è più all’altezza degli enunci di una Costituzione considerata la fonte del nostro sistema di libertà (pag. 32/33)”.
3. Le critiche di Lauréline Fontaine al funzionamento della giustizia costituzionale francese. I legami con il mondo politico e l’assenza di una vera indipendenza
Ma quali sono più precisamente gli argomenti di Lauréline Fontaine per rivolgere al Conseil costitutionel critiche così severe?
La prima, come anticipato, è quella di non essere indipendente, soprattutto nei confronti del governo e del mondo politico.
Lauréline Fontaine premette che quando il Conseil costitutionel deve verificare la costituzionalità di una legge “giudica il lavoro di più attori: il Governo, che è spesso all’iniziativa della legge, il Presidente della Repubblica, che ne può aver dato l’impulso, e il Consiglio di Stato, che si è pronunciato a monte sul progetto”; e in questo contesto è evidente che dunque: “il Governo svolge un ruolo di difensore della legge davanti al Consiglio costituzionale” (pag. 39).
Ora, a fronte di ciò, si ha invece una situazione nella quale il Conseil costitutionel “è essenzialmente composto di personalità tutte uscite dal mondo politico che dovrebbe essere controllato. Dal 1959 sono infatti soprattutto nominate personalità la cui carriera è stata principalmente politica, e che sono stati implicati nella preparazione o nell’adozione delle leggi che il Consiglio è chiamato a giudicare” (pag. 40/1).
Precisa Lauréline Fontaine: “in seno al Conseil costitutionel si possono trovare ex Presidenti della Repubblica, ex primi ministri (attualmente due, di cui uno presiede l’istituzione), ex ministri (attualmente due), ex titolari delle più alte posizioni amministrative (attualmente un ex segretario generale dell’Assemblea nazionale), o ex direttori di gabinetti ministeriali (attualmente due). Non vi si trovano personalità che non hanno avuto attività direttamente legate all’esercizio del potere se non in via di eccezione (attualmente nessuna)” (pag. 41). Ciò fa sì che: “un consigliere deve controllare una legge che egli stesso può aver concorso a fare, o a livello di iniziativa, o a livello di adozione, e ciò quando egli era ancora membro del Consiglio, o era ministro, o direttore di gabinetto, o parlamentare” (pag. 41).
Nelle pagine successive Lauréline Fontaine fa esempi concreti in cui ciò è avvenuto, con tanto di nomi e di date.
Sono casi che non interessano un pubblico italiano, ma sui quali Lauréline Fontaine, per dimostrare la bontà delle sue tesi, si dilunga: ricordo solo la decisione 1 aprile 2022 a proposito della legge urbanistica detta ELAN; due membri del Conseil costitutionel avevano conosciuto la legge quali ministri, uno di questi aveva addirittura adottato la circolare attuativa della legge (pag. 44); v’è poi l’esempio della legge sull’interruzione volontaria della gravidanza, di cui un membro del Conseil aveva partecipato all’approvazione della legge (décision n° 2001-446 DC); o quella relativa alla legge sull’indipendenza dei professori universitari, di cui una personalità aveva avuto un ruolo prima in Parlamento e poi in seno al Conseil costitutionel (décision n° 2010-20/21 QPC), ecc…..(pag. 45).
Spesso, avverte Lauréline Fontaine, la nomina a consigliere avviene “Quando questi sono ancora membri del governo o del parlamento” (pag. 45), e fa gli esempi di Jacqueline Gourault e Laurent Fabius (presidente del Conseil dal 2016), nominati quando ancora erano ministri in esercizio, o di Jacques Mézard e Francois Pillet, che al momento della nomina sedevano ancora in Senato (pag. 46).
Ed inoltre: “Al momento di prendere le funzioni Laurent Fabius indicava in effetti che egli avrebbe conservato la presidenza del COP 21 (Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici), e a tale titolo conservava un ufficio a Quai d’Orsay” (pag. 172).
Sono molti i casi del genere e così Lauréline Fontaine sottolinea che v’è indiscutibilmente presso il Conseil costitutionel: “una concezione leggera delle incompatibilità con l’esercizio d’altre funzioni” (pag. 196).
A colorire la situazione v’è poi la questione delle decorazioni della Légion d’honneur: “Ora, queste decorazioni sono sotto la responsabilità del Presidente della Repubblica, gran maestro dell’Ordine della Légion d’honneur. Tra coloro che hanno accettato questo onore mentre erano giudici del Conseil costitutionel si conta Louis Gros, Léon Jozeau-Marigné, Louis Joxe, Pierre Mazeaud, Pierre Steinmetz, Hubert Haenel, Lionel Jospin, Laurent Fabius; nessuno di loro, peraltro, era estraneo al mondo politico. Domenique Schnapper, ex membro del Conseil costitutionel fa questa constatazione: Alcun testo lo vieta, ma sarebbe più dignitoso, per sottolineare l’indipendenza del Consiglio, di accettare queste decorazioni alla fine del mandato, o, in ogni caso, di evitare che esse siano rimesse dall’autorità che ha il potere di nomina dei consiglieri quando questi sono ancora nell’esercizio delle loro funzioni. Una tale interdizione esiste per i parlamentari, è sbalorditivo che al contrario non esista per i membri del Conseil costitutionel” (pag. 171).
Evidentemente, osserva Lauréline Fontaine “Cette situation de double casquette est un problème pour la garantie d’un procès équitable”.
Ne’, prosegue ancora Lauréline Fontaine, avverso simili situazioni esistono norme che consentano “la ricusazione dei giudici che non offrono sufficienti garanzie d’imparzialità” (pag. 50); anzi, ella ricorda, a tal fine, che la legge 6 luglio 2016, che sottoponeva la magistratura al controllo delle incompatibilità e delle obbligazioni deontologiche, veniva dichiarata incostituzionale dal Conseil costitutionel in data 28 luglio 2016 (décision n° 2016 -732 DC): a) per quanto riguarda l’autorità giudiziaria ordinaria nella parte in cui sottoponeva detto controllo dell’Alta Autorità per la trasparenza della vita pubblica, e ciò, evidentemente, in nome dell’autonomia del potere giudiziario; b) e invece interamente, e in ogni sua disposizione, nella parte in cui essa si applicava anche ai membri del Conseil costitutionel: “Questi due pesi e due misure tra i membri del Consiglio costituzionale e i magistrati dell’ordine giudiziario sembra indegno. Il Consiglio così evita dunque ancora una volta di sottostare a delle regole ispirate dalla deontologia” (pag. 176).
Lauréline Fontaine ricorda infine il pensiero di Léon Duguit, che nel 1923 aveva detto: “se una Corte costituzionale si recluta per cooptazione, ella diventerà presto una sorte di corpo aristocratico incompatibile con una democrazia moderna”
Osserva Lauréline Fontaine: “Egli aveva visto giusto, poiché cento anni dopo, i membri del Consiglio costituzionale in Francia si reclutano con una procedura assimilabile a quella della cooptazione, ovvero con un semplice sistema di ricompensa per la carriera politica svolta” (pag. 66).
4. Segue: l’inadeguatezza dei membri che la compongono
La seconda critica mossa al Conseil costitutionel è quella che i suoi membri, in molti casi, non sono all’altezza dei compiti che devono svolgere.
I compiti di una Corte costituzionale sono infatti assai delicati e difficili, e quindi dovrebbero essere svolti da giuristi di chiara fama, indipendenti, i migliori che uno Stato abbia a disposizione.
Al contrario, secondo Lauréline Fontaine, in Francia: “si scelgono soprattutto delle personalità che hanno una carriera politica a livello nazionale…..pure quando sono nominati autentici magistrati di carriera, ciò avviene perché essi hanno una carriera all’interno dell’organizzazione amministrativa della giustizia" (pag. 94), ed anzi: “dal 1959 le autorità aventi potere di nomina hanno scrupolosamente tenuto a nominare delle personalità uscite dal mondo politico, e abbastanza spesso senza formazione o esperienza giuridica effettiva…….Questa pratica ignora le qualità necessarie che deve avere chi rende detto tipo di giustizia, e così il rischio che l’organo possa diventare un vero contro potere si riduce……..Il Consiglio è piuttosto considerato come un collaboratore del quale si ammette assai raramente che l’azione possa effettivamente contrariare quella di una maggioranza o di una coalizione in carica” (pag. 95); “Il potere politico, infatti, in tanto tollera una Corte costituzionale in quanto questa non va contro i suoi interessi” (pag. 102).
Ed ancora: “Qualcuno dei componenti del Conseil costitutionel ha avuto una formazione giuridica, ma dati alla mano ha sempre riguardato solo una minorità tra loro, e in tutti casi erano tutte personalità legate all’esercizio del potere politico. Quattro membri sono usciti dall’ENA, di cui due ex primi ministri, un ex direttore di gabinetto del presidente del Senato, e un ex direttore generale del gruppo AXA; un membro è stato un tempo professore di storia e geografia, esercitando in seguito funzioni locali e senatoriali e infine ministeriali, due membri sono avvocati di lunga esperienza ma hanno quasi sempre contemporaneamente esercitato delle funzioni politiche elettive, un membro infine è stato allievo della scuola nazionale della magistratura e poi magistrato” (pag. 93).
In sostanza: “Uno dei vecchi consiglieri lo confessa: il Consiglio vive in un clima di povertà intellettuale” (pag. 134); “Il Consiglio costituzionale manca di competenze e di esperienza nel campo della discussione giuridica” (pag. 135).
Si richiamano, infine, le testimonianze di Domenique Schnapper, universitaria e sociologica di formazione, membro del Conseil costitutionel dal 2001 al 2010, al termine del mandato ha scritto un libro dal titolo : “Une sociologue au Conseil costitutionel” (pag. 135/6). Onestamente ha confessato di essersi messa umilmente a studiare il diritto al suo ingresso al Consiglio, ma di essersi subito accorta che la formazione giuridica non era poi così necessaria per decidere i casi. E poi ancora così si rivolgeva Olivier Becht, in Assemblea nazionale, alla consigliera Jacqueline Gourault: “Non è precisato da nessuna parte della Costituzione che è necessario aver fatto studi di diritto per poter sedere al Conseil costitutionel. Voi avete, signora, esperienza di Stato e più ancora, quelle delle collettività locali. Voi disponete di tutte le competenze e di tutte le qualità richieste, il pragmatismo e il senso dell’equilibrio non sono inferiori per esercitare quelle funzioni” (pag. 137).
Lauréline Fontaine fa le sue osservazioni su questa situazione: “Valutare la costituzionalità delle leggi non è fare della politica, è stabilire al contrario cosa la politica può fare e cosa non può fare……..il lavoro del giudice costituzionale deve essere a distanza dalla politica………la cultura giuridica normalmente è assente tra i membri del Conseil costitutionel, soprattutto quella del diritto costituzionale. Se questa mancanza di conoscenze può far parte del giuoco nel momento della fabbricazione delle leggi, si comprende che tale ignoranza a livello della giustizia compromette il futuro stesso di una società secondo diritto” (pag. 139).
5. Segue: l’inadeguatezza dell’accertamento dei fatti rilevanti ai fini della decisione, normalmente rimesso alle indicazioni del Governo o del Parlamento
La terza critica mossa al Conseil costitutionel è quella di non svolgere una vera funzione giurisdizionale.
Lauréline Fontaine osserva in proposito che la giustizia costituzionale, diversamente dalla funzione giurisdizionale ordinaria, non accerta sostanzialmente i fatti.
Si tratta di un aspetto non secondario, che è bene precisare.
Un giudice, infatti, prima di decidere, deve accertare i fatti controversi, e solo sull’accertamento di quei fatti, che egli compie personalmente e quale autorità terza e imparziale, provvede poi a rendere la sua determinazione di diritto, e quindi la sua decisione.
Nella giustizia costituzionale, al contrario, il momento dell’accertamento del fatto non esiste nelle modalità tipiche dell’esercizio della funzione giurisdizionale.
E se alle volte l’accertamento del fatto non è rilevante nel giudizio di costituzionalità, e quindi la diversità della giustizia costituzionale con la giustizia ordinaria non pone problemi, altre volte invece la determinazione del fatto può essere rilevante, e ciò avviene soprattutto nei casi, sempre più frequenti, nei quali il giudizio di costituzionalità dipende da un’attività di bilanciamento tra diritti che si ritengono contrapposti tra loro.
Scrive Lauréline Fontaine: “nel controllo di costituzionalità di una legge nell’ambito di un giudizio di proporzionalità, le misure restrittive di un diritto devono effettivamente contribuire al perseguimento dell’obiettivo che si intende raggiungere, di tal sorta che non le si possa considerare eccessive rispetto al fine dato. L’idea essenziale che traversa questo controllo è, non lo si dirà mai abbastanza, che se delle misure meno restrittive possono egualmente raggiungere quel fine, allora quelle oggetto di controllo devono essere dichiarate sproporzionate. Si parla in proposito altresì di un controllo sulla necessità delle misure”. (pag. 123).
A pensarci, infatti, nei giudizi c.d. di bilanciamento, il giudizio di costituzionalità, potremmo dire, più che su una legge, cade su dei fatti, e precisamente cade su quei fatti in forza dei quali possa dirsi o meno corretto e proporzionato il sacrificio di un diritto in favore di un altro.
Lauréline Fontaine fa degli esempi, tra i quali v’è anche quello, ovviamente, relativo al Covid 19 (pag. 124 e ss.), e poi quelli: “alla lotta contro il terrorismo, lotta contro l’immigrazione clandestina” (pag. 230), oppure quelli nei quali: “Il Consiglio proclama esplicitamente la protezione dell’ambiente e la possibilità a questo fine di limitare la libertà imprenditoriale” (pag. 235), ecc…….
Ed infatti, e a titolo di esempio: se la condizione Covid 19 è grave, detta gravità giustifica per l’appunto la restrizione del diritto alla libertà di circolazione o l’imposizione dell’obbligo vaccinale; se la situazione dell’immigrazione è grave, detta gravità può giustificare talune compressioni del diritto di asilo e/o di accesso e/o soggiorno nel territorio dello Stato; se la situazione climatica e ambientale è grave, il livello di inquinamento generale e di degradazione delle condizioni del pianeta possono giustificare talune restrizioni alla libertà personale o imprenditoriale, oppure imporre talune altre condotte finalizzate alla salvaguardia dell’ambiente e/o della salute; ancora, se vi sono in corso minacce terroristiche od altri fatti gravi e concreti volti a minare la sicurezza personale dei cittadini, leggi repressive straordinarie possono ritenersi costituzionalmente legittime alla luce della situazione di fatto del momento; se infine la circolazione stradale produce ogni anno un numero assai elevato di morti o di feriti, talune limitazioni alla circolazione in automobile potrebbero essere poste in essere nel rispetto dei principi costituzionali, ecc……
In tutti questi casi, come ben si vede, il giudizio di costituzionalità non ha ad oggetto la legge, poiché la legge, infatti, escludendo un diritto di libertà garantito costituzionalmente, di per sé è sempre incostituzionale; il giudizio ha ad oggetto, al contrario, quei fatti in forza dei quali si ritiene che sia egualmente legittimo comprimere un diritto per salvarne un altro; e in tutti questi casi non è la legge che è costituzionale o incostituzionale; sono i fatti che la rendono, o non la rendono, tale.
Ora, però, ed è questa la questione, l’accertamento di questi fatti non è dato, nella sostanza delle cose, in modo terzo e imparziale dall’organo costituzionale che è tenuto ad esprimere il giudizio, bensì è dato dalla stessa pubblica amministrazione che ha posto la legge e che dinanzi al giudice costituzionale la difende.
Lauréline Fontaine: “Le ragioni presentate dal legislatore (e, nei fatti, dal Governo, che difende la legge davanti il Consiglio costituzionale) per giustificare una restrizione ai diritti, è data come vera”; e ciò perché: “secondo la formula normalmente usata, il Conseil costitutionel non dispone d’un potere generale d’apprezzamento dei fatti e di decisione della stessa natura del Parlamento.” (pagg. 126/7).
In sostanza, il Conseil costitutionel valuta la costituzionalità delle leggi sulla base degli elementi di fatto forniti dal legislatore e dal Governo e non ha la possibilità, ne’ rientra tra i suoi compiti, quella di indagare sulla bontà delle ragioni che hanno giustificato la legge.
“Il Conseil costitutionel espone dei fatti e delle idee: “sans avor l’air de les vérifier”, e quindi: “Il consiglio non svolge dunque una vera funzione di giudice, ma si basa precisamente sulla dinamica della posizione del legislatore per valutare la costituzionalità della legge” (pag. 125); seppur: “Il giudice costituzionale è teoricamente un giudice” (pag. 127).
Oltre agli esempi sopra richiamati, Lauréline Fontaine ne porta altri, e ricordo qui, per tutti, il caso Georg Vedel, relativo alla legge sulla cittadinanza del 12 dicembre 1981, nel quale si discuteva se il Conseil costitutionel potesse entrare nel merito dei fatti e delle idee che avevano indotto il legislatore a fare certe scelte: “Il problema della nazionalizzazione oppone una filosofia dirigista ad una liberale, il Consiglio non può entrare in questi giudizi” (pag. 128).
Dunque, la questione penso sia chiara: la circostanza che nei giudizi di costituzionalità c.d. di bilanciamento oggetto del giudizio siano soprattutto i fatti che giustificano la legge, e la circostanza che la fissazione di questi fatti non è data dal giudice ma dal potere politico, o da enti che a quel potere sono riconducibile, fa sì che la giustizia costituzionale debba considerarsi in tutti quei casi una giustizia al ribasso (Une justice au rebais, pag. 133 e ss.), ovvero inidonea a tutelare i diritti di libertà che uno Stato democratico assicura ai suoi cittadini.
Aggiungo che la questione, se si vuole, può presentarsi anche in Italia.
Il problema non esista in teoria, poiché il teoria il procedimento dinanzi alla nostra Corte costituzionale prevede una possibile attività istruttoria agli artt. 13 e ss. della l. 10 marzo 1953 n. 87, il problema esiste in pratica e a livello di consuetudine procedimentale, poiché a me personalmente non risulta che la Corte costituzionale abbia mai sfruttato questa possibilità a fronte invece dei molti giudizi basati sul bilanciamento di contrapposte esigenze.
E direi che questa è anche la posizione della nostra dottrina, se è vero che G.A. FERRO, Modelli processuali ed istruttoria nei giudizi di legittimità costituzionale, Torino, 2012, 252 ha asserito che: “Il giudice delle leggi ha voluto mantenersi sempre –nell’esercitare i propri poteri istruttori- entro i confini cognitivi della sfera del potere pubblico”, e G. ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale, Bologna 1988, 291, ha altresì precisato che il Governo “è spesso soggetto interessato, e comunque la sua attività di reperimento dei dati richiesti si svolge fuori di qualunque controllo e di ogni contraddittorio” (v. infatti, G. RAGONE, L’attivazione del potere istruttorio, AIC, 2020, I, 231).
6. Segue: l’inadeguatezza della procedura e delle motivazioni delle decisioni
È chiaro, e torno immediatamente in Francia, che una simile situazione incide altresì sul procedimento e sul giudizio.
Il procedimento dinanzi al Conseil costitutionel, escluso l’accertamento indipendente dei fatti rilevanti, si manifesta, conseguentemente, poco equo e poco rispettoso del principio del contraddittorio paritario tra le parti (“peu équitable et peu contradictoire”, pag. 202).
Le parti, infatti, sotto questo punto di vista, non stanno sullo stesso piano, poiché la parte che chieda la dichiarazione di incostituzionalità della legge non ha tuttavia la possibilità di contraddire e/o far verificare la ricostruzione dei fatti sulla base dei quali si fonda la ragione di bilanciamento tra diritti.
Lauréline Fontaine osserva che: “Ci sono, nel processo costituzionale, degli attori previlegiati: il Governo, il Segretario generale” (pag. 220), soprattutto quest’ultimo, visto che: “l’esperto della legge sulla quale il Conseil costitutionel deve pronunciarsi è proprio il Segretario generale del Governo, che può considerarsi come il più agguerrito e il più formato sulle questioni che devono essere dibattute” (pag. 203).
E’ di tutta evidenza, poi, che questi limiti incidono inoltre sulla qualità delle decisioni.
Su questo, Lauréline Fontaine si dilunga.
Osserva che, normalmente, i presupposti di fatto sono meramente riportati in sentenza sulla base della prospettazione presente negli atti difensivi dell’avvocatura dello Stato, e la motivazione delle sentenze normalmente non contengono disamine giuridiche particolari, ma solo la dichiarazione che il bilanciamento già effettuato dal Governo e/o dal Parlamento per legittimare la legge è conforme a Costituzione e proporzionato.
Lauréline Fontaine: “Il Conseil costitutionel chiude la porta all’argomentazione giuridica e risponde con una procedura che possiamo considerare tautologica. Nella premessa, il Consiglio normalmente ricopia l’enunciato dei valori costituzionali che ha scelto come referenza. Ma non esplicita le ragioni della scelta di quei principi, ne’ la sua origine, ne’ il suo contenuto. In seguito, il Consiglio non spiegherà le ragioni per le quali le disposizioni da giudicare sono o non sono contrari ai principi di referenza scelti. Tutte le decisioni rese dal Consiglio possono servire da esempio.” (pag. 147).
Gli esempi contenuti nel volume di Lauréline Fontaine sono molti, e non avrebbe senso riportarli in questa sede.
L’autrice ne evidenzia soprattutto le caratteristiche più ricorrenti.
La prima regola generale è quella di richiamare tutti i precedenti, alle volte in modo esteso: “Una prima soluzione consiste nell’andare a ricercare dei precedenti” (pag. 154).
Ciò, si osserva, può allungare la misura delle pagine dedicate alla motivazione, ma non renderla sufficiente se questa si limita, come in molti casi, a dei richiami meramente formali con argomenti di tipo tautologico.
Normalmente, secondo meccanismi ben conosciuti e ben rodati: “il giudice stabilisce l’opportunità di decidere in un modo o nell’altro, e solo dopo va a cercare le ragioni per giustificare la scelta che a monte aveva già fatto” (pag. 112)
V’è poi: “La pratica del Conseil costitutionel che consiste nel far passare ciò che dice come evidente” (pag. 152). O ancora: “Per mascherare una incostituzionalità il Conseil costitutionel può dare le apparenze della necessità di una tale violazione” (pag. 114). “Oppure può ricorrere a una nozione puramente e semplicemente inventata per l’escludere l’idea che la costituzione sia stata violata” (pag. 117). Od ancora il Conseil costitutionel può usare la tecnica della brevità, e: “la brevità della decisione fa passare per evidenti le circostanze particolari della fattispecie” che evidentemente possono però non esserlo (pag. 118). Lauréline Fontaine fa in proposito l’esempio della motivazione (standard): “tenuto conto delle circostanze particolari della fattispecie non v’è luogo di giudicare che questa legge (organica) sia stata adottata in violazione delle regole previste dall’art. 46 della Costituzione” (pag. 118)
O “Il Conseil costitutionel usa costantemente dei concetti generali che non sono formulati tra i valori costituzionali per legittimare scelte di politica legislativa” (pag. 120). Tra questi ricorda soprattutto l’interesse generale, la lotta contro qualcosa (lotta contro il terrorismo, lotta contro l’immigrazione clandestina, lotta contro l’evasione fiscale, lotta contro la delinquenza minorile, ecc…..pag. 121), o il controllo di proporzionalità (pag. 123 e ss.), o ancora quello del cavalier législativ, una espressione “che designa il fatto che il legislatore ha introdotto nella legge delle disposizioni che non hanno alcuna pertinenza, nemmeno indirettamente, con l’oggetto della legge o con l’oggetto delle altre disposizioni della legge stessa” (pag. 176), con ciò rendendo possibile, evidentemente, l’espulsione dalla legge, a discrezione, di un po’ tutto quello che si vuole.
“Altra tecnica del Consiglio consiste al riguardo a minimizzare la portata restrittiva posta in essere su un diritto garantito costituzionalmente da una parte, e a aumentare e potenziare la portata dell’interesse generale che è perseguito a scapito di quel diritto, da altra parte” (pag. 124).
Alle volte le decisioni del Conseil costitutionel sono lunghe e procedono per pagine e pagine di motivazione, “Ma una decisione più lunga non costituisce garanzia di una decisione argomentata” (150), poiché come nel caso della décision n. 2016-745 DC su eguaglianza e cittadinanza: “la decisione del Conseil costitutionel è lunga perché ha ad oggetto cinquanta diverse disposizioni di legge” (pag. 150).
Le osservazioni di queste prassi trovano critiche severe, e forse anche esagerate, da parte di Lauréline Fontaine: “In conclusione può dirsi che i consiglieri non hanno ne’ la formazione ne’ l’esperienza sufficiente per giudicare in queste condizioni. Ma l’idea che essi hanno della giustizia costituzionale non li conduce ad allarmarsi di ciò poiché essi non ritengono che il loro lavoro debba essere qualcosa di complesso, paziente e particolarmente esigente. Il risultato è che le decisioni sono povere, senza alcuna vera argomentazione, e non fanno apparire la giustizia costituzionale come un contro-potere ma come un'altra maniera d’esercitare il potere. Il problema è che nemmeno gli osservatori fino ad oggi hanno ritenuto di denunciare la situazione. Presso i giuristi l’idea è che si debba interpretare le decisioni del Consiglio con i magri elementi a disposizione, non altro. In questa maniera il Consiglio e i suoi membri hanno persistito nell’ignoranza di cosa sia una giustizia costituzionale degna di uno Stato democratico e continuano a considerarlo un semplice lavoro di collaborazione al potere politico…..e la lealtà della quale hanno dato prova all’esercizio del potere esecutivo è considerata come un atto necessario e salutare. La concezione minimalista della giustizia costituzionale regna dunque in seno al Consiglio” (pag. 165/6).
Con toni un po’ forti Lauréline Fontaine titola alcuni paragrafi del libro: “La justice constitutionnelle: un club privé” (pag. 202); “Les lobby à l’assaut de la justice constitutionnelle” (pag. 209); “La désillusion sociale de la justice constitutionnelle” (pag. 223), ecc...
7. Osservazioni riassuntive delle questioni sollevate
In conclusione, io credo che questo libro possa suscitare tre diverse reazioni, a seconda delle sensibilità:
a) alcuni possono ritenere che si tratti solo della posizione di una giurista, affatto corrispondente alla realtà, e relativa esclusivamente alla sua soggettiva interpretazione dei dati;
b) altri possono invece ritenere che le argomentazioni di Lauréline Fontaine sono documentate, e quindi che la sua rappresentazione dello stato della giustizia costituzionale sia reale, ma che tuttavia essa rappresenta solo la realtà della Francia e nient’altro;
c) ed altri ancora potrebbero essere indotti a valutare quanto di quelle critiche possono corrispondere a dei possibili difetti anche della nostra giustizia costituzionale, e ciò a prescindere dal fatto, sotto un certo profilo non di primordine, che Lauréline Fontaine abbia torto oppure ragione.
Aggiungerei che, in ogni caso, seppur i modi di Lauréline Fontaine siano inusuali per la dottrina italiana, e in taluni momenti brutali, le questioni che solleva, affinché il Conseil costitutionel mantenga la sua funzione, così come la indicava il Presidente Roger Frey nel 1977, “in favore della difesa delle libertà e della protezione dei diritti dei cittadini nei diversi ambiti assegnati al suo controllo dalla Costituzione” (pag. 260), non appaiono anodine, e a tal fine le riassumerei:
aa) la funzione della giustizia costituzionale è quella, si ripete ancora: “di limitare l’esercizio del potere politico a partire dal riconoscimento dei diritti di libertà e dell’essere umano” (pag. 25).
bb) In questa ottica ne consegue che i giudici costituzionali non devono avere legami con la politica e non devono aver svolto in precedenza funzioni governative, ed è altresì necessario che questa indipendenza dalla politica da parte dei giudici costituzionali vi sia anche nelle apparenze, e sia mantenuta successivamente alla cessazione dell’incarico.
cc) È necessario altresì che i giudici costituzionali siano giuristi di indiscutibile preparazione e indipendenza, i migliori tra quelli che lo Stato dispone, e non siano nominati con funzione premiale per le attività precedentemente svolte quali ministri, parlamentari o alti funzionari dello Stato.
dd) È necessario che nel giudizio di costituzionalità, così come avviene in tutti gli altri procedimenti aventi carattere giurisdizionale, il giudice accerti in autonomia e indipendenza i fatti rilevanti ai fini della decisione, e senza che gli elementi fattuali che servono per esprimere il giudizio di bilanciamento, o di congruità e/o di proporzionalità dei sacrifici imposti da una legge per favorire la protezione di altri valori, siano quelli prospettati dal Governo o da enti riconducibili al potere esecutivo.
ee) È infine necessario che le decisioni costituzionali siano compiutamente motivate, ove per motivazione completa debba intendersi qualcosa che non sia la mera ripetizione, o la semplice tautologia, di quanto già le relazioni governative e/o parlamentari hanno esplicitato per giustificare la legge in ordine alla sua legittimità costituzionale.
E possiamo, così, terminare con le parole di Alain Supiot, il quale osservava che, in fondo, “niente di così drammatico fortunatamente si trova nella storia del Conseil costitutionel tracciata in questo libro. Piuttosto qualche -épisode burlesques-, come quello della certificazione dei conti relativi alla campagna di M.M. Chirac e Balladur nel 1995. O francamente inquietante, la giurisprudenza covid, che ha sospeso, nel marzo 2020, il controllo di costituzionalità delle leggi nel momento preciso nel quale le restrizioni di libertà senza precedenti in tempo di pace l’avrebbero reso particolarmente necessario” (pag. 18).
E ancora cita Montesquieu: “c’est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser; il va jusqu’à ce qu’il trouve des limites” (pag. 18).
Garanzia di questi limiti è, appunto, il giudizio di costituzionalità delle leggi.

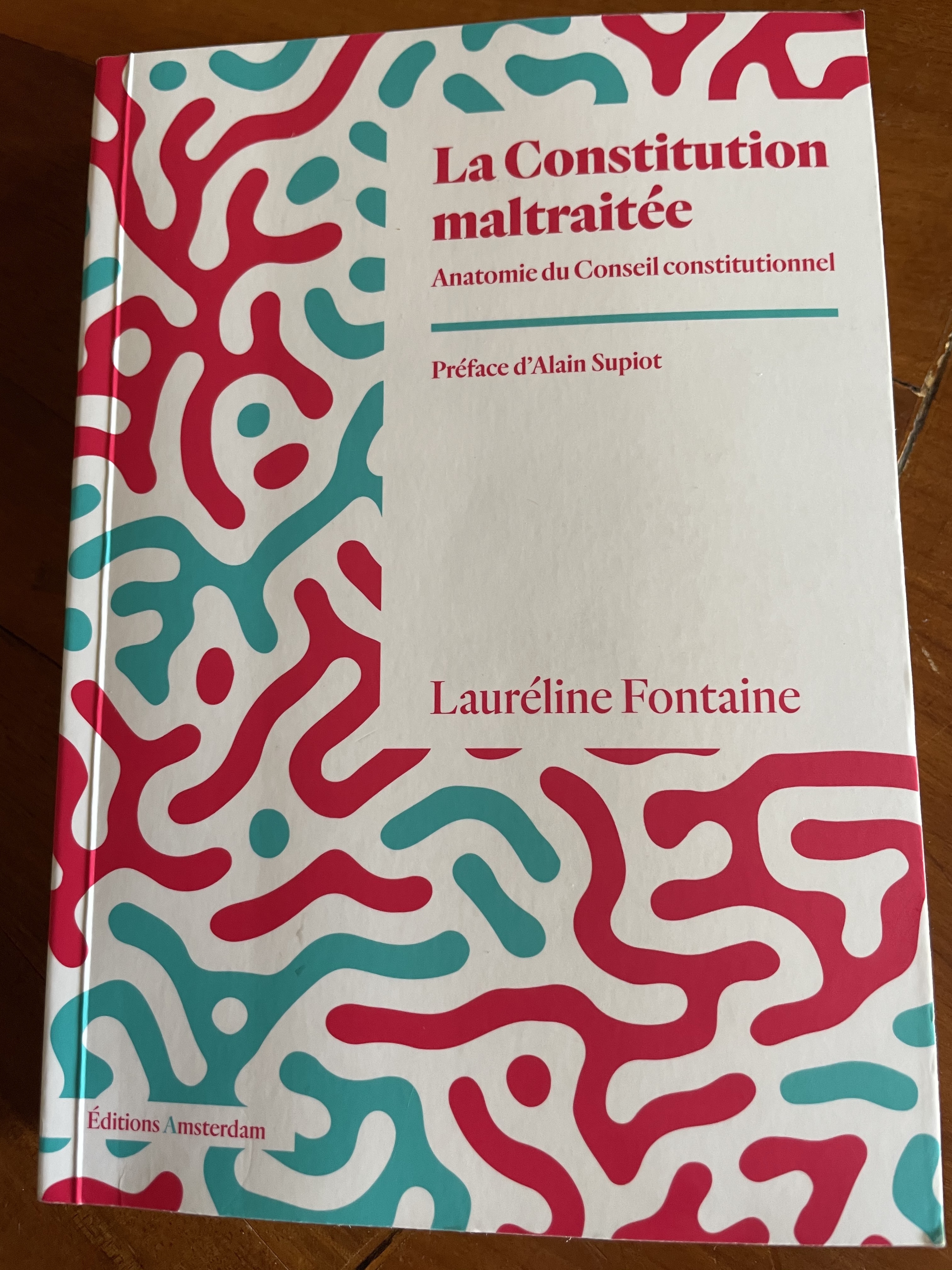

 And then Add to Home Screen.
And then Add to Home Screen.