- Luciano Ciafardini
- Magistratura onoraria
- Visite: 15175
Il restyling prossimo futuro dello status della magistratura onoraria: cosa bolle davvero in pentola?
Il restyling prossimo futuro dello status della magistratura onoraria: cosa bolle davvero in pentola?
di Luciano Ciafardini
Che lo status attuale del magistrato onorario sia un “oggetto misterioso”, è circostanza ben nota agli addetti ai lavori, al pari del sospetto di contrasto con una pluralità di principi costituzionali aleggiante sulla disciplina normativa stratificatasi, in materia, nel corso degli anni, fino al decreto legislativo 13 luglio 2017 recante «Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57» (cosiddetta “Riforma Orlando”), emanato in attuazione della delega contenuta nella legge 28 aprile 2016, n. 57.
Occorre partire da una constatazione: è lo stesso legislatore delegante a individuare, nell’art. 106, secondo comma, della Costituzione, la fonte di alcune caratteristiche ritenute “intrinseche” alla (e dunque necessarie per) la magistratura onoraria: a) la sostanziale gratuità dell’attività svolta, al limite compensabile con un’indennità, ma mai “retribuibile”; b) la temporaneità dell’incarico, da rendere compatibile con altre attività professionali; c) il carattere non continuativo dell’attività prestata; d) l’impossibilità di imporre a carico delle finanze statali gli oneri previdenziali, pur ritenuti “necessari”.
È possibile ritenere, al contrario, che queste caratteristiche, se pure non sono in contrasto con l’art. 106 Cost., riflettendone, anzi, lo spirito originario, non sono neppure imposte dalla Costituzione.
Esse sono, piuttosto, il frutto del modo in cui la legge di ordinamento giudiziario ha inteso attuare il precetto costituzionale.
I soli punti fermi che possiamo trarre dalla norma costituzionale sono due:
1) la nomina non avviene per concorso, atteso che la previsione del secondo comma costituisce una deroga al principio generale posto dal primo comma (che quella rigorosa modalità di selezione impone, invece, per la magistratura professionale)[1];
2) i magistrati onorari possono svolgere «tutte le funzioni attribuite a giudici singoli».
Sul significato da attribuire a questo secondo precetto si è ampiamente soffermata la recente sentenza n. 41 del 2021 della Corte costituzionale, sicché è possibile rinviare alla lettura dell’ampia, ricca e articolata motivazione che sorregge la pronuncia, con la quale la Corte ha dichiarato incostituzionali le norme che avevano previsto l’impiego, in pianta stabile nei collegi, come magistrati onorari, dei giudici ausiliari presso le Corti d’appello.
Più interessante, alla luce dei recenti sviluppi di cui si darà conto più avanti, è interrogarsi sullo status del magistrato onorario.
Sul piano funzionale, è ormai un dato acquisito che anche i giudici onorari sono magistrati ordinari, poiché esercitano la funzione giurisdizionale, civile e penale, di primo grado, nei limiti della competenza (ricordiamolo, indefettibilmente “minore”) loro attribuita, secondo un dato procedimento, pronunciando sentenze suscettibili di assumere l’efficacia propria del giudicato.
Questo comporta una serie di implicazioni sul piano delle garanzie che devono qualificare ogni organo dotato di poteri decisori.
In quanto organo della giurisdizione ordinaria, il giudice onorario deve assicurare l’affidamento dei cittadini nell’esercizio indipendente, autonomo e imparziale delle sue funzioni, al pari di ogni altro giudice.
Anche nei suoi confronti valgono le garanzie generali che caratterizzano l’esercizio di qualsiasi attività giurisdizionale e cioè l’autonomia e l’indipendenza (art. 104 Cost.), l’imparzialità (art. 111 Cost.) e la soggezione alla sola legge (art. 101 Cost.).
Quanto al profilo strutturale del rapporto intercorrente tra i magistrati onorari e l’amministrazione di riferimento (quella della giustizia), occorre essere chiari.
La Corte costituzionale afferma costantemente che tra i giudici professionali e quelli onorari esiste una netta distinzione, scolpita appunto nell’art. 106 Cost.
Per il perimetro limitato delle presenti note, è sufficiente ricordare che, anche di recente, la Corte costituzionale – pur rilevando l’identità (si potrebbe dire “ontologica”) della funzione del giudicare svolta dal magistrato professionale come da quello onorario (sentenza n. 267 del 2020) – ha più volte affermato che la posizione giuridico-economica dei magistrati professionali non si presta a un’estensione automatica nei confronti dei magistrati onorari tramite evocazione del principio di eguaglianza.
Nel pensiero della Corte, la differente modalità di nomina, radicata nella previsione dell’art. 106, secondo comma, Cost., il carattere non esclusivo dell’attività giurisdizionale svolta (sebbene, come si dirà, la realtà degli uffici giudiziari restituisca una situazione profondamente diversa da quella ipotizzata dal legislatore, anche costituzionale) e il livello di complessità degli affari trattati rendono conto dell’eterogeneità dello status del giudice di pace, dando fondamento alla qualifica “onoraria” del suo rapporto di servizio (sentenza n. 41 del 2021). Per usare le parole della Corte, «[e]nunciata a proposito del trattamento economico dei componenti delle commissioni tributarie (ordinanza n. 272 del 1999) e per quello dei vice pretori onorari (ordinanza n. 479 del 2000), l’affermazione è stata ripetuta anche per i giudici di pace, sia in tema di cause di incompatibilità professionale (sentenza n. 60 del 2006), sia in ordine alla competenza per il contenzioso sulle spettanze economiche (ordinanza n. 174 del 2012)» (così, ancora, sentenza n. 267 del 2020).
Su tale affermazione, per la giurisprudenza costituzionale, non ha inciso la recente pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE, caso “UX”, in C-658/18, sentenza del 16 luglio 2020)[2], la quale, tuttavia, in sede di rinvio pregiudiziale, ha sancito alcuni principi che hanno dato più di una scossa al panorama giurisprudenziale interno, da troppo tempo pigramente riposante su affermazioni tralatizie.
La Corte UE, infatti, ha affermato che, considerate le modalità di organizzazione del lavoro dei giudici di pace[3], essi «svolgono le loro funzioni nell’ambito di un rapporto giuridico di subordinazione sul piano amministrativo, che non incide sulla loro indipendenza nella funzione giudicante, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare» riportando, quindi, la figura del giudice di pace alla nozione di «lavoratore a tempo determinato».
La decisa presa di posizione della CGUE, se non risulta ancora aver determinato un cambio di prospettiva nelle magistrature superiori di legittimità[4] e amministrativa[5], sembra, invece, aver spiegato notevole influenza sui giudici di merito, tanto che in alcune pronunce ci si è spinti a riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e, di conseguenza, a condannare lo Stato italiano al risarcimento del danno (c.d. “eurounitario”) per l’illegittima reiterazione di contratti di lavoro a termine nei confronti di uno stesso lavoratore (ossia del magistrato onorario, per decenni confermato nell’incarico)[6], oppure a riconoscere – in aggiunta – il diritto a percepire un trattamento economico corrispondente a quello del magistrato professionale di prima nomina[7], oppure, ancora, ad accertare e riconoscere (anche prima della sentenza europea) «la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato di fatto […], con ogni effetto conseguente per legge»[8].
La decisione, però, non giunge come fulmine a ciel sereno.
Era già del tutto lecito interrogarsi, senza scomodare le fonti sovranazionali ed appigliandosi esclusivamente ai principi costituzionali, sulla configurabilità di un rapporto di lavoro, fosse anche in senso lato, tra il magistrato onorario e lo Stato.
I magistrati onorari in servizio da decenni considerano questa una domanda retorica.
L’esperienza quotidiana insegna che essi, al mattino, escono di casa, raggiungono l’ufficio, siedono in udienza in tribunale o entrano in un ufficio di procura, trattano affari di giustizia assegnati secondo criteri predeterminati dal dirigente dell’ufficio, sono tenuti a rispettare orari, termini e ordini di servizio, a partecipare a riunioni e attività di formazione, a redigere provvedimenti, a interagire con le strutture anche informatiche degli uffici, con le cancellerie e segreterie, con l’utenza, a sottostare alla vigilanza dei dirigenti degli uffici e a rispondere delle violazioni dei loro doveri funzionali. Tornano a casa e, spesso, studiano i fascicoli che si sono portati dall’ufficio, per ricominciare il mattino successivo.
Eppure.
Come spiega la relazione illustrativa al d.lgs. n. 116 del 2017 (in perfettacontinuità, almeno sul punto, con le direttive del legislatore delegante), tra il magistrato onorario e lo Stato non può intercorrere alcun rapporto di lavoro, in quanto la sua figura è assimilabile a quella del “funzionario onorario”, sicché l’attività svolta non è “retribuibile”, ma al più al compensabile con un’indennità, che fungerebbe quasi da rimborso spese.
Si può dire che il legislatore abbia mutuato questi concetti dalla giurisprudenza costituzionale, la quale, dal suo canto, ha sempre negato la possibilità di configurare un rapporto di impiego, potendosi riconoscere solo la sussistenza di un rapporto di servizio, espletato da un “funzionario onorario”.
Impostazione ripresa dalla giurisprudenza, fino al massimo livello costituito dalle Sezioni Unite della Cassazione (si pensi, tra le tante, a Cass., sez. un., 9 novembre 1998, n. 11272).
Occorre, allora, vedere più da vicino quali sono le caratteristiche del “rapporto onorario” desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.
È la sentenza n. 70 del 1971 la prima che applica anche ai magistrati onorari i principi sul funzionario onorario, ribadendoli nelle ordinanze n. 57 del 1990 e n. 225 del 1998.
Si legge, nelle pronunce appena richiamate, che il rapporto di servizio dei funzionari onorari si distingue sotto diversi profili da quello impiegatizio.
I profili sono i seguenti:
a) la scelta del funzionario onorario si ispira a criteri di natura politico-discrezionale e non tecnico-amministrativa;
b) la disciplina del rapporto deriva, pressoché esclusivamente, dall’atto di conferimento dell'incarico;
c) il compenso percepito ha natura indennitaria e non retributiva, sicché non si pone in rapporto di corrispettività con la prestazione resa;
d) si tratta di «incarichi di natura particolare e saltuaria»;
e) viene in rilievo l’esercizio di «funzioni spontaneamente assunte per sentimento di dovere civico e di dignità sociale, e non identificabili con attività professionale».
La domanda successiva che allora occorre porsi è questa: è predicabile una configurazione del magistrato onorario in termini di funzionario onorario alla luce della disciplina introdotta dalla “riforma Orlando”?
Sarà sufficiente operare quello che potrebbe essere definito un fact-checking, per ciascuno degli indici enucleati dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria. Giova ripeterli:
1) La scelta del funzionario onorario deve ispirarsi a criteri di natura politico-discrezionale e non a valutazioni tecnico-amministrative.
Sappiamo che oggi:
- ai fini della nomina, il CSM individua i “posti da pubblicare”, sulla base delle “vacanze previste nelle piante organiche degli uffici”, pubblicando il relativo “bando” e fissando il termine per la presentazione delle domande, che vengono vagliate dal Consiglio giudiziario che, in applicazione di criteri prefissati e titoli di preferenza indicati dalla legge, “redige la graduatoria degli aspiranti” e “formula le motivate proposte di ammissione al tirocinio” (art. 6);
- si effettua un tirocinio, organizzato dal CSM e dalla Scuola superiore della magistratura, consistente, oltre che nell’attività svolta presso gli uffici giudiziari, sotto la direzione di un magistrato professionale collaboratore, anche nella “frequenza obbligatoria e con profitto dei corsi teorico-pratici di durata non inferiore a 30 ore”, mediante “esercitazioni pratiche, test e altre attività teorico-pratiche”, sulle quali il magistrato collaboratore redige un “rapporto dettagliato”, allegando le “minute dei provvedimenti” (art. 7);
- all’esito del tirocinio il Consiglio giudiziario formula un parere sull’idoneità del magistrato onorario in tirocinio e, per ciascun ufficio, propone al CSM la “graduatoria degli idonei per il conferimento dell’incarico”, “in numero pari alle vacanze esistenti in ciascun ufficio”. Graduatoria che “conserva efficacia per i due anni successivi” (art. 7 commi 8 e 9).
Si tratta, per inciso, di scansioni procedimentali prefissate e di moduli provvedimentali la cui violazione è giustiziabile innanzi al TAR.
2) la disciplina del rapporto dovrebbe derivare “pressoché esclusivamente”, dall’atto di conferimento dell’incarico.
Sappiamo che, oggi:
- l’attività è minuziosamente disciplinata dalla legge e dalle circolari del CSM;
- l’attività è pre-determinata attraverso l’applicazione delle tabelle e dei programmi organizzativi;
- l’attività è etero-diretta dai magistrati professionali, con i quali i magistrati onorari hanno l’obbligo di collaborare.
3) Il compenso percepito dovrebbe avere natura indennitaria.
A normativa ancora vigente, nonostante la decurtazione in termini quantitativi, il compenso somiglia ad una vera e propria retribuzione, se si pensa che:
-da essa vengono detratti i contributi previdenziali (art. 23, comma 2);
-viene corrisposta anche per il periodo di sospensione feriale dell’attività (art. 24; e ricordiamo che il terzo comma dell’art. 36 Cost. dispone che il “lavoratore” ha diritto a ferie annuali retribuite);
-viene differenziata in base all’attività svolta, giurisdizionale o collaborativa all’interno dell’ufficio, ed è maggiorabile in relazione ai risultati conseguiti rispetto ad obiettivi prefissati dal dirigente dell’ufficio e, dunque, in base ad un vero e proprio ordine di servizio: caratteristiche incompatibili con un mero “rimborso spese” (art. 23).
3) l’attività dovrebbe essere “saltuaria” e “particolare”.
Appartiene alla sfera del notorio che essa, invece:
-è continuativa, in quanto il giudice onorario non può scegliere di non partecipare all’udienza calendarizzata, se non adducendo un impedimento documentato, pena la sottoposizione al procedimento di revoca (art. 21)[9];
-trattasi di attività part-time, per due giorni a settimana, che, se vogliamo usare concetti tecnici noti ai giudici del lavoro, costituisce un part-time verticale pro die (art. 1, comma 3);
-non è affatto “particolare”, quanto, piuttosto, del tutto identica ad una porzione di quella esercitata dai magistrati professionali.
4) L’attività dovrebbe essere svolta, puramente e semplicemente, per sentimento di dovere civico e di dignità sociale: il che significa su base volontaria, non essendo affatto essenziale.
Sta di fatto che gli stessi numeri illustrati nella relazione tecnica di accompagnamento alla riforma ci dicono che tale attività è divenuta parte irrinunciabile di un sistema che collasserebbe, qualora ne fosse privato.
La conclusione che si trae da queste plurime constatazioni pare palese: nessuna delle condizioni previste dalla giurisprudenza costituzionale ed ordinaria, per la riconoscibilità di un funzionario onorario, appare integrata.
Dunque, in base alla legislazione vigente, il magistrato onorario non è più – ammettendo pure che lo sia mai stato – un funzionario onorario.
Nonostante questo, la legge ancora sancisce il principio fondamentale secondo cui lo svolgimento dell’attività non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego (art. 1, comma 3).
Ma c’è di più.
Ci sarebbe da interrogarsi sul perché, se davvero di funzionario onorario ancora si tratta, il legislatore si occupi di alcuni aspetti tipici del rapporto di lavoro.
Viene, così, stabilito che la malattia e l’infortunio dei magistrati onorari non comportano la dispensa dall’incarico, la cui esecuzione rimane sospesa, ma senza diritto all’indennità, per un periodo non superiore a sei mesi, decorso il quale è integrato un caso di decadenza dall’incarico (art. 25).
L’art. 25, comma 5, prevede, ancora, che l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari è attuata con le modalità previste dall’art. 41 del d.p.r. n. 1124 del 1965 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), in base al tasso di rischio corrispondente all’attività svolta[10]. È noto, però, che l’art. 41 del d.p.r. n. 1124 del 1965 disciplina il tasso di premio dovuto dal datore di lavoro sulla base della tariffa (di premio) stabilita in proporzione “all’ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte”. Dunque, l’art. 41 parla di datore di lavoro e di retribuzione: come si spiega l’applicazione dell’art. 41 ad un funzionario onorario?
Tralasciamo, sempre per ragioni di spazio, l’esame della disciplina concernente la tutela previdenziale e assistenziale: è sufficiente ricordare come si preveda l’iscrizione obbligatoria alla Gestione separata dell’INPS, del tutto a carico del “funzionario onorario” e come se si trattasse di un lavoratore autonomo o para-subordinato (perché a queste categorie si riferisce la gestione separata INPS).
E tuttavia, nella più volte menzionata relazione illustrativa, si legge testualmente: «il rapporto del funzionario onorario non rientra nello schema del lavoro autonomo e neppure in quello dell’attività di collaborazione coordinata e continuativa, costituendo esercizio di funzioni spontaneamente assunte “per sentimento di dovere civico e di dignità sociale”».
La posizione – separatamente considerata (artt. 30-32) – dei magistrati onorari già in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 116 del 2017, con il sistema di conferme quadriennali agli stessi riservato per la durata di sedici anni – amplifica al massimo grado tutti i profili di criticità che abbiamo rilevato con riferimento ai magistrati onorari “a regime” immaginati dalla riforma.
A questo punto ci si chiede: occorreva davvero attendere la pronuncia della Corte di giustizie UE del luglio 2020 per ritenere che siamo in presenza di una prestazione del tutto assimilabile a quella lavorativa in senso proprio?
Forse lo stesso Ministero della giustizia era ben conscio del problema: nel mentre, infatti, si stava dando attuazione alla legge di delegazione, contemporaneamente veniva richiesto al Consiglio di Stato un parere sulla possibilità – evidentemente dallo stesso apparato ministeriale avvertita come rispondente ad impellente giustizia sostanziale – di procedere ad una “stabilizzazione” dei magistrati onorari in servizio.
È interessante sottolineare come il massimo organo di giustizia amministrativa abbia indicato una anche una diversa strada: la «conservazione dell’incarico in corso sino al conseguimento della età pensionabile».
Il modello è stato già utilizzato in passato dalla legge n. 217 del 1974 con riguardo ai vice pretori onorari incaricati[11].
Quel parere rimase però ben riposto nei cassetti ministeriali. Almeno fino a poco tempo fa (sul punto si tornerà a breve).
È risaputo che, allo scopo di superare le problematiche variamente connesse ai meccanismi farraginosi – e anche contraddittori, come si è evidenziato – disseminati lungo l’intero testo della Riforma Orlando, nel corso del 2019 è stato presentato un progetto di modifica da parte del Ministro della giustizia, in corso di esame in Parlamento (d.d.l. A. S. n. 1516) nel testo unificato con altri disegni di legge (d.d.l. 1438, 1555, 1582 e 1714).
Non è il caso di esaminare funditus le critiche rivolte anche a questo progetto di “riforma della riforma”[12].
Sta di fatto che, per la diffusa insoddisfazione provocata dal d.d.l. A.S. 1516, presso il Ministero della giustizia è stata istituita, con d.m. 23 aprile 2021, un’apposita Commissione «per l’elaborazione di proposte di interventi in materia di magistratura onoraria», i cui lavori si sono conclusi in data 21 luglio 2021, con la predisposizione di emendamenti che dovrebbero essere apportati alle proposte di riforma confluite nel testo unificato attualmente all’esame del Parlamento.
La Commissione, evidentemente per i limiti di mandato ricevuti, non ha ritenuto di discostarsi dalle linee di fondo della Riforma Orlando, seguendo direttrici chiaramente compendiate nella relazione finale, alla cui lettura è sufficiente rimandare.
Il merito, indubitabile, della Commissione è stato quello di aver offerto al decisore politico proposte di modifica del d.lgs. n. 116 del 2017, almeno nei punti in più stridente contrasto con le esigenze di tutela della categoria, se non proprio con il semplice buon senso.
Per limitarci alla categoria che più desta preoccupazione, ossia quella dei “magistrati onorari di lungo corso”, la Commissione ha avanzato una serie di proposte certamente apprezzabili, pur muovendosi nel solco dell’“onorarietà” (fittizia) disegnata dalla Riforma Orlando.
E così, ha suggerito, ad esempio, di prolungare, previe conferme periodiche, l’incarico dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 116 del 2017 sino al limite massimo anagrafico, incrementato, rispetto a quanto previsto dall’art. 29, comma 2, della riforma, da sessantotto a settanta anni, per uniformarlo a quello dei magistrati professionali.
Ancora, ha proposto di ridimensionare in maniera originale l’impegno richiesto, modulandolo su base mensile (e non più settimanale) e lasciando al magistrato onorario la scelta di optare per un impegno rispettivamente di tredici, nove o cinque giorni mensili. Nel formulare il progetto, ha avuto cura di evidenziare un profilo che converrà tenere a mente, in vista di ciò che si dirà al termine del presente contributo: si vorrebbe consentire «(quanto al minor tempo di impegno) di non disperdere la professionalità dei magistrati onorari recentemente approdati ad incarichi amministrativi nel comparto giustizia ovvero ad altri rapporti di pubblico impiego».
Un deciso miglioramento è stato prefigurato in ordine al trattamento economico, pur sempre di natura indennitaria, suggerendo la corresponsione, in favore dei magistrati onorari in servizio che abbiano scelto la fascia di maggiore impegno, di somme “non inferiori” a 2.200 euro netti su base mensile (per 12 mensilità), e non più a cadenza trimestrale.
In questo contesto, la sentenza della Corte europea irrompe sulla scena, “sparigliando le carte”: le affermazioni di principio esibite nella densa motivazione si “saldano” con le pronunce dei giudici di merito italiani di cui si è dato conto in precedenza, stringendo il decisore politico in una ideale “morsa” dalla quale è assolutamente necessario uscire.
Fonti (allo stato solo) giornalistiche[13] riferiscono che la Ministra della giustizia, prof.ssa Cartabia, ha illustrato a rappresentati della categoria interessata una nuova strada scelta dal Governo: non più modifiche al d.d.l. A. S. n. 1516, bensì emendamenti al disegno di legge di bilancio per il 2022 (d.d.l. A.S. n. 2448) presentato in Parlamento.
I contorni dell’intervento proposto, per le ovvie semplificazioni giornalistiche, sono ancora incerti e in gran parte avvolti nel mistero, sicché possiamo solo provare ad ipotizzare.
A livello di status, si profila una “stabilizzazione” «nelle attuali funzioni di tutta la magistratura in servizio, secondo un procedimento da completare nell’arco di tre anni, in base all’anzianità di incarico e previo superamento di apposito esame», che verrebbe condotto «in ossequio all’art. 97 della Costituzione, mediante prove con modalità in via di definizione, volte a valorizzare le esperienze pregresse e tenendo conto delle procedure di conferma già esistenti».
L’ipotesi della “stabilizzazione” dei magistrati onorari in servizio sembra “ripescare” i suggerimenti contenuti nelle pieghe del parere reso dal Consiglio di Stato nel 2017, che vengono però “assemblati” tra di loro.
In forza delle pur scarne notizie fornite, infatti, non è implausibile ipotizzare che si intenda scegliere una “via ibrida”, rispetto sia al prolungamento tout court dell’incarico onorario, sia alla prova concorsuale old style sia, infine, alla stessa assunzione senza concorso[14]: non si parla, infatti, esplicitamente di concorso, ma di superamento di un “esame”, da condurre però nel rispetto dei principi di cui all’art. 97 Cost. ed allo scopo ben definito di rispondere alle richieste di un “precariato” intellettuale.
L’iniziativa si inserirebbe nel trend legislativo tipico di questa epoca pandemica, diretto a semplificare al massimo lo svolgimento delle prove concorsuali per l’assunzione nei ruoli delle pubbliche amministrazioni. Lo stesso Ministero della giustizia, del resto, se ne è già avvalso, bandendo concorsi ai quali hanno partecipato numerosissimi magistrati onorari di lungo corso, che hanno ottenuto l’inquadramento nei ruoli dell’amministrazione della giustizia, come, del resto, dà esplicitamente atto la stessa relazione finale del 21 luglio 2021 della Commissione ministeriale che, come si ricorderà, ha ritenuto di articolare il possibile impegno onorario in tre fasce temporali crescenti, per «non disperdere la professionalità dei magistrati onorari recentemente approdati ad incarichi amministrativi nel comparto giustizia ovvero ad altri rapporti di pubblico impiego»[15].
Lo schema parrebbe replicabile, sia pure con gli opportuni adattamenti: l’assunzione – magari “semplificata” – nei ruoli della pubblica amministrazione consentirebbe di assicurare effettivamente quel pacchetto di tutele (in materia previdenziale, di maternità, di ferie retribuite, eccetera) che le Istituzioni europee considerano irrinunciabile corredo di ogni lavoratore, che sia da considerare tale in applicazione del diritto dell’Unione.
Dall’altro lato, l’obiettivo di non disperdere preziose risorse, perfettamente formate e già integrate nei meccanismi della complessa macchina dell’amministrazione della giustizia, sarebbe conseguito mercé la “sovrapposizione” a questo rapporto d’impiego di un incarico – questa volta genuinamente onorario, nello spirito del primigenio dettato Costituzionale – in forza del quale continuare a svolgere le funzioni giudiziarie appunto onorarie.
Il vero problema è però il seguente: nelle intenzioni ministeriali, sommariamente riportate dalle fonti giornalistiche, quale ruolo “stabile” dovrebbe assumere il magistrato onorario che partecipasse, superandolo, all’annunciata “prova d’esame”?
Difficile ipotizzare di ricorrere, ancora, ai ruoli pienamente corrispondenti alle tradizionali figure dell’apparato dell’amministrazione della giustizia, come definitine nella contrattazione collettiva di comparto: se “tutta” (così le fonti giornalistiche) la magistratura onoraria in servizio fosse “travasata” nei ruoli dei Direttori amministrativi, cancellieri esperti, assistenti giudiziari et similia, l’obiettivo di “non dispersione” cui si è fatto cenno non potrebbe dirsi compiutamente raggiunto, perché sarebbe giocoforza ipotizzare che tutti i vincitori di concorso – che non riuscissero a “strappare” un part-time verticale all’amministrazione di appartenenza – opterebbero per il modulo minimale di impegno calibrato su cinque giorni mensili, con intuibili conseguenze in punto di raggiungimento degli ambiziosi obiettivi fissati nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Più agevole immaginare, invece, una risagomatura proprio dell’Ufficio per il processo e, in particolare, di quella articolazione sulla quale si è registrato un ingente investimento di risorse con fondi del PNRR.
Il d.l. n. 80 del 2021, come convertito, per favorire la piena operatività dell’UPP, ha previsto (artt. 11 e ss.) il reclutamento di un contingente straordinario di personale da destinare proprio alle strutture organizzative denominate Ufficio per il processo.
Si tratta, però, di personale a termine.
In questo caso, invece, verrebbe in rilievo l’assunzione di personale a tempo indeterminato, destinato tuttavia, non certo a svolgere l’attività di collaborazione prevista dalle regole (legislative) d’ingaggio del personale a termine di cui si è detto, ma un’attività peculiare – che magari potrebbe essere, con un po’ di fantasia, costruita in termini di “consulenza, studio e ricerca” ed ovviamente adeguatamente retribuita – per dipendenti pronti ad assumere incarichi, temporalmente delimitati, ma rinnovabili previa conferma della persistenza dei requisiti di cui abbiamo parlato in precedenza[16].
Non ci sarebbero limiti temporali – né settimanali né mensili – all’impiego di queste nuove figure, mentre l’articolato sistema “a fasce” immaginato dall’ultima Commissione ministeriale potrebbe sopravvivere a beneficio dei magistrati onorari già attualmente assunti, con le ultime tornate concorsuali, alle dipendenze del Ministero della giustizia. Non si riesce a scorgere, infatti, una valida ragione per rinunciare a queste altrettanto preziose risorse umane[17], in considerazione dell’assoluta necessità di utilizzare tutti i mezzi disponibili per centrare, nei termini prefissati, gli obiettivi indicati dal PNRR in materia di giustizia.
Quelle appena esposte sono, ovviamente, solo congetture, magari destinate a dissolversi come neve al sole.
Soltanto l’analisi delle concrete misure legislative che saranno oggetto dell’annunciato emendamento consentiranno di valutare se l’ambizioso obiettivo dichiarato potrà essere davvero raggiunto (e in che modo).
[1] A quanto consta, nel panorama europeo, solo la Costituzione italiana e quella portoghese prevedono che il reclutamento dei magistrati professionali debba avvenire per concorso. Che questa modalità sia poi seguita nella maggior parte dei Paesi dipende, più che da vincoli costituzionali, da scelte politiche rimesse alla legislazione ordinaria, per garantire la selezione dei soggetti più preparati.
[2] Sulla quale, da ultimo, il pregevole lavoro di R. Calvano, Corte di giustizia, primato del diritto Ue e giudici onorari, in questa Rivista, 22 novembre 2021.G
[3] Secondo la Corte UE, «la caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è la circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un’altra e sotto la direzione di quest’ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceva una retribuzione». Ne consegue che, per il diritto europeo, poiché i magistrati onorari sono assunti a determinate condizioni, si vedono assegnare compiti e cause, sono valutati dal Consiglio superiore della magistratura e soggetti a un’autorità superiore che può revocarli dall’incarico se non osservano i loro doveri o che può decidere in merito al rinnovo del loro «mandato» sulla base della loro idoneità a continuare a svolgere le funzioni, essi potrebbero rientrare – accertate queste condizioni dal giudice nazionale – nella nozione di “lavoratore” e il loro compenso potrebbe essere assimilato ad una vera e propria retribuzione.
[4] Ferma sull’esclusione di qualsiasi possibilità di ipotizzare la sussistenza di un rapporto di impiego del magistrato onorario (ex plurimis, Cass., sez. lavoro, 5 giugno 2020, n. 10774; Cass., sez. III, 14 ottobre 2019, n. 25767; Cass., sez. lavoro, 4 gennaio 2018, n. 99).
[5] La quale, anzi, con la sentenza 4 febbraio 2021, n. 1062, del Consiglio di Stato (sez. V), ha escluso qualsiasi effetto della pronuncia europea, sul piano della qualificazione del rapporto secondo il diritto interno, che resta “onorario” e distinto da quello di pubblico impiego.
[6] Tribunale di Roma, sentenza 13 gennaio 2021, e Tribunale di Napoli, sezione lavoro, sentenza 7 ottobre 2020.
[7] Tribunale di Vicenza, sentenza 16 dicembre 2020.
[8] Tribunale di Sassari, sezione lavoro, sentenza 24 gennaio 2020.
[9] Non ci soffermiamo qui su quella che appare una vera e propria “truffa delle etichette”, frutto della scelta legislativa di rinunciare, da un lato, a dare attuazione a una precisa direttiva contenuta nella legge di delegazione, che imponeva di regolamentare il regime disciplinare, ma di recuperare, dall’altro, nell’ambito della procedura di revoca, le ipotesi di responsabilità disciplinare previste dal legislatore delegante. Da affermazioni di carattere quasi “confessorio” contenute nella relazione di accompagnamento, si legge che l’attuazione di un sistema disciplinare avrebbe in qualche modo intaccato il carattere onorario dell’incarico, delineando indici rivelatori di un sostanziale incardinamento in un ufficio (in particolare, il regime disciplinare, per sua natura, presupporrebbe la stabilità del rapporto).
[10] La classificazione tariffaria delle specifiche attività svolte dai giudici onorari e dai vice procuratori onorari è stata individuata nella voce di tariffa 0722 – cui corrisponde un tasso pari al cinque per mille (circ. INAIL 8 novembre 2017 n. 50, ) – perché si è ritenuto che questi soggetti siano impegnati abitualmente a svolgere le proprie funzioni mediante l’uso di videoterminali e macchine elettroniche di ufficio. Incombe al Ministero della giustizia inoltrare all’INAIL la denuncia di iscrizione per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali per i magistrati onorari. L’obbligo di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale ricade sull’ufficio competente individuato dal ministero della giustizia, sulla base del proprio assetto organizzativo interno.
[11] Del resto, forse non è noto a tutti che in passato, ai sensi degli artt. 24 e 32, comma 1, O.G. – ora abrogati – i conciliatori, vice conciliatori e vice pretori onorari, pur destinatari di incarichi della durata di 3 anni, potevano essere riconfermati senza alcuna limitazione temporale. Il che smentisce l’assunto che l’art. 106 Cost. “imponga” la temporaneità dell’incarico onorario.
[12] È sufficiente rinviare alle acute osservazioni contenute nel saggio di F. Russo, Breve storia degli extranei nella magistratura italiana. Giudici onorari, avvocati e professori universitari immessi nella magistratura dall’Unità d’Italia al d.lgs. 12 luglio 2017, n. 116, Roma, 2019.
[13] IlSole24ore e ItaliaOggi del 23 novembre.
[14] La Corte costituzionale, ancora di recente, ha affermato che il principio del pubblico concorso, di cui all’art. 97, quarto comma, Cost., non è di per sé incompatibile, nella logica dell’agevolazione del buon andamento della pubblica amministrazione, con la previsione per legge di «condizioni di accesso intese a consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione», purché l’area delle eccezioni sia delimitata in modo rigoroso e sia subordinata all’accertamento di specifiche necessità funzionali dell’amministrazione e allo svolgimento di procedure di verifica dell’attività svolta (sentenze n. 275 del 2020, n. 113 del 2017, n. 167 del 2013 e n. 310, n. 189 e n. 52 del 2011), dovendosi però avere cura di «trovare un ragionevole punto di equilibrio» tra il principio del pubblico concorso e l’interesse a consolidare le pregresse esperienze lavorative del personale (da ultimo, sentenza n. 164 del 2020). L’assunzione nei ruoli della pubblica amministrazione senza concorso non è fenomeno frequente, ovviamente, ma non è neppure raro. Ad esempio, con decreto del ministero dell’Interno del 18 dicembre 2014, venne data attuazione al decreto-legge n. 101 del 2013, come convertito, che introdusse (art. 7, comma 1, lett. b), un nuovo comma (il 2-bis) all’art. 16-ter del d.l. n. 8 del 1991 in tema di benefici spettanti ai testimoni di giustizia, prevedendo l’assunzione senza concorso appunto dei testimoni di giustizia.
Probabilmente non avrebbe menato scandalo una decisione politica che avesse riconosciuto anche ai magistrati onorari – specie a quelli in servizio ormai da decenni, e sottoposti a periodiche conferme (e sempreché queste ultime avessero restituito risultati tranquillizzanti in ordine ai requisiti di equilibrio, capacità, indipendenza e imparzialità) – meriti nei confronti dello Stato, e dell’amministrazione della giustizia in particolare, tali da giustificare il ricorso a procedure in deroga al principio del pubblico concorso.
[15] È appena il caso di ricordare che, del tutto condivisibilmente, il CSM, con delibera del 2 marzo 2021 (prot. 23/VA/2021), ha sancito la piena compatibilità tra l’assunzione nei ruoli di direttore amministrativo – tra i più “gettonati” dai magistrati onorari partecipanti ai concorsi – e la prosecuzione dell’incarico onorario, salvo richiedere il nulla osta da parte dei dirigenti degli uffici interessati (quello in cui si svolge il rapporto di pubblico impiego e quello in cui si esercita l’incarico onorario, che dovranno entrambi certificare l’assenza di cause d’incompatibilità funzionale), nonché l’assolvimento degli oneri comunicativi (specialmente attinenti alle remunerazioni percepite) previsti a carico di tutti i dipendenti pubblici autorizzati allo svolgimento di incarichi extra-funzionali.
[16] Non sarebbe, a ben vedere, un modello eccentrico rispetto ad altri istituti rinvenibili nell’ordinamento del lavoro pubblico. Pur se il paragone può sembrare azzardato, si pensi, ad esempio, allo schema disegnato dal legislatore nell’art. 19 (spec. al comma 10) del d.lgs. n. 165 del 2001, per gli incarichi di funzioni dirigenziali.
[17] Salvo consentire loro, alternativamente, e per elementari esigenze di equità, di optare per il passaggio in questo rinnovato status (che sarà presumibilmente più conveniente dal punto di vista economico), senza necessità di affrontare un nuovo concorso, quand’anche molto più “agevolato” di quello da pochissimo tempo superato.


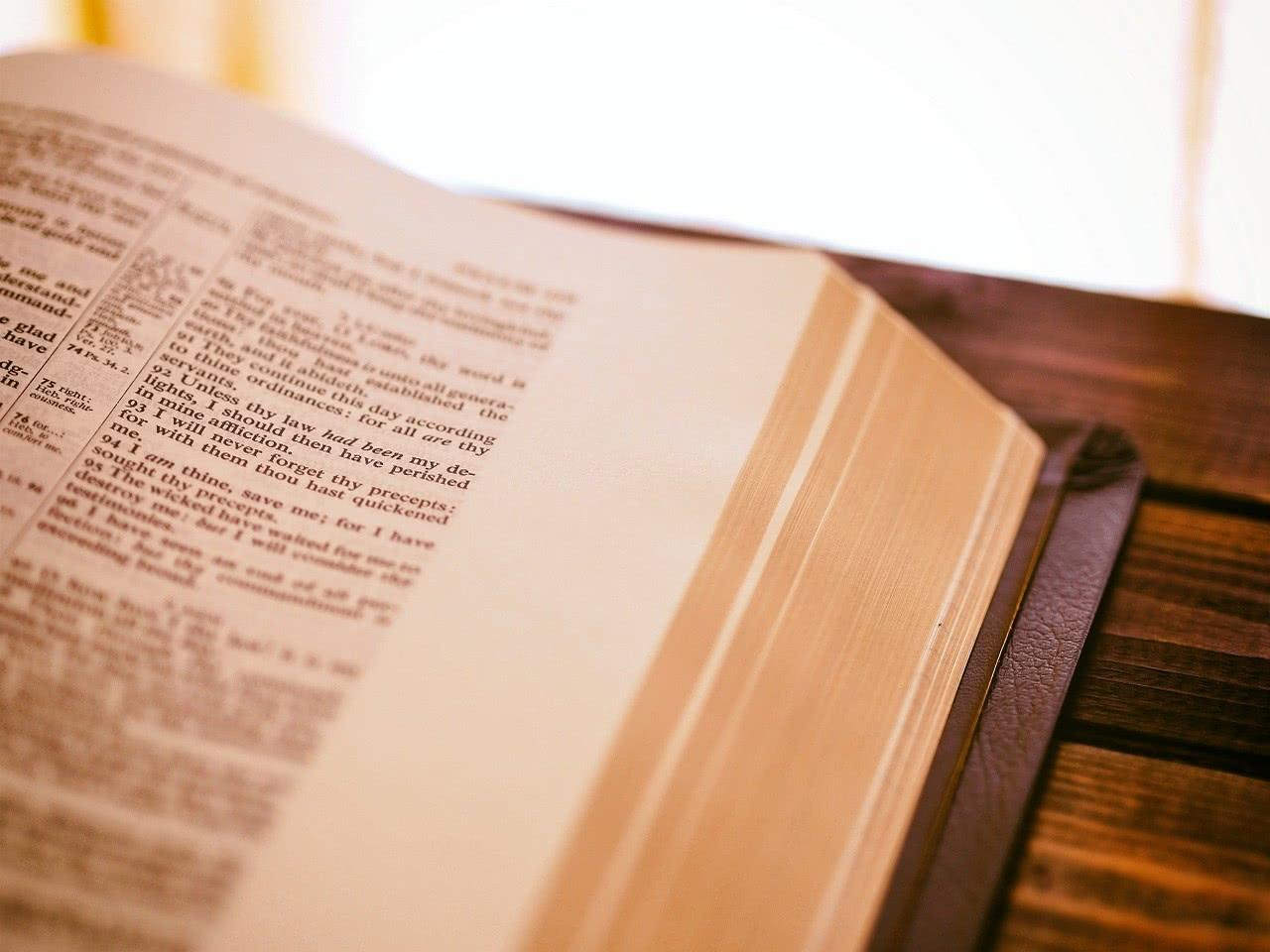

 E poi Aggiungi alla schermata principale.
E poi Aggiungi alla schermata principale.