“Prima lezione sulla giustizia penale” di Glauco Giostra
Recensione di Ernesto Lupo
1.Le cronache relative alla giustizia penale occupano molto spazio nei quotidiani e, più in generale, nei media. Sostanziano anche, in parte non esigua, il dibattito politico. La collettività nazionale è poco preparata a comprendere i complessi meccanismi con cui si esercita questa giustizia. E spesso l’informazione non raggiunge un livello qualitativo idoneo a consentirne una corretta comprensione, anche perché, quando la giustizia tocca persone della vita politica o comunque di potere, può verificarsi la distorsione delle notizie a fini di parte.
La rilevanza politica e sociale assunta, nei lustri recenti, dai processi penali, unita alla difficoltà della opinione pubblica di rendersi conto degli sviluppi, dei tempi e degli esiti, alcune volte sorprendenti, delle vicende giudiziarie, costituiscono una miscela che contribuisce a diminuire la fiducia verso la giustizia italiana (anche penale), secondo una tendenza risultante da recenti rilevazioni nazionali.
Glauco Giostra, professore ordinario di procedura penale della Sapienza di Roma, è consapevole di “quanto profonde siano le interconnessioni tra il modo di intendere la giustizia e il modo di vivere la democrazia”. Con questa consapevolezza egli si è accinto a scrivere il volume dedicato al processo penale, nell’ambito della nota e ricca collana degli Editori Laterza “Prime lezioni”, con l’intento di spiegare le ragioni e la complessità della giustizia penale ad una ampissima fascia di lettori, che va ben al di là di coloro che operano o che comunque si accingono a studiare la materia. Egli ha, perciò, scritto una pubblicazione che, con linguaggio semplice e scorrevole, mira a fare “capire” il meccanismo processuale, più che a dare nozioni, al fine di fare acquisire al lettore “un’intelligenza critica dei problemi piuttosto che apprendere tecnicismi e procedure”. L’Autore avverte, sin dall’inizio, che il proprio progetto è “assai ambizioso, probabilmente velleitario”.
Debbo subito dire che esso mi sembra pienamente riuscito, perché, come si vedrà, l’agile volumetto consente ad ogni uomo di media cultura di “entrare” nei valori e nei difficili equilibri del processo penale, attraverso una chiara e sempre argomentata esposizione dei principali aspetti problematici che esso oggi presenta.
2. Al risultato Giostra è pervenuto attraverso, innanzi tutto, una sapiente selezione degli argomenti da trattare, che gli ha consentito di limitarsi ad indicare i punti fondamentali della materia. In ciò egli è stato facilitato dalla opportuna
decisione di riservare ad un “glossario” finale la spiegazione dei più frequenti termini tecnici e di qualche dettaglio della disciplina codicistica.
Felice è già il titolo della Lezione: l’Autore considera il funzionamento della giustizia penale, e non solo lo studio teorico del diritto processuale. D’altro canto il processo è il momento necessario per l’applicazione della norma penale sostanziale, che diventa operativa soltanto attraverso l’attività giudiziale (nulla poena sine iudicio).
Dettata da chiarezza sistematica è la costruzione della Lezione, che si sviluppa in quattro capitoli ed in un epilogo breve, ma molto significativo.
Il primo capitolo concerne la giustizia quale funzione universale (“compito impossibile” – quello della ricerca della verità -‐ ma “necessario”) ed i limiti che a questa ricerca non possono non accompagnarsi: limiti “valoriali” a tutela dei diritti fondamentali dell’individuo e limiti “epistemologici”, a garanzia dell’attendibilità dell’accertamento probatorio. Già nello sguardo generale sul tema, Giostra esprime la sua idea di fondo: “la collettività deve poter ‘vedere’ come viene amministrata la giustizia in suo nome”, idea che, per il nostro Paese, si ricollega esplicitamente alla prima disposizione costituzionale sulla giurisdizione (art.101, primo comma). Ma, per potere “vedere” come funziona la giustizia, superandosi, se del caso, anche lo “specchio deformante dei media”, è necessario che ci si attrezzi mediante la conoscenza delle “strutture portanti” del processo penale italiano.
L’illustrazione che ne fa Giostra avviene in due momenti, la cui distinzione è di enorme aiuto per il lettore. In un primo tempo (secondo capitolo) il panorama del processo penale è guardato dall’alto, come da un “drone”, e cioè dalla Costituzione. Viene previamente tracciata una rapida storia del processo penale, dal codice fascista del 1930 all’entrata in vigore della Legge fondamentale della Repubblica, alla successiva lunga stagione del “garantismo inquisitorio”, che mirava a conciliare la vecchia normativa con i valori culturali della Costituzione (i quali ne sono antagonistici, ma non delineano un determinato modello processuale), sino alla “svolta” del codice del 1989 per il contraddittorio nella formazione della prova (e non soltanto sulla prova già formata). Questa “scelta epistemologica rivoluzionaria” determinò resistenze politiche e difficoltà tecniche, che dettero origine a discussi orientamenti della Corte costituzionale, la quale, affermando un inaspettato “principio di non dispersione delle prove”, mise in discussione la detta scelta. Alla fine di “una via crucis culturale durata esattamente un decennio”, si giunse, nel 1999, alla “riscrittura” dell’art.111 della Costituzione, che oggi, a differenza delle pure essenziali garanzie previste dal testo originario della Costituzione, individua, nei primi cinque commi, un preciso modello processuale.
All’illustrazione di questo modello sono dedicate approfondite considerazioni che si confrontano, con sincerità e chiarezza di posizioni, con la realtà attuale. L’esigenza insopprimibile del “giudice terzo ed imparziale” induce l’Autore ad affrontare il nodo delicato del rapporto tra la giurisdizione e la politica, esprimendo l’opinione che le due attività “hanno statuti metodologici opposti”. Una opinione che personalmente condivido pienamente e che sono solito esprimere come differenza di vocazioni tra chi è attirato dal compiere una attività che lo deve porre “super partes” (nella realtà e anche nelle apparenze) e chi invece, anche animato da intenti non meno commendevoli di rendere un servizio benefico per la collettività, sente il bisogno di entrare nella competizione politica, assumendo inevitabilmente la posizione (almeno apparente) di una delle “parti” in campo e di tutela degli interessi di cui essa è portatrice. Anche il principio di parità delle parti – altro elemento “nucleare” del giusto processo configurato dalla Costituzione – è analizzato con concretezza, perché esso deve tenere conto della “ineliminabile asimmetria” esistente nelle indagini preliminari, in cui il pubblico ministero “deve avere mezzi e tempi per rimontare lo svantaggio conoscitivo”, giovandosi anche di un eliminabile “effetto sorpresa” (esigenza, invece, ignorata dall’ultimo comma dell’art.68 Cost., che richiede la preventiva autorizzazione pubblica della Camera per intercettare un parlamentare); da qui la difficoltà per il legislatore di “costruire un sistema in cui l’accusa e la difesa abbiano equivalenti opportunità di influire sul convincimento giudiziale”. Il principio di parità delle parti trova piena attuazione nella necessità del contraddittorio nella formazione della prova, sul cui significato epistemologico e valore politico-‐culturale Giostra scrive riflessioni, aperte anche alla incidenza della psicologia cognitiva, che vanno ben al di là di una prima lezione. Valore tassativo hanno, conseguentemente, le tre eccezioni al contraddittorio previste nel quinto comma dell’art.111, che vengono analizzate in modo approfondito.
Sulla base di questa scelta metodologica effettuata dal codice e ribadita dalla riforma costituzionale, si prendono in esame (nel terzo capitolo) “le strutture portanti” del processo, quali indicate dal codice nelle varie fasi (indagini, udienza preliminare, giudizio di primo grado e di impugnazione), con cenni sulle deroghe presenti nei procedimenti speciali. È la parte più ampia del volume (circa 80 delle 200 pagine che lo compongono), che non può essere qui ripercorsa. Va, però, segnalata l’originalità della trattazione della materia processuale, che rinunzia ad una esposizione analitica della disciplina degli istituti, per soffermarsi solo sui suoi snodi fondamentali, esponendo e valutando le ragioni delle scelte legislative, nonché le possibili alternative. Si tratta di un metodo necessario per fare comprendere al lettore come sia necessario e difficile adottare, a livello legislativo, soluzioni equilibrate che contemperino interessi diversi e, spesso, contrastanti: la segretezza della prima fase
delle indagini dell’accusa e la tutela del diritto di difesa; la dialettica delle parti ed i poteri officiosi del giudice dibattimentale; la “solida roccia” della res iudicata, ma anche la necessità di superare il giudicato “ingiusto”.
Originale è l’aggiunta del quarto capitolo, dedicato alla “narrazione della giustizia penale”. Qui si riprende il discorso del capitolo iniziale sulla “relazione osmotica” tra i fatti criminali ed i media e si approfondisce il tema della cronaca giudiziaria. Il capitolo merita particolare attenzione perché proviene da uno studioso che ha dedicato molte energie all’analisi dei rapporti tra processo penale ed informazione, sin dalla ampia monografia del 1989 che studiò la tematica sia nel codice del 1930 che in quello del 1988. Giostra ritiene non ancora raggiunto un soddisfacente punto di equilibrio tra le compresenti esigenze della informazione, della giustizia e della riservatezza individuale, e sostiene che i limiti al diritto di cronaca giudiziaria “peccano per eccesso e per difetto”.
Non ostante queste ed altre inadeguatezze della nostra giustizia penale, Giostra conclude la sua fatica con l’affermazione che essa, pur essendo “imperfetta”, è “da difendere”, ma richiamando la sua posizione sulla necessità “che la magistratura rifugga da ogni commistione tra due funzioni agli antipodi quali sono quella giurisdizionale e quella politica”.
3. Le opinioni magistralmente espresse dall’Autore rivelano, oltre che la preparazione di colui che ha dedicato la vita agli studi sul processo penale, contribuendo anche alla redazione del codice vigente, non facili posizioni di equilibrio in una materia spesso contrassegnata da estremismi astratti ed utopici. Con queste posizioni la mia esperienza di magistrato si è ritrovata, per lo più, in sintonia.
Un solo dissenso avverto il bisogno di non tacere. Esso riguarda l’ammissibilità del c.d. abuso del processo (meglio si dovrebbe dire: di un diritto processuale) che la giurisprudenza della Cassazione ha ritenuto configurabile nella condotta processuale dell’imputato “volta ad ottenere non garanzie effettive ovvero migliori possibilità di difesa, ma esclusivamente la paralisi della funzione processuale” (così, di recente, Cass., sez. VI, ordinanza 5 marzo 2018, n.11414).
L’ammissibilità della figura, analoga a quella (non contestata) dell’abuso di un diritto sostanziale, è stata inizialmente affermata da un collegio delle Sezioni unite da me presieduto (sentenza 29 settembre 2011, n.155/2012). La sentenza ha incontrato critiche nella dottrina, alle quali aderisce anche Giostra, che pure giudica apprezzabile l’intento dell’orientamento giurisprudenziale di evitare un abuso delle garanzie
difensive (ma l’abuso può verificarsi anche in condotte processuali del pubblico ministero). Egli, però, ritiene che “spetta al legislatore predisporre gli accorgimenti dissuasivi per evitare simili strumentalizzazioni” (p.13; v. anche, a p.78, l’affermazione secondo cui “è il legislatore che deve sbarrare la strada agli abusi”).
Mi limito, in questa sede, a due osservazioni sulla tesi dell’illustre Maestro. La prima è che le tecniche e gli strumenti abusivi dei diritti conferiti dalla legge sono difficilmente immaginabili in astratto, onde appare poco realistico ipotizzare che il legislatore possa prevederli e vietarli in concreto. È utile tenere presente che il legislatore del codice vigente si pose il problema se tipizzare i provvedimenti giudiziari “abnormi” che, come è pacifico (sin dal vecchio codice), legittimano alla proposizione del ricorso per cassazione, pur nel silenzio della legge ed in deroga al principio espressamente da essa posto della tassatività delle impugnazioni. Risulta dai lavori preparatori del codice che si rinunziò alla tipizzazione per la sua “rilevante difficoltà”, continuandosi ad affidare alla giurisprudenza l’individuazione delle caratteristiche del provvedimento abnorme perché “non inquadrabile nel sistema processuale o adottato a fini diversi da quelli previsti dall’ordinamento”. La fiducia del legislatore nella giurisprudenza non mi pare che sia stata mal riposta, pure se vanno registrate difficoltà ed incertezze nella individuazione del provvedimento abnorme. Ma nessuno contesta la necessità, per l’equilibrata funzionalità del processo penale, di questa figura di creazione giurisprudenziale.
La seconda osservazione consiste nel richiamo della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che, nell’art. 35, comma 3, lettera a), attribuisce alla Corte di Strasburgo il potere di dichiarare “irricevibile” il ricorso individuale che sia da essa ritenuto “abusivo”. La previsione normativa non prevede alcuna precisazione sugli elementi che concretizzano il ricorso abusivo, il cui accertamento è pertanto rimesso esclusivamente all’organo giudicante. Non è facile sostenere che la disciplina dei giudizi davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo configuri un processo che preveda violazioni dei diritti delle parti, e sia perciò non “giusto”.
4. La lettura della Lezione è consigliabile a più categorie di persone. Innanzitutto ai destinatari normali della collana, a coloro cioè che, accingendosi allo studio di una nuova materia, ne apprendono, in una prima lezione, i rudimenti. E la scrittura di Giostra si rivela quanto mai felice allo scopo, per la sua chiarezza ed anche per il ricorso frequente ad immagini attraenti; per limitarci ad un paio di esempi: il processo penale come “un ponte tibetano malfermo, fragile, dal costrutto contorto, insopportabilmente lungo”; le regole processuali come “un guardrail metodologico”
per il magistrato. Consegnerei il volumetto a tutti gli studenti che iniziano a preparare l’esame di diritto processuale penale perché esso è idoneo a fornire le chiavi essenziali per affrontare i tanti e piuttosto noiosi dettagli della disciplina, nonché a suscitare probabilmente l’entusiasmo derivante dalla percezione di studiare una materia di così elevato rilievo pubblico.
La lezione è utile anche a tutti coloro che, senza intenti di studio, sono interessati a comprendere meglio i meccanismi processuali che tanto frequentemente occupano le cronache quotidiane, al fine di conseguire la capacità di farsi un loro convincimento che non sia solo il frutto di condizionamenti mediatici. Si comprende che, quanto più diffusa è questa capacità, tanto più si consolida la maturità democratica della nostra collettività.
Ma il libro parla anche, se non soprattutto, agli operatori quotidiani della giustizia, sollecitandoli a riflettere sui valori e sugli equilibri che sono essenziali nella loro attività processuale.
In conclusione, mi sembra che la Lezione colmi un vuoto nella pubblicistica italiana sul processo penale, in cui mancava uno strumento agile e semplice di formazione che può rivelarsi utile ad una così ampia categoria di destinatari.

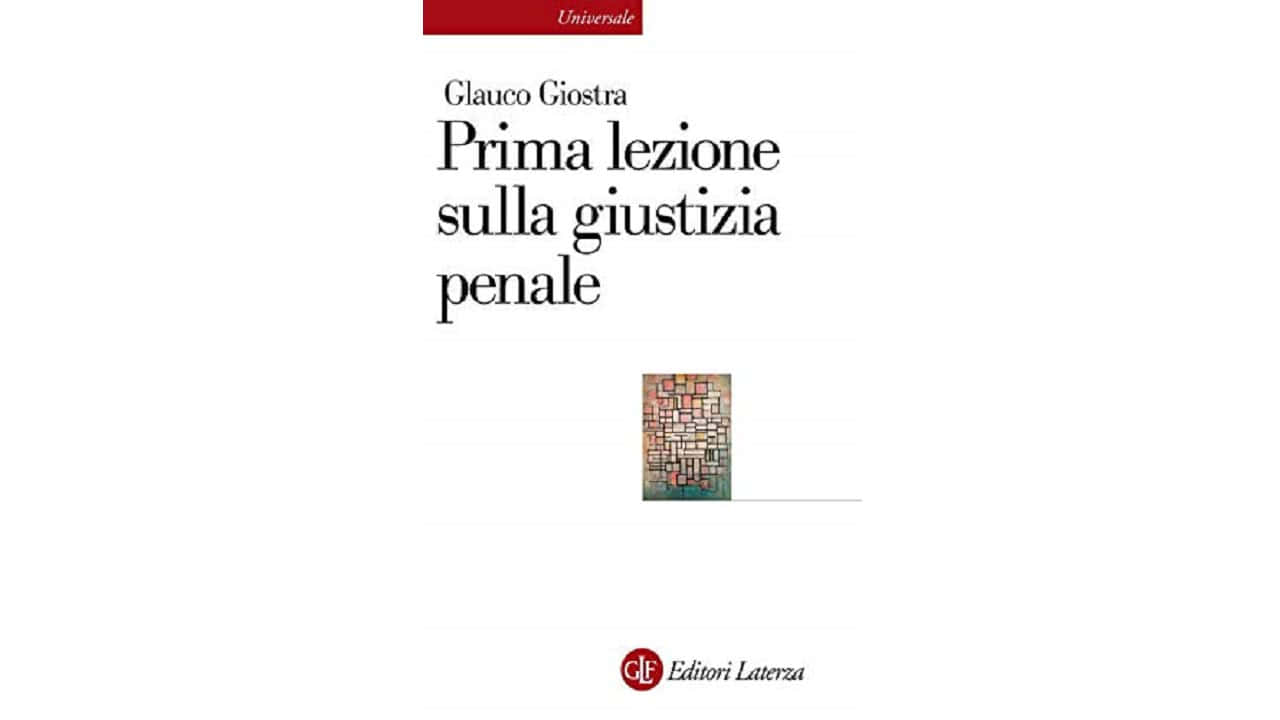

 E poi Aggiungi alla schermata principale.
E poi Aggiungi alla schermata principale.