- Armando Spataro
- Giustizia e Comunicazione
- Visite: 3724
Commento al Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 188 di Armando Spataro
Commento al Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 188 (Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali)[1] [2] di Armando Spataro
Le modalità di pubblica comunicazione dei magistrati hanno dato luogo a frequenti critiche secondo cui essi parlerebbero per rafforzare il peso dell’accusa o la propria immagine, nonostante il dovere di riservatezza cui sono tenuti. Si tratta di accuse quasi sempre infondate, ma che traggono spunto da innegabili criticità: basti pensare alla prassi delle conferenze stampa teatrali e dei comunicati stampa per proclami, o all’autocelebrazione della proprie inchieste. Il dovere di informare è naturalmente irrinunciabile, purchè esercitato nei limiti della legge, del rispetto della privacy e delle regole deontologiche, ma è anche necessario che i magistrati si guardino bene dal contribuire a rafforzare un’ormai evidente degenerazione informativa, di cui non sono ovviamente gli unici responsabili ed alla quale contribuiscono spesso anche appartenenti alle categorie degli avvocati, dei politici e degli stessi giornalisti che spesso producono informazioni sulla giustizia prive di approfondimento e di verifiche. I contenuti del D. Lgs. n. 188/2022 sono pertanto sostanzialmente condivisibili, pur se riguardano solo le Pubbliche Autorità. Ma è anche necessaria, per venir fuori da questo preoccupante labirinto, una riflessione diffusa che coinvolga tutte le categorie interessate .
sommario: 1.Premessa. - 2. Il contenuto delle previsioni introdotte con il D. Lgs. N. 188/2022 (2.a: art. 2; 2.b: art.3; 2,c: art.4; 2.d: art. 5) - 3. Gli altri protagonisti della comunicazione relativa alla giustizia. - 3.a. Avvocati e Informazione - 3.b I politici che strumentalizzano l’informazione sulla giustizia. - 3.c . I giornalisti che producono l’informazione sulla giustizia. - 4. La necessità di una riflessione comune su informazione e giustizia tra magistrati, avvocati e giornalisti. - 5. Cenni sull’ Allegato seguente
Allegato: I criteri direttivi della Procura di Torino dell’8 ottobre 2018 che hanno anticipato varie disposizioni del D.Lgs. n. 188/221.
1.Premessa
Il corretto rapporto tra giustizia ed informazione-comunicazione è oggi uno dei pilastri su cui si fonda la credibilità dell’amministrare giustizia. All’opposto, la comunicazione scorretta ed impropria genera tra i cittadini errate aspettative e distorte visioni della giustizia, in sostanza disinformazione, così determinando ragioni di sfiducia nei confronti della magistratura e conseguente perdita della sua credibilità .
Non è per caso che il Consiglio Superiore della Magistratura abbia emanato nella seduta dell’11 luglio 2018 le Linee Guida per l’organizzazione degli Uffici Giudiziari “ai fini di una corretta comunicazione istituzionale”, quale espressione della necessità di trasparenza, controllo sociale e comprensione - da parte dei cittadini - della giustizia intesa come servizio, come funzione, come istituzione.
Del resto, come è stato osservato[3], il magistrato non è più, in sé, simbolo di prestigio sociale e, tanto meno, di autorevolezza, fiducia, credibilità. La percezione sociale del magistrato e della giustizia – e dunque la maggiore o minore fiducia, il maggiore o minore rispetto, la maggiore o minore credibilità - si nutre sempre di più anche del “costume giudiziario”, ovvero di come i magistrati si pongono, parlano, scrivono, si comportano, e si relazionano con le parti del processo e con il pubblico.
Va precisato, però, che quelle di vari magistrati non sono certo le uniche criticità che ormai si manifestano sul terreno dei rapporti tra giustizia ed informazione: intendo riferirmi, anche in questo caso evitando rischi di ingiuste generalizzazioni, a certi atteggiamenti che sono propri di forze di polizia giudiziaria, di avvocati, politici e di giornalisti. Se ne parlerà appresso.
Si può comprendere, pertanto, come l’approvazione del decreto legislativo n.188/ 2021 (in intestazione precisato) abbia determinato sin dalla fase di sua gestazione divisioni nei commenti, soprattutto, di magistrati (in particolare di quelli che delle conferenze stampa e delle pubbliche dichiarazioni sulle inchieste da loro condotte fanno o hanno fatto un uso inaccettabile durante le rispettive carriere) e giornalisti (specie quelli abituati a cercare e sfruttare canali privilegiati di accesso alle informazioni riservate).
Da appartenenti ad entrambe le categorie si è parlato di un inaccettabile bavaglio che con il provvedimento in questione si vorrebbe imporre a magistrati e giornalisti limitando l’informazione sui procedimenti penali, senza considerare che in discussione sono invece gli eccessi delle modalità informative allorchè, in contrasto anche con la Direttiva UE 2016/343, vanno a ledere i diritti di indagati ed imputati.
Ovviamente vi sono stati anche commenti critici di avvocati e politici, i quali, però, hanno auspicato soprattutto una ulteriore restrizione – francamente impensabile - dei contenuti delle pubbliche dichiarazioni dei magistrati sulle inchieste penali.
Il problema dei limiti da rispettare nelle modalità comunicative in tema di giustizia è comunque reale, poiché non si può ovviamente accettare alcuna forma di censura sulla diffusione di notizie di pubblico interesse per i cittadini, salvo scatenare un “mercato nero”[4] di tali notizie.
2. Il contenuto delle previsioni introdotte con il D. Lgs. N. 188/2022
E’ allora utile, a questo punto, passare all’esame delle previsioni contenute nel decreto legislativo in questione (tralasciando l’ormai abituale “clausola di invarianza”, qui inserita nell’art.6), però con una premessa: in questo intervento non saranno approfonditi gli importanti temi giuridici che derivano dalla direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, citate nell’art. 1 del D. Lgs. 188/2021 (quale “Oggetto” e fine del provvedimento), concernenti il rafforzamento di alcuni aspetti della “presunzione di innocenza”, oggetto anche della giurisprudenza della Corte Edu. Le nuove norme saranno piuttosto oggetto di commenti che chi scrive formulerà alla luce della propria esperienza professionale di pubblico ministero, maturata per tutto l’arco della propria carriera, salvo una pausa quadriennale di esercizio delle funzioni di componente eletto del CSM (1998-2002).
A tal fine saranno comunque di seguito riprodotti i testi delle norme oggetto di commento
2.a - L’art. 2 del D. Lgs. 188/2021 (Dichiarazioni di autorità pubbliche sulla colpevolezza delle persone fisiche sottoposte a procedimento penale) prevede quanto segue:
1.È fatto divieto alle autorità pubbliche di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l'imputato fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.
2. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1, ferma l'applicazione delle eventuali sanzioni penali e disciplinari, nonchè l'obbligo di risarcimento del danno, l'interessato ha diritto di richiedere all'autorità pubblica la rettifica della dichiarazione resa.
3. Quando ritiene fondata la richiesta, l'autorità che ha reso la dichiarazione procede alla rettifica immediatamente e, comunque, non oltre quarantotto ore dalla ricezione della richiesta, dandone avviso all'interessato.
4. L'autorità che ha reso la dichiarazione è tenuta a rendere pubblica la rettifica con le medesime modalità della dichiarazione oppure, se ciò non è possibile, con modalità idonee a garantire il medesimo rilievo e grado di diffusione della dichiarazione oggetto di rettifica.
5. Quando l'istanza di rettifica non è accolta, ovvero quando la rettifica non rispetta le disposizioni di cui al comma 4, l'interessato può chiedere al tribunale, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione della rettifica secondo le modalità di cui al comma 4.
Le previsioni dell’art. 2 appaiono corrette in quanto, al di là delle modalità di comunicazione di cui si dirà appresso, sono ispirate dall’elementare principio di “presunzione di innocenza”, peraltro espressione che ha finito anche per denominare il D. Lgs. 188/2021 nel dibattito pubblico che lo ha riguardato.
La norma ovviamente rispetta quanto previsto nella direttiva (UE) 2016/343 e si riferisce al dovere delle pubbliche autorità (dunque, non solo dell’Autorità Giudiziaria ma, ad es., anche di Ministri: non possono dimenticarsi, a tal proposito, le premature esternazioni in ordine ad una delicata inchiesta del Ministro dell’Interno Salvini che, alla fine del 2018, determinarono contrasti con la Procura di Torino) di non forzare, fino alla decisione definitiva, il modo di presentare alla pubblica opinione gli indagati o imputati anche nel caso in cui le stesse autorità siano pervenute a precisi convincimenti presenti nei provvedimenti emessi nel corso delle varie fasi processuali.
Personalmente, pur dando per scontati vizi e pessime abitudini di cui si parlerà, non credo affatto che sia diffusa tra i pm la convinzione che, incrementando il rilievo mediatico delle proprie inchieste e presentandoli come colpevoli dei reati loro ascritti, sia possibile far crescere le probabilità di ottenere la condanna degli imputati, specie in processi complessi.
Ma è giusto che si preveda un divieto legislativo in materia, così come è giusto prevedere una procedura di rimedio – in caso di violazione del divieto stesso – attivabile dall’interessato il quale potrà richiedere la rettifica della comunicazione, che dovrà intervenire "immediatamente e, comunque, non oltre quarantotto ore dalla ricezione della richiesta", venendo resa pubblica "con le medesime modalità della dichiarazione" o comunque con "modalità idonee", pur se nulla si dice sul connesso dovere di provvedervi da parte degli organi di informazione. In caso di diniego, invece, l'interessato potrà sempre rivolgersi al tribunale in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c. .
La norma evoca anche, in caso di violazione del divieto, oltre al risarcimento del danno, l'applicazione delle eventuali sanzioni penali e disciplinari. A tale ultimo proposito, vanno ricordato le previsioni di cui alle lettere “u”, “v” ed “aa” dell’ art. 2, comma 1 del D. L.vo 109/2006, secondo cui:
1. 1. Costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni:
u) la divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui;
v) pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui nonché la violazione del divieto di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 (2);
aa) il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero il costituire e l'utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati.
Dunque, se le previsioni dell’art. 2 del D. Lg.s. 188/2021 non riguardano le tecniche di redazione dei provvedimenti giudiziari, quanto i confini lessicali imposti alla loro redazione, è giusto che venga ricordato il doveroso contrasto sul piano disciplinare di diffuse propensioni dei magistrati ad accrescere, per quelle vie, la popolarità della propria immagine.
Se infatti l’informazione serve ai cittadini, essa va data con misura e quando lo sviluppo delle indagini lo consente, con connesso dovere dei dirigenti di assicurare che essa avvenga in forma corretta per fatti di pubblico rilievo, specie quanto i fatti sono oggetto di indagine e non ancora di una sentenza, sia pure di primo grado. Per i dirigenti degli Uffici Giudiziari, in particolare per i Procuratori della Repubblica, esiste anche il dovere di intervenire per correggere, anche di propria iniziativa e senza istanza degli interessati, imprecisioni e fake news: serve farlo con misura e precisione per evitarne l’enfatizzazione, così come per far fronte al rischio di “pregiudizio alle indagini, e per la dovuta attenzione ai diritti delle persone coinvolte (tra cui quello di non essere presentato alla pubblica opinione come colpevole di reati), all’immagine di imparzialità e correttezza del singolo magistrato, dell’ufficio giudiziario e, nei casi più gravi” della stessa funzione giudiziaria”[5]
Per chiudere sull’art. 2, si potrebbe ipotizzare la non applicabilità del divieto di cui al co. 1, nel caso di indagato arrestato in flagranza di reato e/o immediatamente reo-confesso: ma anche in questo caso, ove sussista un interesse pubblico alla notizia, il comunicato stampa potrebbe dare atto delle modalità dell’arresto e di altre circostanze non coperte dal segreto investigativo, ma non potrebbe parlare di un “colpevole” prima della sentenza definitiva, tra l’altro essendo possibile anche in quei casi, come è noto, il riconoscimento di avere agito per legittima difesa o in presenza di altre circostanze che rendono non punibile l’autore del fatto.
2.b - L’art. 3 del D. Lgs. 188/2021 (Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 ) prevede quanto segue:
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola «informazione», sono inserite le seguenti: «, esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa. La determinazione di procedere a conferenza stampa è assunta con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. La diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico. Le informazioni sui procedimenti in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.»;
c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Nei casi di cui al comma 2-bis, il procuratore della Repubblica può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire, tramite comunicati ufficiali oppure tramite conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato. L'autorizzazione è rilasciata con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 3.
3-ter. Nei comunicati e nelle conferenze stampa di cui ai commi 1 e 3-bis è fatto divieto di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza.».
2. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopo la parola «preposti,», sono inserite le seguenti: «oltre che dei doveri di cui all'articolo 5,».
Leggendo la lett. a), può dunque dedursi che l’informazione corretta non è quella delle conferenze stampa teatrali e dei comunicati stampa per proclami che ben abbiamo conosciuto in questi ultimi decenni, ma quella comunque sobria in presenza di due condizioni, cioè possibile quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o quando ricorrono altre specifiche ragioni di ordine pubblico. Disposizione valida anche quando il Procuratore autorizzi gli ufficiali di p.g. a fornire l’informazione.
Proprio in tale prospettiva, mi permetto subito un riferimento personale: per il periodo in cui ho diretto la Procura della Repubblica di Torino, cioè dalla fine del mese di giugno del 2014 a metà del dicembre 2018, ho tenuto solo tre conferenze stampa: la prima per denunciare pubblicamente, insieme agli Avvocati (da me invitati a parteciparvi), il grave deficit di personale amministrativo dell’Ufficio; la seconda per illustrare i risultati ostensibili delle indagini sui gravi fatti verificatisi in Torino, in Piazza San Carlo, il 3 giugno 2017 (che avevano scosso l’intera città) e l’ultima per presentare pubblicamente le direttive emesse il 9 luglio 2018 in tema di priorità da accordare alla trattazione dei reati connotati da odio razziale ed al fine di velocizzare le procedure relative ai ricorsi avverso il rigetto delle richieste di protezione internazionale (argomenti, cioè, che richiamavano attualità e diritti fondamentali delle persone). Nel lungo periodo precedente di servizio alla Procura di Milano, ho partecipato solo ad altre due conferenze: la prima nel 1988, insieme al collega Pomarici, in occasione della scoperta dell’ultimo “covo” della Brigate Rosse a Milano che segnò la fine degli “anni di piombo” (fu peraltro una conferenza tenuta dai Carabinieri cui noi, che l’avevamo autorizzata, assistemmo quasi silenti) ed un’altra di cui mi sono pentito, in epoca più recente.
Sarà chiaro, dunque, che non apprezzo in alcun modo la pratica delle conferenze stampa che vedono appartenenti alle forze di polizia schierati in divisa al fianco dei magistrati o dietro di loro. Sono preferibili comunicati stampa sobri ed essenziali che hanno il pregio di diffondere parole e notizie precise, senza possibilità di interpretazioni forzate, come accade con i “racconti” a voce.
Quanto ai comunicati ed alle conferenze stampa, è però inaccettabile la prassi di quei pubblici ministeri che, presentando pubblicamente le proprie indagini, usano lanciare veri e propri proclami del tipo “si tratta della più importante indagine antimafia del secolo” o “finalmente abbiamo scoperto la mafia al Nord”, così proponendosi come icone - categoria purtroppo in espansione - per le piazze plaudenti. Per non parlare della logica sottesa alla esaltazione di certi presunti misteri in relazione ai quali certi magistrati spesso richiamano responsabilità di imprecisate entità esterne e dei soliti “poteri forti”, senza nome e senza volto, così rinforzando il motto che i giornalisti inglesi usano per stigmatizzare quei loro colleghi che rifiutano di accertare/accettare il reale andamento dei fatti pur di non indebolire le loro fantasiose ipotesi: «Non permettere ai fatti di rovinare una bella storia!».
Recentemente, sono stati anche diffusi comunicati in forma non condivisibile: troppo lunghi nel testo e perfino contenenti, da un lato, brani oggetto di conversazioni registrate durante le indagini preliminari, dall’altro spunti critici verso giudici o avvocati, oppure affermazioni apodittiche quasi che le tesi dei pm esposte nei comunicati rappresentino la verità inconfutabile, definitivamente accertata, insomma un anticipo di sentenza. Niente di più lontano, insomma, dal senso del limite e dall’etica del dubbio cui devono conformarsi le parole di un pubblico ministero prima della decisione del giudice.
I comunicati stampa, invece, oltre a dover essere ovviamente chiari, sintetici ed efficaci, non possono che riguardare informazioni di effettivo interesse pubblico e contenere brevi riferimenti alla natura dei reati per cui si procede, alla provvisorietà delle valutazioni del giudice (oltre che del PM) sulle responsabilità delle persone sottoposte a misura cautelare, evitando citazione di nomi e diffusione di fotografie o comunicazione di dati sensibili almeno ove tali nomi ed immagini non siano noti per altri fatti oggettivi (ad es., arresti in flagranza o diffusione di notizie, come è avvenuto, da parte degli stessi indagati).
Particolare attenzione va riservata alla necessità di evitare in qualsiasi modo che notizie segrete o comunque riservate possano essere anche indirettamente propalate o intuite: i danni alle indagini sono in questi casi evidenti e finiscono con il legittimare le accuse sistematicamente rivolte ai magistrati – in quanto detentori delle notizie – di determinarne le cd. “fughe”.
E’ doveroso anche (come previsto nella lett. “c” dell’art. 3 prima riportato) che i Pubblici Ministeri, anche per dare ulteriore concretezza al principio della direzione della Polizia Giudiziaria che la Costituzione ed il Codice di rito loro attribuiscono, debbano sempre ricevere preventivamente dai vertici dei presidi di polizia giudiziaria operanti nel circondario o, a seconda delle competenza, nel Distretto, i comunicati stampa che essi intendono diffondere in ordine a rilevanti indagini effettuate e, in caso di necessità, sottoporli alle valutazioni del Procuratore. Tale prassi è utile anche per pervenire a contenuti, modalità e tempi della diffusione della notizie di interesse pubblico improntati anche al rispetto dei diritti e delle garanzie spettanti agli indagati per qualsiasi reato.
In sostanza, vanno evitati eccessi comunicativi anche della polizia giudiziaria (spesso dovuti al fine di acquisire titoli utili per la progressione in carriera, mediante visibilità e impatto mediatico delle proprie attività) o anticipate diffusioni di notizie che possono determinare il rischio di pregiudicare il buon esito delle operazioni. Queste, infatti, non si esauriscono nel momento dell’arresto di un ricercato o dell’avvenuta effettuazione di controlli e perquisizioni: talvolta, ad es., l’arrestato può chiedere di essere interrogato ed occorre che il PM vi provveda subito se l’atto si presenta utile. Altre volte il materiale sequestrato può determinare ulteriori urgenti attività. E gli esempi potrebbero continuare. E’ importante, dunque, che PM, Polizia Giudiziaria e vertici delle strutture operanti condividano la cultura della informazione appropriata per contenuto e tempistica, che può persino essere frutto di oculata elaborazione di strategie investigative, quando, ad es., si diffonde ad hoc una specifica notizia perché ciò può determinare utili ed importanti sviluppi.
Sia permesso riportare di seguito la parte concernente questo tema che figura nei Criteri organizzativi della Procura di Torino dell’8 ottobre del 2018 (pag. 221), principio già dettato in precedenza (con analoghe direttive del 23.6.2015) e che la Polizia Giudiziaria del Circondario ha condiviso e sempre rispettato:
Pag. 221 dei Criteri Organizzativi dell’8 ottobre 2018
Direttive per i magistrati dell’Ufficio, con particolare riferimento ai rapporti con la Polizia Giudiziaria
Sempre per quanto riguarda la direzione delle indagini, i Pubblici ministeri dovranno raccomandare alla polizia giudiziaria, ogniqualvolta ciò risulti utile o necessario, quanto segue:
…omissis…
- evitare, specie in caso di indagini delicate, conferenze e comunicati stampa relativi ad attività di polizia giudiziaria, senza previo assenso del magistrato che le coordina.
Anche il contenuto dell’art. 3 del D. Lgs. 188/2021, dunque, è condiviso da chi scrive salvo nella parte in cui si prevede (co.1, lett. “a”) che, al comma 1 del D. lgs. 20 febbraio 2006 n. 106 (Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150) venga aggiunta la frase “La determinazione di procedere a conferenza stampa è assunta con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano”.
Si tratta francamente di una previsione di tipo burocratico, quella dell’atto motivato, che allude ad un controllo di tipo gerarchico sulle decisioni del Procuratore della Repubblica: non a caso, con l’ultimo capoverso dell’art. 3 D. Lgs. 188/2021, si prevede che “All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 (ndr.: Attività di vigilanza del procuratore generale presso la corte di appello), dopo la parola «preposti,», sono inserite le seguenti: «oltre che dei doveri di cui all'articolo 5,”. Il procuratore generale presso la corte di appello, cioè, dovrà acquisire anche dati e notizie dalle procure della Repubblica del distretto sulle conferenze stampa e sugli atti motivati con cui sono state autorizzate, ed inviarle al procuratore generale presso la Corte di cassazione con relazione almeno annuale.
Francamente troppo: non vi è bisogno di un atto scritto per motivare una conferenza stampa (salvo quando si tratti di un’autorizzazione diretta alla polizia giudiziaria): il Procuratore della Repubblica, infatti, è comunque responsabile delle decisioni adottate anche quanto alla valutazione della necessità per la prosecuzione delle indagini o delle specifiche ragioni di pubblico interesse che facciano ritenere doverose le conferenze stampa, di cui comunque può dare spiegazione nei casi e nei tempi in cui ciò gli venga richiesto.
Si dovrebbe evitare di “immettere sul mercato”, insomma, altri formalismi inutili e relativi “moduli” da cui è già gravata la vita quotidiana delle Procure, prevedendo, semmai, la redazione facoltativa di tali atti motivati.
E’ anche condivisibile il divieto (ex punto 3-ter della lett. “c”) di assegnare ai procedimenti pendenti, in comunicati e conferenze stampa, denominazioni lesive della presunzione di innocenza: un’altra pessima abitudine conosciuta per valorizzare la teatralità della comunicazione relativa a determinate indagini.
In ogni caso, ai sensi della lett. b) del co. 1 della norma, le informazioni devono far riferimento alla fase in cui si trova il processo e rispettare le prescrizioni del già citato art. 2 del D. lgs. 188/2021.
La regola non scritta rimane comunque, anche in questo caso, quella secondo cui i Procuratori, comunque, ed i loro delegati, devono adoperarsi perché sia diffusa all’interno ed all’esterno degli uffici che dirigono la consapevolezza della delicatezza e importanza della comunicazione relativa alle procedure giudiziarie, pur se – sul punto - i magistrati rimarranno sempre esposti a critiche spesso strumentali quando indagati ed imputati apparterranno alle note “categorie protette”. Molto raramente, invece, è dato rilevare critiche ad altri protagonisti di una deriva insopportabile che ormai si manifesta sul terreno dei rapporti tra giustizia ed informazione : intendo riferirmi, anche in questo caso evitando rischi di ingiuste generalizzazioni, a certi atteggiamenti che sono propri anche di avvocati, politici e perfino, se non soprattutto, di giornalisti.
Il tema in questione va comunque affrontato considerando che l’informazione sulla giustizia è certamente necessaria, rivestendo anzi la dimensione di un dovere da parte di chi deve diffonderla e di un diritto da parte di chi ne è destinatario.
2.c - L’art. 4 del D. Lgs. 188/2021 (Modifiche al codice di procedura penale) prevede quanto segue:
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 115, è inserito il seguente:
«Articolo 115-bis (Garanzia della presunzione di innocenza). -
2. Salvo quanto previsto dal comma 2, nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, la persona sottoposta a indagini o l'imputato non possono essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili. Tale disposizione non si applica agli atti del pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato.
3. Nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, che presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria limita i riferimenti alla colpevolezza della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l'adozione del provvedimento.
4.. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'interessato può, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi alla conoscenza del provvedimento, richiederne la correzione, quando è necessario per salvaguardare la presunzione di innocenza nelprocesso.
5. Sull'istanza di correzione il giudice che procede provvede, con decreto motivato, entro quarantotto ore dal suo deposito. Nel corso delle indagini preliminari è competente il giudice per le indagini preliminari. Il decreto è notificato all'interessato e alle altre parti e comunicato al pubblico ministero, i quali, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi, possono proporre opposizione al presidente del tribunale o della corte, il quale decide con decreto senza formalità di procedura. Quando l'opposizione riguarda un provvedimento emesso dal presidente del tribunale o dalla corte di appello si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36, comma
4.»;
b) all'articolo 314, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo.»;
c) all'articolo 329, comma 2, dopo le parole «Quando è», è inserita la seguente: «strettamente»;
d) all'articolo 474 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il giudice, sentite le parti, dispone con ordinanza l'impiego delle cautele di cui al comma 1. È comunque garantito il diritto dell'imputato e del difensore di consultarsi riservatamente, anche attraverso l'impiego di strumenti tecnici idonei, ove disponibili. L'ordinanza è revocata con le medesime forme quando sono cessati i motivi del provvedimento.».
Assolutamente condivisibili sono le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del nuovo art. 115 bis cpp. : la giustizia, infatti, viene comunicata quotidianamente all’esterno con anche con vari atti giudiziari destinati a diventare pubblici, quali decreti di perquisizione, avvisi di garanzia, provvedimenti cautelari, decreti penali e sentenze, ma fino al momento in cui sia emesso il provvedimento definitivo, non può essere consentito ai magistrati - specialmente se pubblici ministeri - di utilizzare tali provvedimenti per finalità diverse da quelle cui sono direttamente destinate, ad es. per rafforzare il peso dell’accusa e delle proprie convinzioni, anche indirettamente, attraverso la loro pubblicità o mediante improprie modalità di redazione.
Un esempio, certamente estremo ma significativo, può essere utile: riguarda il cd. «derby del Sud», cioè il noto scontro tra la Procura della Repubblica di Salerno e quella di Catanzaro risalente al 2008. Prescindendo dal merito e dall’esito del processo, intendo qui ricordare che il 2 e il 3 dicembre di quell’anno, il procuratore di Salerno «vistava», e due suoi sostituti firmavano, un decreto di perquisizione di oltre millecinquecento pagine nei confronti, tra gli altri, di sette magistrati di Catanzaro, compreso il procuratore generale. Costoro risultavano indagati per reati che andavano dalla corruzione in atti giudiziari all’omissione di atti d’ufficio, dal falso ideologico al favoreggiamento personale e alla corruzione.
Il decreto di perquisizione non rientra tra gli atti destinati a porre l’indagato in condizione di difendersi, ma serve solo a motivare la scelta di cercare qualcosa in un certo luogo; per questa ragione consta normalmente di poche pagine: tre o quattro al massimo. Non mi è mai capitato di firmarne uno più lungo, pur se è accaduto anche a me di condurre qualche indagine delicata. Il decreto di perquisizione emesso dai pm di Salerno venne subito pubblicato su un sito web ricevendo così ampia diffusione: vi si riproducevano pressoché integralmente dichiarazioni rese da persone informate sui fatti contenenti opinioni ed apprezzamenti personali di dubbia compatibilità con le re-gole procedurali e di ancor più dubbia pertinenza con l’oggetto dell’indagine, quali ipotesi di scarsa sensibilità istituzionale, di comportamenti omissivi e sospette relazioni formulate nei confronti di personalità politiche, componenti del Csm, un pubblico ministero della Cassazione, nonché vertici ed esponenti dell’Associazione magistrati.
Provvedimenti così costruiti presentano un altro grave limite, questa volta intrinseco, quello di far «evaporare» le responsabilità penali su cui si indaga, che così rischiano di annegare in un mare di affermazioni non pertinenti e di ipotesi indimostrate.
I commi 1 e 2 del nuovo art. 115 bis cpp, dunque, richiamano il dovere di sobrietà dell’Autorità Giudiziaria e quello di non motivare gli atti giudiziari in modo ultroneo rispetto ai fini cui sono diretti.
Comprensibili e conseguenti le previsioni di cui ai successivi commi 3 e 4 che disciplinano la procedura di correzione dei provvedimenti e di connessa autotutela degli interessati.
Le altre previsioni (lett. “b”, “c” e “d” dell’art. 4 del D. lgs. in esame) rispettivamente riguardano:
-il tema della equa riparazione in caso di assoluzione (art. 314 c.p.p.), rispetto alla quale non incide il diritto ad esercitare la facoltà di non rispondere : si tratta dell’assestamento legislativo di una questione spesso dibattuta;
-la modifica all’art. 329 co. 2 cpp (obbligo del segreto) con la possibilità per il pubblico ministero – in deroga a quanto previsto dall’art. 114 cpp in tema di divieto di pubblicazione di atti e di immagini – di consentire con decreto motivato la pubblicazione di singoli atti o parti di essi solo quando ciò è strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini (ove la novità è l’introduzione nella norma dell’avverbio “strettamente”, che – comunque – non potrà che essere oggetto di valutazione esclusiva del magistrato inquirente su cui neppure il CSM può interferire). Si tratta comunque di modifica dovuta all’esigenza di rispettare l'articolo 4, paragrafo 3, della Direttiva europea già citata;
-l’aggiunta del co. 1 bis all’art. 474 c.p.p. (“Assistenza dell’imputato all’udienza”) che meglio disciplina il diritto alla partecipazione “da libero” dell’imputato all’udienza, anche se detenuto, mediante l’impiego delle cautele di cui al comma 1 e garantendo il diritto dell’imputato e del difensore di consultarsi riservatamente, anche attraverso l’impiego di strumenti tecnici idonei, ove disponibili, certamente essenziale ai fini del pieno esercizio del diritto alla difesa. Si tratta di disciplina formale di prassi che normalmente sono da tempo già attuate nel corso delle udienze, conseguente comunque all’art. 5 della Direttiva che impone agli Stati membri di adottare «le misure appropriate per garantire che gli indagati e imputati non siano presentati come colpevoli, in tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica», consentite ove «necessarie per ragioni legate al caso di specie, in relazione alla sicurezza o al fine di impedire che gli indagati o imputati fuggano o entrino in contatto con terzi».
2.d - L’art. 5 del D. Lgs. 188/2021 (Rilevazione, analisi e trasmissione dei dati statistici) prevede quanto segue:
1. Alla rilevazione, all'analisi e alla trasmissione alla Commissione europea dei dati di cui all'articolo 11 della direttiva provvede il Ministero della giustizia.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono oggetto di rilevazione, tra gli altri, i dati relativi al numero e all'esito dei procedimenti anche disciplinari connessi alla violazione degli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto e dei procedimenti sospesi per irreperibilità dell'imputato ovvero nei confronti di imputati latitanti, nonchè dei procedimenti per rescissione del giudicato ai sensi dell'articolo 629-bis del codice di procedura penale.
Non vi è qui necessità di particolari commenti, salvo ricordare che, ai sensi dell’art. 11 della Direttiva, la trasmissione di tali dati dovrà avvenire ogni tre anni.
3. Gli altri protagonisti della comunicazione relativa alla giustizia
Si è già detto che protagonisti necessari della comunicazione relativa alla giustizia non sono solo i magistrati ma anche la polizia giudiziaria (di cui si è già parlato), gli avvocati, i politici ed i giornalisti.
Avviandomi alla conclusione di questo intervento, qualche osservazione in merito è necessaria anche per porre in evidenza il fatto che sarebbero utili interventi legislativi ulteriori o una severa applicazione dei codici etici o deontologici delle citate categorie professionali, così come dei partiti politici che ne dispongono.
La Ministra Cartabia, nel ricordare la spinta al Governo frutto della Direttiva Europea 2016/343 che sin qui non era stata attuata, ha dichiarato[6] che “oggi è cambiato il contesto: il solo fatto di una notizia di indagini…se viene immediatamente proposto sulla stampa come se si fosse già individuato l’esito di quel processo, può pregiudicare nei fatti quel principio che noi vogliamo garantire, cioè il fatto che la persona non è considerata colpevole fino alla fine della sentenza di condanna. Se posto male dal punto di vista mediatico, il processo può arrecare un danno alla reputazione...alla vita di una persona… Questo non vuol dire che non serve parlare delle indagini, ma bisogna farlo con delle nuove garanzie per preservare questo che è un caposaldo del rapporto tra il cittadino e il potere giudiziario...occorre un equilibrio diverso”.
Parole certo condivisibili, che ad avviso di chi scrive devono però intendersi riferibili alle molteplici strumentalizzazioni delle nuove modalità di comunicazione sulla giustizia addebitabili a larghi settori del mondo forense, del ceto politico e dello stesso giornalismo.
3.a. Avvocati e informazione
Ricordo quando Virginio Rognoni, da ex vice presidente del CSM, ebbe a definire virtuoso il protagonismo dei magistrati e degli avvocati civilmente impegnati a fornire corrette informazioni ai cittadini nell’interesse della amministrazione della giustizia e della sua credibilità.
Ma, così come è stato sin qui fatto per le criticità comunicative dei magistrati, non si può tacere in ordine a certi comportamenti di non pochi avvocati che sfruttano la risonanza mediatica delle inchieste in cui sono coinvolti i loro assistiti, ed anzi le amplificano.
Anche grazie a tale propensione si afferma il processo mediatico, che – maggiormente deprimente se vi partecipano magistrati – diventa spesso più importante ed efficace di quello che si celebra nelle Aule di Giustizia e della sentenza cui è finalizzato. Senonchè, come ha scritto Luigi Ferrarella[7], “su questo piano nessuno si salva, perché nel processo mediatico vince comunque il più scorretto, a prescindere dal lavoro che fa. Vince il magistrato più ambizioso o più vanitoso, come viene lamentato spesso; ma vince anche l'avvocato più aggressivo e scorretto; vince l’imputato (se mi si concede l’errore) più "eccellente", vince il poliziotto-carabiniere-finanziere meglio introdotto nel circuito mediatico ai fini della sua progressione in carriera o della sua logica di cordata interna; e vince il giornalista più spregiudicato. Con un risultato micidiale anche sul modo in cui in una collettività democratica viene amministrata la giustizia”.
Ed a ciò deve anche aggiungersi che il consenso popolare viene televisivamente ricercato da qualche avvocato anche quale mezzo per favorire la espansione della propria clientela
Inesistente, o comunque rara, è peraltro qualsiasi forma di autocritica della categoria anche rispetto a quegli avvocati che, subito dopo la pronuncia di una sentenza di condanna dei loro assistiti, anziché formulare, come è ben possibile, legittime critiche in modo pacato ed eticamente consentito, si lasciano andare a commenti delegittimanti nei confronti dei giudici che hanno emesso la sentenza e dei Pm che hanno condotto le indagini.
Senza questo tipo di atteggiamenti i talk-show non avrebbero seguito e le telecamere non avrebbero ragione di popolare le aule di giustizia, ma il prestigio e dignità della classe forense ne trarrebbero vantaggio.
3.b I politici che strumentalizzano l’informazione sulla giustizia
Non intendo qui far riferimento alle conosciute modalità di reazione a processi, condanne e assoluzioni da parte di politici a vario titolo incriminati. Il tema mi interessa poco anche perché è ovviamente prevedibile che un imputato, a qualsiasi categoria appartenente, ben difficilmente potrà essere riconoscente nei confronti di quanti lo hanno incriminato e condannato.
Mi interessa invece qualche breve cenno al comportamento di quei politici, con incarichi governativi o meno, che sono ben attenti a sfruttare le modalità di comunicazione che i tempi moderni hanno imposto: come si dirà appresso, si moltiplicano giornalisti inclini non tanto all’approfondimento della notizia dai politici propalata con insopportabile retorica, ma a determinarne comunque il massimo clamore .
Basti pensare a come, per mero scopo di supporto populista alle proprie scelte e posizioni, esponenti di rilievo di vari Governi hanno presentato ai cittadini i famosi “pacchetti sicurezza” del 2008 e del 2009, o i “decreti sicurezza” del 2018 e 2019, o a come sono stati diffusi infondati allarmi sui rischi derivanti per l’Italia dal terrorismo internazionale (notizie riguardanti inesistenti scuole di kamikaze; inesistenti progetti di attentati a seggi elettorali, alla cattedrale di Bologna, alle stazioni metropolitane; o, ancora, la massiccia presenza dell’IS a Roma, i numeri esagerati di foreign fighters espulsi, la balla del marocchino arrestato in provincia di Milano – e poi scarcerato dai Giudici - perché complice dell’attentato al Bardo di Tunisi), così come va ricordata la propalazione di pulsioni xenofobe nei confronti degli immigrati, in particolare di quanti arrivano in Italia sui barconi, tra i quali si dice – contrariamente al vero – vi sarebbero terroristi ed aspiranti kamikaze .
Insomma, negli esempi fatti, la notizia che dovrebbe informare correttamente serve in realtà ad enfatizzare il problema sicurezza, così da allarmare i cittadini ed insieme rassicurarli grazie a continui riferimenti alla capacità di chi governa di saperli tutelare attraverso apparati di intelligence e leggi sapienti. Zygmunt Bauman ci aveva già avvertito in odine al senso di questa strategia politica che serve a far passare in second’ordine – rispetto all’abusato tema della sicurezza - problemi sociali ed economici, doveri costituzionali ed incapacità di guida politica del paese. E per tutto questo, ora, basta un tweet o un sms di 160 caratteri: forse lo stesso Bauman non l’aveva immaginato!
E la stessa strategia è utilizzata nel periodo che stiamo vivendo per ogni procedimento che vede indagato o imputato un politico o un suo parente o persone a lui vicine. Il brand utilizzato continua ad essere sempre eguale: si tratta di processi frutto dell’orientamento politico dei magistrati che non rispettano la legge !
3.c . I giornalisti che producono l’informazione sulla giustizia
I giornalisti, ovviamente, dovrebbero essere gli osservanti più scrupolosi delle regole della corretta informazione. E fortunatamente molti lo sono. Ma anche per questa categoria, la modernità ha imposto “anti-regole” pericolose ed inaccettabili.
Cito un altro episodio personalmente vissuto circa trent’anni fa allorchè effettuai un lungo viaggio di studio negli Stati Uniti, trovandomi a discutere, a Chicago, con il locale Prosecutor federale, in ordine al livello di indipendenza possibile dei Procuratori designati dal Presidente degli Stati Uniti (nel sistema di giustizia federale) o eletti (nel sistema di giustizia statale). Gli chiedevo se i pubblici ministeri non fossero condizionati dalla fonte politica della loro nomina. La risposta fu “Caro collega, qui c’è la stampa!”. Non disse “..la stampa libera”. Alludeva al famoso ruolo di cane da guardia del giornalismo d’inchiesta, forse troppo citato, ma che, come è noto, ha consentito – negli Stati Uniti – di far venire alla luce scandali di portata storica.
Il giornalismo d’inchiesta, in sostanza, negli Stati Uniti e dovunque, grazie ad approfondimenti seri, documentati e soprattutto liberi, dovrebbe ricercare la verità dei fatti, come spetta al PM nelle sue indagini giudiziarie: Julian Assange e Wikileaks ne sono un altro esempio, pure nella bufera che stanno vivendo da anni.
E’ così anche in Italia? Purtroppo non è sempre così. Ho prima citato, a proposito dei politici, i vizi originati della moderna informazione, in modo particolare di quella ormai dominante (o quasi) sul web, che impone assoluta rapidità di diffusione delle notizie. Ma se ciò avviene senza approfondimenti e senza le dovute precisazioni, non è affatto una buona informazione, specie ove si pensi che, nei frequenti casi di diffusione via web di informazioni imprecise e superficiali, è molto difficile che l’indomani, i quotidiani titolari del siti web possano correggere ed ammettere l’errore.
Si sono però diffuse altre modalità poco corrette di interlocuzione ed informazione nel settore della giustizia (al quale mi limito): una parola di saluto e commento informale di un magistrato diventa intervista mai rilasciata o autorizzata, titoli in rilievo e virgolettati lasciano pensare a contenuti degli articoli ad essi conformi ed a dichiarazioni rilasciate da persona intervistata, mentre quasi mai quelle parole sono state pronunciate da alcuno e spesso i contenuti degli articoli ne smentiscono i titoli.
Parlandone con qualche autorevole giornalista amico, mi è stato risposto che quella è ormai la moderna tecnica utilizzata dai giornali per attirare l’attenzione del lettore.
E c’è molto altro: presenza di telecamere non autorizzate nei palazzi di giustizia, i cui utilizzatori sono pronti a riprendere persone che si recano negli uffici dei magistrati per essere esaminati o interrogati, con conseguente violazione della privacy; giornalisti che pretendono di dar vita a rapporti confidenziali con i magistrati per avere accesso prioritario a notizie riservate o che nelle interviste pongono domande dai toni e contenuti provocatori per generare imbarazzo negli intervistati e perché ne resti traccia nei servizi televisivi; articoli che tendono ad assecondare le peggiori pulsioni populiste dei lettori etc. . A tal proposito ricordo quando, da Procuratore Aggiunto a Milano, ebbi a ricevere nel mio ufficio un giovane giornalista che, presentandosi come nuovo addetto della sua importante testata alle cronache giudiziarie milanesi, mi rassicurò sul fatto che avrebbe mantenuto segreta la fonte di ogni notizia riservata che gli avrei passato. Mentre lo sbattevo fuori dall’ufficio, pensai che qualcuno doveva avergli detto che così si fa con i magistrati e che i magistrati lo accettano e magari lo gradiscono. E non è difficile ipotizzare che, purtroppo, ciò possa effettivamente avvenire fino a determinare l’ “abbandono” di uno dei più importanti obiettivi che le corrette modalità di comunicazione impongono, cioè quello della massima spersonalizzazione delle notizie : ciò significa, ad es., che si può ben dare informazione – nei limiti sin qui precisati – circa un’indagine di pubblico interesse, ma questa deve essere attribuita all’Ufficio e non al singolo pubblico ministero che l’ha condotta.
Sono questi i principali vizi del giornalismo moderno che si occupa della giustizia, fermo restando che non intendo spendere una sola parola sui professionisti disonesti. Ce ne sono infatti anche tra magistrati, avvocati e politici e non vi è necessità di alcun commento in proposito. Onore, invece, ai tanti giornalisti che fanno il loro dovere con assoluta professionalità e correttezza, senza sconti per alcuno. Ed onore a coloro che, in ogni parte del mondo, sono morti o sono stati perseguitati nell’adempimento del loro dovere.
Il mio sogno è di vedere il nostro mondo della giustizia popolato da giornalisti “factcheckers” che, anziché cercare documenti in modo scorretto, provvedano ad eventualmente richiederli con formali istanze. A tal proposito, mi permetto di citare ancora una volta disposizioni e prassi esistenti presso la Procura di Torino (ma anche presso altre Procure come quella di Napoli), ove, in base a direttive specifiche, anche giornalisti ed altre persone interessate possono proporre istanza ai sensi dell’art. 116 c.p.p.[8] di accesso agli atti e di eventuale rilascio di copie, illustrando il loro interesse e la relativa rilevanza.
Meglio ancora sarebbe, come da anni proposto da Luigi Ferrarella, disciplinare legislativamente il loro accesso agli atti, per evitare dipendenza da fonti portatrici di interesse e per esaltare la libertà e professionalità dei giornalisti.
Lo stesso giornalista, noto per la qualità delle sue osservazioni, ha posto in evidenza[9] quelle che a suo parere sono le criticità del D. lgs. N. 188/2021, che potrebbe amplificare il “mercato nero della notizia…propellente del processo mediatico”. Nel ricordare che le nuove norme non intervengono sul lavoro del giornalista (come sarebbe stato meglio: ndr) e che i guasti nel sistema di informazione sulla giustizia sono dovuti alle scomposte vanterie di magistrati e forze dell’ordine, si dichiara contrario alla stretta delle conferenze stampa che consentirebbe al giornalista scrupoloso di verificare una notizia non più coperta dal segreto di Stato. I giornalisti, conseguentemente, saranno spinti a coltivare nell’ombra rapporti per forza di cose opachi con le varie fonti negate, magari interessate a fornire solo frammenti di notizie. Ferrarella, inoltre, denuncia il rischio insito nel riconoscimento della competenza unicamente in capo ai dirigenti delle Procure della valutazione di cosa sia o non sia di “interesse pubblico” (con la prevedibile accusa di fare politica attraverso tali scelte), compito che invece – alla luce della giurisprudenza della Corte Edu – spetterebbe proprio ai giornalisti.
Certamente osservazioni come queste, specie se provenienti da una fonte così autorevole, devono far riflettere, ma è mia opinione che esse riguardino possibili criticità nell’applicazione delle norme sin qui citate, piuttosto che aspetti negativi dei loro contenuti. Vi è sempre il rischio che una qualsiasi legge non venga rispettata o venga applicata strumentalmente rispetto ad interessi ed obiettivi personali.
In realtà è giusto che le conferenze stampa siano limitate ai fatti di pubblico interesse e che sia il procuratore a deciderlo: si potrebbe mai operare una simile scelta d’intesa con organismi rappresentativi del giornalismo? Ma se tutto avviene correttamente e nello spirito della legge, i giornalisti non vedranno mai depotenziato il loro ruolo ed il diritto di selezionare le notizie di interesse: le indagini non nascono per tale fine, bensì per accertare i responsabili dei reati consumati e toccherà ai giornalisti ricercare le notizie correttamente, attraverso le fonti possibili e – come è sperabile – con possibilità di accesso legale a quelle documentali.
4. La necessità di una riflessione comune su informazione e giustizia tra magistrati, avvocati e giornalisti.
Sono da tempo intervenuti codici deontologici per magistrati, avvocati e giornalisti, cioè per tre delle principali categorie protagoniste del rapporto tra comunicazione e giustizia: tali codici sono sempre più mirati a disciplinare diritti e doveri connessi all’esercizio delle rispettive citate funzioni, ma i vizi sin qui esposti – ed altri ancora - permangono ed anzi rischiano di amplificarsi.
Non occorre – allora – invocare nuove regole deontologiche e sanzioni, quanto applicare quelle esistenti e comunque dar luogo ad un confronto diffuso, serrato e sincero tra le categorie interessate a dar luogo a prassi corrette d’informazione. Rammento, ad esempio, i vari incontri organizzati a Torino negli ultimi anni con giornalisti ed un’assemblea anche con gli avvocati per discutere dell’irrinunciabile importanza della informazione sulla giustizia e dei connessi diritti – doveri, di cui, però, vanno anche conosciuti i confini, diversi a seconda delle fasi del processo e comunque giustamente condizionati dal rispetto delle regole poste a tutela della privacy delle persone e della presunzione di innocenza di indagati e imputati.
L’auspicio è che tutti i magistrati, qualunque sia la funzione da loro svolta (ma in particolare i pubblici ministeri, categoria cui chi scrive ha appartenuto per tutta la sua carriera), siano ben consapevoli che la propria autorevolezza e credibilità non dipendono dallo spazio e dal rilievo eventualmente riservati dalla informazione alla loro attività professionale, ai loro volti ed ai loro nomi, ma dai risultati attestati nelle sentenze definitive. E’ anche questo che dà corpo alla fiducia nella Giustizia.
Il magistrato, dunque, sia protagonista virtuoso di corretta comunicazione e di ogni utile interlocuzione nel dibattito sui temi della giustizia! Ma sia capace di esserlo con misura, anche in questo difficile contesto storico in cui qualsiasi intervento tecnico, persino in ordine ad un disegno di legge che concerna il tema di diritti fondamentali, genera in automatico sempre la stessa risposta: “il magistrato taccia o scenda in politica”, come se a tale tipo di interlocuzione fossero abilitati solo i politici ! Deve essere ben chiaro, allora, che dipenderà soprattutto dai magistrati stessi se i cittadini comprenderanno quali sono le ragioni per cui nessuno può farli tacere e quali i limiti del loro diritto-dovere di informare.
Ben venga, a tal fine, il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 188 !
5. Cenni sull’allegato riguardante i criteri direttivi della Procura di Torino dell’8 ottobre 2018 che hanno anticipato varie disposizioni del D.Lgs. n. 188/221.
Le osservazioni fin qui formulate non devono essere considerate meramente discorsive e volte a stimolare solo dibattito teorico e dialettica sul tema in intestazione. Chi scrive, infatti, ritiene che, unitamente agli spunti tratti dal D. Lgs. N. 188/2021, esse possano costituire la base di precise direttive nella formulazione di circolari e criteri organizzativi degli Uffici Giudiziari di competenza dei rispettivi dirigenti (in particolare dei Procuratori della Repubblica presso i Tribunali).
Per tale ragione, nella consapevolezza della delicatezza della materia e solo per contribuire a possibili ulteriori riflessioni, lo scrivente ritiene utile allegare al presente intervento le parti dei Criteri di organizzazione della Procura della Repubblica di Torino (che ha varato l’8 ottobre 2018 e che, composto da 242 pagine e 25 allegati, è consultabile sulla homepage del sito web dell’ufficio: www.procura.torino.it) concernenti le direttive in tema di rapporti dei magistrati e della polizia giudiziaria con gli organi di informazione.
All’evidenza, tali direttive, che si pongono in linea con quanto previsto dalla citata delibera del CSM dell’11 luglio 2018 che prevede che il Procuratore della Repubblica “..assicura l’informazione sull’organizzazione e sull’attività della procura nel quadro della generale esigenza di trasparenza dell’organizzazione giudiziaria.”, hanno anticipato di vari anni molte delle condivisibili previsioni del Decreto Legislativo n. 188/2021 .
Si rimanda, dunque, alle pagine allegate.
[1] Il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021 (Suppl. Ordinario n. 40) con l'indicazione della vigenza dal 14 dicembre 2021
[2] Questo intervento contiene richiami e riferimenti a valutazioni già formulate dall’autore in occasione di Incontri di studio ed aggiornamento professionale organizzati dalla SSM del CSM (da ultimo in quello del 19 gennaio 2021 su “Il dovere di riservatezza nell’attività giudiziaria”), nonché contenuti in articoli pubblicati in Riviste giuridiche, tra cui si richiama, in particolare, quello intitolato “Comunicazione della giustizia sulla giustizia. Come non si comunica”, pubblicato su Questione Giustizia n. 4/2018.
[3] Documento di presentazione di un Corso di studi tenutosi nel giugno 2017 presso la Scuola Superiore della Magistratura di Scandicci
[4] Efficace definizione di Luigi Ferrarella in “Processo vero o mediatico? Le insidie delle nuove norme” (Corriere della Sera, 27 novembre 2021).
[5] Citata delibera del CSM dell’11 luglio 2028
[6] Intervista a Il Foglio del 3 dicembre 2021
[7] L. Ferrarella : “Proposta minoritaria di ecologia giornalistica” (2007)
[8] Per le parti che qui interessano si ricorda che l’art. 116 c.p.p. (Copie, estratti e certificati) prevede che:
1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti.
2. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza.
3. Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dall’articolo 114.
3-bis. ..omissis..
[9] “Processo vero o mediatico? Le insidie delle nuove norme” (Corriere della Sera, 27 novembre 2021)


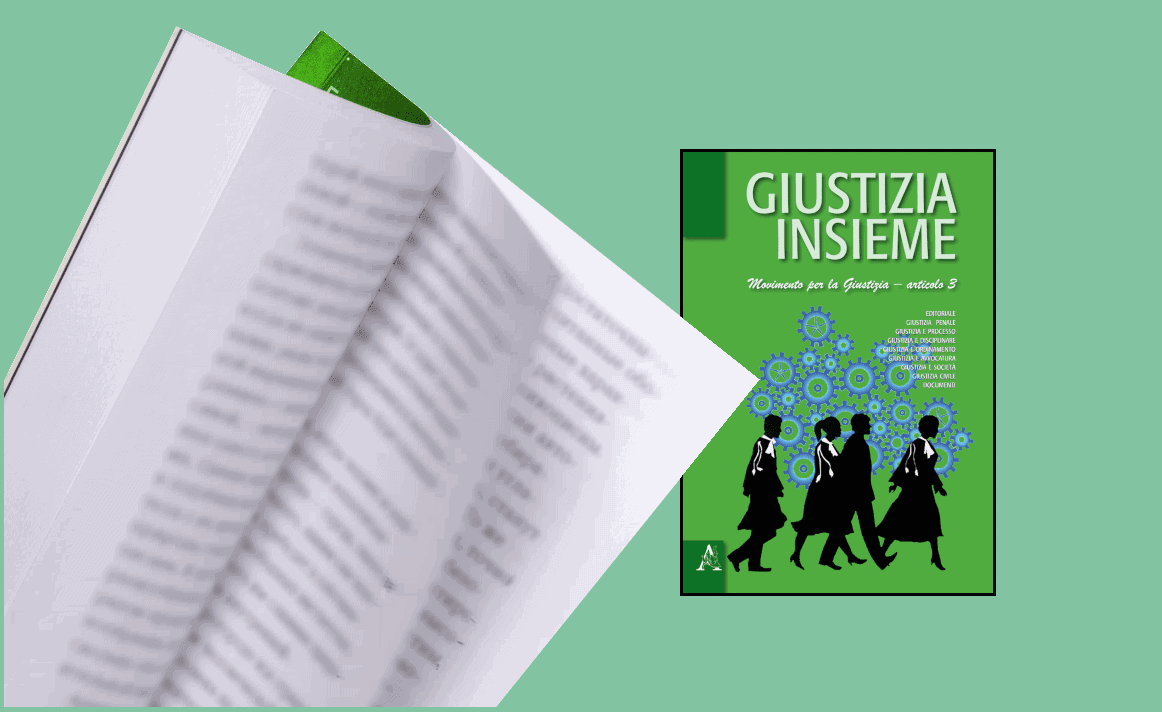
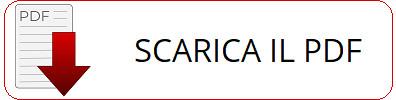

 E poi Aggiungi alla schermata principale.
E poi Aggiungi alla schermata principale.