La prova in giudizio della notifica di atti tributari a destinatario temporaneamente irreperibile. Nota a Cass. Sez. Un. n. 10012 del 2021 di Silvia Marinoni
Sommario: 1. Il caso deciso – 2. Il contrasto giurisprudenziale – 3. La soluzione accolta dalle Sezioni Unite – 4. Alcune considerazioni conclusive.
1. Il caso deciso
Le Sezioni Unite, con sentenza del 15 aprile 2021, n. 10012, sono intervenute in tema di prova giudiziale della regolare notifica eseguita a mezzo posta nei casi di c.d. irreperibilità relativa dando rilievo, mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata, alla ratio sottesa alla notificazione, quale procedura volta a portare a conoscenza del destinatario gli atti a questi indirizzati.
La vicenda trae origine dall'emissione da parte di Equitalia Sud S.p.a. di una cartella di pagamento a carico di una contribuente, che la impugnava lamentando la mancata notifica degli avvisi di accertamento prodromici; la ricorrente contestava il perfezionamento della procedura notificatoria sul presupposto dell'omessa produzione in giudizio da parte dell'Agenzia delle Entrate degli avvisi di ricevimento delle raccomandate di avvenuto deposito del plico (C.A.D.).
In primo grado il ricorso non venne accolto dalla C.T.P. di Caserta, la cui pronuncia, a seguito di gravame della contribuente, veniva confermata dalla C.T.R. della Campania sulla base dell'accertata regolarità delle notifiche degli avvisi di accertamento e del mancato assolvimento dell'onere di impugnazione congiunta degli stessi con la cartella esattoriale.
La contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, il cui esame poneva il problema di comprendere in quale modo dovesse essere giudizialmente provata la ritualità delle notificazioni compiute a mezzo posta allorché, per la temporanea assenza del destinatario e delle persone abilitate alla ricezione, ovvero per rifiuto di queste, i plichi fossero stati depositati presso l'ufficio postale e fossero decorsi dieci giorni senza il loro ritiro, nonostante apposita comunicazione. Sulla questione, la Quinta Sezione Civile, con ordinanza interlocutoria n. 21714 del 2020[1], evidenziava la sussistenza di un contrasto in seno alla Corte, rimettendo al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione del ricorso alle S.U., la questione di massima di particolare importanza concernente la prova del perfezionamento della notificazione di un atto impositivo mediante l'impiego diretto del servizio postale (art. 14, l. n. 890/1982) nel caso di temporanea assenza del destinatario e dei soggetti abilitati alla ricezione.
2. Il contrasto giurisprudenziale
La risposta al quesito formulato dalla sezione rimettente si intreccia col tentativo della dottrina e della giurisprudenza di individuare il giusto equilibrio tra diritto di agire del notificante e diritto di difendersi del destinatario.
Una parte della giurisprudenza[2] ha sostenuto che, ai fini della ritualità della notifica diretta, è richiesta la prova della sola spedizione della raccomandata e non anche dell'avvenuta ricezione di questa. Viene in rilievo l'espressa e puntuale previsione dell'art. 8, l. n. 890 del 1982, nella parte in cui dispone che la notificazione si ha “comunque” per eseguita decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata. La scelta del legislatore, per come interpretata dalla giurisprudenza, è quella di collegare, in via assoluta e generale, il perfezionamento dell'iter notificatorio all'evento 'spedizione' della C.A.D., in particolare dopo dieci giorni dall'invio della raccomandata. Verificatisi tali requisiti, dunque, si realizzerebbe la conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario, con ogni conseguenza in ordine agli effetti che da questa teorica conoscenza derivano[3].
Questa tesi si fonda, inoltre, sulla distinzione tra conoscenza e conoscibilità: la notificazione, quale procedimento complesso e strutturato, mira a consentire la sola conoscibilità, per soddisfare la quale sono state imposte al notificante specifiche formalità, fermo restando il dovere di cooperazione del destinatario dell'atto per integrare la sua conoscenza effettiva[4].
Il punto di incontro tra le posizioni contrapposte dei soggetti e i rispettivi diritti è dato dall'obbligo, in caso di mancato recapito al destinatario, di spedire una seconda raccomandata informativa dell'invio della prima racomandata, che costituisce, al tempo stesso, adempimento necessario per il notificante (che deve adoperarsi affinchè il destinatario sia portato a conoscenza dell'esistenza dell'atto) e sufficiente per il notificato (posto in condizione di sapere che vi è un atto a lui indirizzato). Questo bilanciamento, invero, sembrerebbe sortire un duplice effetto: per un verso, incoraggia il notificante ad attivarsi correttamente consapevole del fatto che il rispetto delle formalità legali comporta il perfezionarsi della notifica anche in mancanza del ritiro del piego depositato; per altro verso, riconoscendo al destinatario un termine ragionevole per ritirare il piego, garantisce il diritto di costui “ad essere posto in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell'atto e l'oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti”[5].
Secondo una contrapposto orientamento[6], ai fini della ritualità della notifica a mezzo posta in caso di irreperibilità relativa del destinatario, non è sufficiente provare la spedizione della raccomandata informativa di comunicazione di avvenuto deposito, essendo necessaria la prova dell'avvenuta ricezione di quest'ultima. Tale ricostruzione valorizza il diritto di difesa (art. 24 Cost.) che può essere realmente assicurato solo allorchè le garanzie di conoscibilità dell'atto siano improntate a logiche di effettività. In questa prospettiva, il Collegio rimettente ha enfatizzato il ruolo determinante della C.A.D. rilevando che quando il legislatore ha considerato sufficiente una raccomandata semplice per informare circa l'avvenuta notificazione ha espressamente disposto in tal senso[7], mentre l'art. 8, co.4, l. n. 890/1982 prescrive l'invio di raccomandata “con avviso di ricevimento”.
L'ordinanza interlocutoria ha così posto l'interrogativo sulla necessità o meno di esibire in giudizio l'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata contenente la C.A.D. come prova del suo invio, al fine di verificare se effettivamente la comunicazione di avvenuto deposito sia giunta nella sfera di conoscibilità del destinatario. Dalle annotazioni ivi riportate, infatti, potrebbe risultare la mancata consegna dovuta al trasferimento o al decesso del soggetto cui l'atto è indirizzato, o ad altre cause ostative alla sua conoscibilità, che parimenti assumono rilevanza in quanto dimostrano che l'effetto legale collegato al procedimento notificatorio non si è potuto produrre[8].
La diversità di prospettiva che caratterizza la tesi favorevole alla prova della ricezione della C.A.D., oltre a rafforzare la posizione del soggetto cui l'atto è rivolto, determina un mutamento notevole dal punto di vista processuale, che va oltre l'onere probatorio gravante sul notificante, producendo effetti anche sotto il versante temporale, con conseguente allungamento dei termini. Chiarisce, infatti, l'ordinanza di rimessione, che il perfezionamento della notifica per il destinatario con il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata della C.A.D. degrada ad “effetto provvisorio o anticipato, destinato a consolidarsi con l'allegazione dell'avviso di ricevimento, le cui risultanze possono confermare o smentire che la notifica abbia raggiunto lo scopo cui era destinata”. V'è, quindi, un effetto normativo sospensivamente condizionato alla verifica del giudice sull'avviso di ricevimento della seconda raccomandata.
3. La soluzione accolta dalle Sezioni Unite
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 10012 del 2021, hanno avallato l'orientamento più garantista per il destinatario dell'atto, ritenendo che nei casi di sua temporanea assenza nella notifica a mezzo posta devono essere rispettate le formalità prescritte dall'art. 8 l. n. 890 del 1982, ivi incluso l'invio della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito degli atti notificandi, di cui deve essere data prova unicamente producendo in giudizio l'avviso di ricevimento della (seconda) raccomandata. La C.A.D. riveste un ruolo essenziale perchè mira a garantire “la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell'atto notificando stesso”.
L'iter argomentativo si basa su una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni sulla notifica e si sviluppa lungo due direttrici: la valorizzazione del diritto di difesa nelle varie procedure notificatorie e la pregnante considerazione degli interventi della Corte costituzionale.
Sotto il primo profilo, le Sezioni Unite evidenziano il maggior rigore previsto per la notifica a mezzo posta, in ipotesi di temporanea assenza del destinatario, col deposito presso l'ufficio postale dell'atto notificando rispetto a quello di cui agli artt. 139 c.p.c. e 7, l. n. 890/1982 disciplinanti la consegna a persona diversa dal destinatario, la cui qualità o relazione col primo fonda un maggior affidamento e dunque giustifica una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna semplificata, ossia tramite raccomandata “semplice”. Nella notifica a mezzo posta, invece, manca la consegna alle persone abilitate e quindi non sussiste la predetta ragionevole aspettativa che l'atto notificando venga effettivamente conosciuto dal destinatario, sicchè, a fronte del mero deposito presso l'ufficio postale, il legislatore - per assicurare la conoscibilità del destinatario - ha previsto un duplice adempimento ulteriore: l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo di notifica e la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Con riguardo al secondo aspetto, ossia al tentativo di interpretare le disposizioni conformemente alle pronunce della Corte costituzionale, le Sezioni Unite estendono la comparazione tra le procedure di cui agli artt. 8 l. n. 890/1982 e 140 c.p.c., accomunate dal medesimo presupposto fattuale della irreperibilità relativa, utilizzando tale ultima disposizione quale tertium comparationis. La sentenza in nota - richiamando la giurisprudenza in tema di notifica da parte dell'ufficiale giudiziario che richiede, ai fini della prova del perfezionamento, la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa[9] - individua una comunanza di ratio tra le due modalità, consistente nel dare al destinatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo. Tale assimilazione si fonda sul legame inscindibile che la giurisprudenza individua tra le formalità proprie del procedimento di notifica e il rispetto dei principi costituzionali di azione e difesa (art. 24 Cost.) e di parità delle parti del processo (art. 111, c. 2, Cost.).
L'estensione della logica garantista fatta propria dalla Corte costituzionale alla disciplina contenuta nella legge n. 890 del 1982 finisce con l'individuare un nuovo punto di equilibrio tra le esigenze del destinatario e quelle del notificante, il cui onere processuale viene qualificato come “non vessatorio o problematico”[10]. L'avviso di ricevimento della C.A.D. costituisce, nella prospettiva accolta da Cass. n. 10012 del 2021, l'indefettibile prova di un presupposto implicito dell'effetto di perfezionamento della procedura notificatoria ai sensi dell'art. 8, commi secondo e quarto, l. n. 890/1982 e il cui esame affidato al giudice consente di verificare se la notificazione ha concretamente assolto il suo compito. La valutazione positiva comporta il consolidamento dell'effetto provvisorio dell'avviso de quo, che diviene definitivo, conformemente alla qualificazione della fattispecie come procedimento a formazione progressiva.
4. Alcune considerazioni conclusive
La sentenza in commento, nel ritenere che per provare il perfezionamento della notifica a mezzo posta, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, sia necessaria l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, giunge a subordinare la regolarità del procedimento notificatorio alla concreta verifica, affidata al giudice, che la C.A.D. sia pervenuta al destinatario e che, quindi, costui abbia potuto avere conoscenza effettiva di quanto notificatogli.
V'è da chiedersi se le conclusioni cui sono pervenute le Sezioni Unite possano rappresentare un definitivo superamento del contrasto giurisprudenziale che ha giustificato il loro intervento o se, come si immagina, saranno necessari ulteriori chiarimenti.
La Cassazione ha optato per un'interpretazione della disciplina sulla notifica adeguatrice ai principi costituzionali, fornendo una ricostruzione sistematica della normativa attraverso una chiave di lettura che parte della dottrina già da tempo sollecitava, così da evitare un non agevole intervento della Corte costituzionale. In particolare, poichè le disposizioni sulla notifica, pur se contenute in testi di legge diversi, si ispirano alla medesima ratio e devono assolvere la stessa funzione, la ricostruzione accolta contribuisce a rendere più uniforme la disciplina della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nei casi di irreperibilità relativa. Ciò attraverso l'estensione alla notificazione postale della regola elaborata dalla giurisprudenza per la notificazione eseguita tramite ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c.
L'impianto risultante dalla pronuncia annotata sembra, così, rafforzare il principio di effettività della tutela, di cui il diritto di difesa rappresenta un prius logico imprescindibile. Infatti, l'avvicinamento tra conoscenza legale ed effettiva è volto ad assicurare che il destinatario sia posto nelle condizioni di far valer le proprie ragioni, in un confronto paritario con l'Amministrazione, attraverso l'instaurazione di un contraddittorio. Ciò in armonia con i principi costituzionali (artt. 24 e 111 Cost) oltre che sovranazionali (artt. 41, 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali dell'UE)[11].
L'impostazione accolta dalle Sezioni Unite pare coerente anche con l'art. 6 dello Statuto del contribuente, rubricato “Conoscenza degli atti e semplificazione”, il cui comma primo fa carico all'Ufficio finanziario di assicurare “l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati” e, nel precisare che “gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario”, sembra richiedere che il soggetto al quale sono indirizzati non sia solo posto in condizioni di conoscere, ma abbia piena contezza del loro contenuto. Ciò salvo ritenere che dalla parte finale del comma, a mente del quale “restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari”, discenda un rapporto di specialità tra queste e l'art. 6 L. n. 212/2000, con prevalenza delle regole sulla notifica.
La soluzione garantista prescelta lascia tuttavia non del tutto chiariti alcuni aspetti: primo fra tutti quello pratico, concernente la fase successiva all'esame del giudice allorchè al corretto (e provato) adempimento del notificante non corrisponda la conoscenza del destinatario. La sentenza, infatti, non chiarisce in modo puntuale quali conseguenze derivino per i soggetti coinvolti nell'iter e per lo stesso atto notificando nei casi di valutazione giudiziale negativa, senza quindi individuare il punto di incontro tra esigenze contrapposte. Le Sezioni Unite, infatti, non si preoccupano di qualificare il vizio che affligge l'atto notificando e, di conseguenza, non si comprende quale sarà la sorte dell'accertamento. Nel caso di specie, invero, in accoglimento del ricorso introduttivo, si è ritenuta nulla la notifica, non avendo l'Agenzia provveduto a dar prova in giudizio dell'avviso di ricevimento della C.A.D.; resta in sospeso, però, cosa succeda nei casi di prova in giudizio della cartolina riportante la notizia, ad esempio, del trasferimento o del decesso.
Perplessità sono state sollevate anche in merito all'interpretazione letterale dell'art. 8, l. n. 890/1982 che sembra ancorare la produzione degli effetti al decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l'avviso della tentata notifica e del deposito del piego presso l'ufficio postale, o al ritiro ove anteriore, escludendo un consolidamento successivo degli effetti correlato alla ricezione. La soluzione accolta non consente ulteriori valutazioni in merito alla ratio della dispozione indicata, la cui differente formulazione potrebbe essere frutto di una specifica volontà in tal senso, cosicchè la parificazione, pur ispirata a valide ragioni di tutela del destinatario, si porrebbe proprio in contrasto con la norma. Dubbio, questo, già espresso da Cass. n. 6089/2020 secondo cui le notifiche di cui all'art. 140 c.p.c. si connotano per un regime che si discosta da quello di cui all'art. 8, co. 4, l. n. 890/1982, atteso che, mentre le seconde si perfezionano decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o al momento del ritiro del piego, ove anteriore, viceversa, l'art. 140 c.p.c., all'esito di Corte cost. n. 3 del 2010, fa coincidere tale momento col ricevimento della raccomandata informativa, reputato idoneo a realizzare non l'effettiva conoscenza, ma la conoscibilità del deposito dell'atto presso la casa comunale, ponendo il destinatario in condizione di ottenere la consegna ed eventualmente predisporre le proprie difese nel rispetto dei termini pendenti per la reazione giudiziale. Peraltro, una differente disciplina delle varie modalità di notificazione non darebbe adito, di per sé sola, a dubbi di legittimità costituzionale poichè non è predicabile un dovere del legislatore ordinario di uniformare il trattamento processuale di situazioni assimilabili, essendo consentita una diversa conformazione degli istituti processuali a condizione che non siano lesi i diritti di difesa.
Del resto, come già chiariva l'ordinanza interlocutoria, il meccanismo configurato dall'art. 8 l. n. 890 del 1982, rappresenta una declinazione, peculiare e specifica, della più generica nozione di “conoscenza legale” che segna, giusto l'art. 149 c.p.c., il perfezionamento della notifica postale dal lato del destinatario, nella consapevolezza che, per comprensibili esigenze di funzionalità, il sistema delle notificazioni a mezzo posta non può indefettibilmente esigere la concreta conoscenza dell'atto, ma ne considera sufficiente l'ingresso nella sfera di conoscibilità del soggetto. Questa diversa ricostruzione si fonda su un discrimen netto tra procedimento notificatorio ed eventi successivi, posto che la comunicazione, il cui contenuto concerne unicamente le attività svolte dall'agente postale, senza dare informazione alcuna sull'intrinseco dell'atto notificatorio, configura soltanto una modalità di rafforzamento dell'iter già perfezionatosi.
Ulteriori incertezze sono state formulate in merito non già alla prova della C.A.D., bensì alla necessità stessa del suo invio, che sembrerebbe escluso per la notifica postale diretta, in cui dovrebbe applicarsi il regime postale e non la legge n. 890/1982[12]. Secondo parte della giurisprudenza[13], infatti, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante cui può essere notificato, ex art. 14 l. n. 890/1982, l'avviso di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, caratterizzata dalla totale assenza di formalità. Peraltro, in base a un comune dato di esperienza, l'avviso di giacenza (modello 26) di cui alla normativa postale - con cui si comunica la mancata consegna e si avvisa del deposito dell'atto presso un determinato ufficio postale ove potrà essere ritirato nei termini, con l'avvertimento che in mancanza si verificherà la compiuta giacenza e l'atto verrà restituito al mittente – viene di regola immesso nella cassetta postale e non spedito a mezzo raccomandata.
Le Sezioni Unite, limitando il loro intervento all'aspetto probatorio, hanno forse perso l'occasione per chiarire il rapporto tra gli artt. 8 e 14 della l. n. 890/1982, al fine di delinearne il reale perimetro applicativo rispetto alle disposizioni di cui al regolamento postale, accogliendo implicitamente quanto statuito nella pronuncia n. 5077 del 2019. Con tale ultima decisione, la Cassazione, dopo aver sottolineato che l'art. 14 l. n. 890/1992 si limita ad estendere agli atti che devono essere notificati al contribuente le stesse modalità previste dalla legge per la notifica a mezzo posta degli atti giudiziari, aveva espressamente escluso un contrasto tra il necessario deposito dell'avviso di ricevimento relativo alla C.A.D. e l'applicabilità del regolamento postale alla raccomandata con cui tale comunicazione viene inviata, ritenendo sussistere un rapporto di complementarietà fra le discipline, le quali, anzichè escludersi, si completano vicendevolmente.
La complessità della questione e le rilevanti ripercussioni che la sentenza in nota potrà avere sul piano sostanziale inducono a considerare non definitivamente risolto il dibattito esistente che, anzi, proprio da questa pronuncia trarrà nuova linfa. Resta da vedere se la giurisprudenza farà piana applicazione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite o troverà margini per rimodularne la portata nei diversi casi posti alla sua attenzione.
[1] Cfr.: M. Bruzzone, Notifiche a mezzo posta e prova della C.A.D.: la parola alle Sezioni Unite, in Giur. Trib., 2021, n.2, 133 e ss.; M. Cancedda, Notifica postale all'“assente” verso il vaglio delle Sezioni Unite; P. Maciocchi, Notifica via posta, regolarità alla prova delle Sezioni Unite, in Il Sole 24 Ore, 9 ottobre 2020, 32.
[2] Cfr. Cass., nn. 4043/2017, 6242/2017, 26945/2017, 13833/2018, 2638/2019, 33070/2019, 33257/2019.
[3] Vedi Cass. n. 26088/2015 e Cass. Sez. Un., n. 1418/2012.
[4] Cfr. Cass. n. 26501/2014; Cass., Se. Un., n. 23675/2014, ove si precisa che “l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, pur costituendo lo scopo della notificazione, rimane estranea alla sua struttura”.
[5] Cass. Sez. Un., n. 1418/2012.
[6] Cass., nn. 5077/2019, 16601/2019, 6363/2020, 23921/2020, 25140/2020, 26078/2020.
[7] Cfr. artt. 139, c. 3, c.p.c. e 7, c. 3, L. n. 890/1982.
[8] Sulla rilevanza dell'avviso di ricevimento quale documento atto a provare l'esecuzione della notificazione, della data e della persona, si veda Cass. n. 3737/2004 e n. 15374/2018.
[9] Corte cost. nn. 3/2010 e 258/2012, nonché Cass. nn. 9782/2018, 25985/2014, 22132/2009, 627/2008.
[10] Sulla tecnica di bilanciamento fra interessi contrapposti cfr. Cass., Sez. Un., 9 dicembre 2015 n. 24822 che ha individuato i quattro steps da seguire nel giudizio. L'ultimo di questi prevede che se entrambe le parti non sono in colpa, il bilanciamento avviene imponendo un onere di diligenza – o, comunque, una condotta (attiva o omissiva) derivante da un principio di precauzione – alla parte che più agevolmente è in grado di adempiere. In questa prospettiva si comprende l'impostazione seguita dalle Sez. Un. n. 10012/2021 che, traendo la norma dalla disposizione di legge, impone al notificante un onere ulteriore.
[11] Cfr. Corte giust. 12 novembre 1969, C-29/69 Erich Stauder c. Stadt Ulm – Sozialamt, secondo cui il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio fondamentale del diritto dell'Unione di cui il diritto al contraddittorio in qualsiasi procedimento costituisce parte integrante.
[12] Cfr. Cass. n. 17598/2010.
[13] Cass. n. 14501/2016, 29642/2019.

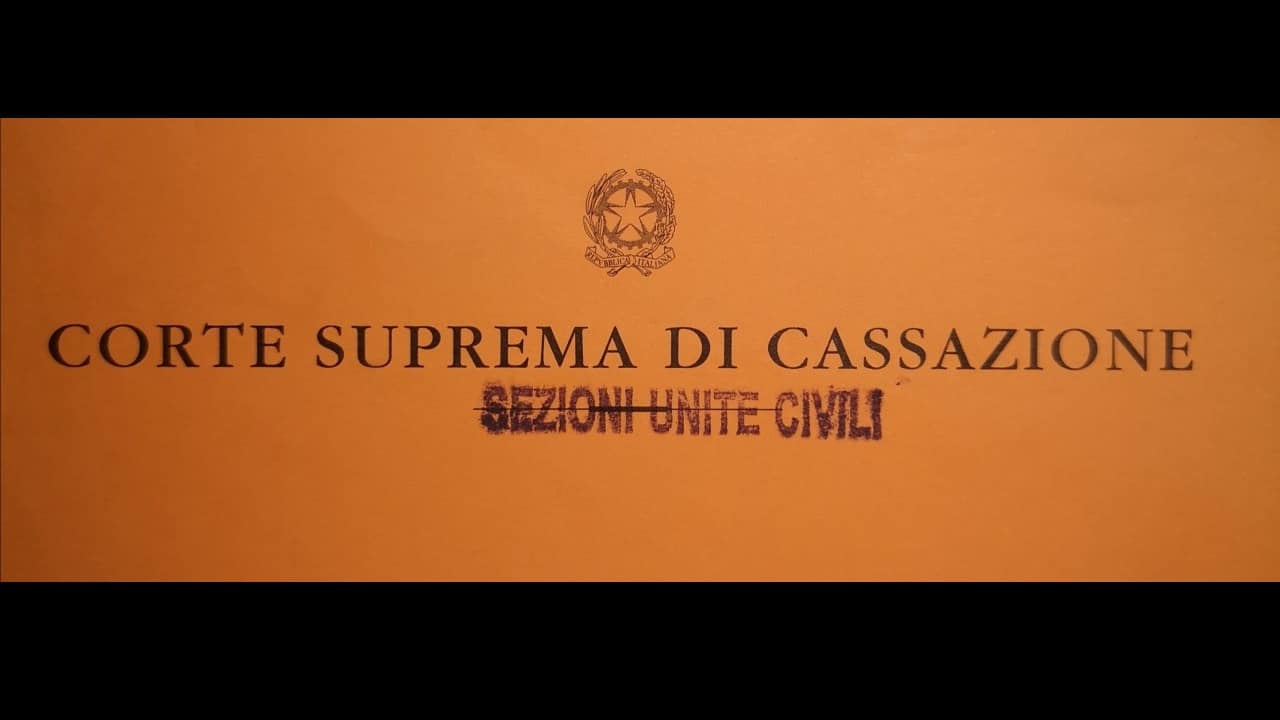

 E poi Aggiungi alla schermata principale.
E poi Aggiungi alla schermata principale.