Tutela cautelare monocratica: il Consiglio di Stato torna ad affermare l’inappellabilità del decreto cautelare reso ex art. 56 c.p.a. (Nota a Cons. Stato, Sez. IV, n. 1962 del 2022)
di Martina Sforna
Sommario: 1. Premessa: la questione dell’appellabilità del decreto cautelare monocratico. – 2. La vicenda e la decisione del Consiglio di Stato. – 3. L’analisi del dato normativo. – 4. L’orientamento favorevole all’appellabilità del decreto cautelare monocratico. – 5.L’orientamento opposto sposato dal Presidente della IV Sezione. – 6. Il principio di effettività della tutela giurisdizionale e il ruolo del giudice. – 7. Considerazioni conclusive.
1. Premessa: l’appellabilità del decreto cautelare monocratico.
Il decreto del Consiglio di Stato in commento si inserisce nell’ambito del dinamico dibattito in corso in seno alla giurisprudenza amministrativa sul tema dell’appellabilità del decreto cautelare monocratico pronunciato ai sensi dell’art. 56 c.p.a. Invero, sebbene il secondo comma di tale articolo preveda che, in caso di richiesta cautelare connotata da estrema gravità e urgenza – tali da non consentire la dilazione sino alla camera di consiglio – il Presidente del T.A.R. (o un magistrato da lui delegato) possa provvedere con decreto motivato non impugnabile, sono molteplici le pronunce della giurisprudenza amministrativa che hanno, invece, riconosciuto uno spazio all’appellabilità di tali decreti. In particolare, decisioni in questo senso si sono accresciute durante il periodo pandemico appena trascorso, nell’ambito del quale i decreti cautelari presidenziali hanno ricoperto un ruolo di primo piano nella tutela degli interessi legittimi affermati dai vari ricorrenti[1].
Diversamente, con il decreto che si sta annotando, la Sezione Quarta del Consiglio di Stato, si pone in linea con quella giurisprudenza che, volendo superare i precedenti orientamenti di altre Sezioni, asserisce la non impugnabilità dei decreti cautelari monocratici resi ai sensi dell’art. 56 c.p.a[2]. Specificamente, in questa occasione, la Quarta Sezione fonda la dichiarazione di inammissibilità del decreto cautelare monocratico sulla base di una interpretazione strettamente letterale della norma codicistica richiamata, nonché sul principio della piena soggezione del giudice alla legge di cui all’art. 101 della Costituzione.
Nonostante la linearità del ragionamento sviluppato dal giudice, si ritiene di dover svolgere, però, delle considerazioni a margine della decisione, soprattutto in relazione all’assenza di un qualsivoglia riferimento al generale principio dell’effettività della tutela giurisdizionale.
Ciò premesso, al fine di comprendere al meglio le questioni sollevate dalla pronuncia in commento, si impone, anzitutto, l’esigenza di ripercorrere brevemente le vicende che hanno condotto alla sua emanazione.
2. La vicenda e la decisione del Consiglio di Stato.
La vicenda origina dal ricorso presentato da un’amministrazione comunale per l’annullamento dell’ordinanza con cui il Presidente della Provincia di riferimento aveva autorizzato lo stoccaggio temporaneo e speciale di alcuni rifiuti rimpatriati dall’estero presso il territorio del Comune ricorrente. In particolare, con il medesimo atto di ricorso, il ricorrente aveva, altresì, richiesto, la concessione di misure cautelari urgenti ex art. 56 c.p.a., al fine di ottenere quantomeno la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza e, dunque, di evitare lo stoccaggio dei 213 container di rifiuti nel sito locato entro il territorio comunale.
Il Presidente del T.A.R. competente, però, ritenendo insussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare e, nello specifico, considerando del tutto generiche le ragioni di tutela della salute pubblica, dell’ambiente e dell’ordine pubblico prospettate dal ricorrente, nonché la prevalenza dell’interesse ad una rapida ed efficace definizione della vicenda mediante il trasferimento dei rifiuti, procedeva al respingimento della medesima istanza, nonché alla fissazione, per il mese successivo, della Camera di Consiglio per la trattazione in sede collegiale[3].
Di conseguenza, il ricorrente procedeva all’impugnazione del decreto così pronunciato dinanzi al Consiglio di Stato, il quale, però, come preannunciato, ne dichiara l’inammissibilità.
Nel dettaglio, il Presidente della Quarta Sezione, dopo aver rilevato trattarsi dell’impugnazione di un decreto reso ai sensi dell’art. 56 c.p.a. e, dunque, espressamente qualificato, dal relativo comma 2, come non impugnabile, al fine di motivare la pronuncia di inammissibilità, procede a richiamare (pressoché integralmente[4]) il decreto del Presidente della Quinta Sezione del 18 febbraio 2022, n. 798.
Invero, quest’ultimo aveva ribadito l’espressa affermazione di non impugnabilità del decreto di cui all’art. 56 c.p.a. da parte della disposizione codicistica, nonché la previsione, da parte del comma 4, dell’efficacia del decreto fino alla trattazione in sede collegiale, periodo in cui, peraltro, è sempre passibile di revoca o modifica su istanza delle parti. Il decreto richiamato, inoltre, sottolineava come anche per i decreti cautelari ante causam, concessi ai sensi dell’art. 61 c.p.a., sia prevista la non impugnabilità accompagnata dalla possibilità di riproporre l’istanza. Infine, esso invocava quanto stabilito dall’art. 62 c.p.a., a chiusura del sistema, circa la previsione dell’appellabilità delle ordinanze cautelari (e, pertanto, non dei decreti), da leggere alla luce del principio di stretta tipicità legale del sistema delle impugnazioni.
Il Presidente della Quarta Sezione procede, inoltre, ad invocare il principio di soggezione del giudice alla legge enunciato dall’art. 101 Cost. In particolare, in ragione di tale principio, egli afferma come in presenza di una preclara formulazione testuale della normativa applicabile, l’unico strumento idoneo a prospettare una differente esegesi è rappresentato dalle sentenze manipolative di accoglimento della Corte costituzionale, potendo solo questa modificare il diritto oggettivo nazionale.
In aggiunta a ciò, ai fini di completezza della parte motiva, viene sottolineato come non si rivengano nemmeno profili di abnormità dell’appellato decreto che possano implicare una non sussunzione dello stesso nelle maglie della fattispecie legale di cui all’art. 56 c.p.a.
Infine, il giudice procede alla fissazione della camera di consiglio in sede di appello (in data successiva alla camera di consiglio fissata in prime cure), ritenendo, comunque, necessaria la garanzia di esercizio dei poziori poteri cognitori di pertinenza del Collegio.
3. L’analisi del dato normativo
Onde comprendere al meglio la portata del dibattito giurisprudenziale sorto intorno al tema dell’appellabilità dei decreti cautelari monocratici, si ritiene di muovere dall’analisi della disciplina legislativa sul punto. Essa è oggi contenuta all’interno dell’articolo 56 del codice del processo amministrativo, il quale regola l’eventualità in cui la richiesta cautelare, per l’estrema gravità e urgenza della situazione, non possa attendere la fissazione della camera di consiglio. In tali casi la norma prevede, dunque, la possibilità di derogare al principio di collegialità delle decisioni nel processo amministrativo, richiedendo al Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale competente l’adozione di misure cautelari provvisorie prima della trattazione della domanda cautelare da parte del Collegio.
In realtà, tale possibilità non ha rappresentato una novità del Codice del Processo Amministrativo, essendo stata, infatti, prevista una forma di tutela cautelare monocratica già nell’ambito dell’art. 21 co. 9 L. Tar, introdotto dalla L. 21 luglio 2000, n. 205[5]. A differenza della disciplina previgente, la quale contemplava la possibilità che il Presidente del Tar provvedesse anche in assenza di contraddittorio, però, il codice del processo amministrativo ha imposto l’attuazione del contraddittorio, sebbene in una forma limitata[6]. Invero, gli unici adempimenti richiesti al ricorrente sono rappresentati dalla notifica (anche via fax) del ricorso all’amministrazione resistente e ad almeno uno dei controinteressati, il cui perfezionamento deve essere verificato dal Presidente o da un magistrato da lui delegato. Peraltro, qualora per cause non imputabili al ricorrente non sia possibile accertare il perfezionamento delle notificazioni, il Presidente può comunque provvedere, fatto salvo il potere di revoca. Inoltre, i soggetti a cui sia stata notificata la richiesta cautelare possono richiedere di essere sentiti dal Presidente anteriormente al decreto, fuori udienza e senza formalità[7].
In ogni caso, una volta emanato il decreto cautelare ricorrendone i presupposti[8], il procedimento cautelare si incanala in quello ordinario affinché possa trovare il suo esito definitivo nell’ordinanza collegiale. In tal senso, si spiega anche la disposizione codicistica che prevede che il decreto mantenga la sua efficacia fino alla camera di consiglio di cui all’art. 55 co. 5 c.p.a.
Quanto ai rimedi esperibili avverso il decreto presidenziale, il Codice prevede espressamente la possibilità per le parti notificate di richiederne la revoca o la modifica fintanto che esso conserva la sua efficacia. Stando alla lettera dell’art. 56, co. 4, invece, il decreto presidenziale non è impugnabile con l’appello al Consiglio di Stato. Sul punto, però, la giurisprudenza amministrativa ha sviluppato orientamenti differenti.
4. L’orientamento favorevole all’appellabilità del decreto cautelare monocratico.
Nonostante l’espressa previsione legislativa dell’inappellabilità del decreto cautelare monocratico, si sono registrate varie pronunce del Consiglio di Stato che, andando oltre il dato normativo, ne hanno ritenuto ammissibile l’impugnazione. Ciò, peraltro, a dimostrazione della centralità assunta dalla tutela cautelare nel processo amministrativo[9].
In particolare, come già evidenziato in premessa, pronunce in tal senso si sono susseguite durante il periodo pandemico in cui i procedimenti cautelari, per espressa previsione legislativa, sono stati decisi con il rito di cui all’art. 56 c.p.a. per espressa previsione dell’art. 84 del D.L. 18/2020. Al proposito è stato, peraltro, osservato come “l’apporto della giurisprudenza del Consiglio di Stato in questo senso può essere letto quale intervento di costruzione del provvedimento cautelare in risposta alle esigenze della società”[10].
Anche prima dell’insorgere della pandemia, però, si erano registrate delle pronunce di tale tenore. Specificamente, con il decreto monocratico 5971 del 2018[11], la quinta Sezione del Consiglio di Stato, facendo leva sul principio della indefettibilità della tutela cautelare nel corso di qualsiasi fase e grado del processo desumibile dall’art. 24 della Costituzione e dagli artt. 6 e 13 della CEDU, aveva accolto l’appello presentato avverso un decreto monocratico del Tar Emilia Romagna che non aveva concesso la misura cautelare richiesta dal ricorrente. In particolare, la Sezione aveva affermato che “l'appellabilità del decreto monocratico del Presidente del T.A.R. va considerata ammissibile esclusivamente quando vi siano eccezionali ragioni d'urgenza, tali da rendere irreversibile - per il caso di mancata emanazione di una misura monocratica in sede d'appello - la situazione di fatto, a causa del tempo che intercorre tra la data di emanazione del decreto appellato e la data nella quale è fissata la camera di consiglio per l'esame della domanda cautelare, da parte del T.A.R. in sede collegiale”.
Il Consiglio di Stato aveva, dunque, operato una interpretazione costituzionalmente orientata della norma di cui all’art. 56 c.p.a., volta a consentire non un appello indiscriminato dei decreti monocratici presidenziali, ma una possibilità di impugnazione, secondo ragionevolezza, nei casi in cui esso rappresenti l’unico strumento di tutela effettiva del ricorrente. Ciò al fine di garantire il principio di indefettibilità della tutela cautelare.
Sulla stessa scia di questa decisione, decreti più recenti del Consiglio di Stato hanno considerato ammissibile l’appello nei confronti di quei provvedimenti che, in casi eccezionali, siano qualificabili come “decreti meramente apparenti”, avendo soltanto la veste formale di decreti ma un contenuto sostanzialmente decisorio[12]. Nell’opinione del Consiglio di Stato, in particolare, ciò accade quando la decisione monocratica di primo grado possa potenzialmente definire in maniera irreversibile la questione oggetto del giudizio.
Ancora, all’inizio del periodo pandemico, il Presidente della III Sezione, pronunciandosi sull’appello proposto avverso un decreto presidenziale che rigettava l’istanza di sospensione cautelare dell’ordine di quarantena obbligatoria, ha asserito come “il decreto monocratico presidenziale del T.A.R., adottato ai sensi dell'art. 56 c.p.a., è appellabile nei soli casi in cui l'effetto del decreto presidenziale produrrebbe la definitiva e irreversibile perdita del preteso bene della vita, e dovendo tale bene della vita corrispondere ad un diritto costituzionalmente tutelato dell'interessato”[13].
Allo stesso modo, in una precedente occasione, il Consiglio di Stato, pur dichiarando nel caso di specie inammissibile l’appello, essendo stato escluso ogni pericolo di perdita definitiva del bene della vita direttamente tutelato dalla Costituzione, aveva implicitamente sposato la tesi per cui quando ciò accada l’appello deve essere esaminato[14].
Deve osservarsi, inoltre, come tali pronunce si pongano in linea con quella risalente giurisprudenza del Consiglio di Stato che, nel corso degli anni Settanta del secolo scorso, affermò l’ammissibilità dell’appello avverso le ordinanze dei T.A.R. aventi ad oggetto la sospensione dei provvedimenti impugnati, nonostante il silenzio della l. 1034/1971 sul punto[15]. In particolare, l’Adunanza Plenaria n. 1 del 1978 asserì come l’impugnabilità di tali ordinanze dovesse essere desunta, non tanto dalla loro veste formale, quanto invece in base alla loro natura decisoria, ovverosia alla loro capacità di produrre effetti assimilabili a quelli della sentenza. E, poiché, l’ordinanza cautelare “risolve, in contraddittorio tra le parti, una specifica controversia (eseguibilità o meno dell’atto prima dell’esaurimento del relativo giudizio di impugnazione), cioè un conflitto di pretese[16]”, la stessa va ritenuta impugnabile.
Si ritiene doveroso menzionare, altresì, la sentenza con cui la Corte costituzionale, sulla base del principio del doppio grado di giudizio, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della L. n. 1 del 1978 nella parte in cui escludeva l’appellabilità al Consiglio di Stato delle ordinanze cautelari dei T.A.R.[17]. Invero, la Consulta, da un lato, richiamando l’art. 125 Cost. aveva asserito come il principio del doppio grado di giurisdizione fosse applicabile anche al settore amministrativo e, dall’altro, sottolineato come anche il procedimento cautelare, in quanto intimamente connesso con il processo di merito, dovesse consentire la soddisfazione dell’interesse meritevole di tutela.
5. L’orientamento opposto sposato dal Presidente della IV Sezione.
Come precedentemente descritto, con l’occasione che ha dato origine al decreto che si commenta, il Presidente della IV Sezione del Consiglio di Stato avverte, invece, l’esigenza di riaffermare l’inappellabilità dei decreti monocratici cautelari. A tal fine, individua nella sottoposizione dei giudici alla legge di cui all’art. 101, co. 2, Cost. un punto essenziale della motivazione. Nello specifico, il Presidente sottolinea come soprattutto nei casi di una chiara formulazione letterale delle norme, non sia possibile da parte del giudice una esegesi differente (o, meglio, contraria), evidenziando inoltre, come l’unico strumento interpretativo idoneo a modificare il diritto oggettivo nazionale sia rappresentato dalle sentenze di accoglimento (pur se manipolative) della Corte costituzionale.
Tale decreto si inserisce, pertanto, nell’ambito delle decisioni che escludono l’appellabilità dei decreti cautelari monocratici. Queste hanno nel tempo fatto leva su diverse motivazioni, evidenziate anche da commenti della dottrina. In particolare, oltre ad aver sottolineato la chiarezza del dato normativo espresso, è stato evidenziato come tale eccezionale misura cautelare monocratica presidenziale “ha funzione strettamente interinale prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, in caso di estrema gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio e che il relativo «decreto» è per legge «efficace sino a detta camera di consiglio», che costituisce la giusta sede per l’esame della domanda cautelare”[18].
Inoltre, deve rilevarsi come la pronuncia di un decreto da parte del Presidente di una delle Sezioni del Consiglio di Stato possa comportare delle problematiche di ordine pratico, dovendosi considerare la possibile sovrapposizione tra la pronuncia monocratica cautelare in grado di appello e quella collegiale in primo grado.
Addirittura, più recentemente, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia ha emesso una pronuncia di non luogo a provvedere in relazione ad una impugnazione avente ad oggetto un decreto presidenziale monocratico reso ai sensi dell’art. 56 c.p.a. evidenziando come non via sia luogo a provvedere sulle istanze di rimedi giuridici inesistenti e non essendoci alcuna possibilità per il Presidente di esercitare poteri non previsti da disposizioni legislative[19].
Infine, attenta dottrina ha osservato la volontà del legislatore nel senso della non appellabilità dei decreti presidenziali monocratici sia emersa con chiarezza anche nella vigenza dell’art. 84 del Decreto c.d. “Cura Italia”[20]. Infatti, anche in tale caso, l’appellabilità di tali provvedimenti, inserita dapprima nello schema, è stata espunta dalla versione definitiva del decreto.
6. Il principio di effettività della tutela giurisdizionale e il ruolo del giudice.
Deve rilevarsi come la pronuncia in commento, motivando la sua decisione esclusivamente sulla base dell’interpretazione letterale della norma e del principio di sottoposizione del giudice alla legge, evita di operare qualsivoglia riferimento al principio di effettività della tutela giurisdizionale. Tale principio, però, volendo utilizzare la celebre espressione di Chiovenda, è la “vivida stella che irradia la sua luce sull'intero sistema”, volta ad assicurare “tutto quello e proprio quello" che il processo mira a garantire[21] e, come tale, non può non guidare l’attività dei giudici. Del resto, è proprio su questo principio che si fondano le teorie a sostegno dell’appellabilità dei decreti cautelari nei casi eccezionali precedentemente descritti.
In questo senso, dunque, si deve osservare come, se è pur vero che una pronuncia della Corte costituzionale potrebbe risolvere la situazione in maniera chiara, è il giudice del caso concreto a essere chiamato a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale. In relazione a ciò, peraltro, essendo le richieste cautelari connotate da gravità e urgenza, è evidente come l’esperimento di un incidente di costituzionalità (con le sue relative tempistiche) vanificherebbe qualsiasi effettività della tutela per il richiedente.
Ecco, quindi, che pur concordandosi con l’affermato principio di sottoposizione del giudice alla legge e, dunque, con impossibilità per questi di andare contro l’espresso dato normativo, si ritiene che l’esigenza di effettiva tutela richiesta dal ricorrente non possa, comunque, passare in secondo piano, essendo il giudice chiamato a garantirla in ogni situazione.
Potrebbero, pertanto, essere apprezzabili le richiamate pronunce a favore dell’impugnabilità di tale tipo di decisioni, che hanno tentato di delineare dei confini per l’appellabilità dei decreti cautelari monocratici senza utilizzare un approccio netto nel senso dell’ammissibilità delle impugnazioni, ma provando a limitarle ai casi di natura decisoria dei provvedimenti, nonché di compromissione definitiva della situazione concreta. Al proposito, però, non può sottacersi l’effettivo rischio di vanificazione del principio di certezza del diritto, connessa alle differenti qualificazioni dei casi concreti da parte dei singoli giudici.
Inoltre, non può non considerarsi anche come le risalenti (e citate) pronunce dell’Adunanza Plenaria e della Corte costituzionale, volte a consentire l’appello delle ordinanze cautelari nel silenzio della legge, abbiano fondato le loro motivazioni proprio sul fatto che le disposizioni di interesse non contenevano divieti e limiti espressi all’impugnazione. Quanto all’articolo 56 c.p.a. deve, invece, ribadirsi come esso contenga una espressa previsione di inappellabilità dei decreti presidenziali monocratici. In questo senso, effettivamente, l’osservazione della pronuncia in commento circa l’impossibilità per il giudice di operare una interpretazione contra legem è più che pertinente.
7. Considerazioni conclusive.
È evidente come la questione dell’appellabilità dei decreti cautelari monocratici sia tuttora aperta nell’ambito della giurisprudenza amministrativa, la quale continua a far registrare orientamenti opposti in seno alle differenti Sezioni, a prescindere dalla parentesi rappresentata dalla vigenza dell’art. 84 del D.L. 18/2020 del periodo pandemico. Ciò, del resto, conferma la perdurante sussistenza di questioni controverse nell’ambito della tutela cautelare del processo amministrativo[22].
Sarebbe, dunque, alla luce delle considerazioni sopra svolte, auspicabile un intervento del Legislatore sul punto o, quantomeno una pronuncia chiarificatrice dell’Adunanza Plenaria. Invero, l’esistenza di orientamenti così contrastanti (o, addirittura, opposti) potrebbe comportare delle diversificazioni rilevanti nella tutela degli interessi dei consociati, i quali, a seconda della Sezione competente, troverebbero forme di tutela contrapposte. È evidente come ciò possa produrre una intollerabile situazione di disparità di trattamento.
Inoltre, come già osservato, questioni problematiche sorgono anche in relazione al principio della certezza del diritto, messo a dura prova dalle differenti opinioni delle varie Sezioni del Consiglio di Stato.
[1] In particolare, si sta facendo riferimento all’art. 84 del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18 (“Cura Italia”), il quale, per il periodo ricompreso tra l’8 marzo 2020 e il 15 aprile 2020, oltre ad aver disposto la sospensione di tutti i termini relativi al processo amministrativo, nonché il rinvio delle udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti, ha previsto che “i procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono decisi con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui delegato, con il rito di cui all'articolo 56 del codice del processo amministrativo, e la relativa trattazione collegiale è fissata a una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020”.
[2] Tra gli altri, si menzionano i decreti presidenziali n. 6534 del 2021 e n. 798 del 2022 (quest’ultimo richiamato nella sua parte motiva dallo stesso decreto che qui si sta annotando).
[3] Tar Campania, Sez. dist. Salerno, 23 aprile 2022, n. 174.
[4] L’unica affermazione non condivisa del richiamato decreto è quella relativa alla esclusione della necessità di fissare “una inconfigurabile trattazione in sede camerale-cautelare in grado di appello”.
[5] Esso affermava che “prima della trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente può, contestualmente alla domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. Il presidente provvede con decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio. Il decreto è efficace sino alla pronuncia del collegio, cui l'istanza cautelare è sottoposta nella prima camera di consiglio utile. Le predette disposizioni si applicano anche dinanzi al Consiglio di Stato, in caso di appello contro un'ordinanza cautelare e in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata”.
[6] Sul punto, per una riflessione più approfondita, si veda R. LEONARDI, La tutela cautelare nel processo amministrativo. Dalla L. n. 205/200 al Codice del Processo Amministrativo, Giuffré editore, Milano, 2010, pp. 208ss.
[7] In dottrina tale contraddittorio viene qualificato come embrionale e deformalizzato (F. CARINGELLA, Manuale ragionato di diritto amministrativo, II ed., Dike giuridica, Roma 2020, pp. 1541ss.).
[8] Sebbene l’articolo 56 c.p.a. menzioni espressamente soltanto il presupposto del periculum in mora, dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere necessaria una ricognizione, anche se sommaria, del fumus boni iuris da parte del giudice. Diversamente opinando, si contraddirebbe il fondamentale principio di strumentalità della tutela cautelare, potendosi attribuire, seppur temporaneamente, situazioni di vantaggio non giustificate dall’esigenza di garantire l’esito della decisione finale. Sul punto A. TRAVI, Lezioni di giustizia amministrativa, XIII ed., Giappichelli Editore, Torino, 2019, pp. 285 ss.
[9] In particolare, R. LEONARDI, ha affermato che “la centralità assunta dalla tutela cautelare nel processo amministrativo ha dato vita a un continuo susseguirsi di norme e di orientamenti giurisprudenziali, nazionali ed europei, che nel tempo ne hanno cambiato profondamente, e continuano a farlo, la fisionomia e i contenuti.” (R. LEONARDI, La tutela cautelare nel processo amministrativo. Dalla L. n. 205/200 al Codice del Processo Amministrativo, Giuffré editore, Milano, 2010, p. 3).
[10] I. GENUESSI, Sull’appellabilità del decreto cautelare monocratico: tra esigenze di tutela conseguenti alla pandemia e orientamenti giurisprudenziali contrastanti, in Giustiziainsieme.it, 20 aprile 2021.
[11] Cons. St., Sez. V, decreto monocratico, 7 dicembre 2018, n. 5971.
[12] In questo senso, Cons. St., Sez. III, decreto monocratico, 10 marzo 2021, n. 1224.
[13] Cons. St., Sez. III, 30 marzo 2020, n. 1553.
[14] Cons. St., Sez. III, 27 aprile 2020, n. 2294.
[15] Il dibattito giurisprudenziale era sorto a causa dell’articolo 28, co. 2, della L. 1034/1971, il quale prevedeva l’appello in Consiglio di Stato per le sentenze emesse dai T.A.R., nulla disponendo, invece, quanto alle ordinanze. Sul tema si veda, A. DE SIANO, Tutela cautelare monocratica e doppio grado di giudizio, in Federalismi.it, 8 gennaio 2020.
[16] Cons. St., Ad. Pl., 20 gennaio 1978, n. 1.
[17] Corte costituzionale, 14 gennaio 1982, n. 8.
[18] Così, Cons. St., Sez. V, 19 luglio 2017, n. 3015.
[19] C.g.a., Sez. giuris., 25 agosto 2020, n. 624. Sul punto si veda M.A. Sandulli, Sugli effetti pratici dell’applicazione del’art 84 d.l. n. 18 del 2020 in tema di tutela cautelare: l’incertezza del Consiglio di Stato sull’appellabilità dei decreti monocratici, in Federalismi.it, Osservatorio emergenza Covid–19, 31 marzo 2020.
[20] I. GENUESSI, Sull’appellabilità del decreto cautelare monocratico: tra esigenze di tutela conseguenti alla pandemia e orientamenti giurisprudenziali contrastanti, in Giustiziainsieme.it, 20 aprile 2021.
[21] G. CHIOVENDA, Istituzioni di diritto processuale civile, Napoli, 1960.
[22] Come osservato da F. Francario, Diritto dell’emergenza e giustizia nell'amministrazione. No a false semplificazioni e a false riforme, in Osservatorio Emergenza Covid-19, 13 marzo 2020, anche le norme dettate nel periodo di emergenza in tema di tutela cautelare “non rispondono ad alcun principio e si disperdono in una confusa e contraddittoria disciplina di dettaglio di cui non si sentiva affatto la necessità e che finisce con il produrre un generale disorientamento”.

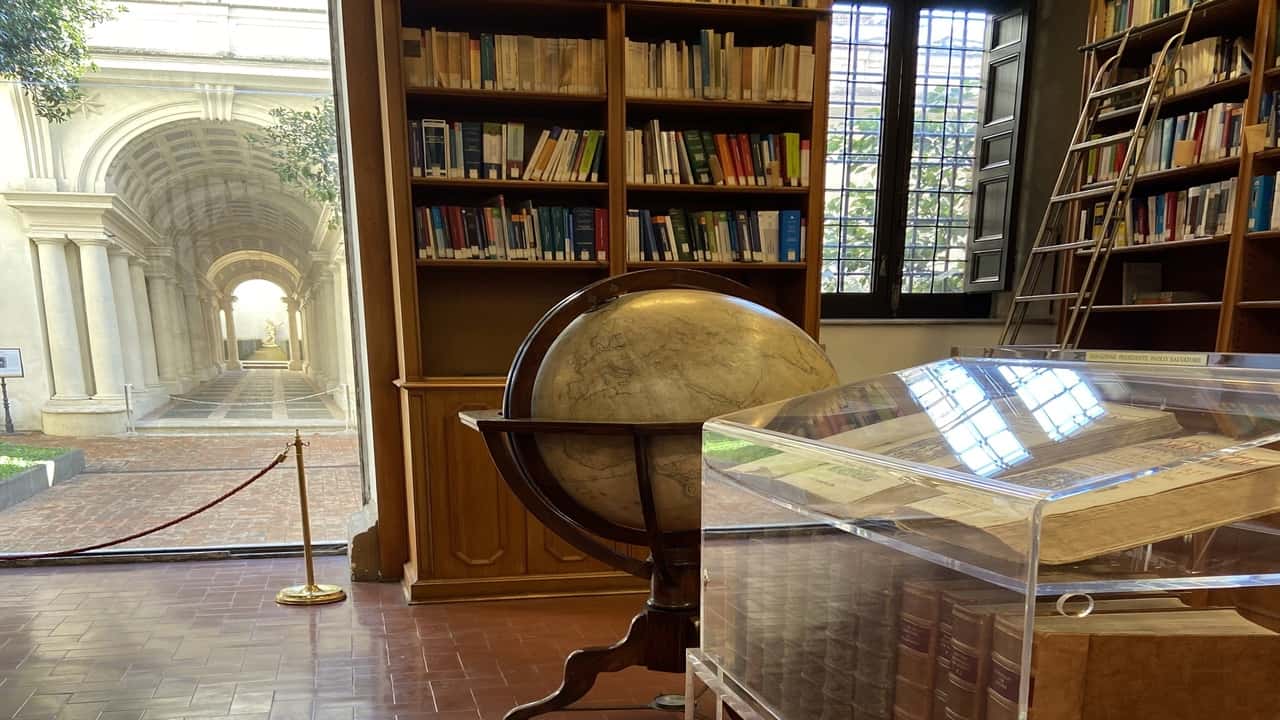

 E poi Aggiungi alla schermata principale.
E poi Aggiungi alla schermata principale.