In un momento così difficile per il mondo e per l’Unione Europea l’ultimo libro di Pasquale Gianniti − L’antico sogno degli Stati Uniti d’Europa tra integrazione politica e dialogo delle Corti Supreme − ci porta a riflettere sulla necessità di perseguire con nuove energie l’antico sogno di realizzare gli Stati uniti di Europa (o comunque altro modello di coesione) e lo fa muovendo da una approfondita analisi di carattere storico dalla quale si desume che, fin dai tempi di Carlo Magno, è stata avvertita l’esigenza di unificare l’Europa senza successo per varie ragioni. Finché, dopo alterne vicende, nel corso della Seconda guerra mondiale, Ernesto Rossi e Altiero Spinelli redassero il Manifesto per un’Europa unita e libera, che fu il punto di partenza per il Congresso europeista dell’Aia del 1948.
Il manifesto di Ventotene è quindi il primo seme dell’europeismo, inteso come volontà di superare le divisioni e i conflitti tra le nazioni europee, in particolare dopo le due guerre mondiali, per creare un’unione di pace e prosperità.
Infatti, poco dopo la Dichiarazione Schuman (1950) ha portato alla nascita di diverse istituzioni e trattati che hanno gettato le basi per l’attuale Unione Europea.
La costruzione è stata favorita e migliorata grazie soprattutto alla Corte di Giustizia e ai rapporti sempre più stretti e frequenti dei giudici europei tra loro e con la Corte di Giustizia.
Parallelamente, grazie all’istituzione del Consiglio d’Europa e al suo interno alla approvazione della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e quindi all’inizio del funzionamento della Corte di Strasburgo, si è perseguito l’obiettivo della salvaguardia e dello sviluppo dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti i 46 Stati membri del Consiglio d’Europa.
La giurisprudenza delle suddette due Corti europee centrali è diventata sempre più importante, nel corso del tempo, per i giudici nazionali ed ha, in primo luogo, consentito di ampliare le tutele delle posizioni giuridiche soggettive, specialmente in favore di soggetti socialmente più deboli, che sono anche quelli per i quali il rischio di discriminazione e/o di violazione della pari dignità è più alto, secondo le parole dell’allora Presidente della Corte costituzionale Francesco Saja, nella presentazione dalla nota “svolta” giurisprudenziale del 1987, che ha portato la Corte ha ritenere che fosse necessario: (i) riferire l’art. 2 Cost. non soltanto ai diritti fondamentali garantiti da altre disposizioni della stessa Carta fondamentale, per affermare che il suddetto articolo contiene un «elenco aperto», di diritti fondamentali; (ii) per dare “energica attuazione in numerosissime occasioni al principio di eguaglianza enunciato dall’art. 3 Cost.” considerare l’indicazione dei fattori di possibile discriminazione di cui al primo comma dell’articolo 3 non di carattere tassativo, ma da riferire soltanto alle situazioni più frequenti.
Il dialogo con le Corti europee centrali ha consentito di potenziare la suddetta indicazione della Corte costituzionale con risultati molto importanti per la tutela della dignità umana e sociale delle persone, che è alla base delle nostre democrazie, con pronunce che non solo hanno riguardato i singoli casi ma tutto il sistema (UE e Consiglio d’Europa) di riferimento.
La tutela della dignità delle persone per entrambe la Corte deve essere effettuata nel rispetto del valore dello Stato di diritto e dei principi della separazione dei poteri e dell’indipendenza della magistratura perché non rispettare tali principi non può non avere ricadute sul rispetto della dignità umana e sociale delle persone.
Nel libro Pasquale Gianniti si sofferma sulle modalità di funzionamento della Corte di Giustizia e degli altri organi giurisdizionali UE oltre che della Corte di Strasburgo e da questa analisi, svolta con metodo storico, desumiamo molte interessanti informazioni che ci consentono di conoscere più da vicino i due suddetti sistemi giurisdizionali, molto diversi da quelli nazionali.
Viene anche sottolineato che l’azione dell’Unione ha sempre affondato le sue radici nel quadro generale della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dei due Patti sui diritti umani del 1966, che costituiscono il paradigma del sistema internazionale di tutela dei diritti umani. Essa, pertanto, riconosce il principio dell’universalità dei diritti umani; il principio della loro indivisibilità (che vieta, almeno in teoria, qualsiasi gerarchizzazione tra diritti civili e politici, da un lato, e diritti economici, sociali e culturali, dall’altro); il principio dell’interdipendenza tra diritti umani, democrazia e sviluppo.
Pertanto, la tutela dei diritti umani si realizza in una pluralità di livelli — tradizioni nazionali, giurisprudenza della Corte di giustizia, vincolatività della Carta dei diritti umani fondamentali e delle altre Carte e Convenzioni — e questo rende lo spazio democratico dell’Unione quello a più sicura garanzia per i loro titolari.
In questo contesto hanno molta rilevanza i principi che trovano espresso riconoscimento nei trattati, tra i quali rientrano:
— il principio di uguaglianza, che, già affermato a livello nazionale e sovranazionale e già riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte, è ora sancito: sia dal tue all’art. 2, sia dal tfue agli artt. 8 e 10, sia soprattutto dalla Carta ue, che dedica un intero titolo, il terzo, alla salvaguardia dell’uguaglianza. Va rilevato che il riconoscimento di tale principio nasce dal dialogo tra la Corte di Giustizia con i giudici nazionali dei Paesi nella cui Costituzione il principio è previsto (l’art. 3 della Cost. italiana, l’art. 1 della Cost. francese, l’art. 7 della Cost. austriaca, l’art. 9 della Cost. spagnola, l’art. 3 della Cost. tedesca, l’art. 11 della Costituzione belga). A livello sopranazionale, il principio è riconosciuto dall’art. 7 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, dall’art. 14 della Convenzione edu, da diverse disposizioni del Patto per i diritti civili e politici, dall’art. 4 della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, adottata dal Consiglio d’Europa;
— il divieto di discriminazione, già riconosciuto dalla Corte di giustizia come un corollario del principio di uguaglianza;
— il principio di sussidiarietà, in base al quale la disciplina generale è devoluta all’attività legislativa ed amministrativa degli organismi che sono più vicini alle collettività destinatarie delle disposizioni comunitarie, che costituisce dagli inizi un presupposto basilare dell’ordinamento europeo e che ora è sancito dall’art. 5 tue (già art. 5 tce);
— il principio di proporzionalità (previsto dall’art. 5 paragrafo 4 tue), secondo il quale la legittimità di un atto comunitario va valutata in base alla sua idoneità o necessità rispetto agli obiettivi dei trattati;
— il principio di leale collaborazione, in base al quale ogni istituzione deve ispirare il proprio comportamento ad atteggiamenti cooperativi, in particolare in quelle ipotesi in cui vi siano sovrapposizioni o interferenze di competenze (affermato dall’art. 4 par. 3 tue e dalla Corte di giustizia);
— i principi in materia ambientale, che sono previsti dall’art. 191 par. 2 tfue), in base al quale la normativa europea è fondata sui principi: della precauzione (per cui, laddove un’azione sia potenzialmente dannosa, chi la pone in essere è tenuto ad adottare delle misure cautelative), dell’azione preventiva (per cui deve essere intrapresa ogni azione utile a prevenire danni all’ambiente), della correzione (per cui devono essere rimossi tutti i danni arrecati all’ambiente da parte dello stesso soggetto che li ha posti in essere), nonché sul principio che chi inquina paga (alla luce del quale coloro che causano danni all’ambiente devono sostenere i costi per ripararli o per rimborsare tale danni);
— il principio della tutela dei diritti fondamentali, che, già affermato dalla Corte di giustizia con sentenza n. 29/60 Stauder c. Città di Ulm– Sozialamt e con sentenza n. 36/75, Rutili c. Ministre de l’Interieur, è ora sancito dalla Carta ue, che costituisce parte integrante dei Trattati;
— il principio di attribuzione (art. 5 e art. 13 par. 2 tue), in base al quale l’Unione (rispetto agli Stati membri) e le sue istituzioni europee (nei loro rapporti) agiscono esclusivamente nei limiti delle competenze.
Si aggiunge che molti sono i principi generali di diritto UE desunti dalla Corte di Giustizia, tra i quali il principio della certezza del diritto (per cui la normativa europea deve essere chiara e la sua applicazione prevedibile per i destinatari) e il connesso principio del legittimo affidamento (per cui vanno tutelate le situazioni soggettive che si sono consolidate in conseguenza ad atti posti in essere dalle amministrazioni pubbliche) o di rispetto dei diritti quesiti, ecc.
Dopo un ampio e interessante approfondimento sul diritto derivato UE e sulla Carta dei diritti fondamentali UE e sulla relativa interpretazione e applicazione, in un confronto tra Carta UE e Convenzione EDU viene, in primo luogo, precisato che l’art. 52 della Carta — nell’indicare i criteri che il giudice nazionale deve tener presente per stabilire il significato del diritto fondamentale garantito dalla Carta che di volta in volta viene in rilievo — apre tre possibili scenari, in quanto:
- può accadere che il diritto fondamentale previsto dalla Carta “ricalchi” una norma del Trattato (cfr. art. 52, par. 2, cdf; questo è il caso di vari diritti contenuti nel titolo V della Carta sulla “Cittadinanza”);
- può accadere infine che il diritto fondamentale previsto dalla Carta corrisponda ad una tradizione costituzionale comune agli Stati membri (art. 52, par. 4, Carta dell’Unione).
- può accadere che il diritto fondamentale previsto dalla Carta corrisponda ad un diritto garantito dalla Convenzione EDU: nel qual caso opera la regola di interpretazione di cui all’art. 52, par. 3, che si occupa per l’appunto dell’interpretazione dei diritti fondamentali della Carta che corrispondono a diritti fondamentali già garantiti dalla Convenzione EDU. In tal caso, «il significato e la portata [del diritto fondamentale in base alla Carta] sono uguali a quelli [del diritto Convenzione edu corrispondente]». Ne deriva che il giudice nazionale che applica una norma della Carta deve in primo luogo chiedersi se essa corrisponda ad un diritto convenzionale edu. Se questo è il caso, allora dovrà ricostruire il significato e la portata del diritto fondamentale previsto dalla Carta tenendo conto della sua formulazione nella Convenzione edu, e soprattutto della pertinente giurisprudenza della Corte edu. Tuttavia, lo stesso art. 52, par. 3, della Carta dell’Unione aggiunge che la regola di interpretazione parallela «non preclude che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa». Dunque, il giudice nazionale dovrà far riferimento anche alla formulazione del diritto nella Carta e alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia, e a questi dovrà dare preferenza ove accordino una tutela più estesa (dal punto di vista della ricostruzione del significato e/o della portata del diritto) di quanto non facciano la Convenzione edu e la Corte edu. Per assistere il giudice nazionale nell’applicazione della regola di cui all’art. 52, par. 3, della Carta, la Spiegazione di questa norma fornisce due elenchi di diritti: il primo, contenente i diritti della Carta con lo stesso significato e la stessa portata dei corrispondenti diritti cedu; e l’altro relativo ai diritti della Carta che hanno lo stesso significato dei corrispondenti diritti cedu, ma portata più ampia.
Quest’ultima evenienza è la più problematica in quanto, sulla base della giurisprudenza della Corte di Giustizia, da un lato, è consentita l’immediata efficacia della disposizione della Carta UE (che, se di derivazione cedu, non può assumere un livello di protezione inferiore a quello convenzionale) ma, dall’altro, si esclude l’immediata efficacia della norma convenzionale e la sua prevalenza rispetto al dato normativo interno con essa incompatibile.
Quanto ai rapporti tra il diritto interno e la Convenzione edu, si ricorda la sentenza n. 317 del 4 dicembre 2009, nella quale (punto 7 del Considerato in diritto) la Corte ha espressamente rilevato che: «il confronto tra tutela convenzionale e tutela costituzionale dei diritti fondamentali deve essere effettuato mirando alla massima espansione delle garanzie, anche attraverso lo sviluppo delle potenzialità insite nelle norme costituzionali che hanno ad oggetto i medesimi diritti»; e che: «nel concetto di massima espansione delle tutele deve essere compreso, come già chiarito nelle sentenze nn. 348 e 349 del 2007, il necessario bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, cioè con altre norme costituzionali, che a loro volta garantiscano diritti fondamentali che potrebbero essere incisi dall’espansione di una singola tutela. Questo bilanciamento trova nel legislatore il suo riferimento primario, ma spetta anche a questa Corte nella sua attività interpretativa delle norme costituzionali».
Sentenza, peraltro, seguita dalle numerose pronunce nelle quali la Corte costituzionale ha affermato che “a differenza della Corte EDU, questa Corte … opera una valutazione sistemica, e non isolata, dei valori coinvolti dalla norma di volta in volta scrutinata, ed è, quindi, tenuta a quel bilanciamento, solo ad essa spettante”, che, nelle singole fattispecie si traduce nelle soluzioni indicate.
Ampio spazio è dedicato alla mancata adesione della UE alla CEDU e al rapporto tra Corte costituzionale e Corte di Giustizia, nei mutamenti avutisi nel tempo.
Nella parte finale del libro, di carattere geopolitico, si affronta il tema della necessità di “ripensare all’Europa”, muovendo dalla premessa che per i c.d. Padri fondatori dell’odierna Europa, l’esito del processo di integrazione avrebbe dovuto essere la creazione di istituzioni politiche federali e, quindi, la creazione degli Stati Uniti d’Europa, sicché l’attuale unificazione europea è una opera incompiuta, anche se è stato progressivamente ampliato il numero dei settori coinvolti nel processo di integrazione e delle funzioni attribuite alle istituzioni europee ed è stata creata la moneta unica.
Vi sono però delle controindicazioni; in primo luogo, vi è la questione della scarsa democraticità dell’attuale assetto delle istituzioni europee.
Secondo lo spirito del Trattato sull’Unione, poiché sono democratici sia il circuito sovranazionale che il circuito intergovernativo, dovrebbe essere democratico anche il prodotto dei due circuiti, cioè il funzionamento complessivo dell’Unione.
Tuttavia, osserva l’Autore, questa democraticità, per così dire indiretta, non sembra sufficiente:
- per il Parlamento europeo è sì un organo politico decisionale, che è composto di rappresentanti dei cittadini dell’Unione (art. 14 tue) e, quindi, vanta un collegamento elettorale diretto con quest’ultimi il Trattato non chiarisce se ciascun parlamentare europeo rappresenta tutti i cittadini dell’Unione (come dovrebbe essere in linea con le tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, che prevedono quasi tutte il divieto di mandato imperativo) ovvero soltanto quelli dello Stato membro, nel cui collegio è stato eletto (come sembra doversi desumere dal fatto che i seggi vengono assegnati agli Stati membri, secondo il criterio della proporzionalità degressiva rispetto alla popolazione, nonché dal fatto che cittadini di diversi Stati votano necessariamente in diversi collegi elettorali);
- i governi degli Stati membri esercitano collettivamente, nel Consiglio Europeo, la funzione legislativa, approvando così collettivamente regole che sono immediatamente efficaci e prevalenti su quelle deliberate dai parlamenti nazionali. Ma ciascun componente del Consiglio, pur contribuendo all’assunzione di provvedimenti efficaci nei confronti di tutti i cittadini europei, rappresenta soltanto una sola parte di essi — i cittadini di un singolo Stato membro — e solo a quella parte risponde;
- la Commissione UE, che in un certo qual modo è il governo dell’Unione, opera nell’interesse generale dell’Unione, ma è composta da 27 commissari (uno per ciascun Paese dell’Unione) a ciascuno dei quali viene attribuita la competenza per uno specifico settore tematico, insieme all’autorità sui relativi servizi amministrativi. Quindi vi è il pericolo che ciascun Commissario non abbia la visione generale dei problemi da risolvere, ma si occupi solo dello specifico settore tematico di competenza. Inoltre, il Presidente della Commissione rappresenta sì l’Unione, ma trae la propria legittimazione esclusivamente da un organo intergovernativo. E ciò rappresenta un ulteriore profilo del deficit democratico;
- infine, singolare è la posizione della Banca Centrale Europea, che, pur governando la politica monetaria dell’Unione (e, dunque, pur gestendo un forte potere), può rimanere, anche a lungo, irresponsabile del proprio operato dal punto di vista politico. Sotto questo profilo, è necessario non soltanto un governo economico, preludio di un governo politico, al quale la bce possa fare riferimento ma anche che la Banca sia responsabile del suo operato dinanzi ai Parlamenti nazionali ed al Parlamento europeo.
Per evitare derive antieuropeiste che possono manifestarsi in questa situazione di scarsa democraticità interna l’Autore auspica la formazione di organi decisionali che — rappresentando l’Unione nel suo insieme, e, nel contempo, avendo un collegamento elettorale con i cittadini europei — siano autenticamente sovranazionali.
Da anni l’Unione Europea non riesce ad affrontare in modo adeguato alcune questioni di grande rilievo, a partire dalla immigrazione e dalla creazione di una capacità fiscale europea, dotata di indipendenza e rilevanza, espressione di una nuova sovranità europea da affiancare a quella degli Stati nazionali.
Queste sono tra le più rilevanti questioni strategiche, con importanti ricadute economiche, ma da anni non si riesce a risolverle come meriterebbero.
Ma la controindicazione maggiore è rappresentata dal fatto che oggi i governi degli Stati membri hanno una diversa visione del futuro dell’integrazione europea. A fronte di alcuni Paesi favorevoli ad una maggiore integrazione (come Francia, Spagna, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Malta), ve ne sono altri che sostengono il mantenimento dello status quo, pur con qualche aggiustamento (come la Germania, la Finlandia, i Paesi Bassi); e c’è poi il blocco dei Paesi sovranisti (Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca); e ve ne sono altri ancora (come l’Italia, che è peraltro un Paese Fondatore) la cui linea politica è decisamente incerta.
Però per fare fronte all’emergenza COVID e per deliberare le sanzioni nei confronti di Putin dopo l’invasione dell’Ucraina la risposta di tutti i Paesi UE è stata unitaria.
Con questo stesso spirito andrebbe affrontata l’attuale congiuntura che richiede coesione perché solo a questa condizione, nello scenario internazionale, l’Unione Europea potrebbe avere un posto di rilievo non solo come mercato ma anche come portatrice di un modello culturale di organizzazione della vita sociale, che è astrattamente suscettibile di estendersi in ogni parte del globo e che si articola in tre fondamentali idee madri: la democrazia rappresentativa, il mercato ed il c.d. rule of law.
In particolare, sul terreno del diritto e dei suoi strumenti l’Unione europea rappresenta un esempio a livello globale. Ne fanno fede la sua Carta dei diritti, i suoi Trattati, l’efficacia immediata nel diritto nazionale delle sue direttive, la presenza di due Corti che emanano decisioni importanti, nuovi strumenti quali la nuova Procura europea, il mandato di arresto e tutti gli altri istituti di cooperazione.
La fissazione di regole condivise e di organi di giustizia comuni hanno consentito il formarsi di una “cultura giuridica europea” sempre più integrata, che pone al centro la persona umana.
Questo modello culturale di riferimento rappresenta la grande, impareggiabile, forza dell’Unione, che tutto il mondo ci invidia.
Ma l’integrazione tra gli Stati membri dell’Unione non può procedere soltanto attraverso la giurisprudenza e le nomofilachie delle corti supreme (nazionali ed europee), perché richiede decisioni politiche da parte delle competenti istituzioni, rappresentative sul piano nazionale di ciascuno Stato membro.
Sotto questo profilo, l’auspicio è che, sulla scena politica europea vi siano statisti, che sappiano integrare i singoli interventi in progetti politici unitari, superando sovranismi nazionali e impostazioni individualistiche (come accadde negli anni Cinquanta del secolo scorso con Alcide De Gasperi, Konrad Adenauer, Robert Schuman).
Questo è l’auspicio di fondo che l’Autore formula come messaggio di un libro denso di informazioni storiche, geopolitiche, giuridiche condite da acute osservazioni nel quale viene affrontato, con serietà e con uno stile letterario fluido, un argomento di cui si parla da decenni ma che oggi, nell’era Trump, è diventato di stringente attualità perché se l’Unione Europea in ambito internazionale non si pone come un unico soggetto forte rischia l’irrilevanza.

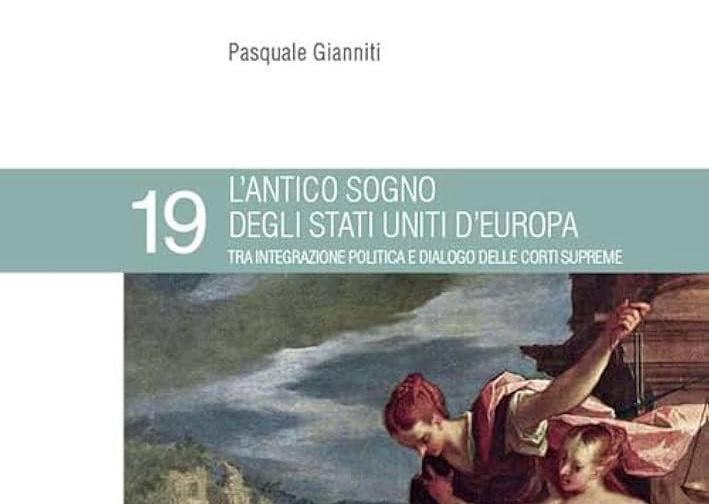

 E poi Aggiungi alla schermata principale.
E poi Aggiungi alla schermata principale.