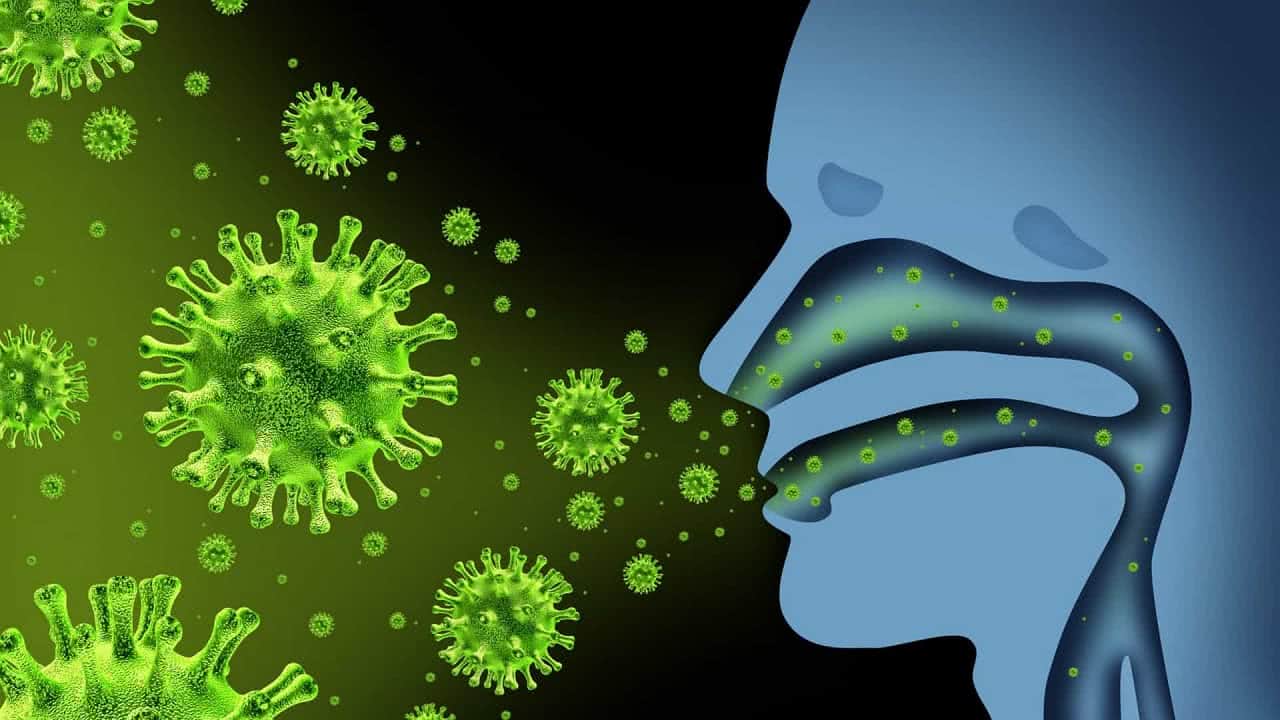Giudice e precedente: per una nomofilachia sostenibile*
di Franco De Stefano
[
[sul ruolo della Corte di Cassazione v.su questa Rivista, A. Scarpa, Nomofilachia codificata e supremazia dei precedenti, 23 febbraio 2021 e R. Conti, Nomofilachia integrata e diritto sovranazionale. I "volti" delle Corte di Cassazione a confronto, in questa Rivista, 4 marzo 2021]
Sommario: 1. Prologo – 2. Giurisprudenza e sistema delle fonti – 3. Il ruolo del precedente e la certezza del diritto – 4. La certezza del diritto in tensione dialettica con le esigenze del cambiamento – 5. Il ruolo del precedente nella disciplina processuale – 6. La forza indiretta del precedente – 7. Una nomofilachia consapevole e responsabile – 8. I progetti tematici – 9. La rilevanza interna del principio di diritto – 10. Epilogo.
1. Prologo.
In un dibattito complessivo sul ruolo della Corte di cassazione nel sistema giudiziario civile italiano è indispensabile prendere le mosse dalle chiare coordinate costituzionali, che disegnano un giudice soggetto soltanto alla legge ed impongono l’ammissibilità sempre e comunque, contro le “sentenze”, del ricorso per cassazione per violazione di legge; ma anche dall’evidente involuzione del sistema nel senso di un incremento esponenziale del contenzioso, segnale preoccupante dell’insoddisfatta domanda di giustizia in un contesto di eccezionale crescente complessità anche nei rapporti tra fonti ed ordinamenti anche su più livelli concorrenti.
La nomofilachia, dall’antico ellenico (i sostantivi nomos - legge - e phylakìa - guardia - quale sinonimo di phylaké[1]), è appunto la custodia (del retto significato) della legge, in ultima analisi dell’ortodossia (anche in questo caso dall’antico ellenico orthos - giusto o corretto - e doxa – opinione - da cui già in quella lingua orthodoxìa) del diritto. Ci si chiede allora se la nomofilachia, che resta un valore già soltanto per positiva definizione di legge e quindi per scelta del legislatore, possa essere adeguata alle attese della moderna società in tumultuosa evoluzione: come, in sostanza, essa possa dirsi sostenibile in questo ambiente sociale e culturale, caratterizzato, nel campo giuridico, da un rapporto interattivo tra il giudice ed il precedente giurisprudenziale.
L’esigenza di conciliare la “qualità” e la “quantità” del prodotto giurisdizionale della Corte di cassazione – di come, quindi, questa Corte possa dirsi sostenibile nel sistema anche nel senso di svolgere una funzione utile e coerente – deve farsi carico allora di esaminare senza ipocrisie la situazione attuale[2], al fine di offrire una risposta che possa dirsi la più in linea possibile col dato normativo vigente e quindi de iure condito, senza rinunciare però ad una riflessione anche de iure condendo. E sempre in un equilibrio dinamico tra lo ius litigatoris e lo ius constitutionis, che connotano da sempre il giudizio di legittimità nazionale.
Ma l’analisi non può mancare di un momento progettuale, dinanzi alla constatazione della insostenibilità della situazione attuale, anacronistica in un contesto globalizzato dove si esige affidabilità e prontezza, spesso misurata in nanosecondi, di ogni decisione; ed occorre chiedersi se non sia il caso di tentare una selezione degli obiettivi ragionevolmente raggiungibili nel contesto dato in base ad un ordine assiologico chiaro.
È auspicabile che ogni tentativo di reinterpretazione della struttura processuale vigente e, al suo interno, della nomofilachia sia orientato a considerarla quale suo valore fondante, in costante tensione dialettica tra il principio della soggezione del giudice soltanto alla legge e quello della certezza del diritto quale precondizione del quotidiano percorso verso l’uguaglianza sostanziale e l’effettiva tutela della dignità della persona.
2. Giurisprudenza e sistema delle fonti.
Le brevi osservazioni che qui si svolgono si riferiscono al diritto ed al processo civile.
Può definirsi una conclusione pacifica che l’ordinamento giuridico italiano non annovera la giurisprudenza dei giudici comuni - al di là quindi di quella costituzionale - nel sistema delle fonti del diritto, poiché anche i provvedimenti giudiziari che enunciano “principi di diritto” hanno il solo ruolo di comprimari nell’interpretazione delle norme giuridiche: la giurisprudenza comune, pertanto, mantiene una funzione essenzialmente dichiarativa e non altera, né integra la norma interpretata.
Soltanto in via mediata, peraltro, è accettata l’idea della dottrina e della giurisprudenza come fonti integrate di diritto[3]: ed in tanto può accettarsi tale conclusione, in quanto l’una e l’altra sono obiettivamente in grado di influire, talvolta in modo determinante anche negli ordinamenti che non vi riconoscono un ruolo formale, sulla conformazione concreta delle regole di diritto e sul sistema delle loro interazioni.
È certo tuttavia che la giurisprudenza, neppure quando si presenta in quella sua species peculiare che è il precedente in senso stretto[4] (e che, in via descrittiva, può indicarsi nella pronuncia riferita ad un caso plausibilmente suscettibile di generalizzazione o di apprezzabile reiterazione e quindi idonea a regolare una serie potenzialmente indefinita di fattispecie analoghe o simili), non implica, neppure quando è articolata sull’enunciazione esplicita di un principio di diritto, la codificazione di una norma di dettaglio a corredo di quella interpretata, ma si mantiene invece, formalmente e sostanzialmente, entro la struttura e la funzione di un’enunciazione della regola di giudizio applicata, benché suscettibile di applicazione in fattispecie uguali o analoghe[5].
L’ordinamento italiano, come tutti quelli tradizionalmente ricondotti alla struttura di civil law, non riconosce formalmente al precedente giurisprudenziale, quand’anche proveniente dagli organi di vertice delle rispettive giurisdizioni, un carattere vincolante in senso stretto, nel senso di imporsi quale regola di giudizio a sé stante al decidente di casi diversi: e pure la Corte costituzionale riconosce alla giurisprudenza una funzione essenzialmente dichiarativa[6].
D’altra parte, non è nuovo il rilievo che il riferimento al precedente non è più, da tempo, una caratteristica peculiare degli ordinamenti di common law, essendo ormai diffuso anche in quelli di civil law, allo stesso modo in cui nei primi è sempre più diffuso il ricorso alla legge scritta e ad una vera e propria codificazione di sempre maggiori settori del diritto[7].
Eppure, sebbene nel sistema non operi il canone di stare decisis[8] tipico degli ordinamenti di common law, la circostanza che un principio di diritto risulti nel tempo fissato in una massima di diritto non è senza effetti: un indirizzo costante e ripetuto negli anni comporta la formazione di una situazione qualificata come di “diritto vivente”, che esprime la norma di legge contestualizzata dai principi di diritto che ad essa afferiscono; situazione questa che crea affidamento nella tendenziale stabilità del quadro normativo e nella certezza dei rapporti giuridici.
Nel nostro ordinamento giuridico, caratterizzato dalla complessità dell’insieme delle norme che lo compongono, l’attività interpretativa della giurisprudenza svolge una funzione di completamento delle norme stesse che, pur nella dialettica delle possibili diverse soluzioni interpretative, confluisce infine a realizzare la “uniforme interpretazione della legge” e la stessa “unità del diritto oggettivo nazionale”, di cui è menzione nel richiamato art. 65 ord. giud. (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12).
Tale è il diritto vivente, categoria da tempo ben nota sul piano del giudizio di costituzionalità, tanto che la Consulta, cui si deve la teorizzazione della relativa dottrina[9], tende a dichiarare inammissibili o manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal giudice rimettente su un presupposto interpretativo contrastante con il diritto vivente.
In primo luogo, solo in tempi relativamente recenti si è rafforzata normativamente in Italia l’obbligatorietà dell’enunciazione del principio di diritto in caso di cassazione ed il relativo istituto è stato rivitalizzato con le riforme del giudizio di legittimità, nonostante le perplessità di parte della Dottrina.
Ai limitati fini di queste riflessioni, può proporsi operativamente e descrittivamente il principio di diritto come una species del genus del precedente giurisprudenziale, in cui l’enunciazione della regola di diritto applicata in concreto dal giudicante è esplicita e formale, anche a fini di immediata identificazione ad opera vuoi del giudice del rinvio, vuoi della generalità dei consociati cui essa è diretta.
È vero che soprattutto l’enunciazione del principio di diritto in termini generali ed astratti si presta ad una generalizzazione tale da offrirne una funzione integratrice del comando contenuto nella norma, non soltanto esplicativa del suo contenuto, ma appunto di produzione della norma da applicare alla fattispecie concreta e, di conseguenza, ad una serie potenzialmente indefinita di fattispecie analoghe future o diverse: con caratteri, così, di per sé assimilabili a quelli della norma stessa.
Ed è altrettanto vero che il principio di diritto, anche al di là della sua formale enunciazione, può comunque ricavarsi dalla ragione posta a base della singola decisione del giudice: anzi, normalmente integrando la motivazione appunto la stessa esposizione dei passaggi argomentativi che, dal giudizio di fatto, hanno condotto il giudicante a quello conclusivo di diritto e, quindi, alla regolazione della fattispecie.
Tuttavia, nell’ordinamento italiano il principio di diritto, come il (più o meno autorevole) precedente giurisprudenziale pure non articolato nell’enunciazione esplicita di una regola generale ed astratta e che si limiti ad applicarla rimettendo all’attività dell’interprete la sua enucleazione, non è tecnicamente vincolante e non ha il rango di fonte del diritto. E suole dirsi che la sua valenza sta nella sua persuasività, cioè nella sua idoneità, per la coerenza del processo decisionale e motivazionale espresso, a convincere la platea potenzialmente indefinita di operatori del diritto in generale e dei futuri decisori in particolare[10].
3. Il ruolo del precedente e la certezza del diritto.
L’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale sul ruolo del precedente nell’ordinamento è vastissima[11].
La stabilità della giurisprudenza è solitamente ricondotta alle esigenze imposte dai principi generali di uguaglianza e della certezza del diritto: e. quanto al primo, è intuitivo che uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge significa anche uguaglianza dinanzi alle interpretazioni della legge, uguaglianza di trattamento in sede giurisdizionale[12].
Dal canto suo, la certezza del diritto può definirsi un bene giuridico autonomo, riconosciuto in quanto tale dalla generalità degli ordinamenti e pure da quelli sovranazionali[13], come l’Unione europea ed il sistema della Convenzione europea sui diritti dell’Uomo e le libertà fondamentali, attraverso la giurisprudenza delle sue Corti: ma la ragionevole prevedibilità, intesa ormai sempre più diffusamente come autentica calcolabilità[14], del diritto è diventata obiettivo centrale degli ordinamenti, che, sia pure sotto la spinta incessante di mercati aggressivi e globalizzati, la esige quanto meno quale precondizione per la parità di trattamento in casi uguali, con la riscoperta e l’interpretazione evolutiva o adeguatrice del principio di uguaglianza in senso formale e sostanziale.
Tanto è verosimilmente dovuto alle caratteristiche che stanno via via acquistando gli scambi economici e giuridici in una dimensione globale e tecnologica del diritto, ma si correla al principio della calcolabilità e della ragionevole durata in termini di prontezza della risposta di giustizia ed alle prospettive, ancora allo stato indefinite, dell’applicazione dell’automazione anche al mondo giuridico ed alle sue articolazioni tradizionali, non ultime quelle della decisione[15].
Il medesimo principio si correla intimamente a quello della tutela dell’affidamento: se qualcuno sa che in una determinata situazione vale una certa regola adeguerà i suoi comportamenti; e, facendo affidamento sui precedenti, vengono compiuti atti e attività. Ma il mutamento di giurisprudenza colpisce, con invalidità degli atti o forme di responsabilità, chi, avendovi fatto affidamento, è ora parte soccombente nel giudizio che porta alla nuova decisione; ed il cambiamento plausibilmente colpirà anche altre persone che nel frattempo, prima delle nuove decisioni, hanno compiuto un simile atto o tenuto un determinato comportamento[16].
In generale, ogni persona ha diritto di sapere a priori quali saranno le conseguenze giuridiche delle sue scelte e dei suoi comportamenti; in proiezione giudiziale, colui che inizia un giudizio ed investe le sue risorse, impegnando al tempo stesso risorse del sistema giustizia, deve poter calcolare, o quanto meno, ragionevolmente prevedere l’esito della controversia. La ragionevole prevedibilità della soluzione di un giudizio è una componente, non secondaria, del diritto di difesa costituzionalmente garantito. Essa inoltre, inducendo a rinunciare a giudizi il cui esito prevedibile è negativo, si riflette sul sistema giustizia evitando inutili appesantimenti e, di conseguenza, si riflette sugli altri giudizi che, meno numerosi potranno essere trattati con maggiore attenzione e rapidità. In ultima analisi, vi è un nesso tra ragionevole prevedibilità e i principi del giusto processo e della sua ragionevole durata.
Sono, in definitiva, sempre più pressanti le esigenze di riduzione dei margini di oscillazione e quindi di imponderabilità delle decisioni giudiziali, perché si richiede al diritto, onde consentirgli di perseguire la sua funzione di regolatore dei rapporti di forza in un contesto di effettiva e sostanziale uguaglianza, un’intima coerenza non più solo in sede di elaborazione, ma soprattutto al momento della sua applicazione, la quale è infine sentita come irrinunciabile nei traffici giuridici odierni[17].
Ogni scelta giurisprudenziale, incidendo sull’assetto normativo complessivo, ha quindi un costo in senso tecnico (non solo economico e non sempre immediatamente traducibile in termini pecuniari): ed ogni consociato si attende gli elementi per computarlo, al fine di assumere consapevolmente le corrispondenti scelte della propria quotidiana condotta.
L’esponenziale incremento degli scambi, reso possibile non solo e non tanto dalla dimensione globalizzata dei mercati, ma soprattutto dall’impiego sempre più diffuso e capillare di strumenti di comunicazione di anno in anno sempre più sofisticati e comunque nuovi ed impensabili rispetto a poco tempo prima, ha moltiplicato in modo altrettanto esponenziale la domanda di giustizia.
La risposta che il sistema deve essere in grado di apprestare deve possedere connotati tali da scoraggiare i suoi agenti dal rivolgersi a strumenti o sistemi alternativi o da scongiurare che, peggio ancora, essi restino senza alcuna tutela, abbandonati ad una moderna giungla di sfrenata anomia, dove assai semplicemente viga la legge del più forte e si regredisca quindi al mondo preistorico.
Non è un caso che sempre maggiore attenzione è riservata alla decisione robotica, sia negoziale che giudiziale, nel senso di automatizzata o standardizzata, ad ulteriore netta riduzione dell’imponderabilità delle conseguenze delle umane azioni, sia nel fisiologico momento dello sviluppo delle autoregolamentazioni tra i privati, sia nella patologica evenienza del malfunzionamento degli strumenti da questi elaborati per disciplinare i loro rapporti. In sostanza, l’aspirazione ad un diritto “automatico” – è significativo che un simile lemma può bene intendersi nell’accezione di “pertinente ad automa” o di “elaborato dall’automa” – altro non è che l’estrinsecazione di una sempre maggiore esigenza di stabilità o certezza del diritto, anche nel senso della sua prevedibilità.
Del resto, nessuna norma può dirsi coerente al suo scopo di regolare un’attività umana, se non è in grado di offrire una chiara prefigurazione al soggetto a cui è diretta sia delle condotte che da quello si attendono, sia delle conseguenze della mancata ottemperanza al comando così impartito.
In questo quadro, un delicato equilibrio va ricercato tra la parità di trattamento e la soggezione del giudice soltanto alla legge, salvaguardando l’incoercibile esigenza di uguale regolamentazione di fattispecie uguali ed al contempo l’irrinunciabile libertà di coscienza di chi deve giudicare: a volere riprendere ricostruzioni ormai classiche, sia nel giudizio di fatto che in quello di diritto il giudice civile non è mai pienamente libero, nel senso di svincolato da regole di varia natura, comunque impostegli appunto dalla legge, cui solo pure egli è soggetto.
Nel giudizio di fatto (e quindi nella ricostruzione della fattispecie da sussumere nella norma e cui applicare quindi quest’ultima nel significato), egli deve comunque applicare regole di inferenza tali da assicurare una coerenza tra premesse e conseguenze che reggano al vaglio di plausibilità, ad evitare una mera apparenza di motivazione che neppure oggi, pur dopo la severa limitazione del controllo di legittimità introdotta con la riforma del 2012, sfuggirebbe al vaglio della Corte suprema: e tanto per potere pur sempre rispondere a quell’esigenza di corrispondenza del giudizio – nella specie, di rappresentazione e cioè di raffigurazione di un fatto necessariamente anteriore ed esterno al processo all’interno di questo – a quello di una generalità indistinta di consociati in un dato contesto storico per così dire obiettivizzato, nel cui nome del resto la decisione è presa.
Nel giudizio di diritto, reso ogni giorno più arduo dall’intrico di norme anche su più livelli in settori sempre più specialistici e connotati da un tecnicismo esasperato, vigono poi regole, sostanziali e procedimentali in senso lato, di singolare complessità e sempre maggiore raffinatezza, i meccanismi della cui interazione sono assai spesso di non agevole individuazione e la cui attitudine alla generalizzazione è messa a dura prova da una molteplice multiformità dell’ordinamento che nelle epoche passate non si riscontrava.
4. La certezza del diritto in tensione dialettica con le esigenze del cambiamento.
Una decisione o una serie di decisioni possono essere ripensate in adesione alle critiche della dottrina o degli stessi operatori pratici, che ne hanno sollecitato una rimeditazione; oppure era certamente indubbia la loro congruenza con la temperie culturale, sociale e giuridica del tempo della loro emanazione, ma non anche nell’evoluzione successiva di una di queste: sul rapporto tra disposizione e norma incide sensibilmente il fattore tempo[18] e, con esso, la dinamica della realtà fenomenica che si vuole regolare e che, per sua naturale predisposizione, tende ad evolversi, svilupparsi o modificarsi.
Può essere mutato il contesto normativo con la modificazione di altre e correlate norme, idonee ad interagire con quelle poste a base delle decisioni di un tempo: in tal caso, mutato il sistema, si esige un adeguamento dell’interpretazione del suo assetto, in base appunto ad una interpretazione sistematica rinnovata; può essere cambiato il contesto culturale e sociale in cui la disposizione è destinata ad applicarsi e a produrre i suoi effetti, la cui evoluzione è direttamente proporzionale all’ampiezza dei concetti e dei riferimenti adoperati, o alla loro sensibilità alla trasformazione dei costumi, dei valori o delle tecniche[19].
L’ordinamento deve lasciare spazio all’evoluzione della giurisprudenza, come la realtà che questa governa naturalmente si evolve e si modifica; ma le ragioni per il cambiamento devono essere forti, consapevoli e convincenti: devono essere in grado di prevalere sulle ragioni della stabilità, a loro volta importanti e con implicazioni di ordine costituzionale[20].
In primo luogo, non è stata mai modificata la norma fondamentale dell’ordinamento giudiziario in base alla quale la Corte di cassazione «assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge».
Con l’uso di questa duplice espressione il legislatore mostra di essere consapevole che di una disposizione a volte possono essere date ragionevolmente più interpretazioni: se fosse stato convinto che l’interpretazione esatta è necessariamente unica, avrebbe parlato solo di esattezza dell’interpretazione[21]; invece, la duplicazione delle espressioni e dei concetti – e quindi l’endiadi – indica che, anche nelle ipotesi in cui sia possibile più di una soluzione ermeneutica, deve comunque essere garantita l’uniformità dell’interpretazione, all’evidente fine di evitare che, con argomenti analogamente persuasivi, siano date risposte diverse in giudizi su casi simili.
L’ordinamento affida alla Corte di cassazione il compito di garantire questa declinazione del principio costituzionale di uguaglianza: i suoi precedenti hanno pertanto anche questa particolare valenza. Ma in generale il sistema giudiziario, in tutte le sue articolazioni, deve muoversi in questo senso[22]: un sistema per definizione deve dare risposte coerenti tra loro.
L’ordinamento giuridico deve dare alle domande di giustizia dei cittadini risposte unitarie e coerenti tra loro: stabilità e coerenza devono essere prioritariamente garantite; e mutamenti di giurisprudenza possono allora giustificarsi per ragioni gravi, così pesanti da controbilanciare e prevalere su esigenze rispondenti a principi di ordine costituzionale.
Tutto ciò è sempre stato, ma forse oggi se ne sente maggiormente la necessità; lo stesso intensificarsi del dibattito dottrinale sul tema del precedente è indice di questa particolare sensibilità. La riflessione giuridica risente naturalmente di dinamiche culturali e sociali più ampie, che oggi registrano un sentimento di perdita e spaesamento, che si tende ad affrontare guardando al passato, ricercando continuità in luogo di fratture; persino nella psicoanalisi si riscopre il valore di concetti come quello di “eredità” quale momento fondante dell’evoluzione: una declinazione, in fondo, del concetto di precedente[23].
Probabilmente vi è un rapporto tra complessità del sistema normativo ed esigenze di coerenza e affidabilità giurisprudenziale. Quanto più aumentano articolazione e disordine del quadro normativo tanto più si percepisce l’esigenza di una giurisprudenza che sia in grado di ricucire le maglie della rete, di ridurre le aporie, di dare senso e coerenza al sistema. In analoga misura, più aumenta il soggettivismo dei giudici, il loro proporsi come monadi autoreferenziali, tanto più è sentita l’esigenza di una risposta convergente e coerente alla domanda di giustizia[24].
E se questo è vero in generale, lo è ancor di più con riferimento alle regole processuali: il processo è il luogo in cui più che mai deve essere garantita l’esigenza di certezza e stabilità delle regole del gioco[25].
. Il ruolo del precedente nella disciplina processuale.
Può dirsi che il ruolo del precedente di legittimità – e quindi della nomofilachia – è oggi disegnato da una serie di dati normativi testuali: quasi una forma attenuata della regola di stare decisis[26] dopo le riforme del 2006 (d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), del 2009 (l. 18 giugno 2009, n. 69), del 2012 (art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con l. 7 agosto 2012, n. 134) e del 2016 (d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con l. 7 agosto 2016, n. 197) soprattutto del giudizio di legittimità, ma anche della disciplina sulle motivazioni del provvedimento civile.
Il sistema si regge, in sostanza, da un lato sulle norme specificamente volte alla tendenziale unificazione della giurisprudenza, cioè gli artt. 374 e 420-bis c.p.c., nonché all’enfatizzazione della forza del precedente: da un lato e quanto a quello di legittimità, gli artt. 384, 363 e 360-bis c.p.c.; dall’altro e in generale, l’art. 118, co. 1, d.a.c.p.c.
Va però sottolineato che soltanto per il giudice del rinvio, nella specifica sede sua propria disciplinata dagli artt. 392 e seguenti c.p.c., incontra un vincolo positivamente stabilito, quanto al principio di diritto. Neppure dà luogo ad un precedente in senso tecnico l’istituto disegnato dall’art. 420-bis c.p.c. [27], assimilabile piuttosto ad una sorta di rinvio pregiudiziale o di costituzionalità, o, a voler operare un parallelo con altri ordinamenti, ad una saisine par avis del diritto processuale francese[28]: ma è limitato al campo della contrattualistica collettiva ed esita in una sentenza interpretativa in via pregiudiziale.
Incide sulle modalità di ordinaria elaborazione della giurisprudenza successiva, di merito e di legittimità, la previsione della possibilità di motivare col richiamo ai precedenti, di cui all’art. 118, co. 1, d.a.c.p.c.: questi assurgono quindi a strumento di motivazione semplificata e, al tempo stesso, a parametri di giudizio ai quali è sufficiente un rinvio, con esenzione del giudicante dalla riproduzione di evidentemente analoghi snodi argomentativi.
Si tratta di norma sistematica di grande rilievo, riferita ad una generalità potenzialmente indefinita di provvedimenti di merito, introdotta da non molto nel nostro ordinamento nel tentativo di contenere l’inarrestabile tendenza all’espansione delle motivazioni. È ora consentito di redigerle con richiamo ai precedenti conformi: e questo sia da parte dei giudici del merito con rinvio a precedenti anch’essi di merito[29], purché – beninteso – reperibili a garanzia della trasparenza della decisione e del diritto di difesa delle parti (e restando immutato l’onere di riprodurli nelle successive impugnazioni), sia nel giudizio stesso di legittimità, per il caso di adozione di forme semplificate di motivazione[30].
In questo caso, il precedente acquista una sua forza intrinseca, in quanto esonera il giudicante successivo dall’attività di specifica motivazione, ove beninteso il relativo contenuto possa essere analogo. La capacità conformativa della giurisprudenza successiva è quindi riferita sia al momento della decisione, sia a quello della concreta estrinsecazione dei passaggi argomentativi a suo sostegno; si rivolge al momento della motivazione, ma, ovviamente, offre un indiretto stimolo al decidente a verificare l’idoneità e sufficienza del richiamo a quei passaggi, auspicabilmente dissuadendolo dalla convinzione della ineluttabilità di una ripetizione, spesso pedissequa o peggio meramente di rifinitura e rielaborazione di quelli (non solo in genere più faticosa, ma anche foriera del rischio di esaltare impropriamente le conseguenze di divergenze o sfumature semantiche adottate).
Significativamente ricondotto all’oggetto del provvedimento impugnato ed al mezzo di impugnazione posto in campo contro di esso è da segnalare l’istituto dell’inammissibilità del ricorso per cassazione per suo contrasto con un orientamento di legittimità, previsto dal n. 1 dell’art. 360-bis c.p.c..
Questo elemento esige oramai, nuovamente ricondotto com’è nell’alveo della sua testuale definizione ad una ipotesi di inammissibilità in senso tecnico[31] (sia pure per ragioni di merito), che parti e giudice del merito si facciano carico di quell’orientamento o di quella giurisprudenza ove vogliano confutarla o superarla, con un onere di argomentazione rafforzato, dovendo gli uni e l’altro prendere in considerazione critica gli argomenti a sostegno di quelle conclusioni e non bastando loro i richiami a quelli contrari già disattesi. Il riferimento della norma alla giurisprudenza della Corte di cassazione, senza altre specificazioni, esclude la necessità di una particolare costanza di reiterazione, riconoscendosi l’applicabilità dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. anche ad ipotesi di un unico precedente, quand’anche remoto, purché congruo e convincente[32]: a dimostrazione che l’autorevolezza e la persuasività di quello può bene ricondursi non tanto alla frequenza statistica della sua reiterazione, quanto all’intrinseca sua congruenza ed alla sua sostanziale accettazione nella pratica successiva, che potrebbero essere state tali da non suscitare mai la necessità di ribadirlo.
Il precedente delle Sezioni Unite vincola poi la singola sezione semplice, che è obbligata – sia pure senza la previsione di una sanzione e, certamente, senza che possa configurarsi un errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., potendo semmai trattarsi di un error in procedendo (in quanto tale insindacabile se commesso dalla Corte di legittimità) e mai di un errore di fatto – a rimettere la questione alle stesse Sezioni Unite. Nella pratica, un tale vincolo è con una certa attenzione rispettato dalle sezioni semplici, le quali, quanto meno nei casi liminari, comunque si preoccupano generalmente di adottare una tecnica simile al distinguishing degli ordinamenti di common law, sottolineando le differenze tra le fattispecie tali da giustificare lo scostamento dall’apparente precedente rafforzato. È da escludere una qualsiasi forma di impugnazione alle Sezioni Unite delle pronunce delle sezioni semplici con esse in contrasto: ed è auspicabile comunque che, per il senso di leale ossequio alle norme dell’ordinamento che ci si attende da un giudice e a maggior ragione da quello di legittimità, una norma processuale di tale delicata portata sia spontaneamente osservata senza la necessaria deterrenza di una sanzione.
Più ampio discorso andrebbe fatto per l’enunciazione del principio di diritto: sia nella fattispecie, ormai generalizzata, per il caso di rigetto del ricorso, sia nell’altra, rivitalizzata appunto con la riforma del 2006, prevista dall’art. 363 c.p.c., nella duplice versione della pronuncia di ufficio direttamente dalla Corte in caso di inammissibilità del ricorso e di quella su richiesta del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione. Entrambi meriterebbero ben altro approfondimento, ma è da notare che la Corte di legittimità si è occupata sovente dell’istituto, a dimostrazione del recupero di una certa sua vitalità, sia pure dipendendo dalle determinazioni del Procuratore generale la maggiore o minore ampiezza della sua applicazione e nonostante le preoccupazioni e, talvolta, le vigorose critiche di parte della Dottrina.
6. La forza indiretta del precedente.
Pur in assenza di un obbligo di conformazione, vi è un’innegabile influenza del precedente “autorevole”: l’autorevolezza può derivare da una serie di elementi, estrinseci o intrinseci.
Quelli estrinseci concernono il giudice che lo ha emesso. A parte le sentenze che possono incidere direttamente sulle previsioni legislative, come quelle della Corte costituzionale o della Corte di giustizia dell’Unione europea, è indubbio che, di massima, si attende che l’autorevolezza cresca in relazione alla posizione del giudice nell’ordine giudiziario e che le decisioni della Corte di cassazione abbiano una particolare valenza come guida nell’interpretazione della legge, siccome rese dall’organo funzionalmente preposto alla nomofilachia e collocato al vertice del sistema delle impugnazioni.
Quelli intrinseci attengono alla qualità della motivazione del provvedimento che forma il precedente: il grado di persuasività degli argomenti, la sua chiarezza e linearità[33]; per persuadere occorre essere certamente chiari, ma anche adottare argomenti congruenti e che si facciano carico, se possibile, anche delle tesi contrastanti, offrendo una soluzione ragionata e meditata, quand’anche opinabile, auspicabilmente finalizzata alla risoluzione del caso concreto, sia pure facendo chiara enunciazione di principi generalizzabili.
L’aspirazione alla completezza, apprezzabile in vista dello ius constitutionis, può nuocere alla fruibilità del discorso ed alla limpidità delle conclusioni, oltre a innescare talvolta più conflitti di quanto non possa sopirne; ma questo dipende, beninteso, dalla personalità del singolo decidente e dalle sue personali doti di estensore.
Il precedente autorevole si pone poi in un rapporto di tensione dialettica tra le ragioni della stabilità e quelle del cambiamento: e, sostanzialmente, l’uno e l’altra sono espressione evidente della funzione della giurisprudenza[34].
Un ruolo importante può riconoscersi al precedente nel momento in cui la sua considerazione esplicita nella motivazione da parte del decidente è imposta da norme che non incidono in maniera diretta sul procedimento decisionale in senso stretto e sul contenuto e gli eventuali vizi del provvedimento che ne costituisce l’esito, ma solo in via indiretta, nel connotare l’attività intellettuale del giudice che sta determinandosi in un senso o nell’altro.
In questo modo, il precedente è rivestito di un’indubbia sua forza o efficacia cogente, nel senso di essere in grado di orientare in concreto la decisione, sia pure senza potersi prospettare come un vincolo formale; e si tratta allora di una forza evidentemente indiretta, sebbene verosimilmente molto più significativa, in ragione degli effetti sulla persona del singolo decidente, attraverso la definizione dei suoi obblighi professionali in senso stretto, le cui violazioni siano tali da esporlo a responsabilità civile o disciplinare e quindi connotino di giuridicità l’ossequio che, entro certi limiti, l’ordinamento comunque richiede al giudicante o almeno si attende da lui.
Un’indubbia forza del precedente è, benché solo indirettamente, riconosciuta da un duplice elemento di matrice giurisprudenziale, elaborato dalla stessa Corte di legittimità nell’individuazione, da un lato, dei contorni della responsabilità dello Stato per grave violazione di legge da parte dei giudici nell’interpretazione di questa ai sensi della legge n. 117 del 1988 e, dall’altro, delle fattispecie di illecito disciplinare del magistrato per violazione di legge.
Il primo regola la delicata materia della discrezionalità del giudice nell’interpretazione delle norme e nel suo obbligo di motivazione: premesso che – come avviene anche a livello sovranazionale – non è mai richiesta una risposta puntuale del singolo giudice ad ogni singolo argomento sottopostogli dalla parte, una motivazione qualunque non è mai sufficiente ad escludere l’illegittimità della condotta del giudicante e la responsabilità dello Stato ai sensi della legge 13 aprile 1988, n. 117 (già nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge 27 febbraio 2015, n. 18); infatti, a fondare una responsabilità dello Stato (prima e del singolo giudice poi), occorre che la decisione non appaia frutto di un consapevole processo interpretativo, oppure che contenga affermazioni ad esso non riconducibili perché sconfinanti nel provvedimento abnorme o nel diritto libero e pertanto caratterizzate da una negligenza inesplicabile, prima ancora che inescusabile, in vari momenti dell'attività prodromica alla decisione, in cui la violazione non si sostanzia negli esiti del processo interpretativo, ma ne rimane concettualmente e logicamente distinta, ossia quando l’errore del giudice cada sulla individuazione, ovvero sulla applicazione o, infine, sul significato della disposizione, intesa quest’ultima come fatto, come elaborato linguistico preso in considerazione dal giudice che non ne comprende la portata semantica. La “ribellione” ai precedenti giurisprudenziali non determina, cioè, di per sé responsabilità, perché il precedente giurisprudenziale, pur se proveniente dalla Corte di legittimità e finanche dalle Sezioni Unite, e quindi anche se è diretta espressione di nomofilachia, non rientra tra le fonti del diritto e, pertanto, non è di norma vincolante per il giudice; tuttavia, in un sistema che valorizza l’affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, l’adozione di una soluzione difforme dai precedenti non può essere né gratuita, né immotivata, né immeditata, ma deve essere frutto di una scelta interpretativa consapevole e riconoscibile come tale, ossia comprensibile, ciò che avviene più facilmente se sia esplicitata a mezzo della motivazione[35].
Costituisce poi illecito disciplinare una grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) e g), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, che si risolva nella mancata applicazione di norme anche solo processuali: l’attività interpretativa non attinge l’illecito disciplinare solo se resa evidente da chiara condotta di motivazione, idonea a rendere le ragioni della decisione verificabili a posteriori, anche mediante l’adesione ad una scelta ermeneutica riconducibile ad un orientamento minoritario, purché reso evidente da un percorso argomentativo valutabile ed impugnabile così come previsto dalla legge; in sostanza, esclude l’illecito la circostanza che l’adottata scelta ermeneutica non sia implausibile e che cioè non sia tale da qualificare abnorme il risultato dell’interpretazione, solo in tali casi si può intendere superato il limite dell’insindacabilità sancita dall’ultimo comma dell’art. 2 del d.lgs. n. 109 del 2006[36].
7. Una nomofilachia consapevole e responsabile.
In questo contesto, il ruolo di una Corte suprema in grado di elaborare una nomofilachia sostenibile dovrebbe allora quello di una Corte suprema consapevole e responsabile, nel duplice senso di attenta ad evitare contrasti involontari e pronta a rendere conto dinanzi alla collettività delle proprie scelte, ad un tempo prudente custode dell’uniformità e sensibile interprete delle esigenze del cambiamento, concentrata nel rendere un prodotto fruibile anche in termini di qualità e tentando di influire sulla quantità deprimendo, con la chiarezza e talvolta la secchezza dei propri arresti, la domanda di giustizia di legittimità.
L’effettiva applicazione delle norme sull’enunciazione del principio di diritto è essa stessa complessivamente molto prudente.
In via di fatto, nella sua forma pienamente ufficiosa quell’enunciazione è in linea di tendenza evitata oramai, dopo una prima caustica reazione negativa da parte della Dottrina nei primi anni di applicazione, quando il principio che dovrebbe essere enunciato andrebbe a favore del ricorrente nei cui confronti pure è pronunciata l’inammissibilità.
È stata sancita espressamente l’incompatibilità dell’enunciazione del principio di diritto di ufficio col rito camerale di sezione ordinaria, ma nulla vieta alla sezione semplice (compresa la sesta, cui è istituzionalmente devoluta ogni questione su inammissibilità o improcedibilità o manifesta infondatezza o fondatezza) di farvi luogo, o, in alternativa ed ove ritenga sussistere una questione di massima di particolare importanza, di rimettere il ricorso alle Sezioni Unite[37]: alle quali è stato, almeno in via di prassi, finora devoluto l’esame delle non moltissime richieste del Procuratore generale ai sensi dei primi due commi dell’art. 363 c.p.c.
Del resto, un altro ed apprezzabile self restraint un vincolo al mutamento di giurisprudenza, quanto meno in materia processuale, le Sezioni Unite della Corte di cassazione si sono imposte riconoscendolo opportuno solo quando l’interpretazione fornita dal precedente risulti manifestamente arbitraria e pretestuosa o dia luogo a risultati disfunzionali, irrazionali o ingiusti, poiché l’affidabilità, prevedibilità ed uniformità dell’interpretazione delle norme processuali costituisce imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini e di giustizia del processo[38].
Certo, il revirement non è mai di per sé solo precluso, nemmeno nella giurisprudenza sovranazionale, purché appunto siano apprestati strumenti per i giustiziabili atti a tutelarne l’affidamento quanto meno in materia processuale. Ma l’approfondimento della tematica condurrebbe davvero lontano, involgendo il tema della prospective overruling o comunque degli effetti immediati dei mutamenti di giurisprudenza radicali: i quali non attengono, se non altro in senso stretto, al principio della stabilità del precedente.
È certo che sulla motivazione semplice o semplificata gli sforzi della Prima Presidenza della Corte suprema di cassazione si sono appuntati da almeno dieci anni: basti pensare alle note del Primo Presidente di questa Corte del 22/03/2011 e del 14/09/2016, la prima delle quali a seguito di un interessante esperimento di autoformazione in forma di laboratorio per una riflessione sulla struttura della motivazione della sentenza civile di Cassazione, culminato in un “dodecalogo” per la sua redazione, voluto dall’allora Primo Presidente Ernesto Lupo[39].
Certamente, motivazione semplice o semplificata è funzionale ad una facilitazione nella redazione dei provvedimenti.
Ma è altrettanto certo che non si esaurisce in questo la nomofilachia, tanto meno una nomofilachia sostenibile: redigere provvedimenti agili non deve significare solamente poterne scrivere un numero infinitamente o indefinitamente maggiore, ma deve servire a liberare risorse per concentrarsi sulle questioni nuove e ad attivare motivazioni davvero sommarie nei casi agevolmente riconducibili ai precedenti. Del resto, la concentrazione degli sforzi motivazionali nei casi pilota non è una novità nemmeno nel panorama sovranazionale: già la Corte europea dei diritti dell’Uomo assicura la priorità ai ricorsi in materie caratterizzate dal well-established-case-law, in cui cioè sussiste una giurisprudenza già consolidata, che consente una definizione perfino con una composizione ridotta del Collegio decidente.
Il metodo delle cause pilota deve tendere non ad aumentare o rendere più produttiva la risposta di Giustizia di legittimità, ma a deflazionare, rendendola per quanto possibile priva di necessità (se non di ragione), la domanda di Giustizia di legittimità.
Una giurisprudenza stabile e rapida almeno sulle questioni principali, semmai accompagnata da un uso non più troppo timido, sebbene pur sempre prudente, di strumenti quali le condanne ai sensi dell’art. 96 co. 3 c.p.c., dovrebbe poter servire senz’altro a ridurre il contenzioso e a riservare le limitate risorse umane a disposizione alle fattispecie serie e degne di attenzione, evitando che le oscillazioni ed il tempo necessario per la definizione inducano, in una perversa spirale, sempre più qualunque giustiziabile ad azzardare la via del ricorso per cassazione, nella sia pur tenue possibilità di una pronuncia favorevole nel mare magnum di provvedimenti. E si potrà evitare di demotivare anche i giudici del merito, i quali, dinanzi all’instabilità intrinseca di cui può dare impressione la Corte di legittimità, potrebbero restare privi di qualunque riferimento affidabile e, al contempo, ritenersi svincolati da ogni precedente, prefigurandosene una permanente instabilità.
8. I progetti tematici.
Analogo meccanismo è tentato ormai da quasi tre anni almeno in una delle Sezioni della Corte di cassazione, ad iniziare dalla materia dell’esecuzione civile e poi via via in quella delle locazioni e della responsabilità sanitaria: un tale meccanismo è inteso a recuperare al giudice di legittimità un suo istituzionale ruolo nomofilattico e definito dalla stampa “un esempio di best practice nel settore giustizia, per coniugare le ragioni del diritto con quelle dell’economia, rafforzando la funzione della Cassazione nell’assicurare un’uniforme interpretazione della legge”[40].
Il “Progetto” (che, nella stessa giurisprudenza di legittimità, è definito la «metodologia organizzativa ... volta alla rilevazione e concentrazione delle questioni nuove o che presentano specifiche “criticità” in apposite udienze dedicate»[41]) mira a correggere gli effetti della tradizionale impostazione del giudizio di cassazione come “occasionale”, nel senso che la controversia tra privati (incentrata sullo ius litigatoris) costituisce per la Corte soltanto un’occasione per svolgere la sua funzione nomofilattica (finalizzata invece allo ius constitutionis) e dipende quindi dal caso la concreta articolazione del ruolo delle singole udienze. Con la prassi applicativa del Progetto, invece, si attribuisce centralità alla programmazione, sia pure – beninteso – in relazione al concreto carico di lavoro pendente ed alle questioni comunque portate alla cognizione della Corte dalla mutevole e imponderabile iniziativa dei singoli litiganti, poiché è lo stesso giudice di legittimità che, selezionate le questioni attualmente più rilevanti o dibattute, individua una controversia idonea a fornire l’opportunità di pronunciare una decisione idonea ad orientare le future determinazioni dei giudici di merito (e non solo a correggere le pronunce già emesse) e, così, di assicurare l’uniforme interpretazione del diritto nazionale e per di più di farlo tempestivamente.
La prassi tende a una razionale e mirata gestione delle pendenze in una determinata materia mediante l’individuazione, il più possibile compartecipata da tutti gli operatori del diritto (attraverso l’interazione con forum specializzati, convegni e riviste giuridiche), delle questioni di maggior rilievo o più controverse negli uffici di merito.
La ricerca – condotta dal gruppo di lavoro istituito in seno alla Sezione (composto dai magistrati dell’Ufficio del Massimario destinati alla collaborazione nell’attività di spoglio e classificazione dei processi, da alcuni Consiglieri e Presidenti di Sezione esperti del settore) – individua le questioni che assumono rilievo nomofilattico in quanto:
- riguardano tematiche di sicura attualità e rilevanza, ma non ancora approfondite;
- patiscono divergenti interpretazioni dei giudici di merito oppure incertezze e dubbi indotti da giurisprudenza di legittimità oscillante o eccessivamente remota o la cui tenuta deve essere rimeditata in ragione di mutati contesti ordinamentali;
- hanno impatto sistematico e di ricaduta immediata sulle procedure pendenti, a causa delle conseguenze applicative nel quotidiano lavoro dei giudici dell’esecuzione forzata e dei loro ausiliari.
All’individuazione delle questioni seguono:
1) il reperimento, preferibilmente con mezzo informatico, tra le cause pendenti in Sezione (in precedenza oggetto di attenta schedatura da parte dei magistrati destinati allo spoglio e alla classificazione), di quelle che siano portatrici di una o più di quelle stesse questioni;
2) l’accorpamento di quelle controversie in più udienze dedicate;
3) la divulgazione agli operatori del settore di un calendario di udienze che faccia esplicita menzione dei temi trattati, così che i giudici di merito possano, a loro volta, razionalmente gestire il proprio ruolo;
4) l’applicazione dei principi elaborati in seno al Progetto in successive ordinanze con motivazione davvero sommaria[42].
Parallelamente, il P.G. presso la Corte di Cassazione, dopo avere promosso una consultazione degli uffici di merito con invito a formulare segnalazioni, propone alla Corte i ricorsi nell’interesse della legge, ai sensi dei primi due commi dell’art. 363 cod. proc. civ.
9. La rilevanza interna del principio di diritto.
Per concludere, solo pochi cenni alla rilevanza interna del principio di diritto, intesa come vincolo specifico al giudice del rinvio nella sede sua propria del giudizio disciplinato dagli artt. 392 a 394 c.p.c.: riguardo alla quale è indispensabile un rinvio alle trattazioni istituzionali e specialistiche e sulla quale qui ci si sofferma solo per rimarcare le differenze con la rilevanza esterna del principio di diritto fin qui esaminata, vale a dire quella che quest’ultimo ha in relazione a processi diversi da quello in cui è stato enunciato e tra soggetti diversi dalle parti o dai loro aventi causa a qualsiasi titolo.
È, tale vincolo, un istituto tipico dell’ordinamento nazionale, visto che quello da cui è stato importato, cioè quello francese, non prevede un obbligo immediato del giudice del rinvio di conformarsi al principio di diritto affermato dalla Cassazione, ma soltanto in un secondo momento, qualora, a seguito della sua “ribellione” o non condivisione, la stessa Corte di legittimità pronunci in Assemblée Plénière (si tratta quindi di un procedimento particolarmente rafforzato: che se, da un lato, esalta l’indipendenza del giudice del merito, dall’altra si inserisce in un sistema in cui le ribellioni alle pronunce di legittimità, sebbene tecnicamente ammissibili, sono praticamente rarissime).
Nell’elaborazione nazionale, esso integra una fattispecie di vero e proprio vincolo interpretativo per il giudice: è imposto al giudice di rinvio dopo la pronuncia di cassazione (secondo il disposto dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., analogo a quello, in materia penale, posto dall’art. 627, terzo comma, c.p.p.).
È un vincolo interpretativo che ha superato il vaglio di costituzionalità fin da epoca ormai risalente[43]; ma è un vincolo interno al processo e consegue ad un suo sviluppo particolare: la regola di giudizio è fissata prima della sua applicazione alla fattispecie concreta. Questo scarto diacronico[44] crea una preclusione processuale: la regola di giudizio, pervenuta nella dialettica processuale, attraverso i vari gradi del giudizio, all’enunciazione del principio di diritto da parte della Corte di cassazione non può più essere posta in discussione non già in ragione di un’applicazione fuori sistema del principio di stare decisis, ma perché le parti ne hanno già discusso nel processo fino a quando e nei limiti in cui le regole del processo lo consentono. Pertanto, la violazione del principio di diritto da parte del giudice del rinvio determina una nullità della sentenza e la espone al successivo ricorso per cassazione sotto questo specifico profilo.
È poi consolidata la giurisprudenza di legittimità nel ritenere comprese nella preclusione derivante dall’enunciazione del principio di diritto tutte le questioni – di fatto e di diritto – logicamente sottese ed il cui esame deve aversi per necessariamente svolto in senso congruente col principio stesso[45].
Di recente, poi, quanto alla prosecuzione in sede civile del giudizio di danni