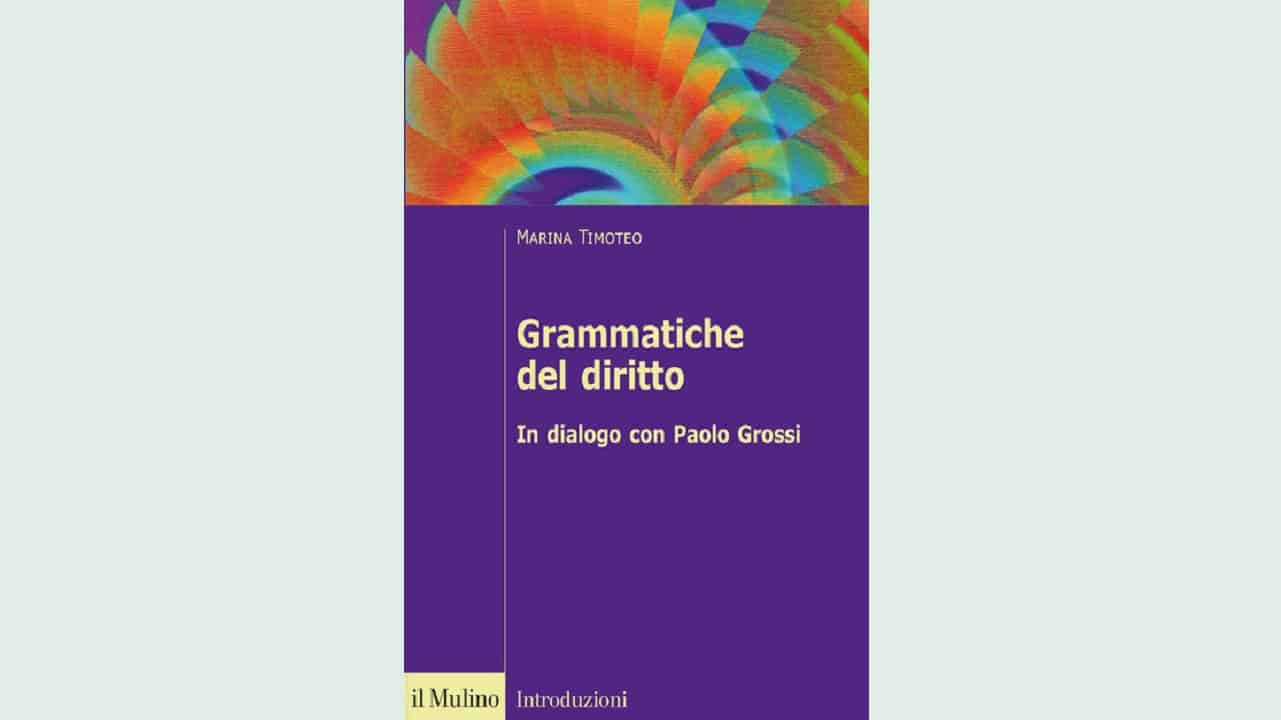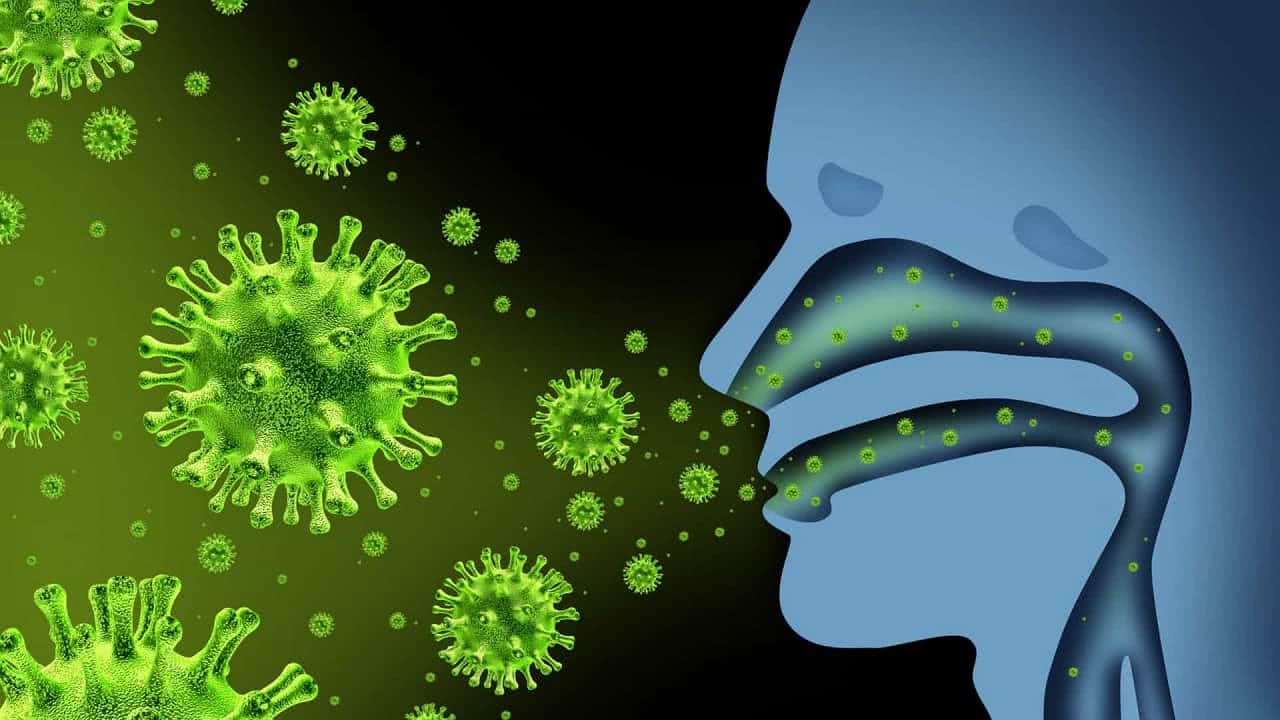Il fine vita e il legislatore pensante
2. Il punto di vista dei comparatisti - Parte II
Considerazioni di Nicoletta Patti e Giancarlo Geraci
Introduzione di Mario Serio
[v. Il fine vita e il legislatore pensante. Editoriale - Il fine vita e il legislatore pensante. 1. Il punto di vista dei penalisti (di Vincenzo Militello, Beatrice Magro e Stefano Canestrari) - Il fine vita e il legislatore pensante. 2. Il punto di vista dei comparatisti - Parte I (di Mario Serio, Giuseppe Giaimo, Rosario Petruso e Rosalba Potenzano)]
Introduzione
Ancora una volta Giustizia Insieme si rende lodevole interprete della sensibilità sociale sviluppatasi attorno a temi in cui le implicazioni giuridiche esigono un coordinamento chiaro e ragionato con altri forme di conoscenza e giudizio ,anche eticamente qualificati.
L'occasione è oggi costituita dal significato da attribuire, sul terreno del diritto e delle soluzioni che esso appare in grado di prospettare, al concetto di vita in generale e, più in particolare, su quello di vita che valga la pena di essere continuata a condurre a cospetto di condizioni, situazioni, evenienze che dolorosamente mettano in dubbio, tanto dal punto di vista soggettivo, quanto da quello oggettivo, questa possibilità.
Tema da sviluppare, oltre che con il ricorso al patrimonio delle competenze strettamente tecniche, tenendo conto della crudezza delle circostanze e della necessità di governarle assumendo come linea di indirizzo il superiore valore della dignità della persona umana in ogni momento della sua esistenza, fino a quello del suo epilogo.
La molteplicità delle sollecitazioni culturali e, in declinazione aconfessionale e rigorosamente laica, in senso ampio spirituali che la ricerca proposta lascia affiorare serve certamente ad affinare la profondità delle riflessioni, caricandole del nobilitante onere di controllarne la doverosa compatibilità con la preservazione, sempre e comunque, del decoro della vicenda umana.
La Scuola comparatistica palermitana, i cui esponenti addito orgogliosamente addito quali Allievi, qui presente sia con affermati ed esperti studiosi sia con freschi contributi di giovani cultori, ha coltivato una ricca indagine sulle modulazioni dell'oggetto dello studio opportunamente suggerito dalla rivista, dirigendo la propria attenzione verso un duplice obiettivo: da un canto, sceverando la natura delle varie questioni in sé, nella loro essenza considerate; d'altro canto, convogliando verso la sponda dell'appropriato metodo comparatistico l'apparato concettuale appena fissato. E' così che il mutuo contratto con altre esperienze ordinamentali si risolve in, anche implicito, criterio di orientamento per scelte, indirizzi, proposte attuabili nel nostro ordinamento.
Alla prima parte del lavoro scientifico già pubblicata, segue oggi la parte II, qui di seguito presentata.
Alle approfondite riflessioni di Giuseppe Giaimo, Rosario Petruso e Rosalba Potenzano, si ricongiunge dunque l'altrettanto pregevole analisi, acuta ed informata, che Nicoletta Patti svolge relativamente alle conseguenze, agli insegnamenti ed alle svolte impresse dalle soluzioni giurisprudenziali multi-livello nei dolorosi casi Englaro e Cappato ,costituenti basi fondative di attesi interventi legislativi italiani che ben potrebbero trarre proficuo alimento dalla situazione registrata in altri Paesi. Nel medesimo, generale ordine argomentativo, allargato alla questione dell'efficacia da assegnare alla opzione volitiva del paziente rivolta a conseguire assistenza al proprio disegno di suicidio si pone l'ulteriore contributo della medesima Autrice che si indirizza alla ricerca di soluzioni al terribile problema, rinvenendone tracce in un certo numero di ordinamenti stranieri, europei e non.
Ed infine, con finezza di pensiero e dovizia informativa l'analisi di Giancarlo Geraci affonda nel tessuto del processo civile e degli strumenti cautelari che esso presta per quanto attiene alla possibilità di aiuto al proposito di porre termine alla propria esistenza di fronte alla carenza di fattivo sostegno da parte delle competenti autorità sanitarie: il pesante fardello gravante sulle spalle del Giudice, anche straniero, è conseguentemente esplorato. La ricerca di un ragionevole, dignitoso contemperamento tra i concorrenti beni-valori in competizione nella tragica cornice di una vita la cui prosecuzione contrasta ,sul piano della tollerabilità delle sofferenze che ne sgorgano, è adeguatamente perseguita dallo stesso giovane studioso con l'ausilio del raffronto tra le caratteristiche conformanti sul punto il diritto italiano ed il common law inglese.
Il quadro tratteggiato da questi generosi contributi ben si inscrive nell'ariosa visione che Giustizia Insieme ha voluto, nella scia di un dibattito radicato nella coscienza sociale, descrivere nel generale contesto della sublimazione dei precetti costituzionali atti riscattare la dignità umana dal giogo del dolore umiliante ed opprimente.
Anche l'ultima parte di questo lavoro collegiale, ed i singoli contributi, non avrebbe visto la luce senza la costante opera di guida e suggerimento posta in essere con la consueta maestria dalle Professoresse Timoteo e Cetchia, rispettivamente ordinarie di Diritto privato comparato nelle Università di Bologna e di Milano Statale.
Mario Serio
Nicoletta Patti
1. Il valore normativo della sentenza Englaro e delle pronunzie della Corte costituzionale sull'aiuto al suicidio. Punto di arrivo o punto di partenza per il legislatore?
È possibile rintracciare un tratto comune tra le decisioni indicate - sia pure nella diversità delle questioni affrontate - nell’attitudine dei giudici a oltrepassare gli ostacoli ideologici e a confrontarsi con la concretezza delle questioni ad essi sottoposte. Ciononostante, le soluzioni cui sono pervenute le Corti nelle suddette pronunzie non possano che costituire un punto di partenza per il legislatore, il cui intervento oltre che auspicabile, si ritiene doveroso. Al fine di argomentare tale risposta si ritiene opportuno trattare separatamente le due decisioni che, come evidenziato, affrontano due diversi profili del caleidoscopico tema delle decisioni di fine vita. L’obiettivo sarà quello di evidenziare per ognuna i nodi irrisolti e di ricercare possibili soluzioni operando un rimando ad esperienze straniere (fermo restando che una compiuta analisi richiederebbe ben altro spazio).
Nel caso Englaro la Corte di Cassazione ha affrontato il problema che si pone nel caso in cui l’infermo non sia in grado di esprimere la propria volontà a causa del suo stato di totale incapacità e non abbia - prima di cadere in tale condizione, allorché era nel pieno possesso delle sue facoltà mentali - specificamente indicato, attraverso dichiarazioni di volontà anticipate, quali terapie egli avrebbe desiderato ricevere e quali, invece, avrebbe inteso rifiutare nel caso in cui fosse venuto a trovarsi in uno stato di incoscienza. Con un articolato percorso argomentativo, i giudici di legittimità sono giunti ad enunciare il principio di diritto per cui “ove il malato giaccia da moltissimi anni in stato vegetativo permanente, con conseguente radicale incapacità di rapportarsi al mondo esterno (…), su richiesta del tutore che lo rappresenta, il giudice può autorizzare la disattivazione dei presidi sanitari che lo mantengono artificialmente in vita, unicamente in presenza dei seguenti presupposti:
- quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno;
- e sempre che tale istanza sia espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l'idea stessa di dignità della persona.”[1]
Secondo quanto statuito dalla Corte, allora, il diritto all’autodeterminazione dell’infermo in ordine ai trattamenti terapeutici cui sottoporsi - che discende dagli articoli 2 e 32 della Costituzione - deve essere rispettato anche quando il degente versi in uno stato di incapacità volitiva. In tale ipotesi è necessario che la sua volontà - in effetti mai concretamente manifestata - sia ricostruita ed, infine, dichiarata dal tutore, il quale deve agire nell’esclusivo interesse del primo. Tale argomentazione si attesta su posizioni fortemente tributarie al meccanismo del substituted judgement elaborato dalle Corti statunitensi[2], il quale - facendo perno sulla personalità e sulle opinioni del soggetto incapace così come ricostruite dai soggetti preposti alla sua tutela - non ha a proprio fondamento una volontà reale ma, come il nome stesso manifesta, un surrogato di questa.[3] Proprio tale circostanza fa sorgere alcune perplessità. Il tutore, infatti, incaricato del compito di individuare la decisione che l’infermo avrebbe assunto laddove fosse stato capace, non potrà evitare, nell’opera di ricostruzione di una siffatta volontà, una sovrapposizione tra i propri desideri e convincimenti e le opinioni dell’incapace, magari rese in relazione a circostanze tanto differenti da non essere adattabili alla situazione specifica[4]. In altri termini, in assenza di chiare e dirette istruzioni anticipate, non ci sono garanzie che la decisione sostitutiva sia veramente rappresentativa della concezione morale e della valutazione soggettiva dell’infermo. Il rischio, allora, è che, nel ricostruire l’ipotetica determinazione del rappresentato, vi sia uno stravolgimento del giudizio sostitutivo il quale, partendo dalla decisione del paziente, giunge a una decisione del sostituto. Queste brevi riflessioni inducono a ritenere che il meccanismo del substituted judgment non sia realmente idoneo a tutelare l’autodeterminazione della persona che versi in uno stato di incoscienza. È, dunque, necessario un intervento del legislatore che, lungi dal trasporre in forma organica le coordinate già delineate dalla Corte di Cassazione, ricerchi un criterio alternativo maggiormente idoneo a tutelare gli interessi delle persone incapaci.
De iure condendo, un modello di riferimento potrebbe essere rintracciato nell’ordinamento giuridico francese, dove la questione è stata specificamente prevista ed è stata adottata, pur nella delicatezza della materia, una precisa scelta di campo. Nello specifico, il Code de la santé publique, all’art. L.1110-5-1, dispone che nessun trattamento sanitario debba essere iniziato o proseguito nel caso in cui questo si traduca in una irragionevole ostinazione; pertanto, quando gli stessi trattamenti appaiono privi di alcuna utilità, sproporzionati o limitati unicamente al prolungamento artificiale della vita del degente, essi possono essere interrotti conformemente alla volontà del paziente o, in caso di impossibilità di quest’ultimo ad esprimere un volere, in base ad una decisione assunta dal personale sanitario ad esito di una procédure collégiale disciplinata dal codice deontologico della professione. In particolare, se chi ha in cura il degente intende interrompere i trattamenti di sostentamento vitale - in considerazione dell’inutilità degli stessi ad apportare un concreto miglioramento della condizione clinica del degente – ha il dovere di consultare previamente un altro medico (con il quale non intrattenga alcun rapporto di natura gerarchica) e di ascoltare l’opinione di chi abbia la responsabilità legale dell’incapace. La decisione assunta al termine di tale concertazione dovrà essere motivata, riportata all’interno della cartella clinica dell’infermo e comunicata alla personne de confiance[5], se nominata o, in sua assenza, ai familiari dell’infermo. Soltanto nell’ipotesi in cui vi sia disaccordo tra questi ultimi e i medici in ordine alla scelta di proseguire, o meno, i trattamenti sanitari è necessario il ricorso all’autorità giudiziaria, la quale tuttavia ha esclusivamente il compito di verificare che la decisione del medico sia stata assunta nel rispetto della procedura prescritta dalla legge.
La conseguenza di una siffatta scelta legislativa è, dunque, nel segno dell’attribuzione di un ruolo predominante al giudizio dei professionisti sanitari. Come è evidente, in alcun modo viene attribuita rilevanza alla volontà inespressa del paziente quale criterio atto a stabilire se interrompere i trattamenti di sostentamento vitale. Piuttosto, tale decisione si fonda su una valutazione obiettiva dell’irreversibilità dello stato clinico e della conseguente inutilità delle terapie apprestate - inevitabilmente rimessa alla competenza scientifica del medico - e può essere assunta da quest'ultimo anche in contrasto con l’eventuale opinione divergente espressa dai familiari dell’infermo, i quali pur dovendo essere ascoltati nell’ambito della procédure collégiale, non hanno, tuttavia, alcun potere ostativo.
La stessa materia ha trovato una regolamentazione legislativa e giurisprudenziale anche in Inghilterra, con esiti del tutto assimilabili alla soluzione adottata in Francia. La vicenda che ha permesso di avviare una riflessione sul tema è quella che ha coinvolto il giovane Bland, ridotto ad uno stato vegetativo permanente a causa delle lesioni riportate a seguito di un grave incidente[6]. La House of Lords, chiamata a pronunciarsi sulla sospensione della somministrazione di trattamenti terapeutici di sostegno vitale, ha statuito che, nell’ipotesi in cui il paziente non possa esercitare il proprio diritto all’autodeterminazione terapeutica, l’unico elemento che legittima la prosecuzione o l’interruzione di un trattamento sanitario è la necessità di perseguire il best interest del paziente stesso, valutato secondo i parametri condivisi dalla scienza medica. Anche i giudici inglesi, dunque, hanno fatto ricorso a quella misura oggettivamente valutabile costituita dall’inutilità di proseguire un trattamento terapeutico in assenza di un beneficio ulteriore rispetto alla mera sopravvivenza incosciente. Il principio del best interest è stato espressamente recepito dal legislatore inglese che lo menziona all’interno della section 1 del Mental Capacity Act del 2005. La Supreme Court poi, recentemente chiamata a pronunciarsi nuovamente sul tema, ha stabilito che non è necessario ottenere una preventiva autorizzazione giudiziale laddove la decisione circa l’interruzione dei trattamenti di sostentamento vitale sia assunta, sulla base dei parametri oggettivi testé richiamati, da professionisti e congiunti dell’infermo di comune accordo. Soltanto in subordine – quando, cioè, non sussista tale unanimità d’intendimenti – è necessario ricorrere all’autorità giudiziaria, affinché si accerti, con le garanzie del dibattimento processuale, la soluzione più idonea alle esigenze dell’infermo, tenendo conto anche della specifica personalità di quest’ultimo ricavata attraverso elementi attendibili.[7] Sebbene l’ultimo frammento di tale decisione sembra rievocare il giudizio sostitutivo fatto proprio dalla nostra Corte di Cassazione nel caso Englaro, occorre tuttavia considerare come la Corte Suprema del Regno Unito abbia espressamente dichiarato che la competenza delle Corti nell’assumere determinate decisioni sia di fatto inferiore a quella dei medici, la cui valutazione costituisce, dunque, elemento fondante della stessa decisione giudiziaria.[8]
Il criterio del best interest, nell’impossibilità di ricostruire con certezza l’effettiva volontà del paziente incosciente, appare di gran lunga preferibile rispetto alla soluzione adottata dalla Corte di Cassazione e può costituire un utile riferimento per l’auspicato intervento del legislatore italiano: “pur costituendo, senz’altro, una deroga al diritto all’autodeterminazione dell’infermo - dal momento che il compito di accertarlo è demandato al personale sanitario - esso ha almeno il pregio di non consistere in una finzione giuridica, come quella su cui si fonda la tecnica ermeneutica del substituted judgement. Quest’ultima, infatti, perseguirebbe il fine, generalmente impossibile da raggiungere, di pervenire alla stessa decisione che il paziente, se cosciente e capace, avrebbe assunto.”[9]
Il secondo profilo su cui il quesito posto induce a riflettere riguarda i confini del diritto ad ottenere assistenza medica a morire in situazioni patologiche irreversibili alla luce dell’ordinanza n. 207/2018 e, da ultimo, della sentenza n. 242/2019 della Corte Costituzionale.[10]
Con la prima ordinanza la Consulta - investita della questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p., nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio, a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito altrui di togliersi la vita - attraverso un complesso ragionamento la cui descrizione esula dai fini della presente indagine, era giunta alla considerazione per la quale le questioni connesse ad un tema tanto controverso quanto ricco di implicazioni etiche non potessero che essere risolte in Parlamento, luogo deputato per antonomasia alla ricerca di una sintesi tra interessi contrapposti e tutti meritevoli di tutela. La decisione, prima facie, era stata allora quella di assegnare al Parlamento stesso il compito di predisporre una regolamentazione legislativa dell’assistenza al suicidio, nella piena ed espressa consapevolezza che una mera ed incondizionata dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 580 c.p. avrebbe creato un vulnus di tutela al malato stesso e alla collettività tutta, ben maggiore di quello determinato dal mantenimento di una norma in parte illegittima. A distanza di quasi un anno, di fronte alla sostanziale inattività del legislatore – non essendo sopravvenuta alcuna normativa in materia – la Corte ha ritenuto opportuno pronunciarsi in merito alle questioni già diffusamente trattate nell’ordinanza n. 207 del 2018. È allora intervenuta con una nuova decisione al fine di rimuovere quegli aspetti di illegittimità costituzionale che essa aveva già riscontrato nella succitata ordinanza, non limitandosi tuttavia a emettere una sentenza meramente ablativa, ma arrivando di fatto a dettare una regolazione autosufficiente e innovativa, seppur parziale, in tema di fine vita e suicidio assistito[11].
In particolare la Consulta, pur mantenendo intatta la vigenza dell’art. 580 c.p., lo integra di una causa di non punibilità qualora (a) il paziente sia affetto da una patologia irreversibile, (b) questa sia fonte di sofferenze fisiche o psicologiche ritenute assolutamente intollerabili dal malato, (c) la persona sia tenuta in vita attraverso trattamenti di sostegno vitale, (d) l’individuo interessato resti capace di prendere decisioni libere e consapevoli.[12]
Innanzitutto, quanto al primo requisito, è interessante notare come, a differenza del quadro che emerge dal panorama comparatistico, la Corte Costituzionale italiana non abbia subordinato l’accesso all’aiuto al suicidio al fatto che il paziente sia affetto da una malattia in stato terminale, ma richiede la sola “irreversibilità” di una condizione che procura al malato «sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili». La condizione di “terminalità” è richiesta, per esempio, nella legislazione dello stato di Victoria in Australia, dove la legge sul Voluntary Assisted Dying Act (n. 61/2017) prevede, all’art. 9, co. 1, lett. d), n. 3, che il soggetto che intenda suicidarsi abbia ricevuto la diagnosi di una malattia che “is expected to cause death within weeks or months, not exceeding 6 months”[13]. Sulla stessa traiettoria, il progetto di legge presentato alla House of Lords inglese nel 2015 (l’Assisted Dying Bill), delimita l’accesso al suicidio medicalmente assistito al malato terminale che, affetto da una patologia a decorso progressivo e resistente alle cure, “is reasonably expected to die within six months”.[14] Ancora, l’art. 241.2, co. 2 del codice penale canadese prevede - tra i presupposti soggettivi, che la persona sia affetta da “grievious and irremediable medical condition” e che (lett.d)) “their natural death has become reasonably foreseeable”[15].
Ora, le previsioni normative appena riportate appaiono foriere di sperequazioni tra infermi che patiscono le stesse sofferenze. Subordinare, infatti, l’accesso al suicidio assistito ad una circostanza che si fonda su una valutazione medica, neppure certa in ordine al suo verificarsi nei tempi previsti, circoscrive in modo eccessivo la portata applicativa delle disposizioni richiamate. Il rischio è che venga riservato un trattamento diverso a coloro che, pur sopportando i medesimi patimenti, abbiano - secondo l’opinione dei professionisti sanitari - una differente prospettiva di vita in termini strettamente quantitativi. In questo senso, la sola irreversibilità della malattia, come previsto dalla Corte, appare una condizione ben più inclusiva rispetto allo stato terminale, dal momento che la stessa si riferisce ad una patologia “non guaribile” sulla base delle conoscenze e delle tecniche medico-scientifiche disponibili nel momento in cui viene valutata la richiesta di assistenza medica a morire. Da questo punto di vista, allora, la scelta operata dalla Consulta risulta condivisibile. Fa sorgere dubbi, sul piano della ragionevolezza, invece, la previsione che il paziente, affinché possa ottenere assistenza medica nel morire, debba essere tenuto in vita da trattamenti di sostentamento vitale. Tale condizione, assente nelle legislazioni di ordinamenti stranieri, comporta (quantomeno fino all’auspicabile intervento del legislatore) risposte giuridiche opposte tra chi necessita di tali interventi e chi, invece, pur malato irreversibilmente e sofferente in un modo ritenuto non più sopportabile, abbia la “sfortuna” di vedere la propria vita svincolata da qualsiasi terapia vitale. I primi, infatti, hanno il diritto di chiedere la cessazione delle cure, lasciandosi morire (ex legge n. 219 del 2017) e – adesso – anche di ottenere il suicidio medicalmente assistito; i secondi, invece, si vedrebbero precluse tali opprtunità: l’una perché non vi è alcun trattamento da interrompere, l’altra in quanto verrebbe a mancare uno dei requisiti che legittima l’accesso dell’infermo al suicidio assistito, rimanendo così “condannati a vivere” contro la loro volontà e la loro (percezione) di dignità.
Il legislatore dovrebbe allora intervenire estendendo la platea di beneficiari del suicidio medicalmente assistito, includendo anche chi, non tenuto in vita da detti trattamenti, risulti comunque affetto da patologie irreversibili - fonti di intollerabili sofferenze fisiche o psichiche - e contemporaneamente capace di assumere decisioni libere e consapevoli.
Una simile soluzione si trova nella proposta di legge n. 1875 la quale, all’art 3, comma 1, prevede che possa chiedere aiuto nella morte il soggetto affetto da una malattia a prognosi infausta che gli procuri sofferenze evidenti, insostenibili e irreversibili[16]. In maniera condivisibile, il presupposto applicativo della norma viene sganciato dalla dipendenza da trattamenti di sostentamento vitale, per ancorarlo esclusivamente a condizioni di vita terribilmente deteriorate in cui versa il paziente e che giustificano un intervento diretto, in maniera compassionevole, ad abbreviarle.
Un ulteriore elemento che emerge dall’analisi comparatistica è che in alcuni ordinamenti (si vedano, ad esempio la legislazione adottata in Australia[17] e in Canada[18], nonché l’Assisted Dying Bill inglese[19]) il perimetro applicativo della depenalizzazione dell’aiuto al suicidio riserva la possibilità di attivare il relativo procedimento ai soggetti che posseggano la residenza nella stessa nazione.
Una tale limitazione, non prevista tra le condizioni dettate dalla Consulta, né inserita in alcuno dei progetti di legge attualmente pendenti dinnanzi al Parlamento italiano, ha il pregio di impedire a soggetti stranieri - cittadini di stati nei quali non è permessa l’assistenza all’infermo a porre termine alla propria vita - di recarsi in quegli ordinamenti al fine di accedere a quell’atto estremo vietato nei luoghi di provenienza, così evitando il fenomeno del c.d. “turismo della morte”.
Procedendo oltre nella disamina della pronuncia n. 242/2019, la Corte Costituzionale, dopo aver aperto al suicidio assistito nei casi che sopra esaminati, vi affianca altri elementi che ricava dalle «coordinate del sistema vigente», avendo, in particolare modo, come «punto di riferimento» la legge n. 219 del 2017[20].
Il richiamo a tale legge consente alla Corte di collegare e circoscrivere l’aiuto al suicidio alla relazione terapeutica, estendendovi la “procedura medicalizzata” già prevista dal legislatore. Tale percorso “medicalizzato” comporta una verifica dei presupposti oggettivi indicati dalla Corte (in particolare l’esistenza di una patologia irreversibile, le sofferenze fisiche o psichiche intollerabili per il degente, la presenza di trattamenti di sostegno vitale). Tale compito, «in attesa della declinazione che potrà darne il legislatore», viene affidato a strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale. Ad esse spetta vagliare anche «le relative modalità di esecuzione, le quali dovranno essere evidentemente tali da evitare abusi in danno di persone vulnerabili, da garantire la dignità del paziente e da evitare al medesimo sofferenze». L’importanza dei valori in gioco porta la Consulta a richiedere, quale ulteriore requisito, «l’intervento di un organo collegiale terzo, munito delle adeguate competenze», idoneo a «garantire la tutela delle situazioni di particolare vulnerabilità». Sempre nell’attesa delle scelte legislative, il compito è affidato ai comitati etici territorialmente competenti, già investiti di funzioni consultive «che involgono specificamente la salvaguardia di soggetti vulnerabili»[21].
L’esigenza di un presidio rafforzato di garanzia non può non essere condivisa. Residuano, ciononostante, talune perplessità: da un lato sull’effettiva capacità del sistema sanitario nazionale di sostenere l’incombenza, in modo particolare dal punto di vista organizzativo, specialmente in mancanza (come vedremo) di un obbligo nei confronti del personale medico; dall’altro in rapporto alla reale idoneità dei comitati etici ad assumere il ruolo di “organi collegiali terzi muniti delle adeguate competenze”[22] (per la loro composizione, per il possibile rischio di approcci non uniformi tra i diversi comitati territorialmente competenti; per la non meglio precisata natura del parere espresso, vincolante o no).
A tale proposito, un utile spunto per il legislatore italiano può essere tratto dalla procedura prevista nell’Assisted Dying Bill. Tale progetto di legge, oltre a richiedere (similmente a quanto stabilito dalla normativa canadese[23], australiana[24], olandese[25] e belga[26]) che ben due medici in posizione di indipendenza tra loro attestino – dopo avere esaminato separatamente il malato e la sua storia clinica – l’esistenza dei presupposti che legittimano il suicidio assistito, prevede altresì che l’istanza dell’infermo sia rivolta alla Family Division della High Court, la quale ha il compito di accertare la genuinità del volere del richiedente e il rispetto di tutte le formalità prescritte dalla legge.[27] Tale soluzione che, sulla scorta delle stesse preoccupazioni che animano la procedura delineata dalla Corte Costituzionale, prevede un doppio controllo appare idonea a eliminare ogni probabile abuso che possa dipendere sia dalla presenza di un medico eccessivamente pronto ad assecondare la richiesta eutanasica, sia pure in assenza di un rigido controllo sulla sussistenza di tutti i presupposti soggettivi; sia, ancora, dall’esistenza di una pressione indebita sul volere del malato non rilevabile da un medico come potrebbe esserlo, invece, da parte di un giudice[28]. Un’ultima riflessione. La Corte Costituzionale già nell’ordinanza n. 207 aveva suggerito al legislatore la necessità di contemplare (colmando l’attuale lacuna della legge n. 219/2017) una regolamentazione dell’obiezione di coscienza del personale sanitario coinvolto nella procedura di agevolazione al suicidio in presenza delle più volte richiamate circostanze. Nella sentenza il punto, in realtà centrale, è velocemente risolto prevedendo che, esclusa la punibilità dell’aiuto al suicidio nei casi considerati, nessun obbligo è previsto in capo al singolo medico, affidandosi alla sua coscienza la scelta “se prestarsi, o no, a esaudire la richiesta del malato”[29]. Il rischio, tuttavia, è di rendere in questo modo del tutto aleatorio l’agognato aiuto a porre fine alle proprie sofferenze e di ridurre, di conseguenza, il suicidio assistito ad un «diritto» privo di una concreta azionabilità. Piuttosto dovrebbe prevedersi, pur sempre nel rispetto di eventuali obiezioni di coscienza del personale sanitario, la presenza all’interno della struttura sanitaria di almeno un medico pronto a dare seguito alla volontà del paziente.
In questo senso la normativa belga, a seguito della novella introdotta con legge del 15 marzo 2020, può costituire un utile punto di riferimento. Essa, infatti, prevede che se il medico consultato, esercitando la propria libertà di coscienza, rifiuta di praticare l’eutanasia, è tenuto ad informare il paziente entro 7 giorni dalla formulazione della richiesta, contestualmente rendendolo edotto delle ragioni del diniego. Egli dovrà inoltre fornire al paziente o alla persona di fiducia i recapiti di un centro o associazione specializzata nelle pratiche eutanasiche e inviare la cartella clinica ad un medico designato dal paziente stesso o dalla personne de confiance.[30] In questa traiettoria, condivisibilmente, la proposta di legge n. 1875, all’art. 6, dopo aver riconosciuto il diritto del personale sanitario a non prendere parte alle procedure del suicidio medicalmente assistito e del trattamento eutanasico, stabilisce che le strutture del Servizio sanitario nazionale sono comunque tenute a garantire il rispetto della volontà manifestata dal paziente. Qualora tale diritto non sia garantito, la struttura del Servizio sanitario nazionale, ferme restando le conseguenze penali o civili, dovrà provvedere al risarcimento del danno morale e materiale provocato[31].
Quanto discusso finora dovrebbe aver chiarito la non completa esaustività della decisione della Corte e, al contempo, la consapevolezza della stessa di non esserlo né tantomeno di poterlo essere. Non va dimenticato, infatti, come la decisione assunta con ordinanza n. 208 di rinviare la trattazione (o per meglio dire di differire la declaratoria della ravvisata illegittimità costituzionale dell’art. 580 c.p.), sia stata mossa dalla finalità di consentire al Parlamento, in nome dell’invocato “spirito di leale e dialettica collaborazione istituzionale”[32], l’esercizio delle proprie prerogative. Già a suo tempo, indicando le linee guida dell’auspicato intervento legislativo, che hanno poi trovato concretezza nella sentenza n. 242, la Corte ha intrapreso un’apprezzabile opera di bilanciamento di interessi contrapposti (l’ autodeterminazione del singolo individuo e la protezione del bene-vita) che, in ogni caso, oggi il legislatore è chiamato a completare (seppur nell’esercizio della sua discrezionalità); è questo il significato da attribuire al monito, sia pur conciso, contenuto a chiusura della sentenza n. 242 del 2019 a che “la materia formi oggetto di sollecita e compiuta disciplina da parte del legislatore, conformemente ai principi precedentemente annunciati”[33].
2. Il valore della volontà del paziente incosciente e l’aiuto al suicidio
Prima di affrontare il quesito posto è necessario effettuare una breve premessa di carattere terminologico, che consenta un approccio il più possibile analitico all’oggetto di studio.
Per “eutanasia attiva” si intende quella condotta attraverso la quale il personale sanitario avvia dei processi idonei a provocare il decesso di chi soffra di una patologia caratterizzata da una prognosi infausta ed irreversibile, al fine di abbreviarne i conseguenti patimenti e di preservare una (altrimenti difficile) dignità nella sofferenza. All’interno di tale categoria occorre poi compiere una necessaria distinzione tra l’ipotesi di eutanasia attiva diretta - che si realizza attraverso il compimento di atti con i quali si pone fine, a determinate condizioni, alla vita altrui in maniera immediata e senza arrecare sofferenze - e quella, differente, di assistenza al suicidio che si sostanzia nella procedura in base alla quale il personale del Servizio sanitario nazionale fornisce al paziente ogni supporto sanitario e amministrativo necessario per consentirgli di porre fine alla propria vita in modo dignitoso, autonomo e volontario[34]. La differenza tra le due fattispecie è netta: se nella prima ipotesi il decesso è provocato direttamente dal medico tramite la somministrazione di farmaci che inducono la morte, generalmente per via endovenosa, nel caso di suicidio medicalmente assistito l'atto finale di togliersi la vita - somministrandosi le sostanze necessarie in modo autonomo e volontario - è compiuto interamente dal soggetto stesso e non da soggetti terzi, i quali si occupano di assistere la persona per altri aspetti, quali il ricovero, la preparazione delle sostanze e la gestione tecnica post mortem.
Risolto tale iniziale problema definitorio, risulta evidente come nessun valore possa essere attribuito alla volontà del paziente diretta ad ottenere assistenza al suicidio per l’ipotesi futura in cui dovesse versare in uno stato di incoscienza. In tale circostanza, infatti, l’interessato non potrebbe esercitare quel dominio sull’atto finale che innesca il processo letale che è insito, per definizione, nel suicidio assistito. Vi sarebbe, dunque, un’incompatibilità logica tra lo stato di incoscienza in cui versa il degente e la modalità attraverso la quale lo stesso dovrebbe raggiungere la morte.
Bisogna allora, più correttamente, domandarsi quale sia il valore eventualmente da attribuire alla manifestazione di volontà resa anticipatamente dal paziente incosciente al fine di accedere ad un atto di eutanasia attiva diretta, praticato interamente dal personale sanitario.
A tal proposito può essere utile volgere lo sguardo alla disciplina adottata in altri ordinamenti, in modo da rilevare possibili spunti di riflessione dalle differenti soluzioni legislative adottate sul punto. In particolare analizzeremo la disciplina prevista in Belgio, Olanda, Canada e Australia (stato di Victoria)[35], al fine di confrontarla con quella individuata, per la medesima materia, nelle proposte di legge presentate al Parlamento italiano.
In Belgio, così come in Olanda, è attribuita rilevanza alla volontà del paziente incosciente soltanto se la stessa sia stata trasposta in una dichiarazione anticipata, contenente in modo chiaro ed univoco, la richiesta di eutanasia e siano rispettate alcune condizioni. In particolare il legislatore belga ha previsto che la dichiarazione anticipata debba essere firmata da un maggiorenne o da un minore emancipato. In entrambi i casi dev’essere sottoscritta da due testimoni, di cui almeno uno non deve avere un interesse materiale nel decesso del dichiarante. Questa dichiarazione, revocabile o modificabile in qualsiasi momento, può essere utilizzata dal medico solo nel caso in cui il paziente si trovi in stato d’incoscienza irreversibile secondo le conoscenze scientifiche dell’epoca.[36] Il dichiarante può designare una o due persone di sua fiducia che gli facciano da portavoce nel momento in cui non sarà in grado di esprimersi. In ogni caso la dichiarazione anticipata non è vincolante, e il medico può rifiutarsi di praticare l’eutanasia[37].
Anche la legge olandese sull’eutanasia prevede che un soggetto possa rendere delle dichiarazioni anticipate destinate ad assumere rilevanza nel caso di sopravvenuta incapacità e impossibilità di esprimere al medico la propria volontà di accedere alle pratiche eutanasiche, sebbene alle stesse non sia attribuita natura vincolante. L’art 2, comma 2 prevede infatti che “se il paziente che ha sedici anni o un’età superiore non è capace di esprimere la sua volontà, ma prima di raggiungere questa condizione clinica aveva una ragionevole capacità di intendere e di volere circa i suoi interessi ed ha fatto un testamento scritto che contiene la richiesta per l’eutanasia, il medico può non tenere conto di questo requisito.”[38]
Una soluzione simile si ritrova nelle proposte di legge italiane n. 1586 e n. 1655 le quali, rispettivamente agli articoli 3 e 4 ter, stabiliscono che «ogni persona può compilare un atto scritto, con firma autenticata dall’ufficiale di anagrafe del comune di residenza o domicilio con il quale chiede l’applicazione dell’eutanasia nell’ipotesi in cui egli diventi incapace di intendere e di volere ovvero di manifestare la propria volontà, nominando contemporaneamente un fiduciario (…) perché confermi la richiesta ricorrendone le condizioni. La richiesta di applicazione dell'eutanasia deve essere chiara ed inequivoca e non può essere soggetta a condizioni. Essa deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, da un’autodichiarazione, con la quale il richiedente attesta di essersi adeguatamente documentato in ordine ai profili sanitari, etici e umani ad essa relativi. La conferma della richiesta da parte del fiduciario deve, altresì, essere chiara e inequivoca, nonché espressa per scritto».
Effettuando un raffronto comparatistico emerge come, in modo condivisibile, nessuna delle previsioni richiamate attribuisce natura vincolante alla volontà espressa nelle disposizioni anticipate, consentendo dunque al medico di discostarsene. Ciò che desta perplessità, invece, è che né nella disciplina olandese né in quella individuata nelle proposte di legge richiamate è richiesta la maggiore età del disponente per la redazione di una siffatta dichiarazione anticipata, con la conseguenza che, nell’ipotesi di trattamenti eutanasici da praticarsi in futuro, è sufficiente la capacità di intendere e di volere, piuttosto che quella di agire. Una simile conclusione potrebbe essere condivisibile laddove la volontà del paziente fosse diretta a definire un percorso di cura, quale estrinsecazione del potere di autodeterminazione dell’individuo in ordine alla pianificazione del trattamento terapeutico conseguente allo stato patologico in cui versa. Tale diritto di scegliere le cure cui sottoporsi, all’interno del quadro delle possibili alternative, dovrebbe ragionevolmente non essere circoscritto entro i limiti della capacità d'agire. L’ipotesi di richiesta di eutanasia, formulata in anticipo rispetto al momento in cui dovesse insorgere uno stato di incoscienza, è però del tutto diversa: in questo caso, infatti, il soggetto dispone, in modo irrimediabile, di sé stesso e della propria vita. Allora tale manifestazione di volontà, destinata ad incidere in maniera profonda e irreversibile sulla sfera giuridica e personale del dichiarante, dovrebbe presupporre, in ragione della estrema delicatezza e irrimediabilità della decisione, la piena capacità legale d’agire del soggetto e non soltanto la naturale capacità di intendere e di volere[39]. Sotto questo profilo, condivisibile risulta la scelta effettuata nell’ordinamento giuridico belga di limitare la possibilità di richiedere l’eutanasia, in previsione di una eventuale futura incapacità deliberativa, ai maggiorenni e ai minori abilitati.
Al di là del dato anagrafico, tuttavia, vi è un ulteriore elemento, più incisivo, che induce a discostarsi in modo radicale da ognuna delle soluzioni finora analizzate.
Le disposizioni anticipate possono essere redatte in un momento lontano rispetto a quello in cui si dovrebbe applicare il trattamento eutanasico, in cui il paziente può anche non essere affetto da alcuna malattia cronica, invalidante o mortale. Questa circostanza si pone in radicale antitesi con il presupposto proprio dell’eutanasia, che risiede, invece, nell’attualità di una condizione patologica che arrechi sofferenze così gravi da rendere insopportabile l’esistenza dell’infermo.[40] Alla luce di tale considerazione, si ritiene del tutto preferibile l’opzione legislativa di cui alla proposta n. 1875[41], la quale, analogamente alla legge canadese[42] e a quella australiana (stato di Victoria)[43], non contempla la possibilità di redigere dichiarazioni anticipate che abbiano ad oggetto la richiesta di pratiche eutanasiche, negando in radice l’attribuzione di qualsivoglia valore ad una manifestazione di volontà pregressa in tal senso orientata. È necessario, allora, che chi richiede l’eutanasia sia dotato di piena capacità decisionale durante l'intero processo che condurrà all’esito esiziale, al fine di assicurarsi che la decisione assunta sia volontaria, ponderata e coerente rispetto alla condizione clinica attuale.
Giancarlo Geraci
1. Alla ricerca di un bilanciamento fra dignità, diritto alla vita, autodeterminazione e tutela della salute. Potrà mai essere trovato “per legge”?
La domanda pone una preliminare difficoltà. Il riferimento a termini che hanno una portata e una pregnanza assai profonda nell’ordinamento giuridico, non solo a livello nazionale, quali la dignità, il diritto alla vita, all’autodeterminazione e la tutela della salute, sembrano porre l’interprete innanzi a una matassa assai ingarbugliata che, pertanto, necessita di essere accuratamente sbrogliata.
Con riferimento alla dignità[44], ragionando in termini generali, è stato osservato[45] come sia assai complicato tentare di inquadrare tale termine all’interno di una cornice definitoria ben determinata. Sulla scorta di un’analisi della giurisprudenza della Corte Costituzionale[46], tuttavia, si può ragionevolmente ritenere come il concetto di dignità sia assunto quale indefettibile presupposto per l’esercizio dei diritti, ossia come quel requisito fondamentale che, all’interno di una Carta costituzionale che si ispira al principio personalista, qual è quella italiana, è riconosciuto ad ogni individuo come tale e di cui quest’ultimo non può in alcun modo essere spogliato.
Non a caso si è osservato[47] come per indicare la parola “dignità”, intesa nel senso di qualità, valore elevato dell’essere umano, nel greco antico veniva usato il termine axìoma che, successivamente, è stato tradotto con la parola “assioma” intesa, appunto, come principio primo, come enunciato presupposto di ogni procedimento argomentativo.
In tal senso, dunque, per poter coerentemente rispondere alla domanda e per cercare di entrare in un campo di indagine più specifico, è necessario coniugare la dignità con un altro fondamentale diritto, ossia quello all’autodeterminazione dell’individuo e osservare come, con specifico riferimento a tale aspetto, esistano due specifiche concezioni[48] del termine in discorso[49].
Secondo una prima accezione, che si pone in linea di continuità con quanto sinora osservato, la dignità sarebbe un concetto inerente ad ogni individuo e da cui deriva ogni altro diritto fondamentale a questi ascrivibile[50]. Tale accezione di dignità è nota come dignity as empowerment, poiché la dignità diviene proprio quello strumento di rafforzamento dell’individuo nei confronti di qualsivoglia interferenza altrui.
Altra accezione del termine, contrapposta a quella sinora brevemente analizzata, individua nella dignità sempre quell’indefettibile presupposto di ogni diritto fondamentale che, tuttavia, ed è questa la fondamentale differenza, non è propria di ciascuna persona ma del genere umano complessivamente inteso[51]. Si parla, in tale accezione, di dignity as constraint, poiché la dignità è essa stessa fonte di interdizioni e divieti inderogabili anche da parte dei relativi “titolari”.
Per poter, dunque, trovare un corretto bilanciamento tra la dignità umana e l’autodeterminazione dell’individuo, non può che accogliersi la prima concezione, previamente spiegata, di dignità. Solamente in tal senso, infatti, l’idea del diritto all’autodeterminazione della persona assume un suo significato compiuto e trova nella dignità stessa il suo presupposto indefettibile e fondamentale.
Con specifico riferimento, poi, al principio di autodeterminazione, non può non osservarsi come esso abbia subito un processo evolutivo, che lo ha portato ad una progressiva emersione. Nonostante, infatti, l’art. 32, secondo comma, Cost.[52] abbia sempre previsto il diritto di ciascuno ad autodeterminarsi in ambito sanitario in particolare garantendo il diritto di rifiutare ogni trattamento sanitario che non sia obbligatorio per legge si ritiene[53] che tale principio sia incominciato ad emergere effettivamente solo dagli anni’ 70 del secolo scorso. In tale periodo, infatti, si assiste al graduale superamento della concezione del rapporto medico/paziente di stampo “paternalistico” (in cui il sanitario aveva l’obbligo di trattare il paziente secondo i dettami della scienza medica e quest’ultimo era visto più come un oggetto delle cure che come soggetto delle stesse) ad uno di tipo “personalistico” basato, per l’appunto, sul principio di autodeterminazione del paziente stesso.
Il suddetto principio ha assunto oggi un ruolo preminente nell’ambito dei trattamenti sanitari, in quanto connesso al concetto di dignità dell’individuo quale presupposto indefettibile dello stesso essere umano e di cui egli è principale, se non addirittura esclusivo, arbitro. Ad ulteriore sostegno di quanto si sta affermando, non può non citarsi la recentissima legge n. 219 del 2017 che, facendo propri principi stabilmente affermatisi nella giurisprudenza, ha finalmente riconosciuto un ruolo primario al consenso dell’individuo, che solo se adeguatamente informato potrà consentire una libera esplicazione della sua autodeterminazione nel campo dei trattamenti sanitari[54].
Alla luce di quanto sinora esposto, dunque, non può non ritenersi che, per ritornare alla domanda iniziale, la dignità e l’autodeterminazione debbano necessariamente essere poste sullo stesso piatto della bilancia.
Il punctum pruriens rispetto al tema in discorso è certamente uno. Se, infatti, il principio di autodeterminazione, coniugato con la concezione di dignità umana di cui si è detto, certamente consente all’individuo di rifiutare i trattamenti sanitari (anche quelli c.d. salva-vita) ci si domanda se questi stessi principi possano consentire all’individuo anche di pretendere un trattamento sanitario che lo conduca al decesso: si fa, evidentemente, riferimento alle pratiche di eutanasia attiva[55] e di suicidio assistito[56].
In questi casi viene ad affacciarsi l’altro piatto della suddetta ipotetica bilancia, ossia quello del diritto alla vita, rectius della sacralità della vita. Sarebbe pleonastico sottolineare come in qualsiasi ordinamento giuridico democratico, il diritto alla vita è sempre tutelato e garantito nei confronti di ogni individuo. Ma tale tutela può giungere fino a “costringere” taluno a vivere anche qualora non lo voglia? Si può dire, in altri termini, che esista non un “diritto” alla vita ma un “dovere” alla vita? Orbene, guardando al nostro ordinamento, due notazioni sono preliminari.
La prima, quella secondo cui, come in altri ordinamenti occidentali[57], la tutela del diritto alla vita non arriva al punto di sanzionare penalmente colui che commetta, o tenti di commettere, un suicidio e, la seconda, che si pone in linea di continuità con questa, che è garantito, come visto precedentemente, il diritto “a lasciarsi morire”, rifiutando un trattamento sanitario, non obbligatorio. Tuttavia, come si diceva, il problema sorge allorché si pretenda che qualcuno attivamente interferisca nella vita di un altro, con il suo consenso, per porvi fine.
La questione deve necessariamente essere letta con l’ultimo dei concetti cui si fa riferimento nella domanda, ossia quello della tutela alla salute. Questo potrebbe essere ritenuto quale chiave di volta per addivenire ad un corretto bilanciamento dei termini della questione, solo se correttamente inteso. È chiaro che la salute di ogni individuo non è solamente quella fisica ma anche quella psichica. In tal senso, allora, la situazione in cui un soggetto che si trovi in uno stato patologico irreversibile, che gli causa sofferenze gravi ma non tali da determinarne la (prossima) morte e che maturi pertanto un’autonoma e consapevole volontà di porre fine alle proprie sofferenze, porta a una domanda. In tali casi l’ordinamento giuridico, che tutela il diritto alla salute dell’individuo stesso, deve intervenire assecondando la volontà dell’infermo ovvero, al contrario, rimanere inerte, negando al soggetto tale volontà, nel nome di un’astratta tutela della salute (solamente fisica in questo caso) e di un dovere, più che un diritto, alla vita?
È evidente come il bilanciamento tra questi concetti, come si è anticipato in apertura, sia assai complicato per il legislatore, per il fatto che essi involvono talmente varie, complesse, situazioni che diviene assai difficile prevedere e disciplinare tramite la legge, per definizione astratta e generale[58].
Allo stesso tempo, tuttavia, nell’inerzia del legislatore, si pongono inevitabilmente drammatici casi inerenti alla tematica del fine vita che devono essere risolti dal giudice che, assai spesso, proprio a causa dell’assenza di un adeguato strumentario normativo, si trova costretto a pronunce di tipo creativo[59], basate su un bilanciamento dei diritti in gioco, ovvero a rimandare la questione al giudice delle leggi[60].
Dando uno sguardo oltre i confini nazionali, come si è già osservato, sono assai pochi gli ordinamenti che sono riusciti a darsi una legislazione in tema di fine vita.
Tuttavia, vi è senz’altro un fil rouge tra gli ordinamenti che non può essere sottaciuto. Si fa riferimento, in particolare, al fatto che tanto le varie proposte di legge, sia italiane che straniere (come nel caso inglese[61]), che le leggi in tema di fine vita (come quella canadese[62]) sono state precedute da casi giurisprudenziali che hanno destato l’attenzione dell’opinione pubblica e che hanno in qualche modo segnato la strada che poi il legislatore ha effettivamente intrapreso.
Quanto finora osservato conduce ad una conclusione. Trovare un bilanciamento tra dignità, autodeterminazione, diritto alla vita e tutela alla salute è qualcosa di estremamente complicato, in particolare per il legislatore. Tuttavia, come si è detto, la varietà e la quotidianità delle drammatiche vicende che involvono il tema del fine vita impongono a questi di intervenire e non rimanere inerte. Per far ciò, un aiuto fondamentale può essere senz’altro rinvenuto nel patrimonio fecondo di principi di diritto enunciati nelle pronunce delle autorità giurisdizionali, non solo interne, che hanno affrontato il tema e che, per forza di cose, non si sono in alcun modo potute sottrarre ad una decisione.