L’improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione
di Giorgio Spangher
Sommario: 1. Chiarezza definitoria e concettuale - 2. Le situazioni “arate” e... - 3. ...gli orientamenti in via di consolidamento - 4. I profili controversi.
1. Chiarezza definitoria e concettuale
Di fronte alla nuova formula di definizione del processo, appare necessario distinguere anche formalmente, oltre che sostanzialmente, le tre situazioni attorno alle quali spesso ruota il dibattito, evitando di cambiarne la letteralità, con il rischio di inquinarne gli effetti, anche perché nel pronunciarle il giudice deve precisarne i presupposti nel dispositivo (artt. 529 e 531 c.p.p.).
L’estinzione del reato opera solo in primo grado; l’improcedibilità per mancanza di querela, o di altra condizione di procedibilità, opera in ogni stato e grado; l’improcedibilità per superamento dei termini di durata del giudizio di impugnazione opera solo nel giudizio di impugnazione dopo la sentenza di primo grado e d’appello. Quindi, netta distinzione, evitando sovrapposizioni tra le ipotesi di improcedibilità, e tra l’improcedibilità (a volte definita prescrizione processuale o cronologica) e l’estinzione del reato per prescrizione.
In questa prospettiva, due punti sembrano anche da considerare ulteriormente significativi: la differenza tra prescrizione sostanziale e improcedibilità, stante almeno la previsione differenziata dell’art. 578, comma 1 bis, c.p.p., altrimenti non giustificabile; la diversità anche con le altre situazioni di improcedibilità in relazione all’esercizio dell’azione penale, nel caso dell’art. 344 bis c.p.p., invece, regolarmente esercitata.
Per queste ragioni trova piena giustificazione la tesi per la quale l’art. 344 bis c.p.p. non opera in relazione alle impugnazioni ex art. 428 c.p.p. della sentenza di non luogo di cui all’art. 425 c.p.p., alle impugnazioni per i soli interessi civili, alle impugnazioni cautelari ed a quelle straordinarie.
2. Le situazioni “arate” e...
Il confronto di opinioni sulla decisione di improcedibilità dell’art. 344 bis c.p.p. introdotta dalla l. n. 134 del 2021 sta registrando alcune convergenze su alcuni profili della relativa disciplina, pur non mancando, naturalmente, i dissensi, anche autorevoli e motivati.
La prima questione – che invero sembrava definita, riguarda gli effetti della declaratoria di improcedibilità sulle decisioni oggetto di impugnazione.
Secondo un convincimento solidamente diffuso si affermava che la sentenza di improcedibilità, conseguente all’impugnazione, supera la decisione emessa nel grado precedente.
In particolare, si ritiene che con la declaratoria di improcedibilità, non c’è né condanna né proscioglimento; sono assorbite le precedenti decisioni sia di condanna, sia di assoluzione; si caducano le misure cautelari personali (anche quelle a tutela della vittima) e quelle reali; l’imputato perde il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione; vengono meno i provvedimenti civili provvisoriamente esecutivi nonché le decisioni di confisca; non c’è nessuna decisione sul querelante; la sentenza non ha autorità di giudicato in sede civile o disciplinare; si prospettano questioni sul valore probatorio del materiale in un altro procedimento; in caso di annullamento con rinvio per la determinazione della pena viene meno il giudicato sulla responsabilità; forse l’imputato può avvalersi della legge Pinto.
La conclusione proposta non esclude la presenza di alcune questioni “aperte”.
Fra queste non possono non segnalarsi – mancando a differenza della estinzione del reato ogni indicazione sul punto – le possibili implicazioni sulla responsabilità delle persone giuridiche ex l. n. 231 del 2001; le patologiche implicazioni ex art. 604, comma 6, c.p.p., di una errata decisione di prescrizione in primo grado, stante l’impossibilità di dichiarare l’estinzione del reato, eventualmente maturato, nel giudizio di appello; la fissazione del termine in caso di sviluppo dell’impugnazione della decisione di inammissibilità; l’indicazione del termine massimo in caso di plurimi annullamenti con rinvio e quello in caso di conversione in appello, il valore delle prove assunte nel procedimento di cui al gravame.
Recentemente si è affermato che l’art. 344 bis c.p.p. costituisce una causa di inammissibilità sopravvenuta con effetti soltanto nel grado in cui si è verificato l’esaurimento del tempo per il relativo giudizio, lasciando sopravvivere la sentenza impugnata, sia essa di condanna, sia essa di proscioglimento.
La tesi, che non trova nessun riferimento testuale, è contraddetta in primo luogo dagli effetti che essa determinerebbe.
Il dato non solo è smentito, come riconosciuto pure da chi avanza questa tesi, anche se ipotizza un suo superamento in attuazione della delega (art. 1, comma 13, lett. d, l. n. 134 del 2021), da quanto previsto dall’art. 578, comma 1 bis, c.p.p. (di nuovo conio), ma soprattutto dalle ricadute negative della “conservazione” della sentenza impugnata.
Si sostiene, infatti, che in caso di proscioglimento questa opererebbe a favore dell’imputato, senza conferire verosimilmente al p.m. nessun potere negativo o interdittivo, come nel caso in cui la decisione fosse viziata da nullità ovvero fosse basata su prove inutilizzabili (che, conseguentemente, diverrebbe irrevocabile).
Nel caso della condanna, si afferma che all’imputato sarebbe consentito il diritto di rinuncia alla improcedibilità rectius, la richiesta di prosecuzione del processo (art. 344 bis, comma 7, c.p.p.).
I riferiti effetti della declaratoria di improcedibilità hanno prospettato il problema della possibilità di riavviare il percorso processuale per il medesimo fatto.
Dopo aver chiarito quale rapporto possa prospettarsi con la possibilità che il decorso della prescrizione sia o meno cessato con la sentenza in primo grado (ex art. 161 bis c.p.), una volta sopravvenuta la declaratoria di improcedibilità è necessario interrogarsi sull’operatività di quanto previsto dall’art. 649 c.p.p. ove è disciplinato il divieto di un secondo giudizio (ne bis in idem).
Fatta salva la possibilità di una diversa qualificazione del fatto (da ritenersi ipotesi remota), le situazioni derogatorie di cui all’art. 649 c.p.p., riferite a quanto previsto dall’eccezione di cui all’art. 345 c.p.p., non sembrano attagliarsi al caso qui considerato che, pertanto, sembrano suggerire che non sia possibile avviare un nuovo procedimento.
La soluzione interpretativa proposta prospetta anche non poche questioni legate alle sue implicazioni sotto il profilo della legittimità costituzionale.
Invero, in termini estremamente pregnanti, la previsione prospetta una questione sotto il profilo del possibile contrasto con l’art. 101 Cost. in relazione al pregiudizio per l’esercizio della funzione giurisdizionale che è pregiudicata dal decorso del tempo massimo delle fasi di impugnazione, con conseguente pregiudizio sia delle iniziative dell’accusa sia delle aspettative difensive.
In altri termini, si tratta di riflessi indiretti sugli artt. 112 e 24 Cost.
Il dato ha ricadute anche in relazione all’effettività della giurisdizione di cui all’art. 47 del Trattato dell’Unione europea, nonché dell’art. 6 della Cedu.
Si sono prospettate anche violazioni dirette con il principio di obbligatorietà dell’azione penale; invero, la richiesta del pubblico ministero di una decisione sull’ipotesi accusatoria risulterebbe preclusa dalla decisione di improcedibilità.
Il dato non è convincente, considerato che a differenza delle situazioni di mancanza di una condizione di procedibilità, dove difetta l’elemento dell’esercizio dell’azione penale, nel caso di specie l’azione è stata validamente esercitata.
La disciplina dell’art. 344 bis c.p.p. prospetta, tuttavia, ulteriori possibili questioni di incostituzionalità. Il primo dato è ricollegabile alla irrazionabilità delle cadenze cronologiche dei possibili percorsi processuali (es.: in primo grado otto anni; due anni in appello e uno in cassazione: perfettamente legittimo, ed un anno in primo grado, tre anni di appello con declaratoria di improcedibilità).
Inoltre, non possono non essere segnalate, da un lato, la forte criticità del conferimento al giudice di determinare con la sua iniziativa (seppur impugnabile) la durata o meno del processo (impugnabile in caso di sua determinazione ed esclusa in caso di rigetto di una parte che l’abbia richiesto), dall’altro, la irragionevolezza della diversa durata delle fattispecie criminose non tutte pienamente giustificate, nonché la possibilità (escluse le ipotesi per i reati puniti con l’ergastolo, dichiarate non improcedibili) di proroghe illimitate.
L’incostituzionalità del sistema integrato (art. 161 bis c.p. e art. 344 bis c.p.p.) aprirebbe la strada ad altre soluzioni, fra le quali si segnalano quella del parallelo decorso dall’inizio dei due orologi, cioè, delle due procedure “estintive” ovvero quella di trasformare la durata ragionevole delle fasi di impugnazioni, prima dei tempi assolutamente irragionevoli, in situazioni suscettibili di risarcimenti (per il prosciolto o riduzioni di pena (per i condannati).
3. ...gli orientamenti in via di consolidamento
Sin dalla introduzione dell’art. 344 bis c.p.p. si è prospettata la questione della sua possibile applicazione retroattiva, cioè della sua operatività anche ai procedimenti relativi ai reati commessi prima del 1° gennaio 2021.
Si sono confrontate sul punto le opinioni sulla natura della sentenza, prospettandosi le varie opzioni in relazione al fatto che si possa trattare di norma sostanziale, processuale, ovvero processuale con effetti sostanziali.
L’impostazione – come è emerso anche dai primi orientamenti giurisprudenziali - appare non correttamente impostata.
Invero, con la riforma il legislatore ha predisposto un sistema integrato tra la prescrizione (sostanziale) ex art. 161 bis c.p. operante in primo grado e l’improcedibilità dell’azione ex art. 344 bis c.p.p. operante in grado d’impugnazione. Invero, il suo smembramento con recupero dell’improcedibilità anche nel grado precedente affiancherebbe questa ipotesi di definibilità del processo con quella che vedrebbe contestualmente correre il tempo della prescrizione che risulta regolata dalle leggi antecedenti la riforma della l. n. 3 del 2019.
In altri termini, ci si troverebbe in una situazione di palese incompatibilità, anche in considerazione della ragione posta a fondamento della riforma, cioè, quella di definire tempi adeguati al giudizio di impugnazione, per effetto della sospensione del decorso della prescrizione, con il timore di processi di gravame non governati da definizioni in tempi adeguati.
Va, del resto, sottolineato, come i riferimenti costituzionali spesso evocati (C. cost. n. 32 del 2020 e C. cost. n. 183 del 2021) a supporto della tesi contraria, arrivavano dalla mancanza di una disciplina transitoria che, invece, la riforma esplicitamente indica (1.1.2020) e che appare razionalmente motivata (l’operatività della l. n. 3 del 2019).
Una questione di costituzionalità sull’operatività dell’art. 344 bis c.p.p. in relazione a reati antecedenti al 1° gennaio 2021, potrebbe prospettarsi sotto un diverso profilo.
Il riferimento potrebbe indirizzarsi a quella situazione per la quale siano proposte nello stesso giorno, per la stessa fattispecie di reato un appello per un fatto antecedente il 1° gennaio 2021 ed un appello per la stessa fattispecie di reato commesso successivamente al 1° gennaio 2021, con disparità di trattamento, operando solo per quest’ultimo il tempo massimo di definizione del giudizio (mentre per il primo varrebbe la prescrizione).
Al profilo qui considerato vanno collegate anche le questioni relative al regime transitorio regolato dai commi 3, 4 e 5 dell’art. 2 della cit. l. n. 134.
Com’è noto, il comma 3 dell’art. 2 cit., dopo aver previsto che la nuova disciplina operi per i reati commessi successivamente al 1° gennaio 2021, stabilisce al comma 4 dello stesso art. 2 che nel caso in cui gli atti siano già pervenuti al momento dell’entrata in vigore della legge (19 ottobre 2021) decorrono i termini di cui all’art. 2, comma 1 e 2, cioè quelli ordinari, mentre tempi più lunghi sono previsti nel caso in cui gli atti, sempre per i reati successivi al 1° gennaio 2021, pervengano entro il 31 dicembre 2024.
Si è prospettata una lettura sistematica dei commi 4 e 5 cit. che non trova giustificazione stante la sua ragionevolezza, che sembrerebbe escludere anche la possibilità di prorogare i termini che dall’entrata in vigore della legge sono già in corso.
La previsione, oltre la sua chiara letteralità, appare pienamente giustificata dal fatto che nella prima ipotesi non appare necessario l’arrivo degli atti (già presenti) per i quali la decisione può quindi seguire i termini fisiologici.
Nonostante alcune diverse opinioni non pare suscettibile di operare il cpv. dell’art. 129 c.p.p., in mancanza di adeguata copertura normativa.
Va sottolineato che in questo caso il problema non sembra prospettarsi in caso di reati puniti con l’ergastolo, nonché per i reati che consentono numerose proroghe (fatta salva l’ipotesi in cui le proroghe non vengano disposte).
Negli altri casi è evidente la mancanza di una previsione sul punto, non potendo essere applicata analogicamente quella del cpv. dell’art. 129 c.p.p. (comunque ancora operate solo in primo grado) e comunque confliggente con i poteri del giudice del gravame.
Non sarebbe possibile, come si tenta di sostenere, far leva sul mantenimento della sentenza di prima istanza, da porre in comparazione con quella di improcedibilità, né in caso di doppio conforme, ipotizzando la rinuncia all’improcedibilità, invero, definita dal comma 7 dell’art. 344 bis c.p.p. come richiesta di “prosecuzione del procedimento” (quindi precedente la dichiarazione della sentenza che non verrebbe pronunciata).
Nel primo caso di ipotizza che la sentenza di primo grado o d’appello, pur se invalida manterrebbe efficacia; nel secondo andrebbero considerati, dalla difesa, gli esiti del ricorso del pubblico ministero e comunque del giudizio di impugnazione.
Si consideri che si applicherebbe l’intero ventaglio delle ipotesi di cui al cpv. dell’art. 129 c.p.p., non tutte del tutto favorevoli, seppur di proscioglimento.
Va sottolineato che “l’apertura” all’operatività del cpv dell’art. 129 c.p.p. apre la strada a non secondari effetti collaterali, anche a prescindere dalla conseguente chiara prevalenza della inammissibilità sulla improcedibilità.
Invero, appare chiaro che, di fronte a questa possibilità, si aprirebbe la strada per l’impugnabilità della declaratoria di improcedibilità (certamente possibile per la mancanza dei presupposti della sua pronuncia) anche per il difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione del cpv. dell’art. 129 c.p.p., ovvero per una formula migliorativa della precedente.
Inoltre il riconoscimento di un potere decisorio in favor significherebbe al contrario una decisione implicitamente negativa per l’imputato.
4. I profili controversi
Il profilo attualmente più controverso riguarda il rapporto tra inammissibilità dell’impugnazione proposta e la decisione di improcedibilità. Si tratta di un aspetto teorico, dai risvolti significativamente pratici; l’improcedibilità - come detto – travolge le decisioni impugnate; l’inammissibilità, le fa diventare irrevocabili ed esecutive (con i limiti, di cui si dirà, della impugnabilità).
Va sottolineato che non essendo possibile dichiarare la prescrizione in fase di impugnazione anche in Cassazione, non trova più alcun riferimento tutta la giurisprudenza delle Sezioni unite sul rapporto tra inammissibilità e prescrizione.
Conseguentemente, il tema – in relazione alla improcedibilità – va riconsiderato, a parte la considerazione che la questione non si pone nei casi di proroghe illimitate nel tempo (salvo il caso in cui le proroghe non siano disposte) o nel caso di reati puniti con l’ergastolo, stante la mancata applicabilità dell’art. 344 bis c.p.p.
La questione si prospetta nel caso in cui il giudice deve dichiarare l’improcedibilità, essendo scaduti i tempi del giudizio a fronte di una impugnazione inammissibile, ancorché qualche problema – come si dirà – potrebbe porsi anche nel caso in cui l’inammissibilità sia pronunciata prima della scadenza dei termini, la relativa decisione venga impugnata, con effetti decisori diversificati (rigetto/accoglimento).
A tempi brevi – nel regime transitorio – la questione potrebbe essere agevolmente superata nei fatti, sicuramente ai sensi del comma 5 dell’art. 2 l. n. 134 del 2021, stante gli ampi tempi di smaltimento, ma anche nel caso del comma 4, se pur solo in cassazione, in sede di esame preliminare di ammissibilità, ovvero con meccanismi organizzativi tesi ad escludere il superamento dei tempi.
Tuttavia, restando la questione comunque prospettabile, è necessario indicare una possibile soluzione al problema, in ordine al quale tuttavia, un punto fermo, alla luce dell’art. 648 c.p.p. può dirsi raggiunto in relazione all’impugnazione proposta fuori termine: il giudicato non permette una declaratoria di improcedibilità.
Fermo restando, per le riferite diversità strutturali, le differenze con estinzione del reato per prescrizione e della conseguente inapplicabilità della giurisprudenza delle Sezioni Unite che ha progressivamente regolato il relativo rapporto con l’inammissibilità, facendo prevalere quest’ultima, fatta salva l’ipotesi della pena illegale, così definita dalla Corte costituzionale, le tesi contrapposte possano essere così delineate.
La soluzione che fa prevalere l’improcedibilità sull’inammissibilità considera che il decorso del tempo delinei lo spazio decisorio del giudice, esaurito il quale non gli residuerebbe nessun potere deliberativo (anche l’art 578,comma 1 bis, c.p.p. si configurerebbe solo per una mera trasmissione degli atti). Confermerebbe questo dato l’irrilevanza dell’atto di impugnazione al quale non si fa alcun riferimento nell’art. 344 bis c.p.p.
Questo dato è vero e si evidenzia nel caso in cui l’atto di gravame pervenga sia prima, sia dopo il tempo astrattamente previsto dal legislatore per il decorso del tempo massimo per la sua “definizione”.
Se nel primo caso, il giudice dovrebbe poter decidere anche anticipatamente, fermo il limite massimo, ove non ritenesse di attendere, escludendosi la possibilità di scorporare quel periodo, nel caso dell’arrivo tardivo, potrebbero determinarsi le condizioni per la proroga del tempo massimo, se non già scaduto.
In ogni caso, a prescindere da questi elementi, pur significativi, non può negarsi che il tempo per la “definizione”, rileva solo se c’è un atto di gravame da valutare; diversamente, esso opera inutilmente. In altri termini, senza un atto di impugnazione, quel tempo non rileva: scorre inutilmente e non ci sarà nessuna declaratoria di improcedibilità ex art. 344 bis c.p.p. e nessuna decisione intermedia.
Invero, il riferimento alla “definizione” del giudizio, nonché al “giudizio di impugnazione” (complessità, per numero delle parti, delle imputazioni e delle questioni), ed anche agli sviluppi processuali dell’impugnazione, figura in molte previsioni dell’art. 344 bis c.p.p..
Ci sono, invero, molti elementi che, seppur ai fini del tempo a disposizione del giudice dei gravami, fanno riferimento all’atto di impugnazione.
La sentenza non impugnata o tardivamente impugnata diventerà definitiva ed il trascorrere di quel tempo sarà stato irrilevante.
È per effetto della presenza nel processo dell’atto di impugnazione che rilevano quei tempi che il legislatore ha fissato per la definizione del giudizio di gravame entro l’arco temporale che intercorre fra quello di cui al comma 3 dell’art. 344 bis c.p.p. ed il giorno antecedente per la definizione: in questo spazio temporale il giudice ha pienezza di poteri (merito e inammissibilità), eccettuata la possibilità di dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione.
Diversamente si devono considerare gli effetti di una impugnazione che sia stata proposta e che abbia investito il giudice dell’impugnazione e che abbia visto decorrere i tempi assegnati per la sua definizione. Problema che non si pone con riferimento ai reati che non consentono l’improcedibilità. Invero, l’inammissibilità dell’atto costituisce un prima, rispetto alla declaratoria temporale che precluderebbe il suo stesso decorso. Il tempo della decisione fissato dal legislatore nella prospettiva di un atto di gravame sarebbe condizionato dall’atto proposto in relazione al quale ha fissato il tempo della definizione, con la conseguenza di valutarne anche la validità.
Il discorso, anche alla luce della diversa opinione, forse potrebbe essere considerato nella prospettiva dei poteri che il decorso del tempo conserva al giudice. Sembra doversi riconoscere al giudice, anche a termini scaduti, alcuni poteri non esauritisi con il passare del tempo assegnatogli.
Al di là di quanto previsto dall’art. 578, comma 1 bis, (ed inoperatività dell’art. 622 c.p.p.), non può escludersi che il giudice debba valutare la qualificazione del fatto in relazione al tempo massimo a sua disposizione.
Va sottolineato che nel caso in cui si acceda alla tesi della prevalenza della declaratoria di inammissibilità su quella di improcedibilità questa ultima decisione se non condivisa sarà suscettibile di impugnazione, come per l’ipotesi opposta sarà gravata la sentenza di improcedibilità che non abbia dichiarato l’inammissibilità.
Il discorso si salda con le situazioni nelle quali la declaratoria di inammissibilità dichiarata entro i termini ordinari, sia impugnata.
Con riferimento all’appello, in caso di ricorso contro la decisione, in caso di rigetto, la decisione diventerebbe definitiva (art. 648 c.p.p.), in caso di accoglimento da parte del Supremo Collegio, bisognerebbe vedere se il giudice d’appello sia in tempo per decidere, altrimenti si riprospetta, salva la possibilità di ritenere i termini sospesi, proprio il tema del rapporto tra inammissibilità e improcedibilità.
Non può escludersi che sia la Cassazione, nel contesto di un ricorso ammissibile a riconoscere (d’ufficio o su istanza di parte) l’inammissibilità dell’appello, non dichiarata in precedenza (in via ordinaria, cioè, entro i termini) con conseguente definizione del processo.
Il tema prospetta risvolti diversi in caso di inammissibilità dichiarata dal Supremo Collegio, anche in questo caso considerando le ipotesi di un ricorso con possibile declaratoria di accoglimento o di rigetto.
Al riguardo, è necessario considerare quanto previsto dall’art. 610, comma 5 bis, c.p.p.
Invero, se la Cassazione decide entro il termine massimo, si prospettano due ipotesi: la prima vede la questione definita; la seconda riguarda l’operatività dell’art. 610 c.p.p. e l’esito di un eventuale ricorso, di rigetto o di accoglimento, riproponendosi le soluzioni già indicate.
Il tema riguarda, pertanto, le ipotesi delle possibili declaratorie esauriti i tempi massimi che, tuttavia, sono definite nei contenuti decisi dal Supremo Collegio, non essendo le sue decisioni ordinariamente impugnabili.

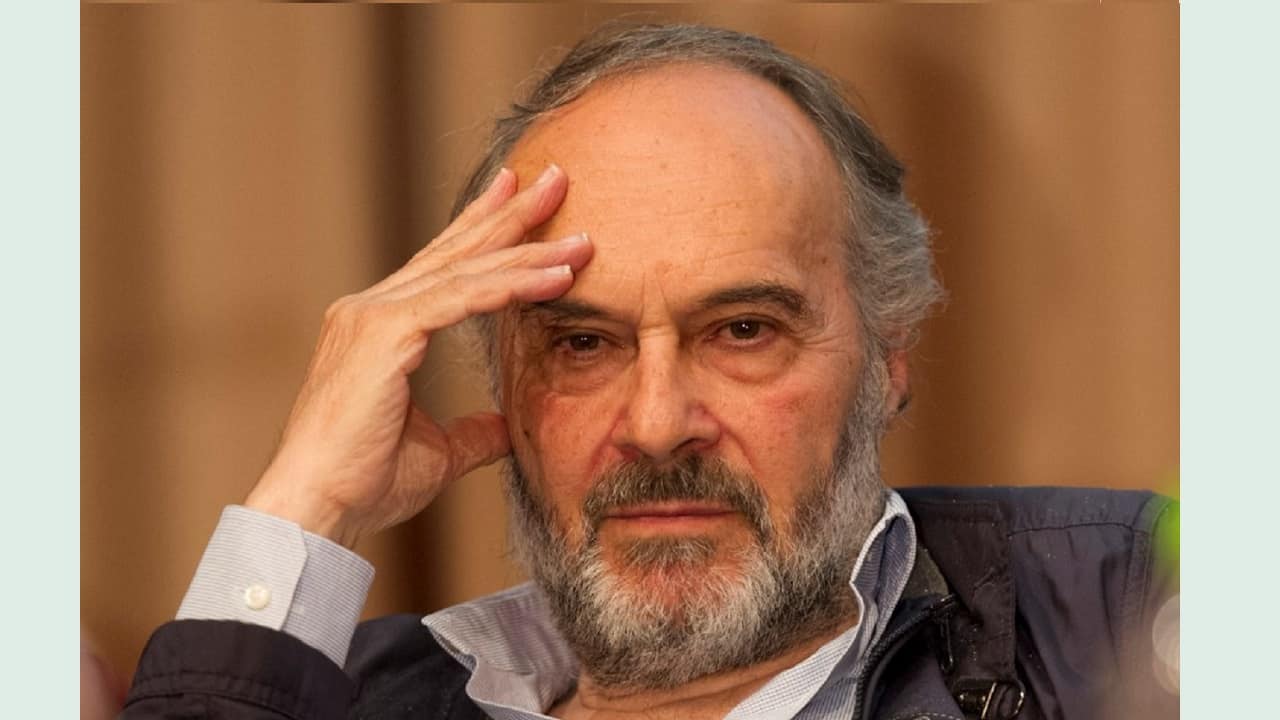

 And then Add to Home Screen.
And then Add to Home Screen.