Il diritto di accesso di fronte all’esercizio di poteri speciali: limiti e prospettive (nota a Cons. Stato, n. 171 del 13 gennaio 2025)
di Raffaella Dagostino
Sommario: 1. La vicenda. – 2. La disciplina dell’accesso agli atti dei consiglieri regionali. – 3. Esercizio del golden power e impenetrabilità di tale potere. – 4. Proporzionalità, pertinenza, riservatezza, tutela del terzo e altre disquisizioni giuridiche a giustificazione dei limiti alla conoscibilità di tali atti… solo uno specchio per le allodole. – 5. Uno sguardo oltre confine per qualche ulteriore riflessione critica.
1. La vicenda.
In una recente sentenza, la n. 171 del 13 gennaio 2025, il Consiglio di Stato si è pronunciato sul diritto di accesso, da parte di un consigliere regionale, agli atti relativi alla decisione del Consiglio dei Ministri di non esercitare il golden power in una operazione di cessione di quote societarie di una azienda sanitaria del Molise, escludendolo.
Più in particolare, il Consiglio di Stato, confermando la sentenza di prime cure del T.A.R. per il Lazio, sez. I, 12 luglio 2024, n. 14158, ha ritenuto legittima la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri con cui si era negata l’ostensione della decisione del Consiglio dei ministri di non esercitare il golden power nella cessione delle quote di Gemelli Molise s.p.a. (poi acquisite da Responsible s.p.a.), trattandosi di documentazione sottratta al diritto di accesso, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 13 del d.P.C.M. 1° agosto 2022, n.133, se non per l’ipotesi di accesso difensivo, ex articolo 24, comma 7, della l. n. 241/1990, non ricorrente però nella fattispecie oggetto di controversia.
Pertanto, il consigliere regionale della regione Molise ha visto soccombere il proprio diritto di conoscere tali atti, sul presupposto per cui «la dialettica tra il diritto/dovere di un consigliere regionale di conoscere atti in possesso dell’amministrazione, nell’ambito dell’esercizio del suo fondamentale ruolo di controllo politico dell’attività della pubblica amministrazione, in un contesto di democrazia partecipata e partecipativa, e la riservatezza che la legge impone di osservare rispetto a documentazione in relazione alla quale entrano in gioco interessi contrapposti, si risolve in favore della seconda nelle ipotesi in cui il sindacato (cui rimanda la richiesta di accesso) non sia relativo ad atti dell’ente di appartenenza dell’istante e laddove, in ogni caso, le disposizioni primarie e secondarie consentono di negare l’accesso per la tutela di contrapposti (e superiori) interessi dell’amministrazione e di soggetti terzi. Deve infatti assicurarsi una ragionevole proporzione e un equilibrio tra gli opposti e meritevoli interessi, coinvolti dall’accesso a documenti amministrativi, nelle ipotesi in cui non ricorrano esigenze di accesso difensivo ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241»[i].
2. La disciplina dell’accesso agli atti dei consiglieri regionali.
La pronuncia che si commenta pone l’attenzione sulla delicata questione dei limiti all’accessibilità di alcuni documenti amministrativi, per via della necessità di assicurare un equilibrato e bilanciato contemperamento fra gli interessi contrapposti che specificatamente vengono in gioco.
Una tematica, questa, che assume particolare rilievo nell’attuale contesto storico posto che, da più di una decina di anni, l’ordinamento pubblicistico ha visto notevolmente rafforzare i principi di pubblicità e trasparenza[ii] degli atti amministrativi, al fine di assicurare la piena accessibilità dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, così come stabilisce il d.lgs. n. 33 del 2013.
Già prima dell’affermazione e del riconoscimento del principio di trasparenza come piena accessibilità dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni da parte del cittadino, nella prospettiva di garantire un controllo generale e diffuso sull’operato di queste ultime, ossia sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, nonchè per promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, il nostro ordinamento conosceva forme di accesso ai documenti amministrativi speciali rispetto alla disciplina generale di cui alla l. n. 241/1990.
Fra le discipline di settore, derogatorie rispetto a quella generale di cui alla l. n. 241/1990, certamente vi è l’istituto del diritto di accesso previsto nell’ordinamento locale, che ancora oggi disciplina due differenti ipotesi.
Un primo riferimento normativo si rinviene nell’art. 10 d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli enti locali o T.U.E.L.) che titola: «diritto di accesso e di informazione». Tale norma, come noto, sancisce la pubblicità di tutti gli atti dell’amministrazione comunale e provinciale, ad eccezione di quelli riservati per espressa previsione di legge o per motivata e temporanea decisione del sindaco o del presidente della provincia, in ragione della necessità di tutela della riservatezza di persone, gruppi o imprese.
Tale disposizione normativa, oggi da coordinarsi con la disciplina di cui al d.lgs. n. 33/2013[iii], già in passato assicurava a tutti i cittadini residenti nel comune o nella provincia di riferimento, singoli o associati, il diritto di accedere a tali atti amministrativi, nonché di avere informazione sullo stato degli atti o delle procedure pendenti dinanzi all’amministrazione stessa.
Seconda ipotesi di accesso prevista nella normativa degli enti locali è quella di cui all’art. 43 T.U.E.L., che più direttamente ci interessa. Tale norma disciplina l’accesso dei consiglieri comunali e provinciali a tutte le notizie e informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Un accesso, dunque, funzionale all’efficace ed efficiente svolgimento dell’incarico consiliare.
È noto, che tale norma sia espressione del principio di democrazia partecipativa e di rappresentanza esponenziale tanto che tale istanza di accesso non si collega solo all’interesse precipuo del singolo consigliere a conoscere questa o quella informazione, piuttosto alla cura del più generale interesse pubblico connesso all’espletamento del mandato[iv].
Tale istanza di accesso, infatti, mira a consentire al singolo consigliere di avere piena cognizione dell’operato consiliare, così da poter esprimere in maniera consapevole il proprio voto su tutte le questioni di competenza del consiglio comunale ed eventualmente di promuovere ulteriori iniziative o proposte. Pertanto, il bisogno di conoscenza del titolare di una carica elettiva si pone in rapporto di strumentalità con la funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, di cui è investito, nell’ordinamento dell’ente locale, il consiglio comunale.
La stessa ratio sottesa alla fattispecie normativa appena richiamata, ossia di garantire il principio democratico dell’autonomia territoriale e della rappresentanza esponenziale, regge la disciplina posta dalle specifiche leggi regionali, volta a regolamentare l’accesso agli atti da parte dei consiglieri regionali.
Così come per i consiglieri comunali e provinciali, il diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri regionali non richiede una motivazione dettagliata, né una puntuale dimostrazione delle attività consiliari che si andranno a svolgere e neppure la dimostrazione di un eventuale pregiudizio che dalla mancata ostensione dei documenti richiesti potrebbe derivare.
Il diritto di accesso del consigliere regionale è infatti funzionale non tanto all’interesse del Consigliere regionale, ma alla cura dell’interesse pubblico connesso al mandato conferito, essendo strumentale a garantire un controllo “qualificato” sul comportamento degli organi decisionali dell’ente di riferimento[v].
Pertanto, l’esercizio di tale diritto di accesso non richiede particolari vincoli motivazionali, ciò al fine di garantire che il consigliere possa svolgere il proprio mandato scevro da condizionamenti.
Tuttavia, questo non significa che lo stesso possa esercitarsi incondizionatamente.
È pacifico che l’esercizio del diritto di accesso – che sia quello documentale di cui alla l. n. 241/1990, o quello civico generalizzato ai sensi dell’art. 5-bis del d.lgs n. 33/2013, o quello di cui alla particolare fattispecie in esame – incontri sempre dei limiti o comunque un contemperamento, più o meno incisivo a seconda della disciplina di riferimento, nel bisogno di assicurare la tutela di interessi contrapposti rispetto a quelli sottesi alla istanza di accesso. Ne sono esempi: il rispetto del segreto d’ufficio, della riservatezza altrui, dei dati commerciali o industriali di terzi coperti da segreto o comunque riservati.
La tutela di interessi antagonisti, pertanto, salvo che non si traduca, per legge, in un limite assoluto alla conoscibilità degli atti o documenti amministrativi – come ad esempio accade in materia di segreto di Stato[vi] – necessitano di un bilanciamento in concreto, in ossequio e nel rispetto del principio di proporzionalità[vii] che costituisce, insieme al principio di trasparenza, uno dei valori fondanti il nostro ordinamento democratico[viii].
3. Esercizio del golden power e l’impenetrabilità di tale potere.
Nella vicenda in esame, il documento fatto oggetto di istanza da parte di un consigliere regionale del Molise, atteneva alla decisione del Consiglio dei ministri di non esercitare il golden power nella operazione di cessione di quote societarie di una azienda sanitaria, il Gemelli Molise s.p.a. Tali quote sarebbero poi state acquisite da altra società, la Responsible s.p.a. società benefit.
Prima di soffermarci sulle ragioni del diniego, così come dispiegate in sentenza, la peculiarità del provvedimento fatto oggetto di istanza, richiede di ripercorrere – seppur succintamente – la disciplina del golden power[ix].
Siamo di fronte, infatti, a una normativa che regolamenta l’esercizio di un potere speciale del Governo, con cui si è inteso assicurare la tutela di interessi strategici nazionali nei confronti di operazioni di investimento estere, extra-europee ma anche intra-europee.
Un potere particolarmente ampio e penetrante, capace di incidere su operazioni societarie ed economiche per salvaguardare asset ritenuti strategici per la cura di interessi nazionali, dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalente qualificato come atto di alta amministrazione[x] – non già come atto politico – per consentirne, sebbene con tutti i limiti che tale tipologia di provvedimento pone, un sindacato per lo meno in termini di manifesta illogicità o irragionevolezza, ma anche di proporzionalità[xi].
Conferme sulla natura amministrativa di tale provvedimento si traggono dalla stessa disciplina normativa sul golden power che consente di sostenere che, per quanto si tratti di poteri speciali che si muovono su un terreno ibrido[xii], non siano poteri liberi nel fine (essendo circoscritti e disciplinati dagli artt. 1 e 2 del d.l. n. 21/2012) e che l’esercizio dei medesimi si snodi nel rispetto di un iter procedimentale precipuo, in cui è possibile individuare – alla stregua della legge generale sul procedimento amministrativo – una pluralità di fasi (iniziativa, istruttoria e decisoria) che dovrebbero assicurare quelle garanzie minime di partecipazione al destinatario del provvedimento, sebbene sul punto la dottrina non abbia mancato di evidenziare alcune zone grigie.
Si tratta di un potere, dunque, connotato da amplissima discrezionalità, tanto da far ritenere – e su questo la dottrina è molto critica[xiii] – che non sia nemmeno necessario che tale decisione venga supportata da una approfondita e congrua motivazione, essendo sufficiente una motivazione limitata, trattandosi di atti governativi adottati per la cura di interessi pubblici di carattere assolutamente generale.
Tale potere si sostanzia essenzialmente nella facoltà di porre il veto rispetto all’adozione di determinate delibere, atti e operazioni delle imprese che gestiscono attività strategiche in specifici settori, di dettare impegni e condizioni in caso di acquisito di partecipazioni in tali imprese, ovvero di opporsi all’acquisto delle medesime partecipazioni.
Le emergenze che hanno attraversato l’ordinamento negli ultimi anni, dalla pandemia da Covid-19 alla recente guerra fra Russia e Ucraina, hanno portato il legislatore ad ampliare notevolmente l’ambito oggettivo di applicazione di tali poteri speciali, estendendo la disciplina a settori diversi da quelli per i quali era stato originariamente previsto, come la difesa e la sicurezza nazionale, e a riscrivere più volte la disciplina di cui al d.l. del 15 maggio 2012, n. 21[xiv].
Fra i nuovi settori strategici, oltre quello dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, anche nel settore della comunicazione elettronica a banda larga basata sulla tecnologia di quinta generazione (5G) e cloud, è stato fatto rientrare il settore sanitario e farmaceutico, dapprima solo in via provvisoria – a ridosso del periodo pandemico, con il d.l. n. 23/2020 – e poi, in maniera stabile. Con il decreto legge n. 21/2022, infatti, si è modificato l’art. 2, comma 5, del d.l. n. 21/2012, stabilizzando quello che era il regime temporaneo e allineando la disciplina nazionale a quella europea di cui all’art. 4, comma 1, del Regolamento (UE) 2019/452 che, a sua volta, individua fra i fattori che possono essere presi in considerazione dagli Stati membri perché in grado di incidere sulla sicurezza o sull’ordine pubblico, quelli inerenti infrastrutture critiche, tra cui è menzionata la sanità.
Il caso oggetto di esame rientra proprio in questo ambito, sebbene il governo nazionale abbia poi deciso di non esercitare tale potere. E proprio tale decisione è stata fatta oggetto di istanza da parte del consigliere regionale.
Sia il T.A.R. per il Lazio che il Consiglio di Stato, confermando la pronuncia del giudice di prime cure, hanno ritenuto legittimo il diniego all’istanza di accesso per diversi ordini di ragioni.
La prima ragione, quella per vero assorbente, come meglio si dirà, è che la decisione del Consiglio dei ministri di non esercitare il golden power fosse inaccessibile ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. 25 marzo 2014, n. 86, rientrando, tale atto, nella documentazione sottratta al diritto di accesso, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 13 del d.P.C.M. 1° agosto 2022, n.133, se non per la sola ipotesi di accesso difensivo, ex articolo 24, comma 7, della l. n. 241/1990, non sussistente nel caso di specie.
Seconda ragione, che pur volendo valorizzare il fatto che il consigliere avesse presentato tale istanza in forza delle prerogative sottese al proprio mandato istituzionale, il medesimo avrebbe dovuto chiedere l’accesso limitatamente agli atti in possesso della regione Molise o di enti pubblici ad essa riferibili, sempre nel rispetto dei limiti generali fissati dalla normativa primaria.
Terza e ultima ragione, valutata in via gradata, che anche qualora l’istanza del consigliere regionale fosse stata formulata non già nell’esercizio delle sue prerogative politiche, bensì come comune cittadino – pertanto, ai sensi della disciplina dell’accesso civico generalizzato di cui al d.lgs. n. 33/2013 – l’esito sarebbe stato il medesimo posto che l’art. 5-bis, comma 2, del suddetto decreto richiede un contemperamento in concreto fra contrapposti interessi, escludendo l’ostensione degli atti e documenti amministrativi ogniqualvolta sia necessario assicurare la libertà e segretezza della corrispondenza, nonché interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, compresa l’ipotesi di segreto commerciale, industriale o la tutela della proprietà intellettuale d’autore.
4. Proporzionalità, pertinenza, riservatezza, tutela del terzo e altre disquisizioni giuridiche a giustificazione dei limiti alla conoscibilità di tali atti… solo uno specchio per le allodole.
Le ragioni espresse in sentenza e poste alla base del diniego sono tenute fra loro ben salde. Il consiglio di Stato, però, si sofferma un po’ più dettagliatamente proprio sull’ultimo aspetto, ovvero sul sindacato, in termini di proporzionalità, fra interessi fra loro confliggenti, quello alla trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013, da un lato, e quello della riservatezza o segretezza individuale dall’altro.
È noto, infatti, che nel corso degli ultimi anni il principio di trasparenza[xv] sia stato notevolmente rafforzato, così contribuendo a consacrare il passaggio da una amministrazione burocratica verso un’amministrazione sempre più al servizio dei cittadini, sempre più aperta e trasparente.
Il principio di trasparenza, declinato in forma di accessibilità totale agli atti e documenti dell’amministrazione, ha contribuito da un lato, a portare a compimento il processo di democratizzazione dell’amministrazione pubblica, dall’altro, a implementare forme di democrazia partecipata da parte dei singoli cittadini. Una trasparenza amministrativa, dunque, che non si declina più semplicemente in termini di diritto di accesso, bensì anche come vero e proprio diritto all’informazione.
Nonostante l’affermazione del principio di trasparenza come condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, bensì anche dell’imparzialità, della qualità, dell’efficienza dell’azione amministrativa nella prospettiva del riconoscimento di un vero e proprio diritto ad una buona amministrazione[xvi], il medesimo principio necessita pur sempre di una corretta e consapevole applicazione, non potendo travalicarsi surrettiziamente i limiti dell’altrui riservatezza o del segreto, individuale o pubblico che sia[xvii].
E infatti, richiamando consolidata giurisprudenza, il Consiglio di Stato evidenzia la necessità di garantire una «ragionevole proporzione e un equilibrio fra gli opposti e meritevoli interessi coinvolti dall’accesso ai documenti amministrativi»[xviii].
A dire del Consiglio di Stato, la dialettica tra il diritto/dovere di un consigliere regionale di conoscere atti in possesso dell’amministrazione, pur nell’ambito dell’esercizio del suo fondamentale ruolo di controllo politico dell’attività della pubblica amministrazione, in un contesto di democrazia partecipata e partecipativa, e la riservatezza che la legge impone di osservare rispetto a una documentazione in relazione alla quale entrano in gioco interessi contrapposti, si risolve in favore della seconda nelle ipotesi in cui il sindacato (cui rimanda la richiesta di accesso) non sia relativo ad atti dell’ente di appartenenza dell’istante e laddove, in ogni caso, le disposizioni primarie e secondarie consentono di negare l’accesso per la tutela di contrapposti (e superiori) interessi dell’amministrazione e di soggetti terzi.
L’esito non sarebbe stato diverso se l’istanza d’accesso fosse stata formulata ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013.
Orbene, stando alla motivazione del giudice amministrativo, nel caso di specie, il diritto di conoscere, sia che fosse stato giustificato in ragione di un precipuo ruolo istituzionale – quello di consigliere regionale – che ha nella democrazia partecipata il proprio fondamento, sia che fosse stato manifestato quale espressione più generale del principio di trasparenza, intesa come accessibilità totale agli atti e ai documenti dell’amministrazione, legittimamente deve farsi retrocedere dinanzi a preminenti interessi di terzi e dell’amministrazione, a maggior ragione perché trattasi di atti di amministrazione diversa rispetto a quella cui il cittadino e/o il cittadino qualificato, qual è il consigliere regionale, appartiene.
Ebbene, nella motivazione a sostegno della legittimità del diniego, il giudice amministrativo fa leva sull’esigenza di veder tutelati i diritti dei terzi e dell’amministrazione, senza distinguere (o meglio uniformemente considerando) l’ipotesi di accesso dispiegata in qualità di consigliere, per l’assolvimento del proprio ruolo istituzionale, nonché l’ipotesi gradata di esercizio d’accesso nella forma – meno vincolata nei presupposti – dell’accesso civico generalizzato.
È pacifico[xix], oramai, che le diverse forme di accesso possano anche fra loro cumularsi e che le relative istanze possano proporsi in via gradata, così come è pacifico che l’accesso qualificato dalla presenza di specifici presupposti (che sia l’accesso documentale cui alla legge generale sul procedimento amministrativo o le forme speciali di accesso che si rinvengono nelle discipline di settore, come quella oggetto di esame) e l’accesso civico generalizzato divergano non solo per finalità e requisiti (si pensi alle differenze relative all’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione) bensì anche – e soprattutto – per il diverso grado di profondità di conoscenza consentito.
Nel caso di specie, l’assimilazione nell’esito sembra essere giustificata dalla similare finalità che contraddistingue l’accesso civico generalizzato e l’accesso di un consigliere, ossia l’esercizio di un controllo democratico sul corretto esplicarsi dell’attività amministrativa.
Ciò non toglie però che quello del consigliere regionale sia un controllo qualificato, un controllo politico sull’esercizio dell’attività amministrativa da parte dell’organo di appartenenza, certamente – ove consentito – di portata ben più ampia dell’altro, giustificandosi nella necessità di un efficace espletamento del proprio mandato.
Per cui, a parità di condizioni, sussistendo tutti i presupposti di legittimazione, sarebbe questa l’istanza capace di fornire maggiori garanzie di accesso.
Restando, però, per il momento, al dato della sussistenza di interessi confliggenti, appartenenti a terzi e all’amministrazione, non può non evidenziarsi la fragilità e l’apoditticità della motivazione del giudice amministrativo – evidentemente posta più a corredo che a fondamento motivazionale.
Non può non ricordarsi che nell’era della trasparenza amministrativa, la definizione dei limiti e delle eccezioni al diritto di accesso ai documenti e alle informazioni della amministrazione non si invera sempre in preclusioni assolute, implicando un concreto bilanciamento fra accessibilità, da un lato, e riservatezza e/o segreto[xx], dall’altro, cosa che non sempre porta a un diniego, potendosi valutare strumenti diversi qual è il differimento oppure, l’oscuramento di dati sensibili ma anche semplicemente la pubblicazione per estratto delle decisioni finali di specifici procedimenti di pubblico interesse, oppure ancora il rilascio di informazioni di pubblico interesse per la sola parte del documento o delle informazioni non oggetto di “censura”.
Ciò varrebbe tanto per l’ipotesi di istanza di accesso qualificata (ossia esperita facendo valere il ruolo di consigliere regionale, dovendo questi poter avere accesso anche solo a notizie o informazioni utili per l’espletamento del proprio mandato) sia per l’istanza formulata in termini di accesso civico generalizzato, altrimenti depotenziandosi e vanificandosi le esigenze di controllo democratico sottese al principio di trasparenza.
Il diritto di accesso, infatti, costituisce un principio generale del nostro ordinamento democratico, ragion per cui i limiti e le eccezioni al medesimo debbono interpretarsi rigorosamente e restrittivamente, dovendo valutarsi anche ipotesi alternative al mero diniego.
Ma vi è un secondo dato che porta il giudice amministrativo ad appaiare, nell’esito, le due paventate forme d’istanza d’accesso: il fatto che il documento che si chiede di conoscere non sia riconducibile all’amministrazione di appartenenza del consigliere regionale. Quest’ultimo – si legge in sentenza – avrebbe dovuto chiedere l’accesso limitatamente agli atti in possesso della regione Molise o di enti pubblici ad essa riferibili, sempre nel rispetto dei limiti generali fissati dalla normativa primaria.
Orbene, il requisito della pertinenza – come limite intrinseco per l’esercizio di questa speciale istanza di accesso – si spiega in ragione del fatto che il bisogno di conoscenza del titolare di una carica elettiva si ponga in rapporto di strumentalità con la funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, di cui è investito, nell’ordinamento dell’ente locale, l’organo di appartenenza.
Questo limite oggettivo – ossia della accessibilità ai soli documenti dell’amministrazione di riferimento – risponde alla finalità di garantire il rispetto del principio della separazione dei poteri. Pertanto, si esclude in una interpretazione estensiva della normativa di riferimento volta a ricomprendere fra gli atti dell’amministrazione di appartenenza tutti quegli atti, anche posti da organi differenti, aventi però ricadute sul territorio.
Ciò vale a maggior ragione nel caso di specie, in cui il documento di cui si chiede l’ostensione è un atto di alta amministrazione, una decisione presa dal Consiglio dei Ministri.
È evidente, dunque, che la ragione sottesa è di evitare un controllo democratico multilivello (o decentrato, se si preferisce) su tali atti amministrativi. Se si ammettesse, il fondato timore è che si creerebbe probabilmente un cortocircuito democratico inaccettabile, non potendo consentirsi un sindacato politico da parte di organi espressione della democrazia territoriale, locale, su un potere del governo centrale a sua volta frutto di scelte ampiamente discrezionali giustificate dall’esigenza di veder tutelati interessi nazionali strategici, pur avendo ricadute territoriali, producendo cioè i loro effetti su scelte e decisioni che impattano poi sul territorio regionale.
Purtuttavia, tale rischio, sebbene fondato, non giustifica di per sé l’esclusione del diritto di accesso. Resta, ad esempio, ancor oggi emblematico il caso di avvenuto riconoscimento – in sede giurisdizionale a seguito d’impugnazione del diniego – della legittimità del diritto di accesso agli atti e documenti del procedimento di approvazione di un progetto definitivo del DIPE (Dipartimento programmazione e Coordinamento della Politica Economica), relativo al collegamento viario Ragusa – Catania, da parte degli enti locali interessati alla realizzazione dell’opera[xxi].
La verità è che, fondamentalmente, la ragione dell’esclusione dell’accesso la si fa risalire alla voluntas legis, ossia nel richiamo ai limiti di cui all’art. 24, comma 2, l. n. 241/1990.
Purtuttavia, anche su questo limite è necessario qualche chiarimento.
Come noto, il limite di cui all’art. 24, comma 2, l. n. 241/1990 trova applicazione sia per le ipotesi di accesso documentale, sia disciplinato dalla legge generale sul procedimento amministrativo, sia che si tratti di fattispecie c.d. speciali (come quella in esame dell’accesso del consigliere), sia nell’ipotesi di accesso civico generalizzato, sebbene per quest’ultimo il rinvio al comma 2 dell’art. 24, l. n. 241/1990 abbiano sollevato non pochi dubbi nella definizione delle modalità di attuazione [xxii].
L’art. art. 24, comma 2, della l. n. 241 del 1990 consente alle amministrazioni di precisare le fattispecie di esclusione dell’accesso già individuate dal legislatore nell’art. 24, comma 1, l. n. 241 del 1990, esplicitando i casi di segreto o di divieto di divulgazione per gli atti rientranti nella propria disponibilità. Diversamente, l’art 24, comma 2, non dovrebbe consentire alle amministrazioni di disciplinare autonomamente ipotesi di esclusione rientranti nella disciplina regolamentare di cui al comma 6 del medesimo articolo, diversamente ampliandosi oltremodo il loro potere discrezionale, perché così facendo si assegnerebbe loro una discrezionalità regolatoria incompatibile con il principio generale di accessibilità e trasparenza.
Nel caso di specie, la legittimazione a disciplinare, o meglio, a esplicitare le ipotesi di esclusione del diritto di accesso è data dal fatto che, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 24 richiamato, la fattispecie in esame rientri in quelle ipotesi in cui il divieto di divulgazione è espressamente previsto dalla legge, in particolare ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 2, comma 5, del d.l. n. 21/2012, dell’art. 9, d.p.r. n. 86/2014 e art. 13, d.p.c.m. n. 133/2022. Queste disposizioni normative trovano, fra l’altro, un conforto nei vincoli di riservatezza comunque imposti dalla disciplina europea (si vedano in particolare gli artt. 10 e 3, comma 4 del Reg. UE 2019/452).
Queste norme interne cui si è fatto riferimento, sebbene non classifichino espressamente come segreto o riservato il documento di cui si chiede l’ostensione, escludono genericamente che le informazioni, i dati e le notizie contenute nei documenti originati dalle pubbliche amministrazioni per le finalità di cui è questione siano accessibili, se non per il caso di accesso difensivo.
Orbene, ci si rende conto che vi è innanzitutto una volontà politica di mantenere sostanzialmente oscurate determinate decisioni.
D’altra parte, si evince anche che, pur a fronte di pregevoli disquisizioni sui limiti di proporzionalità e adeguatezza ai fini della tutela della riservatezza dei terzi o dell’amministrazione, la stessa giurisprudenza si rifugia dietro la preclusione ope legis, che come detto lascia margini di apertura limitatamente alle sole ipotesi di accesso difensivo.
Va altresì ricordato, però, che in via generale, il limite di cui all’art. 24, comma 2, è stato interpretato nel senso di non implicare, per le ipotesi di istanze di accesso civico generalizzato, una preclusione assoluta all’accesso, dovendosi compiere un bilanciamento nel caso concreto.
Purtuttavia, come dimostrato, nel caso di specie, trattandosi di decisioni giustificate per la cura e la tutela di interessi strategici nazionali, ogni disquisizione in termini di proporzionalità e ragionevolezza[xxiii], fuori dall’ipotesi di accesso difensivo, diviene velleitaria.
In definitiva ciò che emerge è che il golden power, anche con l’avvallo di una deferente giurisprudenza nazionale, si manifesti come un potere tendenzialmente segreto, che consente margini di accessibilità nella limitata ipotesi di accesso difensivo, anche in questo caso, inverati tutti i presupposti di legge, come noto stringenti (ex art. 24, comma 7, l. n. 241/1990).
Le ragioni, evidentemente politiche, sono da ricercarsi nella volontà di tutelare interessi pubblici ritenuti strategici.
Possiamo ritenere, dunque, che ancora oggi, nell’era della trasparenza, in alcune ipotesi, come quella in esame, il segreto resti lo strumento per preservare l’esercizio di funzioni sovrane, dispiegate in nome di superiori interessi pubblici che, evidentemente, necessitano di essere tutelati anche a garanzia dell’unitarietà dell’ordinamento giuridico.
Ciò non toglie però che dovrebbe essere necessario circoscrivere o individuare più specificatamente, già a livello normativo, le ipotesi in cui sia legittimo ricorrere all’esercizio di tali poteri, altrimenti gli stessi non potrebbero dirsi “speciali”, e poi, che la logica del segreto dovrebbe sempre considerarsi come extrema ratio.
Meritano, in particolare, di essere segnalate quelle voci in dottrina[xxiv] che, al fine di rendere un po' meno opachi i vetri dell’amministrazione centrale, specie nel caso di esercizio di questi poteri speciali, auspicano, in linea con la maggiore democraticità che il principio di trasparenza vorrebbe assicurare, per lo meno una conoscibilità postuma di tali decisioni, ossia a procedimento concluso, da assicurarsi anche solo con la pubblicazione per estratto del provvedimento o, eventualmente, fornendo una nota riepilogativa, che offra maggiori dettagli, all’intero della relazione annuale che viene presentata al Parlamento ex art 3-bis del decreto n. 21/2012.
5. Uno sguardo oltre confine per qualche ulteriore riflessione critica.
A sostegno dell’analisi sin qui svolta, pare opportuno richiamare recente giurisprudenza europea che ci consente di guardare oltre la specifica questione, però per trarre utili spunti per qualche altra considerazione critica.
E invero, in una prospettiva meno garantista per l’esercizio di questi poteri sovrani speciali sembra porsi la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea che pare, in qualche modo, intenzionata proprio a ridimensionare l’ampiezza dell’esercizio dei poteri di golden power da parte degli Stati membri.
Emblematico il caso Xella Magyarorzág, con cui la Corte di Giustizia EU, seconda sessione, 13 luglio 2023, Causa 106/22, ha fornito una interpretazione formalistica e restrittiva del regolamento (Ue) 2019/452, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione, ridimensionandone il perimetro di applicazione della disciplina, con evidenti ricadute in materia di esercizio del golden power da parte degli Stati membri[xxv].
In particolare, in questa pronuncia la Corte di Giustizia ha evidenziato che l’esercizio di un potere di veto da parte del Governo di uno Stato membro all’acquisizione di partecipazioni societarie (nel caso di specie trattavasi poteri esercitati dal Governo ungherese in merito all’acquisizione di una società da parte di un’altra, con particolare riferimento al settore edile) può incidere sull’esercizio di una libertà fondamentale: la libertà di stabilimento.
Di conseguenza, a dire della Corte, una restrizione di una libertà fondamentale garantita dal Trattato può essere ammessa unicamente a condizione che la misura nazionale sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale (quali motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, difesa e di sanità pubblica) e che la stessa sia idonea a garantire il raggiungimento dell’obiettivo da essa perseguito senza andar al di là di quanto necessario per ottenerlo, non potendo tali misure essere giustificate da motivi di natura puramente economica, connessi alla promozione dell’economia nazionale o al buon funzionamento di quest’ultima[xxvi].
Pertanto, è evidente che prima ancora delle ragioni (recte: delle motivazioni) a sostegno della misura adottata, al fine di valutarne la legittimità in termini di proporzionalità, rilevano i motivi sottesi all’esercizio di tali poteri, dovendo questi essere interpretati restrittivamente, non potendo la loro portata essere determinata unilateralmente da ciascuno Stato membro senza il controllo delle istituzioni dell’Unione.
E infatti, precisa ancora la Corte, ferma la libertà politica riconosciuta a ciascuno Stato membro di determinare, conformemente alle necessità nazionali, le esigenze dell’ordine pubblico e della pubblica sicurezza a fondamento dell’esercizio del golden power, tali motivi possono essere invocati solamente in caso di minaccia effettiva e sufficientemente grave ad uno degli interessi fondamentali della collettività, non potendo gli stessi essere piegati per il perseguimento di fini puramente economici[xxvii].
La pronuncia, pertanto, si rivela particolarmente importante perché dilata le maglie del sindacato del giudice sull’esercizio del golden power, al contempo, circoscrivendo i limiti soggettivi e oggettivi che legittimano l’esercizio del medesimo da parte degli Stati membri.
E infatti, l’esercizio del sindacato del giudice non solo potrebbe dirigersi verso il provvedimento frutto dell’esercizio del potere speciale, bensì anche sull’atto regolamentare che ne regola i presupposti, il quale o potrebbe essere disapplicato oppure essere oggetto, assieme al provvedimento, di doppia impugnativa da parte del ricorrente. Ancora, se si volessero valorizzare le esigenze sociali sottese all’esercizio di tali poteri, potrebbe non escludersi un ampliamento della legittimazione e dell’interesse a ricorrere a nuovi attori, come associazioni di categoria, sindacati, imprese concorrenti[xxviii].
Ad ogni modo, al di là del tipo di tutela esperibile, ciò che realmente rileva è assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale e del sindacato del giudice su tali poteri, pur nei limiti dell’ampia discrezionalità che li connota.
Infatti, il rischio che si corre a lasciar incondizionato e incontestato (recte: privo di sindacato) tale potere, nascondendosi dietro il velo dell’amplissima discrezionalità, è che il golden power si trasformi in un facile strumento di politica dirigista[xxix].
Ragion per cui, se la decisione resta nella sostanza inaccessibile e impenetrabile – se non scalfita in alcuni limitatissimi casi, attraverso un impervio sindacato di proporzionalità (come si è detto per il caso dell’istanza di accesso difensivo), pare opportuno assicurare un crisma di legalità all’esercizio di tale potere anche attraverso un rafforzamento degli addentellati normativi legittimanti il medesimo.
Il che porterebbe a valorizzare, fra le possibili patologie del provvedimento, sintomatiche di vizi di legittimità sostanziale, anche quella tradizionale figura nota come sviamento di potere. Cosa che probabilmente consentirebbe di allargare le maglie del sindacato giurisdizionale valorizzando più efficacemente la correlazione esistente fra fatto – fattispecie – potere – atto (ossia: fatto – norma – potere – effetto), cogliendo più da vicino quella relazione intercorrente fra presupposti normativi, fatti accertati in sede istruttoria, motivazione del provvedimento e interessi pubblici effettivamente perseguiti.
Questa prospettiva sembra emergere dalle posizioni difensive del ricorrente, in una recente questione oggetto di pronuncia del T.A.R. del Lazio[xxx], espressasi sul delicato caso Unicredit/Banco BPM, successiva alla sentenza che si commenta. In particolare, la questione oggetto del giudizio richiamato verte su un ricorsopromosso da UniCredit S.p.A. per l’annullamento – per difetto di presupposti richiesti dalla disciplina di legge – del DPCM del 18 aprile 2025, con il quale, in relazione all’offerta di scambio volontaria di UniCredit, avente ad oggetto la totalità delle azioni di Banco BPM S.p.A., sono stati esercitati, da parte del Governo, i poteri speciali di cui al decreto legge 15 marzo 2012, n. 21. Sulla questione certamente non è possibile indugiare nella presente sede.
Ciò che preme rilevare in questa sede è che, a fronte di un tentativo demolitorio del provvedimento in questione, operato dalla Unicredit s.p.a. proprio attraverso la valorizzazione del difetto dei presupposti normativi legittimanti l’esercizio del potere sovrano di golden power, la giurisprudenza amministrativa finisce per limitarsi a un tiepido sindacato sull’esercizio del medesimo.
Anche quest’ultima decisione cela un atteggiamento se non protezionistico per lo meno deferente dei giudici nei confronti del governo, tanto che in questa pronuncia il T.A.R. Lazio, attraverso un abile esercizio di erudizione normativa, si pone in posizione sostanzialmente antitetica rispetto all’indirizzo della giurisprudenza europea, arrivando a declinare la nozione di «sicurezza economica» come species del più ampio genus della «sicurezza nazionale», in virtù tanto della normativa nazionale, quanto di quella europea.
Non si può non sottolineare però che una strumentalizzazione dell’uso di tali poteri da parte del governo potrebbe anche esporre il nostro paese a una procedura di infrazione.
Orbene, è evidente che la complessità della materia ci porta molto lontano nei ragionamenti giuridici.
Tornando alle questioni che più da vicino ci hanno interessato, pare opportuno evidenziare che le diverse esigenze, così emerse, di valorizzazione di istituti partecipativi o di implementazione delle garanzie procedimentali o ancora, di demarcazione, in via interpretativa, degli indeterminati confini di suddetta materia, sono tutte manifestazioni della necessità di assicurare il rispetto di un livello minimo di democrazia partecipativa.
La valorizzazione delle istanze di accesso civico generalizzato o di istanze di accesso da parte dei rappresentanti degli enti locali a tali documenti, ad esempio, risponde al bisogno di assicurare un controllo democratico su decisioni che sono certamente il frutto di una visione politica nazionale strategica ma che, in alcuni specifici casi, potrebbero avere ricadute dirette o mediate anche in ambito locale e, eventualmente, avere come effetto latente quello di implementare divari territoriali di cittadinanza[xxxi].
Favorire forme di democraticità partecipativa a supporto di scelte di rilevanza strategica nazionale, potrebbe tornare utile proprio in materie, come quella della sanità, oppure delle infrastrutture[xxxii], che si presentano complesse, non avendo una disciplina uniforme, ma che hanno grande e rilevante impatto sui territori.
Circoscrivere l’esercizio di tali poteri speciali, attraverso una interpretazione restrittiva dei presupposti normativi e, al contempo, valorizzare l’esistenza di garanzie procedimentali, nonché di strumenti espressione di istanze partecipative, come le forme di accesso di cui si è detto, risponde a esigenze di democraticità che uno Stato di diritto è tenuto ad assicurare nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini.
Purtuttavia, non si può non evidenziare che queste esigenze non possono essere lasciate al buon senso o alla sensibilità giuridica o all’interpretatio di questo o di quell’altro giudice, ponendo il creazionismo giurisprudenziale[xxxiii] un grave vulnus alla certezza del diritto e di conseguenza al diritto di uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge.
Pertanto, concludendo, per evitare che un potere camaleontico[xxxiv] come il golden power, possa di fatto tradursi in uno oscuro strumento di politica dirigista capace, da un lato, di creare Stati competitor[xxxv], dall’altro, di comprimere indebitamente diritti o libertà fondamentali dei cittadini, bensì anche di recare pesanti disallineamenti fra politiche centrali e realtà territoriali, così finanche esacerbando i già gravi e radicati divari territoriali di cittadinanza, sarebbe forse opportuno un ripensamento della normativa in questione a garanzia della legalità e della certezza del diritto, espressione primaria della democraticità di uno Stato di diritto.
[i] Così in motivazione lo stesso il Consiglio di Stato, 13 gennaio 2025, n. 171.
[ii] R. Villata, La trasparenza dell’azione amministrativa, in Dir. proc. Amm., 1987, 529 ss.; G. Arena, Trasparenza amministrativa e democrazia, in G. Berti, G.C. de Martin, Gli istituti di democrazia amministrativa, Milano, 1996, 22 ss.; A. Sandulli, L’accesso ai documenti amministrativi, in Giorn. dir. amm., 5/2005; 494; M.A. Sandulli, Accesso alle notizie e ai documenti amministrativi, (voce) Enc. Dir., appendice di aggiornamento IV, Milano, 2000, 1 ss.; M. Ciammolo, La legittimazione ad accedere ai documenti amministrativi (prima e dopo la l. 11 febbraio 2005 n. 15, Foro amm. T.a.r., 2007, 1198 ss.; C. Marzuoli, La trasparenza come diritto civico alla pubblicità, in F. Merloni, Trasparenza delle istituzioni e principio democratico, Milano, 2008, 45 ss.; F. Merloni, La trasparenza come strumento di lotta alla corruzione tra legge n. 190 del 2012 e d. lgs. n. 33 del 2013, in B. Ponti (a cura di), La trasparenza amministrativa dopo il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, Rimini, 2013, 18 ss.; M. Cocconi, L’acquisizione di documenti da parte di soggetti pubblici: diritto d’accesso o principio di leale cooperazione istituzionale?, in Giorn. dir. amm., 2012, 1, 58; M.C. Cavallaro, Garanzie della trasparenza amministrativa e tutela dei privati, in Dir. Amm. 2015, 121, ss.; F. Manganaro, Evoluzione del principio di trasparenza, in Studi in memoria di Roberto Marrama, Napoli, 2012, 639; Id., Trasparenza e obblighi di pubblicazione, in Nuove autonomie, 2014, 553 ss.; Id., Trasparenza e digitalizzazione, in Dir. e proc. amm., 1/2019, 25 ss; I.M. Marino, Sulla funzione statutaria e regolamentare degli enti locali, ora in A. Barone (a cura di), Scritti Giuridici, tomo II, Napoli, 2015, pag. 1294-1316; D.U. Galetta, Trasparenza e contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione, fra realtà e falsi miti, Relazione al congresso annuale dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto amministrativo, Antidoti alla cattiva amministrazione: una sfida per le riforme, Roma, 7-8 ottobre 2016; A.G. Orofino, La trasparenza oltre la crisi. Accesso, informatizzazione, controllo civico, Bari, 2020; M.R. Spasiano, I principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità, in M.A. Sandulli (a cura di), Codice dell’azione amministrativa, Milano, 2011, 83; M.A. Sandulli - L. Droghini, La trasparenza amministrativa nel FOIA italiano. Il principio di conoscibilità generalizzata e la sua difficile attuazione, in federalismi, 2019, 401 ss.; M. Savino, The Right to Open Public Administrations in Europe: Emerging Legal Standards, Parigi, OECD-OCSE, Sigma Paper n. 46, 2010, 1-41; Id., Il FOIA italiano e i suoi critici: per un dibattito scientifico meno platonico, in Dir. amm., 3/2019, 453 ss.; F. Fracchia, E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2020, 55; A. Barone, La trasparenza amministrativa, in Aa.Vv., Diritto pubblico per l’economia e gli studi sociali, A. Barone - C. Colapietro - G. Seges, Torino, 2024; A. Corrado, Il principio di trasparenza e i suoi strumenti di attuazione, in M.A. Sandulli (a cura di), Principi e regole dell’azione amministrativa, Milano, 2024, 187 – 220.
[iii] Si veda come esempio recente: ANAC, delibera n. 797 del 6 dicembre 2021 sull’istanza di accesso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale e relativi limiti.
[iv] Cfr. fra le sentenze recenti: Cons. Stato, sez. V, 10 ottobre 2022, n. 8667; Cons. Stato, sez. IV, 22 giugno 2021, n. 4792.
[v] Cons. di Stato, sez. IV, n. 846/2013; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, sent. n. 656/2017.
[vi] P. Barile, Democrazia e segreto, in Quad. cost., 1, 1987, 32; T. F. Giupponi, Segreto di Stato (diritto costituzionale), in Enc. Dir., Annali X, Milano, 2017, 856 ss.; S. Perongini, Introduzione a Il segreto di Stato. Un’indagine multidisciplinare sull’equo bilanciamento di ragioni politiche e giuridiche, Torino, 2022, XIV; R. Bifulco, Segreto e potere politico, in Enc. Dir., I Tematici, V, Milano, 2023, 1096 ss.; S. Tranquilli, Il segreto in giudizio. Contributo allo studio del rapporto tra diritto di difesa e tutela della segretezza nel processo amministrativo, Napoli, 2023.
[vii] In generale, sul principio di proporzionalità: A. Sandulli, La proporzionalità dell’azione amministrativa, Cedam, Padova, 1998; V. Fanti, Dimensioni della proporzionalità. Profili ricostruttivi tra attività e processo amministrativo, Torino, 2012; D.U. Galetta, Il principio di proporzionalità fra diritto nazionale e diritto europeo (e con uno sguardo anche al di là dei confini dell'unione europea), in Riv. it. dir. pubbl. com., 6/2019, 907 ss.
[viii] V. Fanti, Segreto di Stato e attività di intelligence: tutela dei diritti dei cittadini tra proporzionalità e trasparenza, manoscritto, di prossima pubblicazione su Dir. e proc. amm. 3/2025.
[ix] L. Belviso, Golden power. Profili di diritto amministrativo, Torino, 2023; G. Della Cananea-L. Fiorentino (a cura di), I “poteri speciali” del Governo nei settori strategici, Napoli, 2020; G. Napolitano, L’irresistibile ascesa del golden power e la rinascita dello Stato doganiere, in Giorn. dir. amm., 2019, 549 ss.; A. Sandulli, La febbre del golden power, in Riv. trim. dir. pubbl., 2022, 743 ss.; R. Chieppa, La nuova disciplina del golden power dopo le modifiche del decreto-legge n. 21 del 2022 e della legge di conversione 20 maggio 2022, n. 51, in Federalismi, 2022, 1-28; M. Clarich, La disciplina del golden power tra Stato, mercato ed equilibri geopolitici, in Giur. Comm., 2024, 702 ss.; S. De Nitto, I golden power nei settori rilevanti della difesa e della sicurezza nazionale, in Dir. amm., 2022, 553-58; L. Masotto, Il golden power alla prova del procedimento e del processo amministrativo, in Giorn. dir. amm., 2022, 663 ss.; R. Angelini, Stato dell’arte e profili evolutivi dei poteri speciali: al crocevia del golden power, in Rivista di dir. soc, 3, 2018, 706 ss. Per un rapido inquadramento generale della disciplina si veda anche il sito: https://temi.camera.it/leg19/post/19_la-salvaguardia-degli-assetti-strategici-inquadramento-generale.html.
[x] Sia sufficiente richiamare: L. Belviso, Golden power. Profili di diritto amministrativo, op. cit.; A. Sandulli, La febbre del golden power, op. cit; R. Chieppa, La nuova disciplina del golden power dopo le modifiche del decreto-legge n. 21 del 2022 e della legge di conversione 20 maggio 2022, n. 51, op. cit. In generale, poi, sull’atto politico e sugli atti di alta amministrazione si veda: A. Contieri - F. Francario - M. Immordino - A. Zito, L’interesse pubblico tra politica e amministrazione, Napoli, 2010.
[xi] Sui temi, anche criticamente: F. Cintioli, La natura amministrativa della decisione sull’esercizio dei poteri speciali e la sua sottoposizione al sindacato del giudice amministrativo, in Aa.Vv., Golden power, R. Chieppa - C.D. Piro - R. Tuccillo (a cura di), Il Foro Italiano, La tribuna, 2023; E.M. Tepedino, Golden powers: i poteri speciali del governo al vaglio del giudice amministrativo, in Amministrazione in cammino, giugno 2022, 11 ss.; D. Ielo, Riflessioni sul sindacato del giudice amministrativo sui cosiddetti “Golden powers”, in Riv. interdisciplinare sul diritto delle amministrazioni pubbliche, 4/2021, 62 ss.
[xii] Così: A Sandulli, La febbre del golden power, op.cit., 753.
[xiii] M. Trimarchi, Potere dorato, potere segreto, relazione tenuta a Convegno su “Segreto, sicurezza dello Stato e discovery delle informazioni di intelligence, svoltosi presso l’Università degli studi di Foggia, Dipartimento di Giurisprudenza, in data 26 settembre 2024 e di prossima pubblicazione su Dir. e proc. amm. 3/2025.
[xiv] Per ripercorrere rapidamente l’evoluzione normativa che ha interessato la disciplina in esame sia sufficiente consultare il sito: https://temi.camera.it/leg19/post/19_la-salvaguardia-degli-assetti-strategici-inquadramento-generale.html.
[xv] Per la bibliografia sul principio di trasparenza si rinvia alla nota 2.
[xvi] R. Resta, L’onere di buona amministrazione, in Annali Macerata, 1938, poi in Scritti giuridici in onore di Santi Romano, vol. II, Padova, Cedam,1940, 104 ss. U. Allegretti, Corte Costituzionale e Pubblica Amministrazione, in Le Regioni, 1982, 1186; A. Andreani, Il principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione, Padova, 1979; P. Barile, Il dovere di imparzialità della P.A., in Scritti in onore di P. Calamandrei, Padova, 1958, IV, 136; G. Berti, Il principio organizzativo nel diritto pubblico, Padova, 1986, 160; P. Calandra, Il buon andamento dell’amministrazione pubblica, in Studi in memoria di V. Bachelet, Milano, 1987; G. Falzone, Il dovere di buona amministrazione, Milano, 1953; N. Speranza, Il principio di buon andamento – imparzialità nell’art. 97 Cost., FA, 1972, II, 86; R. Ferrara, L’interesse pubblico al buon andamento delle pubbliche amministrazioni: tra forma e sostanza, in Dir. e proc. amm, 2010, 31 ss.; A. Massera, I criteri di economicità, efficacia ed efficienza, in Codice dell’azione amministrativa, M.A. Sandulli (a cura di), Milano, 2011, 22 ss.; M.R. Spasiano, L’organizzazione comunale. Paradigmi di efficienza pubblica e buona amministrazione, Napoli, 1995; Id., Profili di organizzazione della pubblica amministrazione in cinquanta anni di giurisprudenza della Corte Costituzionale, in Diritto Amministrativo e Corte Costituzionale,G. Della Cananea - M. Dugato (a cura di), Napoli, 2006, 163 ss.; Id, Trasparenza e qualità dell’amministrazione, in Studi in onore di Spagnuolo Vigorita, Napoli, 2007, III, 1435; Id, Il principio di buon andamento, in Principi e regole dell’azione amministrativa, M.A. Sandulli (a cura di), Milano, 2023.
[xvii] G.P. Cirillo, Diritto all’accesso e diritto alla riservatezza: un difficile equilibrio mobile, 2004, in www.giustizia-amministrativa.it; M. Clarich, Trasparenza e diritti della personalità nell’attività amministrativa, convegno su “Trasparenza e protezione dei dati personali nell’azione amministrativa”, Roma, 11 febbraio 2004, consultabile al sito www.giustizia-amministrativa.it; C. Colapietro, Il complesso bilanciamento fra principio di trasparenza e il diritto alla privacy: la disciplina delle diverse forme di accesso e degli obblighi di pubblicazione, in www.federalismi.it, 2020, 64 ss.; V. Fanti, La trasparenza amministrativa tra principi costituzionali e valori dell’ordinamento europeo: a margine di una recente sentenza della Corte costituzionale (n. 20/2019), in www.federalismi.it, 4 marzo 2020; O. Pollicino – F. Resta, Visibilità del potere, riservatezza individuale e tecnologia digitale. Il bilanciamento delineato dalla Corte, in Il diritto dell'informazione e dell'informatica, 2019, 110 ss.
[xviii] Consiglio di Stato, sez. V, 26 maggio 2020, n. 3345; Consiglio di Stato, sez. II, 28 marzo 2023, n. 3160; T.A.R. Lazio, sez. I, sentenza 11 maggio 2024, n. 9314.
[xix] Cfr. Cons. stato, Ad. Pl., n. 10/2020.
[xx] Sia sufficiente rinviare ai chiarimenti dell’ANAC (delibera 29 dicembre 2016, n. 1309) alla disciplina dei limiti all’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5-bis d.lgs. n. 33/2013 e alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2017 e 1/2019. Sui temi: C. Deodato, La difficile convivenza dell’accesso civico generalizzato (FOIA) con la tutela della privacy: un conflitto insanabile?, www.giustizia-amministrativa.it, 20 dicembre 2017; M. Lipari, Il diritto di accesso e la sua frammentazione dalla legge n. 241/1990 all’accesso civico: il problema delle esclusioni e delle limitazioni oggettiva, www.federalismi.it, 2019.
[xxi] Cons. Stato, 20 dicembre 2019, n. 1468.
[xxii] C. Deodato, La difficile convivenza dell’accesso civico generalizzato (FOIA) con la tutela della privacy: un conflitto insanabile?, op. cit.; M. Lipari, Il diritto di accesso e la sua frammentazione dalla legge n. 241/1990 all’accesso civico: il problema delle esclusioni e delle limitazioni oggettiva, www.federalismi.it, 2019; A. Berti, Il dedalo delle limitazioni assolute dell’accesso civico generalizzato, al sito www.giustizia-amministrativa.it, 2021
[xxiii] M.P. Vipiana, Introduzione allo studio del principio di ragionevolezza nel diritto pubblico, Cedam, 1993.
[xxiv] G. Napolitano, L’irresistibile ascesa del golden power e la rinascita dello Stato doganiere, op. cit.; S. De Nitto, I golden power nei settori rilevanti della difesa e della sicurezza nazionale, op. cit.
[xxv] Sul tema, approfonditamente: A. Sandulli, Corte di Giustizia dell’Unione Europea, libertà di stabilimento, limiti al Golden power, in Riv. regolazione dei mercati, 2/2023. Si v. altresì: D. Gallo, La questione della compatibilità dei golden powers in Italia, oggi, con il diritto dell’Unione europea: il caso delle banche, in Riv. regolazione dei mercati, 1/2021; nonché: E. Zampetti, Infrastrutture e golden power, in Dir. amm., 1/2025, 177 - 205.
[xxvi] Cfr. sentenza del 27 febbraio 2019, Associação Peço a Palavra e a., C-563/17, EU:C:2019:144, punto 70 e giurisprudenza ivi citata; sentenze del 22 ottobre 2013, Essent e a., da C-105/12 a C-107/12, EU:C:2013:677.
[xxvii] V. anche, sentenza del 14 marzo 2000, Église de scientologie, C-54/99, EU:C:2000:124, punto 17 e giurisprudenza citata
[xxviii] Così: H. Simonetti, Il sindacato giurisdizionale sull’esercizio dei golden powers, reperibile al sito www.giustizia-amministrativa.it.
[xxix] Così M. Clarich, Il golden power rischia di trasformarsi in uno strumento di politica dirigista, in Milano Finanza, 2022.
[xxx] T.A.R. Lazio, sez. I, 12 luglio 2025, n. 13748
[xxxi] Sul tema, complesso, dei divari di cittadinanza: Aa.Vv., Le diseguaglianze sostenibili nei sistemi autonomistici multilivello, Atti del Convegno di Copanello 2005, F. Astone, M. Caldarera, F. Manganaro, A. Romano Tassone, F. Saitta (a cura di), Torino, 2006; A. Police, L’organizzazione delle pubbliche amministrazioni tra Stato nazionale e attribuzioni regionali: la parabola dell’eguaglianza, in Aa.Vv.,L’organizzazione delle pubbliche amministrazioni tra Stato nazionale e integrazione europea, R. Cavallo Perin - A. Police - F. Saitta (a cura di), vol. I, Firenze, 2016, 67 ss.; A. Barone, Il tempo della perequazione: il Mezzogiorno nel PNRR, in P.A. Persona e Amministrazione, 2/2021, 7-11; A. Barone - F. Manganaro, PNRR e Mezzogiorno, in Quaderni costituzionali, 1/2022, 148-152; F. Manganaro, Osservazioni sulla questione meridionale alla luce del PNRR e del regionalismo differenziato, in Nuove Autonomie, 2/2022, 387- 404; Id., Dalla cittadinanza alle cittadinanze. Questioni su un concetto polimorfico, in ambientediritto.it, 4/2022, 323-334; Id, Politiche di coesione (voce), in Enc. Dir., Funzioni Amministrative, III, Milano 2022, 839 ss. Infine, sia consentito rinviare a: R. Dagostino, Sistema delle autonomie e divari territoriali di cittadinanza, in Dir e soc., 3/2023, 455-483.
[xxxii] Sul tema delle infrastrutture si v.: E. Zampetti, Infrastrutture e golden power, op.cit.
[xxxiii] Sul tema, in generale, anche in riferimento ad altri rami dell’ordinamento giuridico: L. Ferrajoli, Contro il creazionismo giudiziario, Modena, 2018; Id., Contro il creazionismo giurisprudenziale. Una proposta di revisione dell'approccio ermeneutico alla legalità penale, in Ars Interpretandi, 2/2016, 23-43; D. Dalfino, Creatività e creazionismo, prevedibilità e predittività, in Il Foro italiano, 12/2018, 5, 385-393. Con particolare riferimento alla dottrina amministrativistica: P. Portaruli, La cambiale di Forsthoff. Creazionismo giurisprudenziale e diritto al giudice amministrativo, Napoli, 2021; A. Cassatella, Separazione dei poteri, ruolo della scienza giuridica, significato del diritto amministrativo e del suo giudice. Osservazioni a margine di “Ogni cosa al suo posto. Restaurare l'ordine costituzionale dei poteri” di Massimo Luciani, F. Saitta, Regole processuali, indeterminatezza e creazionismo giudiziario, in Dir. proc. amm., 2/2024, 263 - 343. Sia consentito altresì il rinvio a: R. Dagostino, Le corti nel diritto del rischio, Bari, 2020.
[xxxiv] L’espressione è di H. Simonetti, Il sindacato giurisdizionale sull’esercizio dei golden powers, op. cit.
[xxxv] Così, specificatamente: E. Zampetti, Infrastrutture e golden power, op.cit.

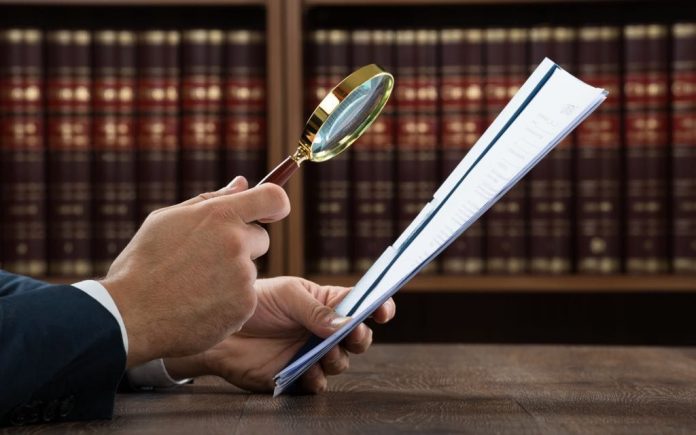

 And then Add to Home Screen.
And then Add to Home Screen.