Recensione di Il dolore della guerra di Bảo Ninh (2025 Neri Pozza Editore, Vicenza)
L’autore di questo romanzo ha quasi 73 anni, è nato ad Hanoi e, come si legge nella terza di copertina, a diciassette anni si è unito all’Esercito popolare del Vietnam del Nord ed ha combattuto fino all’ultima battaglia all’aeroporto di Saigon, il 30 aprile del 1975.
Quella guerra fu un conflitto ingiusto e brutale, che costò al Vietnam – secondo le cifre rilasciate dal Governo – oltre 5 milioni di vittime, in grandissima parte civili, mentre gli Stati Uniti persero circa 60mila uomini appartenenti alle forze armate.
Ma la storia, in questo romanzo scritto nel 1991, è raccontata da altra visuale, quella dei vincitori che però non vi sono affatto descritti come eroi, al punto da smontare i trionfalismi della propaganda vietnamita e da determinare la reazione negativa del governo dell’epoca che ne vietò la pubblicazione: il libro circolò a lungo solo in forma clandestina prima di diventare un best seller internazionale e di essere insignito dell’Indipendent Foreign Fiction Prize nel 1994, importante premio letterario inglese. Solo nel 2006, quindici anni dopo la sua pubblicazione, il divieto del libro fu revocato e l'edizione inglese apparve nelle librerie e nelle edicole in Vietnam.
Il romanzo si apre con una rappresentazione di soldati in missione nel dopoguerra, nel 1976, per raccogliere le ossa dei compagni caduti da seppellire. Così inizia la narrazione di Kien, il soldato nordvietnamita durante la guerra del Vietnam, che inizia a riflettere sul suo passato e racconta la sua perdita di innocenza, il suo amore e la sua angoscia per i ricordi della guerra.
La ricerca dei resti dei soldati caduti si svolge nelle zone impervie degli altipiani ed in quella che Kien immagina come la "giungla delle anime urlanti", ove 500 soldati del suo 27° Battaglione sono stati annientati dal napalm, ad eccezione di una decina di sopravvissuti tra cui lui stesso. I suoi flashback legano insieme il romanzo e spesso sono incentrati sull'amore tra Kien e la sua fidanzata d'infanzia, Phuong con cui ha nuotato in un grande lago fino a sera mentre altri studenti scavavano trincee nei cortili e dalla quale si è separato durante un drammatico viaggio a sud verso la linea del fronte, poco prima di iniziare a combattere.
Kien decide di scrivere un romanzo sulla vita vissuta, ma poi cambia idea e cerca di bruciarlo. Una ragazza muta che Kien conosce quando è ubriaco ed alla quale esprime i suoi pensieri, ottiene il testo dopo la sua partenza per destinazione incerta. Kien, nel libro, riflette sulle sue esperienze, sui molti sacrifici non riconosciuti, come quello della donna-guida militare Hoa che, vicino al Lago dei Coccodrilli, rinuncia alla sua vita per salvarlo dai soldati americani insieme ai suoi compagni feriti («Qualcuno muore perché qualcun altro sopravviva. Niente di più naturale, niente di più banale»), ma ricorda anche la sua prima uccisione personale, che avviene dopo aver assistito allo stupro di Phuong. Il romanzo si conclude con il racconto di un nuovo narratore, che spiega di aver ricevuto il romanzo di Kien dalla ragazza muta.
Il Dolore della Guerra – ha osservato un giornalista inglese - si eleva al di sopra delle rappresentazioni culturali della guerra del Vietnam, sia americane che vietnamite, piene di romanticismo e stereotipizzazione: «Si muove avanti e indietro nel tempo, e dentro e fuori dalla disperazione, trascinandoti giù mentre l'eroe-solitario ti guida attraverso il suo inferno privato nelle Highlands del Vietnam centrale, o sollevandoti quando il suo spirito si innalza. È un ottimo romanzo di guerra e un libro meraviglioso.» Il romanzo è stato spesso paragonato a Niente di nuovo sul fronte occidentale di Erich Maria Remarque ed è stato anche definito “un romanzo di guerra e soprattutto di dopoguerra”, il cui protagonista, Kien, è certamente l’alter ego dell’autore: entrambi vogliono raccontare il dolore a chi vorrà ascoltarlo.
Kien – si legge nel romanzo - «scrive della guerra in modo personale, come se fosse stata una guerra sua e soltanto sua» e rammenta le parole che un vecchio gli rivolge quando sta per partire volontario: «Dunque parti per la guerra? Non che voglia dissuaderti, io sono vecchio, sappi solo che il dovere di un essere umano su questa terra è vivere, non immolarsi».
Dopo molti anni dalla fine della guerra, Kien torna ad Hanoi, «la città che cambiava volto di ora in ora, che tornava sé stessa di notte sotto la pioggia» ed inizia a frequentare un bar sul lago Hoan Kiem, ove si incontravano gli ex militari del “Club dei reduci”. Perché? Perché, spiega Kien come anche Bao Nihn avrebbe detto, «Mi aspetta una nuova vita..devo andare avanti. Ma la mia anima è ancora in tumulto. Il passato mi perseguita e mi imprigiona».

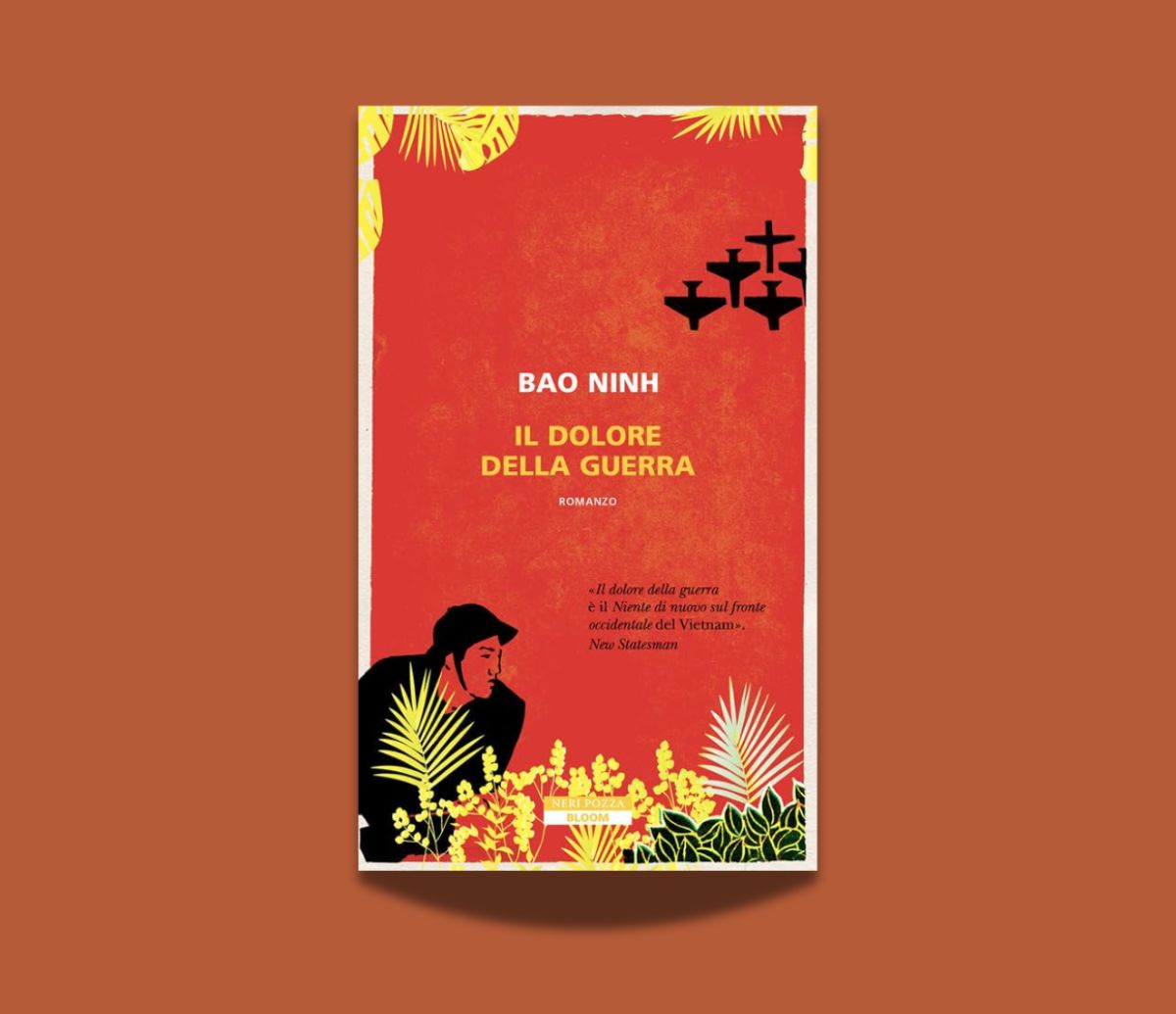

 And then Add to Home Screen.
And then Add to Home Screen.