Memoria, testimonianze e ritratti di giuristi italiani del Novecento - a cura di Vincenzo Antonio Poso
Vita e opere di Gaetano Vardaro, intellettuale giuslavorista
Sommario: 1. La vita – 2. Le opere – 3. L’intellettuale giuslavorista – 4. Vardaro dopo Vardaro – 5. Minima personalia.
1. La vita
Gaetano Vardaro nacque a Montefalcione (AV) il 2 luglio 1949. Il padre, Libero, incarnava la tipica figura – oggi praticamente scomparsa – dell’erudito meridionale, conversatore colto e affascinante, e, tra l’altro, sensibile studioso di cose storiche; esercitò molta influenza sul figlio, che gli era legatissimo. Laureatosi in Giurisprudenza nel 1973 a Napoli, specializzatosi in diritto del lavoro nel 1975 a Roma, dove beneficiò di un contratto di ricerca, G.V. fu nel 1976 assegnista e nel 1981 ricercatore nell’Università di Salerno, inserendosi nel gruppo guidato da Fabio Mazziotti. Lì conobbe Anna Rita Marchitiello, che presto sarebbe divenuta sua moglie, dandogli l’unico figlio, Libero come il nonno.
In un’epoca nella quale la mobilità accademica era favorita e non ostacolata, nel 1982 si trasferì all’Università di Roma “La Sapienza”, per poter lavorare a più stretto contatto con Gino Giugni, da qualche anno suo imprescindibile referente scientifico e accademico, che lo aveva chiamato a far parte della redazione della rivista da lui fondata, il Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, della quale G.V. divenne in breve colonna portante e alla quale avrebbe regalato preziosi contributi.
Sempre da ricercatore, su sollecitazione di Umberto Romagnoli, l’altro studioso che ne aveva subito intuito le doti di studioso brillante e appassionato e al quale G.V. avrebbe costantemente fatto riferimento, approdò nel 1983 come professore a contratto nella Facoltà di Economia e commercio dell’Università di Urbino, primo docente non di scuola bolognese a insegnarvi il diritto del lavoro. La stagione urbinate fu breve, ma intensissima: G.V. vi lasciò un’impronta indelebile, il cui momento culminante fu l’organizzazione di uno straordinario seminario internazionale e interdisciplinare sul rapporto tra diritto del lavoro e corporativismi vecchi e nuovi (28-30 aprile 1986), che vide la presenza di alcuni dei più importanti giuslavoristi, sociologi, storici e scienziati politici italiani e stranieri: erano tempi in cui gli esperimenti di concertazione sociale avviati in Italia sembravano delineare un nuovo scenario delle relazioni industriali, trovando un referente teorico nel dibattito sul neocorporativismo; e in cui sembrava giunto il momento di avviare una riflessione critica sul ruolo svolto dalle dottrine corporative nella formazione e negli sviluppi del diritto del lavoro, soprattutto in un’Italia che, «in omaggio ad un antifascismo talvolta solo di maniera, aveva preferito rimuovere questo “peccato originale”» (Diritto del lavoro e corporativismi in Europa: ieri e oggi, Franco Angeli, 1988; qui l’introduzione, 15-30).
G.V., comunque, abitava sempre ad Avellino, sottoponendosi a faticosi spostamenti per raggiungere le Marche. E nella sua città, a cui era molto legato, viveva molto intensamente, continuando – come meglio si dirà in seguito – a dimostrarsi persona di cultura “a tutto tondo”.
A metà degli anni Ottanta, G.V., forte di due monografie appena pubblicate, partecipò contemporaneamente ai concorsi per professore associato e per professore ordinario. Il primo gli avrebbe consentito di consolidare la sua posizione all’Università di Urbino, che aveva bandito il posto, ma, com’era nell’ordine delle cose, arrivò subito, agli inizi del 1986, la vittoria in prima fascia. Perciò, dopo diverse vicissitudini accademiche, che lo amareggiarono non poco, fu chiamato da “straordinario” (come si diceva allora) all’Istituto universitario navale di Napoli, l’odierna Università “Parthenope”. Mantenne, però, a costo di notevoli sacrifici, una supplenza nell’amata Urbino. Anche in quel bel palazzo in riva al mare accanto al Maschio Angioino, dove rimase per pochissimi mesi, G.V. lasciò un segno profondo, organizzando nella primavera del 1988 un memorabile convegno internazionale sullo sciopero nei servizi pubblici in Europa, tema caldissimo di quel momento (Sciopero e servizi pubblici in Europa, Esi, 1989), incurante tra l’altro delle critiche che gli piovvero addosso perché di lì a pochi giorni il congresso nazionale dell’Associazione italiana di diritto del lavoro avrebbe avuto ad oggetto proprio il tema del conflitto collettivo.
Nell’estate del 1988 G.V. si recò a studiare negli Stati Uniti, quasi a seguire le orme del suo maestro di elezione, Gino Giugni, che alla fine degli anni Cinquanta, frequentata la scuola dell’istituzionalismo economico nell’Università del Wisconsin, aveva poi gettato le basi per il rinnovamento metodologico del diritto del lavoro italiano. Purtroppo, invece, per G.V. il ritorno dalla “Harvard” precedette di poco il gesto estremo con cui si chiuse la sua breve e intensa esistenza il 25 ottobre 1988.
2. Le opere
La produzione scientifica di G.V. si concentra in una dozzina d’anni, dal 1976 al 1988. Essa, comunque, appare estremamente ricca e poliedrica, sempre proiettata alla ricerca delle radici ideali e culturali del diritto del lavoro, che affondavano soprattutto nell’esperienza weimariana. Fin da subito, infatti, le coordinate della ricerca di G.V. furono costituite dalla storia del pensiero giuridico e dalla straordinaria passione per la cultura tedesca e per i giuristi weimariani in particolare. Primo terreno di elezione su cui sondare le direttrici di tale progetto scientifico fu la tematica dell’inderogabilità del contratto collettivo, i cui risvolti in termini di politica del diritto G.V. indagò con cura – e con grande attenzione al dibattito tedesco –, relativamente all’epoca liberale e a quella corporativa, in due importanti saggi usciti sulle riviste di Gino Giugni e di Giovanni Tarello (L’inderogabilità del contratto collettivo e le origini del pensiero giuridico-sindacale, in Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 1979, 537-584; Le origini dell’art. 2077 cod. civ. e l’ideologia giuridico-sindacale del fascismo, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 1980, 437-469).
Lo studio dei classici weimariani indusse G.V. a tradurli e a farli conoscere in Italia, dove allora davvero in pochi ne avevano presente il ruolo, se non addirittura l’esistenza. Si trattò innanzitutto di importare il fecondissimo – e talvolta spigoloso – dibattito scientifico che i giuslavoristi della “Repubblica incantata” ingaggiarono prima di disperdersi per il mondo all’avvento del nazismo. Con Gianni Arrigo, G.V. curò pertanto l’antologia Laboratorio Weimar. Conflitti e diritto del lavoro nella Germania prenazista (Edizioni Lavoro, 1982), assolutamente aliena dall’azzardare simmetrie o profezie fuori luogo e allo stesso tempo portatrice di una linea diversa rispetto alla (forse tardiva) riscoperta che stava contemporaneamente avvenendo in una Repubblica federale tedesca troppo propensa a dimenticare in fretta, se non a rimuovere: l’originalità stava già nella scelta, oltre che dei “classici” (Sinzheimer, Fraenkel, Neumann, Kahn-Freund), anche di brani di autori scomodi e polemici come Karl Korsch. I contorni di quel substrato ideologico e scientifico all’interno del quale il “corporativismo” costituiva espressione di autonomia e pluralismo, lungi evidentemente dalle deviazioni semantiche che lo avrebbero legato necessariamente alle esperienze fasciste, emergeva forse ancora più nitidamente nella corposa antologia che l’anno successivo G.V. dedicò specificamente a uno dei giuslavoristi tedeschi dai percorsi più problematici, Franz Neumann (Il diritto del lavoro fra democrazia e dittatura, Il Mulino, 1983).
Subito dopo per G.V. iniziò una fase di grande concentrazione, in vista della pubblicazione di quel lavoro monografico che ne potesse corroborare un successo concorsuale. Il tema era quello prediletto del contratto collettivo, e di libri ne uscirono due. Il primo (Contrattazione collettiva e sistema giuridico, Jovene, 1984) era originale in maniera sorprendente, perché applicava al tema le teorie dei sistemi elaborate da Niklas Luhmann, sottoponendole a costante confronto con le prospettive ordinamentali di Gino Giugni: un libro difficile e duramente dogmatico, dalle premesse e dagli sviluppi sicuramente discutibili. L’altra monografia (Contratti collettivi e rapporto individuale di lavoro, Franco Angeli, 1985), al confronto, era molto più tradizionale: eppure in essa, sempre seguendo il fil rouge “storico” dell’inderogabilità, G.V. chiudeva mirabilmente il cerchio delle sue ricerche sul tema, proponendo conclusioni mai scontate, quando non esplicitamente innovative.
In quella metà degli anni Ottanta, uno dei temi trainanti il dibattito giuslavoristico fu quello dell’impatto dell’innovazione tecnologica nel mondo del lavoro, alcune delle cui certezze sembrarono vacillare di fronte alla velocità e alla portata dei cambiamenti. G.V. non si sottrasse certo a queste discussioni; anzi, vi contribuì con un saggio memorabile, di taglio praticamente monografico (Tecnica, tecnologia e ideologia della tecnica nel diritto del lavoro, in Politica del diritto, 1986, 75-140), nel quale l’approccio storico e la profondità teorica si fondevano a comprendere il nuovo tema in modo davvero singolare, in un affascinante viaggio tra realtà passate, situazione del momento e prospettive future.
Salito in cattedra, G.V. non tirò affatto i remi in barca, come accade a tanti in quella situazione. Anzi, se possibile, intensificò ancor più i ritmi di lavoro, che si fecero convulsi, scoprendo nuovi oggetti di indagine, senza però tralasciare di coltivare il tradizionale filone storico. Suo nuovo punto di riferimento divenne allora Paolo Grossi e la sua scuola fiorentina, sulla cui rivista pubblicò un’acuta indagine, scritta con Bruno Veneziani, sugli inizi della giuslavoristica italiana ricostruiti attraverso le pagine di uno dei più noti periodici dell’epoca (La «Rivista di diritto commerciale» e la dottrina giuslavorista delle origini, in Quaderni fiorentini, 1987, 441-483), mentre in una collana della stessa rivista uscì – postumo – un volume che raccoglieva gli scritti dell’ennesimo giurista polemico, Thilo Ramm, sulle diverse tappe della storia del diritto del lavoro tedesco (Per una storia della costituzione del lavoro tedesca, Giuffrè, 1989).
La ricerca instancabile, a volte frenetica, di nuovi percorsi di studio portò G.V. a frequentare maggiormente il mondo anglosassone e a sconfinare nei campi della sociologia e delle relazioni industriali, sempre coniugate con il suo tradizionale retroterra storico-giuridico.
Ne vennero fuori una lezione dal profondo impianto teorico all’Istituto universitario europeo di Fiesole sul rapporto di lavoro nelle società collegate, lette come forma organizzativa degli interessi imprenditoriali (Before and Beyond the Legal Person: Trade Unions, Group Enterprises and Industrial Relations, in Sugarman, Teubner, eds., Governance in Group Enterprises, Nomos, 1990, 217-251), al di fuori dei falsi pericoli delle teorie della persona giuridica (Chi ha paura della persona giuridica?, in Il progetto, 1988, 48, 102-106); e gli originali studi sulla giuridificazione, innanzitutto con un intervento breve ma molto denso, nel quale G.V. si preoccupava di portare chiarezza su un tema viziato da polemiche ed equivoci ingeneratisi tra studiosi nordamericani e tedeschi (Giuridificazione, colonizzazione e autoreferenza nel diritto del lavoro, in Politica del diritto, 1987, 601-610); per poi applicare originalmente queste categorie teoriche a un classico tema tecnico del rapporto di lavoro, quale il potere disciplinare (Il potere disciplinare giuridificato, in Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 1986, 1-42).
La mai abbandonata attenzione allo studio dei percorsi dei giuslavoristi weimariani si spostò, infine, su un tema molto particolare, cioè la verifica dell’esistenza – ed eventualmente dell’importanza – di radici ebraiche del diritto del lavoro. Il programma era già stato scritto («Arbeitsverfassung» ovvero la stella dell’assimilazione, in Sociologia del diritto, 1987, 17-39) e la tesi di fondo era – come d’abitudine – affascinante, provocatoria e discutibile. La ricerca necessitava ovviamente di approfondimenti, per cui G.V. accettò di buon grado – e con molto orgoglio – l’invito a recarsi per quel soggiorno di studi alla “Harvard”, al termine del quale tutto finì.
Il suo percorso si trasformò anch’esso in quello Holzweg heideggeriano – una viuzza di montagna stretta e infida, metafora di un (troppo) breve attraversamento – al quale egli volle paragonare l’itinerario giuslavoristico di Franz Neumann (Oltre il diritto del lavoro: un Holzweg nell’opera di Franz Neumann, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 1983, 505-537).
3. L’intellettuale giuslavorista
G.V. «non è stato – in realtà – un giuslavorista, ma un erudito geniale che nel suo breve percorso esistenziale ha incontrato il giuslavorismo». L’affermazione di Luigi Mariucci (Il diritto del lavoro e il suo ambiente, in Scritti in onore di Giuseppe Federico Mancini, I, Giuffrè, 1998, 335-356) coglie assolutamente nel segno. Lo studio del diritto del lavoro non era mai per G.V. un fatto meccanicamente tecnico, ma costituiva una splendida occasione per approfondire la cultura europea delle idee. Nel tema trattato, egli trasfondeva naturalmente l’enorme curiosità intellettuale derivata dalle sue letture, testimonianza di un’erudizione fuori dal comune, imbevuta per lo più di studi extragiuridici (la sua biblioteca personale era ricchissima di libri, ben ordinati tematicamente, di discipline disparate, delle quali era capace di individuare legami insospettabili).
Per i più “puristi”, naturalmente, ciò poteva anche non costituire un pregio; essi, però, tendevano a dimenticare che G.V. si era brillantemente confrontato più volte anche con le tecnicalità più spinose della materia; e che – per dirla con Umberto Romagnoli – quella «vivacità degli interessi culturali ai limiti della sregolatezza», che «lo predestinava a esibire di sé l’immagine dell’irrequieto intellettuale del Sud», era stata invece disciplinata e indirizzata dall’incontro con Giugni (Ricordando Weimar con Gaetano Vardaro, in Giuristi del lavoro nel Novecento italiano. Profili, Ediesse, 2018, 251-259 e 333-334).
G.V è stato, dunque – continuando con Romagnoli –, un «giurista atipico», perché appartenente a «una generazione inquieta […] che le rassicuranti certezze dogmatiche del passato, prossimo o remoto, riescono appena a sfiorare, ma che – figlia di una società “senza vertice e senza centro”, secondo la formula luhmaniana assai cara a Vardaro – sa di essere a sua volta incapace di produrne di nuove, vincenti o convincenti. Cosa di cui soffre, e si vede» (Gaetano Vardaro, un giurista atipico, in Zanelli, a cura di, Gruppi di imprese e nuove regole, Franco Angeli, 1991, 21-33).
G.V. è sempre stato agli antipodi rispetto all’immagine dello studioso chiuso nella turris eburnea: sentiva anzi il bisogno di socializzare, di discutere ogni sua idea. Questa sua vocazione di “propagandista” culturale lo portò a essere assiduo frequentatore di convegni, mai per semplici passerelle. Qui emergeva un altro fondamentale tratto costitutivo della personalità di G.V., cioè il suo essere profondamente anticonvenzionale, caratteristica che si riverberava naturalmente anche nella dimensione professionale.
Perciò, se in generale la sua produzione scientifica fu largamente eterodossa, i suoi interventi ai convegni, forzatamente ristretti in angusti limiti di tempo, furono sempre particolarmente incisivi e spregiudicati (si possono ricordare, per tutti, l’incontro bolognese sulla rappresentanza sindacale: Nuove regole dell’organizzazione sindacale, in Lavoro e diritto, 1988, 218-234, e il convegno trentino sulla subordinazione: Subordinazione ed evoluzionismo, in Pedrazzoli, a cura di, Lavoro subordinato e dintorni, Il Mulino, 1989, 101-109), molto spesso polemici e provocatori, come ad esempio quello al convegno Aidlass di Fiuggi del 1988 (Verso la codificazione del diritto di sciopero, in Aa.Vv., Lo sciopero: disciplina convenzionale e autoregolamentazione nel settore privato e pubblico, Giuffrè, 1989, 221-228). Naturalmente, non appena ebbe la forza accademica per farlo, G.V. i convegni iniziò a organizzarli “in proprio”, come si è visto a proposito di quello urbinate sui corporativismi e di quello napoletano sullo sciopero.
Un’altra caratteristica che va sempre tenuta presente per cercare di comprendere la personalità umana e scientifica di G.V. è costituita dalle sue radici.
Vivere in “provincia” ha avuto per lui innanzitutto il risvolto positivo dell’attaccamento alla città, con la conseguenza di diventare persona sensibilmente impegnata nel suo contesto sociale, attiva politicamente (nel partito socialista di unità proletaria, che nel 1972 confluì nel partito comunista) e assai entusiasta e competente nell’organizzazione di manifestazioni culturali, per lo più nel campo musicale: per Avellino, fin dagli anni Settanta, grazie a lui passarono mostri sacri della musica classica come Claudio Abbado, Maurizio Pollini, Bruno Canino, Luciano Berio, Luigi Nono, Severino Gazzelloni, o del jazz come Giorgio Gaslini, o del rock come Lou Reed. Sull’altro versante, invece, le origini lo hanno sempre segnato nel suo sentirsi un outsider (oggi si direbbe un underdog), facendogli vivere ogni sua affermazione in termini di sofferta rivincita del self-made man nei confronti di chi invece partiva già da solidi piedistalli. In uno dei suoi ultimi contributi, G.V. ripercorse la vicenda di un illustre avellinese, il meridionalista Guido Dorso, delineando i tratti del suo rapporto conflittuale col mondo del diritto, relegato in una sfera nascosta e particolare della sua vita, ed evidenziandone quindi l’emigrazione “interna”, tanto simile – a suo dire – a quella degli studiosi weimariani (Guido Dorso giurista: ovvero Kafka in provincia, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1989, 503-515).
G.V. aveva così – forse inconsapevolmente – scritto la sua autobiografia di “studioso di provincia”: la stessa autobiografia, problematica e lacerante, che è andato scrivendo quando ha studiato Weimar o l’ebraismo.
Alla fine, nessuno meglio di Gino Giugni ha tratteggiato un ritratto autentico di G.V., quando ne pianse la scomparsa coi lettori della sua rivista: «Gaetano Vardaro non parteciperà più agli incontri della nostra redazione. Non leggeremo più i suoi saggi su questa rivista, che si onora di aver ospitato i primi di essi, quelli che subito lo imposero all’attenzione della comunità scientifica. Ci ha privato della sua impegnata collaborazione, della sua entusiastica fiducia nella ricerca e del suo appassionato rigore filologico, della sua eccezionale fantasia progettuale, della sua rara capacità di accumulare una sconfinata cultura storico-filosofica, e precipitarne il concentrato nell’analisi del diritto positivo. […] è stato un autore originale e forse unico, per la sua innata tendenza ad osservare il fenomeno particolare nella totalità culturale, in questo certamente degno erede della miglior tradizione intellettuale del nostro Mezzogiorno. Per questo possiamo anche affermare che ha rappresentato un tipo di giurista sui generis, non facilmente riproducibile» (Ricordo di Gaetano Vardaro, in Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 1988, VII-VIII).
4. Vardaro dopo Vardaro
L’impatto della prematura scomparsa di G.V. sul mondo del diritto del lavoro fu piuttosto forte. Anche chi era più lontano dal suo modo di approcciare il diritto del lavoro, spesso criticamente provocatorio, ne riconosceva comunque la cultura e la genialità. Numerosi furono i ricordi pubblicati a caldo sulle riviste da parte di chi gli era stato più vicino. Chi scrive, insieme con Anna Rita Marchitiello, curò subito un’antologia dei suoi scritti, non a caso intitolata Itinerari (Franco Angeli, 1989): un esplicito invito a continuare a percorrere i suoi sentieri impervi, bruscamente interrotti ma sempre aperti per chi avesse avuto desiderio di seguirli.
A poco più di un anno dalla morte, il 1° dicembre 1989, la “sua” Università di Urbino volle commemorare G.V. con un convegno su uno degli ultimi temi da lui trattati (Zanelli, a cura di, Gruppi di imprese e nuove regole, cit.). Così come fece dieci anni più tardi, il 23 aprile 1999, con un incontro aperto da un intervento di Umberto Romagnoli, che sottolineava l’importanza dei suoi studi e delle sue soluzioni anche a distanza di tempo (L’opera di Gaetano Vardaro, oggi, in Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 1999, 1-8; poi compreso tra i profili dei Giuristi del lavoro nel Novecento italiano, cit.). Più tardi, G.V. venne annoverato tra i maestri che avevano illustrato l’Ateneo urbinate nel secolo scorso (Pascucci, Gaetano Vardaro, in Tonelli, a cura di, Maestri di Ateneo. I docenti dell’Università di Urbino nel Novecento, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, 2013, 547-553).
Col trascorrere degli anni, venne il tempo delle riletture. Il 4 e 5 marzo 2010, all’Università di Brescia si svolse un convegno dedicato alla memoria di G.V., nel quale si discusse del tema a lui più caro, l’autonomia collettiva (gli interventi in Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 2010, 303-399); in quell’occasione, Roberto Romei dedicò un’approfondita analisi al riesame delle due monografie di G.V. sul tema, ripercorrendo poi criticamente gli sviluppi dottrinali successivi (L’autonomia collettiva nella dottrina giuslavoristica: rileggendo Gaetano Vardaro, in Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 2011, 181-223).
Il 14 giugno 2014, l’associazione “SU & giù – giuslavoristi di Siena e Urbino”, fondata da chi scrive, organizzò a Urbino una rilettura del saggio di G.V. sui rapporti tra tecnologia e diritto del lavoro, affidandola a Luca Nogler, che pose in luce la perdurante attualità delle sue riflessioni sull’impatto che l’evoluzione della tecnica esercita sulla gestione del tempo della vita delle persone (Tecnica e subordinazione nel tempo della vita, in Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 2015, 337-357). Più di recente, il ciclo di “letture e riletture” promosso da Oronzo Mazzotta all’Università di Pisa ha visto il 19 aprile 2023 Marco Novella analizzare in profondità gli scritti di G.V. sull’inderogabilità del contratto collettivo, dei quali ha evidenziato le inevitabili obsolescenze ma anche le significative eredità metodologiche e culturali (Gaetano Vardaro e l’inderogabilità del contratto collettivo, in Mazzotta, a cura di, Introduzione al diritto sindacale. Letture e riletture. Volume 2, Giappichelli, 2024, 19-37).
È interessante da ultimo ricordare che quando, a maggio 2025, è rinata – sotto la direzione di Antonio Di Stasi – una rivista giuslavoristica che negli anni Ottanta del Novecento aveva interpretato un importante ruolo di contropotere culturale, si è potuto scoprire che il suo articolo di apertura consisteva in un lungo inedito di G.V. sulle sanzioni civili e sull’art. 28 dello statuto dei lavoratori, ripescato da Anna Rita Marchitiello tra le carte del marito e donato a Giorgio Fontana (Rivista critica di diritto del lavoro, 2025, 11-62).
La cosa più importante, però – e lo sottolinea Fontana, cui non fa sicuramente velo l’origine irpina –, è che ancora oggi «continuiamo a leggere, amare ed utilizzare» le opere di G.V. Non è frequente, infatti, che saggi di quaranta e più anni fa, il cui autore non c’è più da quasi altrettanto tempo, continuino a essere ampiamente citati dagli studiosi di diritto del lavoro, che ormai solo in pochissimi casi hanno conosciuto chi li ha scritti.
Le monografie sul contratto collettivo restano ancora una lettura obbligata per chi intenda occuparsi della materia, mentre il saggio sulla tecnologia è diventato ormai un classico, che sta peraltro rivivendo un suo momento d’oro in tempi di intelligenza artificiale; chiunque, anche solo di passaggio, accenni al diritto del lavoro di Weimar non può prescindere dal ricordare chi ebbe il merito di farne conoscere i protagonisti al pubblico italiano; e anche i suoi scritti più severamente teorici, per non dire di quelli di taglio squisitamente storico, continuano a figurare costantemente nelle citazioni.
Eppure, tutta la produzione di G.V. non è certo il classico esempio di “dottrina dominante”, ma esprime praticamente sempre un pensiero critico e anticonformista: opinioni originali, che definire “minoritarie” è poco.
5. Minima personalia
Gli autori di questo ricordo sentono di essere in qualche modo gli unici allievi lasciati da G.V., senza che naturalmente lui ne sia mai stato consapevole. L.G., ancora studente a Salerno, ne divenne subito «amico e compagno di percorsi», venendone indirizzato agli studi storici e alla conoscenza del mondo tedesco; P.P. venne attratto inesorabilmente nella sua orbita, diventandone il braccio destro a Urbino e ricevendone l’incoraggiamento a prendere la strada della ricerca universitaria.
La scomparsa del comune punto di riferimento significò per entrambi un distacco insopportabile, che li costrinse, però, nella ricerca di una precoce autonomia, a camminare più saldamente solo con le proprie gambe sostenendosi a vicenda. Col tempo, quella ferita difficilmente rimarginabile significò per loro il cementarsi di una profonda e duratura amicizia, non limitata alla sola sfera privata, ma fatta anche di ricerche comuni, di solidarietà e affinità istintive, di pubblicazioni “a quattro mani”, di inserimento in circuiti accademici e scientifici condivisi, della costituzione di una benemerita associazione. Quel che siamo stati dopo, lo siamo stati “per” lui (Gaeta, Pascucci, Da Salerno a Urbino “per” Avellino. Un ricordo comune di Gaetano Vardaro, Aras, 2010).

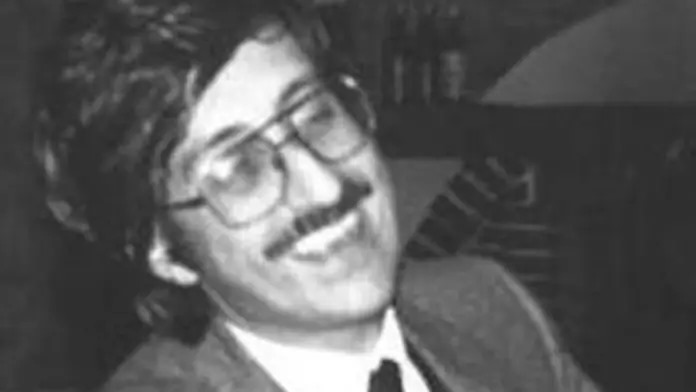

 And then Add to Home Screen.
And then Add to Home Screen.