Recensione di Gaetano De Amicis a Whistleblowing. Commento sistematico alla disciplina del d.lgs. n. 24/2023. Ambiti applicativi, governance, strumenti di segnalazione e protezione, Lefebvre Giuffrè, 2025, pp. 650, a cura di Raffaele Cantone – Nicoletta Parisi – Domenico Tambasco.
1. La recente pubblicazione del Commento sistematico alla disciplina del cd. “whistleblowing”, a cura di Raffaele Cantone, Nicoletta Parisi e Domenico Tambasco, viene a colmare una risalente lacuna nel panorama dell’editoria giuridica italiana.
A distanza di quasi due anni dall’entrata in vigore della disciplina introdotta dal d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali) giunge infatti l’opera collettanea qui recensita, che per la prima volta sviluppa un’analisi completa, a carattere sistematico e multidisciplinare del fenomeno, le cui forme e modalità di recepimento nel nostro sistema vengono esplorate funditus, offrendo uno strumento di approfondimento teorico-pratico di grande chiarezza e agevole consultazione.
Nel Commentario sono raccolti, all’interno di una architettura tematica sapientemente delineata dai Curatori, i molteplici contributi, fra loro efficacemente articolati e coordinati, di esperti (professori universitari, magistrati, avvocati e alti funzionari) particolarmente qualificati nei diversi settori regolati dalla nuova disciplina, ponendo costantemente a raffronto le specificità della normativa europea e le forme della sua attuazione nel nostro ordinamento, senza rinunciare a metterne in luce le numerose criticità riguardo ai profili di non esatto recepimento delle norme “esterne”, alle possibili ipotesi di regressione rispetto al regime giuridico interno precedente al recepimento e a tutte quelle situazioni che potrebbero compromettere il buon funzionamento dell’istituto.
L’opera, ricca di richiami giurisprudenziali e dottrinali, approfondita con riguardo ad ogni nodo problematico e densa di riflessioni critiche e indicazioni operative, si pone come punto di riferimento non solo nella evoluzione del dibattito dottrinale sulla messa a fuoco di questioni nuove e particolarmente complesse per la combinazione dei diversi profili nazionali, eurounitari e internazionali che vengono in giuoco, ma anche per i pratici del diritto che saranno chiamati ad applicare la nuova normativa e a sciogliere i numerosi dubbi interpretativi e le difficoltà di inquadramento teorico e pratico che essa pone, specie per quel che attiene alla individuazione della efficacia e degli ambiti di applicazione dei nuovi strumenti di segnalazione e protezione.
All’interno di un quadro armonico di collegamenti e richiami, la polifonia dei saggi consente, infatti, di avvicinarsi alla complessa materia individuandone con sicuro affidamento la ratio ispiratrice che ne è alla base, i contenuti, spesso problematici, le finalità e, soprattutto, le interrelazioni rispetto a discipline ed aree operative contigue, offrendo interessanti analisi ricostruttive e motivate opzioni esegetiche.
2. Il Commentario è articolato in quattro parti ed affronta in modo completo e dettagliato i diversi profili normativi, operativi e sanzionatori della complessa materia di recente normata dal legislatore in conformità alle indicazioni provenienti dalla sede eurounitaria, esaminando le implicazioni sottese ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, sia di elaborazione sovranazionale che interna.
Nella prima parte del commentario si esamina l’ambito di applicazione del decreto sotto il profilo oggettivo, distinguendo il settore pubblico e quello privato, per poi approfondire le varie categorie di soggetti tutelati, tra cui dipendenti pubblici, lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti, fornitori e altre figure coinvolte nel processo di segnalazione, sia nel comparto pubblico che in quello privato.
Nella seconda parte vengono analizzati i diversi canali di segnalazione, interni ed esterni, la loro gestione, la divulgazione pubblica, i canali europei di segnalazione e la denuncia alle autorità competenti (Autorità giudiziaria ordinaria e Procura della Corte dei Conti) come una delle modalità di comunicazione delle informazioni. Particolare attenzione viene dedicata al ruolo dell’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione), organismo chiave, anche per le sue caratteristiche di indipedenza e autonomia, nella gestione delle segnalazioni esterne e nella tutela della riservatezza del segnalante, ponendone in evidenza le recenti linee guida sui canali interni di segnalazione e in materia di protezione del whistleblower.
Nella terza parte vengono esaminati i profili della governance interna all’ente pubblico e degli obblighi di compliance per enti pubblici e privati (con riferimento ai modelli organizzativi, al codice etico e alla procedura per le segnalazioni interne), attribuendo particolare risalto al funzionamento dei canali di segnalazione, al ruolo degli organi di controllo ed alla cooperazione tra autorità amministrative e giudiziarie.
Nella quarta ed ultima parte, infine, viene esplorato lo statuto di protezione del segnalante, con particolare riferimento al divieto di misure ritorsive e alle correlate misure di protezione, alle limitazioni di responsabilità, al regime sanzionatorio contemplato per le condotte illecite volte ad ostacolare le segnalazioni, nonché all’analisi delle cause di esclusione della protezione del whistleblower.
Il testo normativo è stato capillarmente inquadrato sotto la lente di una serrata ed argomentata analisi critica, la cui esposizione è opportunamente corredata da un costante, quanto puntuale, raffronto con le pertinenti disposizioni di riferimento della Direttiva 2019/1937, senza rinunciare alla prospettazione di motivate opzioni esegetiche o di eventuali modifiche del testo normativo alla luce delle numerose difficoltà applicative rilevate fra le pieghe dell’impianto normativo.
La rilevanza delle riflessioni svolte dagli Autori in ordine alle diverse sfaccettature di un assetto regolativo dagli effetti potenzialmente dirompenti rispetto alle resistenze sotterranee e alle invisibili incrostazioni che, nelle pubbliche amministrazioni o negli enti privati interessati, minano il raggiungimento degli obiettivi di efficienza, correttezza e trasparenza di gestione, emerge già solo dal fatto che il legislatore non ha ritenuto di circoscrivere la facoltà di segnalazione alle sole violazioni del diritto dell’Unione in determinati settori, contemplando invece la possibilità di estendere la segnalazione anche alle violazioni del diritto nazionale.
La Direttiva europea, infatti, oltre a prevedere l’estensione del potere di effettuare segnalazioni a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti (art. 4), ha delineato (art. 2) un’oggettiva estensione del whistleblowing alle questioni concernenti la violazioni del diritto dell’Unione relativamente a determinati settori, espressamente stabilendo che ciò non pregiudica il potere degli Stati membri di ampliare la protezione prevista dal diritto nazionale relativamente a settori o atti da essa non contemplati.
La recente disciplina è stata dal legislatore concepita quale utile strumento di prevenzione della formazione di accordi corruttivi tra il settore pubblico e quello privato, inserendosi in un quadro normativo già sensibilmente innovato dall’entrata in vigore della legge 6 novembre 2012, n. 190, primo intervento legislativo organicamente orientato verso la creazione di un sistema integrato di strumenti, sia repressivi che preventivi, idonei a rimuovere le condizioni genetiche del complesso fenomeno della corruzione, creando moduli organizzativi in grado non solo di scoraggiare la stipula di intese corruttive e tutelare, al contempo, coloro che si impegnino a denunciare o segnalare episodi lato sensu corruttivi, ma anche di consentire l’emersione di tali comportamenti.
Fra le tante misure innovative introdotte dal legislatore basti solo richiamare, al riguardo, il divieto di pantouflage, precedentemente previsto dal disposto di cui all’art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165 del 2001, al fine di prevenire e contenere il rischio di situazioni di conflitto di interesse collegate sia all’assunzione di cariche da parte di ex dipendenti pubblici, sia allo svolgimento di determinate attività lavorative presso l’ente privato, nel successivo triennio dalla cessazione del rapporto di lavoro tra i primi e la pubblica amministrazione.
Entro tale prospettiva diacronica, il nuovo strumento del c.d. whistleblowing, di derivazione prettamente eurounitaria, mira ad introdurre più adeguate ed effettive forme di protezione in favore di chi segnala fatti pregiudizievoli di cui sia venuto a conoscenza in ambito lavorativo: un istituto la cui introduzione è ritenuta utile nella prevenzione sia della corruzione e della mala gestio nel settore pubblico, sia della patologia delle cointeressenze emergenti nei rapporti tra il settore privato e quello pubblico. Le informazioni fornite dal segnalante, infatti, possono contribuire alla genesi di un’indagine penale, dando luogo all’accertamento e al perseguimento di fatti corruttivi o para-corruttivi, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni pubbliche.
Si instilla, in tal modo, un elemento di incertezza nel quadro delle relazioni fra i soggetti contraenti, poiché essi sono consapevoli di poter essere segnalati o denunciati all’autorità competente da soggetti in un primo momento “non individuati”. Il disvelamento di informazioni rilevanti avviene in tal caso da parte di un insider, che porta alla luce notizie altrimenti di difficile emersione.
Entro tale prospettiva, è evidente che una nuova possibilità di tutela della necessaria trasparenza nella gestione della cosa pubblica si affianca all’ulteriore strumento già previsto dal legislatore nell’art. 323-ter c.p., ossia alla causa speciale di non punibilità sopravvenuta, che rompe il vincolo di solidarietà e di omertà tra il corrotto e il corruttore, qualora una parte del pactum sceleris decida di denunciare la controparte.
Vi è, dunque, uno stretto legame fra l’illegalità nell’azione delle organizzazioni complesse, la prevenzione della corruzione e la nuova disciplina delle segnalazioni: un legame che può essere efficacemente compreso ed approfondito proprio alla luce della nuova disciplina del c.d. whistleblowing (su tali aspetti v., di recente, l’ampia analisi ricostruttiva di M. Poggi D’Angelo, La nuova disciplina del whistleblowing come strumento di prevenzione della corruzione, in Cass. pen., 2025, p.1754 ss.).
3. Come è noto, suole definirsi con il termine “whistleblower” “colui che soffia il fischietto”, ossia una persona che segnala violazioni di normative nazionali o europee che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della P.A. o di un ente privato, di cui sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
La genesi dell’istituto vien fatta risalire, storicamente, alla prima affermazione di un meccanismo di incentivo per i “denuncianti” negli Stati Uniti d’America, all’epoca del “False Claims Act” emanato dal Presidente Abraham Lincoln nel 1863, che prevedeva una ricompensa per coloro che denunciavano frodi ai danni del governo federale.
La legge venne in seguito modificata dall’introduzione della legge federale “Whistleblower Protection Act” del 1989, che proteggeva da ritorsioni i dipendenti pubblici federali che lavoravano per il governo e segnalavano l’eventuale esistenza di un’attività in violazione della legge, delle norme o dei regolamenti, o comunque una cattiva gestione, un grave spreco di fondi, un abuso di autorità o un pericolo sostanziale e specifico per la salute e la sicurezza pubblica.
Nel 2002 il Sarbanes Oxley Act (SOX) estese la protezione alle segnalazioni fatte dai dipendenti delle società quotate in borsa, mentre nel 2010 il Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act introdusse un meccanismo di garanzia per gli informatori che presentavano denunce anonime e riservate, con la possibilità, per i segnalanti che riuscivano a far concludere positivamente un procedimento con sanzioni pecuniarie superiori alla quota di un milione di dollari, di ottenere una ricompensa obbligatoria compresa tra il 10% e il 30% dei proventi raccolti.
Nel panorama europeo va menzionata la Convenzione civile sulla corruzione del Consiglio d’Europa, firmata a Strasburgo nel 1999, che impone, con la previsione dell’art. 9, l’introduzione da parte di ciascuno Stato membro di un’adeguata tutela in favore dei dipendenti che denuncino in buona fede alle autorità competenti fatti di corruzione di cui abbiano giusti motivi di sospetto.
Un modello normativo, questo, seguito ed ulteriormente ampliato dalla Convenzione ONU contro la corruzione firmata a Merida nel 2003, che nella disposizione pattizia prevista dall’art. 33 sollecita gli Stati parte a predisporre un sistema di protezione delle persone che comunicano informazioni, enucleando in tal modo una raccomandazione onnicomprensiva, potenzialmente applicabile anche al di fuori del contesto lavorativo.
Nel sistema eurounitario, in particolare, per regolamentare il fenomeno è stata adottata la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, emanata con l’obiettivo di rafforzare l’applicazione del diritto e delle politiche dell’Unione in specifici settori, stabilendo norme minime comuni volte a garantire un elevato livello di protezione in favore delle persone che, avendo acquisito informazioni, segnalano, nel settore privato o pubblico, violazioni del diritto dell’Unione in un contesto lavorativo.
4. Nell’ordinamento italiano la prima, embrionale, forma di regolamentazione dell’istituto si è avuta con la c.d. legge anticorruzione del 6 novembre 2012, n. 190, che ha introdotto la disposizione di cui all’art. 54-bis nel Testo unico sul pubblico impiego (d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165), prevedendo forme di tutela valide soltanto per «il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro».
Al riguardo era stata prevista la tutela della identità del denunciante, che, fatta salva la necessità di garantire l’esercizio dell’altrui diritto di difesa in ambito disciplinare, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia». Una forma di protezione, questa, operante esclusivamente «fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.».
In seguito, con il d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (recante Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), convertito dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, l’ANAC è stata individuata quale soggetto destinatario delle segnalazioni.
Le linee portanti di tale iniziale disciplina di tutela sono state poi estese al settore privato – sia pure parzialmente – dalla l. 30 novembre 2017, n. 179, recante disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.
Con riguardo al settore pubblico, in particolare, la richiamata disposizione di cui all’art. 54-bis è stata modificata, da un lato rafforzando la tutela della condotta di rivelazione attraverso una serie di sanzioni amministrative irrogabili dall’ANAC, dall’altro lato ampliandone l’ambito di operatività al personale degli enti pubblici economici, di quelli di diritto privato sotto controllo pubblico, delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica, valorizzando il riferimento alle denunce sporte «nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione».
Nel settore privato, con la modifica dell’art. 6 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (ad opera dell’art. 2 l. n. 179 del 2017) la tutela, concernente le condotte illecite rilevanti ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa da reato ai sensi degli artt. 24 ss. del citato d.lgs., ovvero le violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, è stata assicurata solo in via mediata e con esclusivo riguardo agli enti dotati di modelli organizzativi, imponendosi l’istituzione di canali di segnalazione interna e forme di protezione e non discriminazione dei dipendenti segnalanti.
La possibilità di tutela è stata successivamente assicurata anche in favore delle lavoratrici e dei lavoratori che denunciano molestie, anche di carattere sessuale, dall’art. 1, comma 218, della l. 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018), che ha introdotto un nuovo comma 3-bis nell’art. 26 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna (d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198).
Con l’art. 3 della l. n. 179 del 2017 si è inoltre previsto che, nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di cui all'art. 54-bis d.lgs. n.165 del 2001 e all'art. 6 d.lgs. n. 231 del 2001, «il perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all'articolo 2105 del codice civile».
Una nuova causa di giustificazione, dunque, la cui rilevanza è stata tuttavia esclusa con riguardo a chi sia «venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata», prevedendo al contempo (art. 3, comma 2, l. n. 179 del 2017) la permanenza della responsabilità per violazione del segreto aziendale, professionale o d'ufficio nell’ipotesi di «rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine».
5. Nelle limitate occasioni in cui la Corte di cassazione ha avuto modo di pronunciarsi riguardo alla utilizzabilità processuale delle segnalazioni, si è precisato che, ai fini della valutazione dei gravi indizi di reato nella autorizzazione delle intercettazioni, la segnalazione proveniente dal "whistleblower" è utilizzabile in quanto l'identità del denunciate è nota, pur essendo coperta da riserbo al fine di tutelare il pubblico dipendente che segnali condotte illecite, sicché non si incorre nel divieto di utilizzazione delle fonti anonime previsto dall'art. 333, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 9041 del 31/01/2018, Gagliardi, Rv. 272387).
In tema di misure cautelari personali, inoltre, la Corte di legittimità ha precisato che la segnalazione proveniente dal "whistleblower" non costituisce un mero spunto investigativo, ma ha natura di dichiarazione accusatoria proveniente da un soggetto la cui identità, pur essendo riservata, è nota; il contenuto di detta dichiarazione, pertanto, può integrare i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione della misura, unitamente agli ulteriori riscontri acquisiti (Sez. 6, n. 9047 del 31/01/2018, C., Rv. 272484).
In altra decisione la Corte, negando l’operatività della scriminante dell’adempimento del dovere invocata dal ricorrente per il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico, ha affermato che la ratio della previsione era, da un lato, quella di delineare un particolare status giuslavoristico in favore del segnalatore d’illeciti, d’altro lato, di favorirne l’emersione dall’interno delle organizzazioni pubbliche, così promuovendosi forme più incisive di contrasto alla corruzione, ma al contempo radicalmente escludendosi che essa potesse fondare «alcun obbligo di attiva acquisizione di informazioni, autorizzando improprie attività investigative, in violazione dei limiti posti dalla legge (Sez. 5, n. 35792 del 21/05/2018).
6. La novella legislativa del 2023 raduna all’interno di un unico testo normativo la disciplina relativa alla tutela della persona segnalante, abrogando le disposizioni vigenti sia nel settore pubblico che in quello privato, e richiedendo, al contempo, sia alle pubbliche amministrazioni che alle società private (che hanno impiegato nell’ultimo anno almeno 50 lavoratori subordinati ovvero hanno adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo, anche se non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori nell’ultimo anno), la predisposizione di un sistema di ricevimento e gestione delle segnalazioni relativo alle violazioni del diritto interno e di quello eurounitario.
Un ambito di applicazione oggettivo, dunque, dalla portata assai più ampia rispetto al passato, prevedendosi la possibilità di segnalare condotte, atti od omissioni consistenti in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti; illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali (indicati nell’allegato al d.lgs. n. 24 del 2023 (relativi a settori di centrale rilevanza come gli appalti pubblici, i servizi, i prodotti e mercati finanziari, la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, la sicurezza e conformità dei prodotti, la sicurezza dei trasporti, la tutela dell’ambiente ecc.).
Parimenti estesa risulta la platea soggettiva dell’applicazione, coinvolgendo non solo i dipendenti delle amministrazioni pubbliche o delle autorità amministrative di garanzia, vigilanza o regolazione, ma anche i dipendenti degli enti pubblici economici e delle società in house, i lavoratori subordinati del settore privato, gli autonomi, i lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività presso soggetti del settore pubblico o privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi, i liberi professionisti e consulenti, ecc.
Molteplici risultano i canali di segnalazione, sia interni che esterni, in forma scritta - anche con modalità informatiche - oppure in forma orale: oltre al canale interno preferibilmente attivabile dai soggetti del settore pubblico e di quello privato (nella prassi coincidente con una piattaforma informatica), è possibile rivolgersi all’esterno, attraverso l’invio della segnalazione all’ANAC ovvero mediante divulgazione pubblica (tramite stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone). Ciò non esclude, peraltro, la possibilità per il segnalante di adire direttamente l’autorità giudiziaria o contabile con una formale denuncia.
Il legislatore ha previsto due presidi protettivi, sia nel momento della segnalazione, in cui deve essere garantita la riservatezza del segnalante (e delle persone a lui collegate), sia in quello successivo, in cui può essere necessario proteggerlo da eventuali ritorsioni connesse alla rivelazione delle informazioni.
Con riguardo alla prima fase temporale, il canale di segnalazione interno deve garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e delle persone coinvolte e menzionate nella segnalazione anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia: l’obbligo di riservatezza prevede, in particolare, che l’identità del segnalante non possa essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.
A seguito della trasmissione dell’informazione sono stati previsti il divieto e la sanzione di ogni forma di ritorsione o di discriminazione diretta o indiretta, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione o denuncia, nei confronti della persona segnalante o della persona che l’ha sporta. Per quel che attiene alla nozione di “ritorsione”, la legislazione interna (art. 2, comma 1, lett. m), d.lgs. n. 24/2023) e quella eurounitaria (art. 5, comma 1, n. 11 Direttiva 2019/1937) vi ricomprendono qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica, che provoca o può provocare al segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato (ad es., note di merito negative, demansionamento, licenziamento ecc.).
Competente ad accertare l’esistenza di eventuali ritorsioni e ad applicare le relative sanzioni amministrative pecuniarie è esclusivamente l’ANAC, cui è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione.
Il legislatore, dunque, conferma l’individuazione dell’ANAC quale principale soggetto destinatario, o comunque come organo terminale, delle relative segnalazioni, espressamente delegando a tale ente il compito di adottare linee guida relative alle procedure per la loro presentazione e gestione.
È, inoltre, previsto che il whistleblower non sia punibile, in caso di violazione del segreto, in relazione ai reati di rivelazione di segreto d’ufficio (art. 326 c.p.), di segreto professionale (art. 622 c.p.), di segreto scientifico o industriale (art. 623 c.p.), dell’obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.), delle disposizioni relative alla tutela del diritto d’autore o alla protezione dei dati personali, nonché nell’ipotesi in cui la stessa persona riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.
Viene dunque ribadita, in termini più ampi rispetto a quelli contenuti nella previgente disciplina, una generale causa di non punibilità e di esclusione della responsabilità, anche civile o amministrativa, per chi «riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall’obbligo di segreto, diverso da quello di cui all’art. 1, comma 3» - concernente le informazioni classificate, il segreto professionale forense o medico, la segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali - «o relative alla tutela del diritto d’autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento delle rivelazioni o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata ai sensi dell’art. 16» (art. 20, comma 1, d.lgs. n. 24/2023).
7. Un’esimente, questa, la cui natura viene ritenuta sostanzialmente analoga alla causa di giustificazione dell’esercizio del diritto (sul tema v., di recente, le riflessioni di G. F. REYNAUD, Il rafforzamento della tutela del whistleblowing nella giurisprudenza della Corte Edu e nella legislazione domestica, in Cass. pen., 2023, p. 4254 ss.), ove il riferimento alla “necessità” della rivelazione sembra rinviare ad un giudizio di contemperamento degli opposti interessi, con il conseguente obbligo di interpretazione conforme da parte del giudice nazionale.
Alcuni profili problematici, al riguardo, sembrano affiorare dalla successiva previsione contenuta nell’art. 20, comma 3, d.lgs. n. 24 del 2023, a mente del quale «salvo che il fatto costituisca reato, l’ente o la persona di cui all’art. 3 non incorre in alcuna forma di responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l’acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l’accesso alle stesse».
Una specifica causa di giustificazione, dunque, riconducibile al genus dell’esercizio del diritto, che, pur apparendo compatibile con l’art. 21, par. 3, della citata Direttiva, non sembra porsi in linea con la recente evoluzione della giurisprudenza convenzionale (Corte EDU, 14 febbraio 2023, Halet c. Lussemburgo, n. 21884/18, in Cass. pen., 2023, p. 4248, con nota di G.F. REYNAUD, cit., p. 4249 ss.), che ha di fatto ritenuto coperta dalla causa di giustificazione riconosciuta al whistleblower in forza dell’art. 10 CEDU anche le condotte - per la quale il ricorrente, nel caso ora richiamato, era stato penalmente sanzionato dall’autorità giudiziaria penale lussemburghese - di accesso fraudolento al sistema informatico aziendale, furto e (auto)riciclaggio dei documenti aziendali poi divulgati.
Con la richiamata decisione, infatti, la Corte di Strasburgo ha ritenuto la violazione dell’art. 10 CEDU nel caso di una condanna penale ad una sanzione pecuniaria irrogata al dipendente di una società privata, per aver consegnato ad un giornalista alcuni documenti aziendali riservati, di cui si era illecitamente appropriato, relativi a pratiche fiscali di note imprese multinazionali, poi divulgati nell’ambito di un’inchiesta giornalistica relativa a regimi fiscali favorevoli praticati per società multinazionali aventi sede in Lussemburgo (c.d. caso LuxLeaks).
Nell’atto di accedere ai sistemi informatici aziendali, il ricorrente si era illecitamente appropriato di documenti riservati relativi a pratiche fiscali di note imprese multinazionali trattate dalla società di cui egli era dipendente e li aveva quindi consegnati ad un giornalista che svolgeva un’inchiesta sulla concessione di regimi fiscali favorevoli riservata a grandi imprese multinazionali aventi sede in Lussemburgo. Questa inchiesta, nel cui ambito il giornalista aveva divulgato e reso pubblici i documenti, ebbe poi grande rilievo mediatico.
Nel valutare la richiesta di esclusione della responsabilità penale del ricorrente per l’esercizio della libertà di espressione tutelata dalla CEDU, con particolare riguardo alla giurisprudenza convenzionale formatasi in relazione alle rivelazioni dei whistleblowers, i giudici nazionali ne avevano negato l’applicabilità, rilevando che i pochi documenti di cui egli si era illecitamente appropriato e che aveva consegnato alla stampa – selezionati soltanto sulla base della notorietà delle multinazionali cui si riferivano – non avevano apportato una “informazione essenziale, nuova e sconosciuta” al dibattito pubblico in corso, cosicché il pregiudizio arrecato al datore di lavoro doveva essere ritenuto prevalente rispetto all’interesse generale alla divulgazione.
La Grande Camera della Corte EDU ha ribadito i criteri delineati nella propria giurisprudenza sulla tutela convenzionale della libertà di espressione riconosciuta ai whistleblowers rispetto alla divulgazione di notizie riservate apprese dai dipendenti, pubblici o privati, nel luogo di lavoro.
Applicando tali criteri interpretativi al caso di specie, la Grande Camera della Corte ha ribaltato, sia pure a maggioranza, la decisione inizialmente assunta da una Sezione semplice, censurando la condanna irrogata a carico del ricorrente e imputando ai giudici nazionali di avere elaborato un’interpretazione troppo restrittiva dell’interesse pubblico connesso alla divulgazione delle informazioni in esame, senza neanche valutare, peraltro, l’insieme delle conseguenze dannose.
Nel rinnovato giudizio di bilanciamento degli opposti beni-interessi in gioco, operato direttamente dalla Corte di Strasburgo, i giudici hanno concluso nel senso della prevalenza dell’interesse generale alla conoscenza delle informazioni divulgate dal ricorrente, sottolineandone il contributo essenziale al dibattito pubblico, su scala nazionale ed europea, circa le pratiche fiscali delle multinazionali.
La decisione dell’autorità giudiziaria lussemburghese, inoltre, è stata censurata per non aver tenuto conto della gravità del cumulo tra le sanzioni nella specie inflitte (il licenziamento e la condanna penale) e del loro effetto deterrente rispetto alla libertà di espressione del ricorrente o degli altri whistleblowers.
8. Anche sotto tale rilevante profilo problematico, dunque, come per taluni aspetti non sufficientemente chiari della nuova disciplina che il Commentario puntualmente pone in luce, il decisivo banco di prova sarà rappresentato dalla sua concreta verifica nella sede giurisprudenziale, dove le forme e le prassi operative del nuovo istituto saranno vagliate e perimetrate nella loro effettiva consistenza e idoneità applicativa, formando oggetto di una interpretazione conforme al sistema eurounitario e, al contempo, convenzionalmente orientata, tenendo conto anche dei principi stabiliti dalla elaborazione giurisprudenziale della Corte EDU.
Nel riconoscere i significativi progressi compiuti dalla vigente disciplina rispetto ai precedenti interventi normativi, il Commentario pone in evidenza alcune criticità emergenti dalla complessa trama disegnata dal legislatore, aggravate, peraltro, dal fatto che la elaborazione giurisprudenziale finora sedimentatasi ha riguardato l’assetto in precedenza regolato dalla l. n. 179 del 2017.
Uno di tali aspetti viene significativamente rilevato con riguardo alla previsione di cui all’art. 1, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 24 del 2023, là dove sottrae all’applicazione del decreto quelle segnalazioni rientranti nell’ambito di applicazione di altra normativa, europea o nazionale, che settorialmente disponga in tema di protezione del whistleblower, sebbene il legislatore europeo (Considerando 20 della Direttiva) richieda una integrazione della normativa di settore con gli elementi ricavabili dallo standard minimo previsto dallo strumento eurounitario di diritto derivato.
Altro profilo problematico investe il fatto, rilevato anche nelle Linee guida elaborate dall’ANAC nel 2023, che se il canale di segnalazione non è istituito perché l’ente non vi è obbligato, il segnalante non è considerato un whistleblower e di conseguenza non può trasmettere segnalazioni all’ANAC.
Nella Premessa del Commentario, inoltre, i Curatori opportunamente suggeriscono la possibilità di una correzione da parte del legislatore con riferimento al sistema delle segnalazioni esterne, là dove, nel silenzio del decreto legislativo, l’ANAC sembra interpretare tendenzialmente in via restrittiva la propria competenza a gestire le segnalazioni tramite i canali esterni che ha istituito, senza valorizzare appieno le prospettive di efficace prevenzione delle illegalità ricavabili dal disposto normativo (art. 2, comma 1) che la individua come l’unica autorità amministrativa interna autorizzata a ricevere segnalazioni esterne di whistleblowing.
Di grande rilievo, infine, appaiono le esigenze, pur esse ampiamente argomentate dai Curatori, di una più ampia opera di armonizzazione a livello europeo degli standard di efficacia, dissuasività e proporzionalità del sistema sanzionatorio adottato in ciascuno dei ventisette ordinamenti nazionali, e, soprattutto, di una diffusa attività di formazione costantemente orientata sia sugli operatori giuridici interni (in particolare magistrati, avvocati e funzionari) che sull’intero contesto della società civile, in una duplice prospettiva, di sostegno professionale e culturale, senza la quale ben difficilmente il senso complessivo della rilevante riforma legislativa potrà vivere ed affermarsi nella coscienza collettiva della comunità sociale.

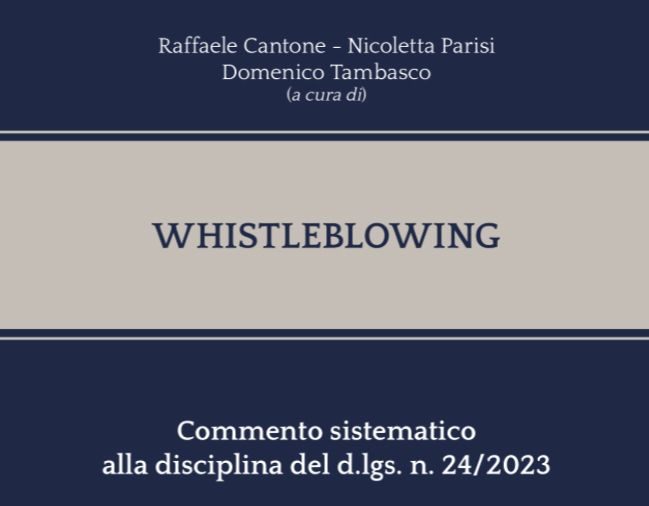

 And then Add to Home Screen.
And then Add to Home Screen.