Attorno a questo corpo dalle mille paludi.
Introduzione al V Convegno di Giustizia insieme, Roma 6 giugno 2025
Il corpo umano ha da sempre rappresentato un mistero.
Le radici più antiche del pensiero occidentale ne hanno tramandato la considerazione alternata tra il platonico carcere dell’anima e la singolare e indissolubile combinazione aristotelica di materia e forma.
Un’ambivalenza che la prima cristianità ha saputo tradurre, a partire dal mistero dell’incarnazione divina, in modelli teologici esemplari e in raffinati sistemi morali.
A questa costitutiva ambivalenza ontologica del corpo umano il pensiero scientifico moderno ha ritenuto di potersi sottrarre sollecitando una visione del corpo dominata dall’esclusiva considerazione dei suoi elementi quantitativi (o artificialmente quantificabili), e relegandone ogni dimensione qualitativa (la mente, il pensiero, l’anima o lo spirito) al dominio della metafisica o della religione.
Proprio in questo contesto del pensiero moderno, con riguardo alla considerazione del corpo, il diritto ha smarrito la sua strada: perdutamente distratto, negligente o disinteressato, ha presupposto il Soggetto (di ascendenza cartesiana) come datità trascendentale, ne ha arredato il mondo con il caleidoscopio dei beni scambiabili o producibili, e ha abbandonato la sorte del corpo agli arbìtri dei giovani Stati sovrani, ai disegni manipolatori della loro biopolitica, e alla disciplina morale delle chiese.
Nella misura in cui il contenuto dei codici borghesi andava costruendo il governo delle società moderne attorno alla regolazione dell’autonomia del Soggetto nella gestione economica del suo patrimonio, il corpo scompariva da ogni orizzonte della giuridicità civile, per ricomparire, ora brutalizzato, torturato, più spesso rinchiuso, tra gli arnesi punitivi del potere pubblico, quelli correttivi dei sanatori o delle istituzioni manicomiali, quando non mortificato dalle severe censure morali delle autorità religiose.
Quando finalmente riapparve in un testo normativo ufficiale (fuori dai misteriosi regolamenti o dalle nascoste circolari del potere), il codice civile italiano del 1942 guardò al corpo (o più propriamente, alle sue parti) al solo fine di regolarne la disponibilità da parte del suo ‘titolare’; una disponibilità riconosciuta e consentita nei rigorosi limiti della sua pur sempre preservata integrità, a beneficio degli interessi della collettività o della Nazione, secondo i toni consueti della stanca retorica del tempo.
Il corpo come mero oggetto, dunque, affidato alle mani del suo ‘padrone’ spirituale, in coerenza ai canoni classici della tradizione idealistica.
Ma sono, quelli, gli anni in cui la riduzione del corpo a mero oggetto veniva rivelando il suo risvolto più oscuro e terrificante, attraverso il racconto del corpo (o, meglio, dei corpi) orrendamente ritratti dalla pagina di Primo Levi.
È, dunque, un uomo quello il cui corpo diventa programmaticamente la ‘cosa’ voluta dagli altri? L’oggetto che (in contrasto con ogni imperativo di ascendenza kantiana) è destinato a fornire il mezzo per la realizzazione d’interessi altrui?
Sono queste le premesse storico-culturali che, dalla metà del secolo scorso, hanno ispirato e animato l’elaborazione delle carte giuridiche di respiro internazionale per cui al singolo è restituito (o, forse, realmente consegnato per la prima volta nella storia) l’esercizio di una piena sovranità su se stesso: il principio del consenso informato della persona per ogni azione che ambisca a toccarne il corpo; la considerazione della salute, non più come assenza di patologie funzionali di una quantità materiale, ma come completo stato di benessere fisico, psicologico e sociale.
Se, dunque, corpo e mente non appaiono ormai più districabili agli occhi del più avvertito pensiero scientifico contemporaneo, neppure al diritto (come all’orizzonte della cultura contemporanea) è più consentito guardare al corpo come a qualcosa di dissociabile dalla ‘persona’ in cui consiste: la conferma, l’ennesima, dell’insufficienza o della banalità della frusta distinzione categoriale di un mondo arredato di soli soggetti e oggetti tra loro ontologicamente contrapposti.
Eppure, il racconto del mondo contemporaneo ci ammonisce che la considerazione del corpo alla stregua di una cosa, la sua oggettivazione; lo sforzo di ridurlo a pura quantità biologica; il recupero di una sua pretesa natura meramente strumentale, costituiscono i tratti di una tentazione permanente, o quantomeno ricorrente, nella storia dell’uomo; il segno, quasi, della fatale attrazione a cui conducono i sotterranei percorsi della volontà di potenza; ora travestita degli interessi della politica, talora dei panni della tecnica, più spesso della cupa avidità del denaro, fino a precipitare nel travestimento abissale dell’istintualità ferina.
È, in definitiva, il ‘potere’ (nelle multiformità delle sue manifestazioni) il vero antagonista, foucaultianamente, della libertà del corpo; la minaccia che insidia senza tregua i progetti della persona e gli spazi della sua fioritura.
Sullo sfondo di queste considerazioni, il convegno che oggi si presenta ambisce a sollecitare una comune riflessione sullo stato attuale del corpo alla luce degli assetti dei poteri contemporanei.
Si tratta di tornare a guardare i contesti o le situazioni della vita individuale o collettiva all’interno dei quali la vita del corpo rinnova il suo confronto con le criticità più antiche, o si avvia all’incontro con quelle proprie del tempo nuovo, secondo una dialettica che guarda, da un lato, all’esercizio delle libertà della persona e delle sue prerogative di liberazione e, dall’altro, alle forme della coercizione, della sua istituzionalizzazione e dei sistemi che la gestiscono.
Da qui l’interrogativo sui poteri che minacciano la condizione del corpo sofferente, segnato dal dolore fisico o dai tormenti del disagio psicologico; sui limiti entro i quali le esigenze morali o il sentimento religioso della collettività o le ambizioni del pensiero scientifico valgano ancora a giustificare l’imposizione, contro ogni volontà o convinzione personale, di trattamenti o cure non accettate né sollecitate da chi sperimenta direttamente, sulla propria persona, l’esperienza del dolore.
E ancora, gli interrogativi sulla condizione del corpo della donna o di quello, in formazione, del minore, sulla consistenza delle esigenze, nuove o antiche, che quei corpi continuamente esprimono e sulle forme in cui si manifesta la violenza delle culture, delle ideologie e delle forme di sfruttamento o di soggezione che ancora quei corpi opprimono o si propongono di farlo.
Sul piano della coercizione agìta in chiave istituzionale (o latamente politica), la riflessione che intende sollecitarsi vorrebbe fermarsi sui limiti entro i quali la detenzione all’interno delle istituzioni carcerarie, l’imprigionamento o il trattamento generale delle popolazioni civili nei contesti bellici, e ancora la gestione politica dei fenomeni migratori (sul cui ‘contrasto’ sin troppo disinvoltamente appaiono costruiti percorsi e programmi strumentali di natura politica) possano considerarsi ancora compatibili con quel ‘senso di umanità’, che pure l’art. 27 della Costituzione italiana richiama come limite (non solo negativo) dei trattamenti sanzionatori interni, e che, riferito all’esperienza della guerra, conferisce almeno uno dei significati del suo ‘ripudio’ come strumento di offesa alla libertà dei popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali (art. 11 della Costituzione).
Il desolante racconto della cronaca dei giorni presenti richiama la nostra attenzione sul dovere della ‘sacralità’ e, dunque, sul dovere di avvertire il senso del limite che la barriera del corpo pur sempre esprime sul piano simbolico, a fronte delle troppe stragi che tornano a raffigurare masse di corpi straziati, trasformati (ora in chiave offensiva, talora in chiave difensiva) alla stregua di strumenti umani nelle mani di un odio che appare inestinguibile.
Se una responsabilità è oggettivamente imputabile all’essere umano, questa è senz’altro la negligente dissipazione delle proprie memorie storiche e culturali; se ancora non è distinguibile un senso del mondo a venire - la pronuncia della parola profetica - è tuttavia senz’altro doveroso il discernimento di ciò che, per comune e generalizzata nozione, ha reso la memoria materia di giustizia; che ha scolpito sulla carne dei nostri corpi ciò “che non siamo, ciò che non vogliamo”.
Attorno a questo corpo dalle mille paludi è il titolo che abbiamo scelto per il nostro Convegno di quest'anno. Si tratta di un prestito da un verso di Amelia Rosselli da Serie ospedaliera, 1969. L'immagine è La danse di Henri Matisse, dipinto nel 1909, esposto al MOMA di New York.
Questo è il programma del Convegno, che si terrà nella Sala Alessandrina presso S.Ivo alla Sapienza, sede dell'Archivio di Stato di Roma, il 6 giugno 2025.
Nel corso della giornata sarà presentato il volume L’amore in gabbia. La ricerca della libertà di un reduce dal carcere di Donatella Stasio (Castelvecchi, 2025).
9.00
Saluti di Antonella Parisi (vicedirettrice Archivio di Stato di Roma)
Introduzione di Paola Filippi (direttrice scientifica di Giustizia Insieme)
Presentazione del restauro e della digitalizzazione di un registro generale della Corte di assise speciale di Roma a cura di Alessandra Terrei (restauratrice)
SESSIONE I
9.25-10.35
IL CORPO DELLA DONNA discussant Marco Dell'Utri (consigliere della Corte di Cassazione)
Marilisa D’Amico (professoressa ordinaria di diritto costituzionale Università di Milano)
Valentina Calderai (professoressa associata di diritto privato Università di Pisa)
10.35-11.45
IL CORPO SOFFERENTE discussant Corrado Caruso (professore ordinario di diritto costituzionale Università di Bologna)
Stefano Canestrari (professore ordinario di diritto penale Università di Bologna)
Paolo Flores D’Arcais (filosofo e giornalista)
11.45-12.55
IL CORPO DEL MINORE discussant Gabriella Luccioli (già presidente di sezione della Corte di Cassazione)
Mirzia Bianca (professoressa ordinaria di diritto civile Università di Roma Sapienza)
Elisabetta Lamarque (professoressa ordinaria di diritto costituzionale Università di Milano Bicocca)
12.55-14 pausa pranzo
SESSIONE II
14-15.10
IL CORPO DETENUTO discussant Donatella Stasio (giornalista)
Susanna Marietti (coordinatrice nazionale Associazione Antigone)
Mario Serio (componente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale)
15.10-16.20
IL CORPO PRIGIONIERO discussant Paola Filippi (sostituta procuratrice generale della Corte di Cassazione)
Emanuela Fronza (professoressa associata di diritto penale Università di Bologna)
Raffaele Piccirillo (sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione)
16.20-17.30
IL CORPO MIGRANTE discussant Sibilla Ottoni (giudice del Tribunale di Tivoli)
Luigi Patronaggio (procuratore generale di Cagliari)
Giovanna Pistorio (professoressa associata di diritto costituzionale Università Roma Tre)
17.30-17.45
Conclusioni di Costantino De Robbio (vicedirettore scientifico di Giustizia Insieme)
La partecipazione è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione.
È prevista la possibilità di partecipare anche da remoto grazie a Radio Radicale.
Il convegno è accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Roma e dà diritto a 8 crediti formativi ordinari.
Per informazioni e iscrizioni:
Comitato scientifico per il convegno: Paola Filippi, Costantino De Robbio, Michela Petrini, Sibilla Ottoni, Riccardo Ionta, Marco Dell'Utri, Angelo Costanzo, Corrado Caruso, Gabriella Luccioli, Giuliano Scarselli.
Comitato organizzatore: Margherita Occhilupo, Michela Petrini, Sibilla Ottoni, Riccardo Ionta, Costantino De Robbio, Paola Filippi, Corrado Caruso.
Immagine: Henri Matisse, La danse, olio su tela, 1909, MOMA, New York.
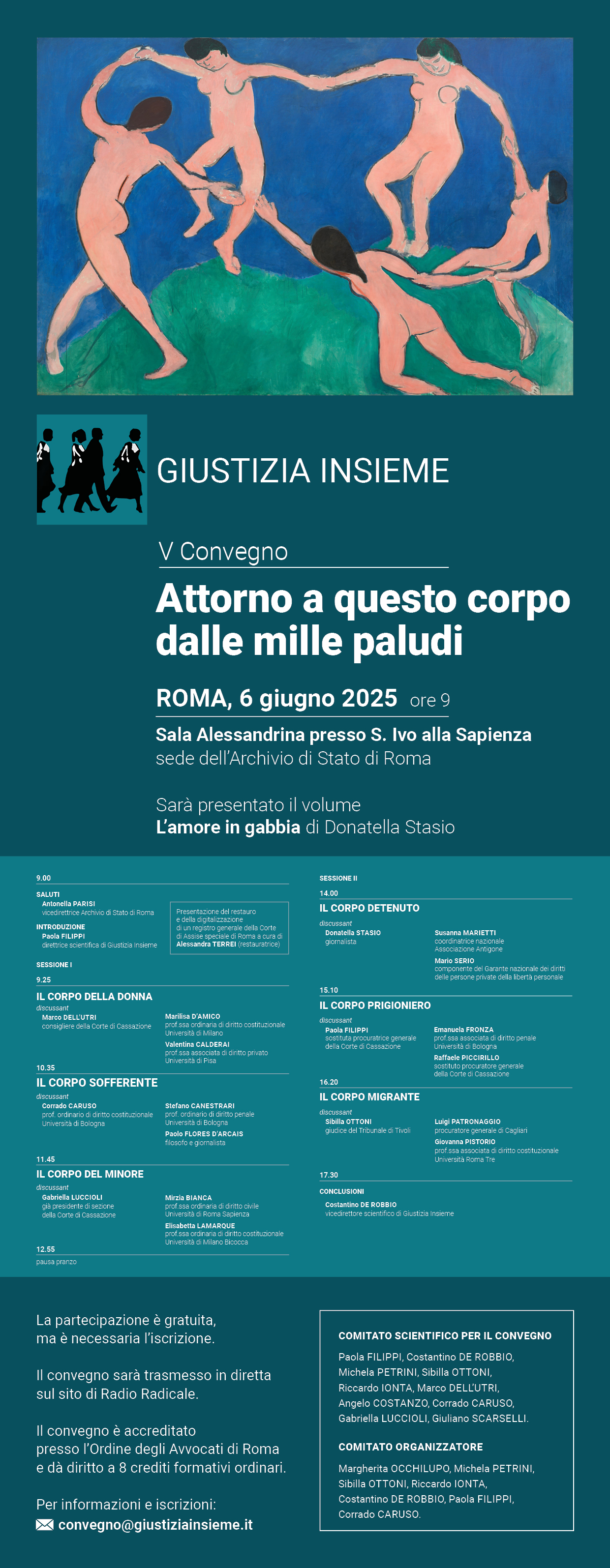



 And then Add to Home Screen.
And then Add to Home Screen.