La lettura del libro di Paola Di Nicola Travaglini è un’esperienza insolita, perché in realtà non si tratta di un libro.
È vero, apparentemente siamo di fronte ad un insieme di fogli stampati, delle stesse dimensioni, rilegati insieme e racchiusi in una copertina (ho preso in prestito la definizione di “libro” di Wikipedia, perdonatemi).
Ma basta leggerne poche righe per avere la sensazione di trovarsi in realtà al cospetto (anzi, all’interno) di una persona, tanta è la immedesimazione dell’autrice in ciò che scrive, e talmente forte la passione con cui ha riversato la sua vita sulla carta.
Nel descrivere cosa vuol dire oggi, nel nostro Paese, essere “una giudice”, l’autrice attinge infatti a piene mani dalla sua esperienza, come è logico; ma non si limita a questo.
Paola Di Nicola Travaglini ci porta infatti nel profondo della sua vita di magistrata, descrivendo le sue giornate di lavoro, la vita in udienza, l’esperienza solitaria della camera di consiglio dei processi trattati come giudice monocratica e la condivisione delle idee nei processi collegiali, il travaglio interiore della decisione e la clausura della scrittura della motivazione e disvela al lettore gli infiniti altri momenti quotidiani che scandiscono il lavoro che ha scelto e che svolge con passione.
Ma nel farlo, con coraggio e trasporto, ci apre anche le porte della sua vita familiare, descrivendo l’atmosfera della sua casa e i suoi abitanti, testimoni, complici e a volte vittime del dipanarsi quotidiano dei mille incombenti della vita di un magistrato, ci descrive gli umori e i caratteri di ognuno di essi, ci fa sentire gli odori della cucina che interrompono e cadenzano le sue giornate lavorative passate in una stanza a scrivere, accompagnandoci dietro le quinte del suo personale vissuto.
Ed anche le giornate in Tribunale sono descritte nello stesso stile vivido e personale: insieme alle riflessioni giuridiche il lettore apprende così delle sue paure, dei momenti di gioia personale e dei rapporti con i cancellieri, gli avvocati e gli imputati dei suoi processi. Non mancano cenni alle necessità corporali che costellano la vita professionale di Paola come quella di tutti, dalla organizzazione del pranzo quando l’udienza si protrae al fastidio di portare i tacchi.
Giunti al termine del suo saggio, i lettori sapranno il nome del compagno e le sue principali caratteristiche, quelli dei figli e della cameriera dell’autrice, nonché degli imputati, dei colleghi e dei cancellieri del suo Tribunale.
Insomma, Paola non ci offre uno spaccato del suo lavoro di giudice ma un ritratto a tutto tondo della sua vita; sorprendente, sincero e proprio per questo estremamente prezioso. Unico come uniche sono le biografie di ciascuno di noi; ma al contempo implicitamente corale perché mira ad essere simbolico.
Si tratta infatti di una scelta consapevole e non di un vezzo stilistico per rendere più appetibile la descrizione di un lavoro a tratti (come tutti i lavori) inevitabilmente noioso in quanto tecnico. Una scelta che ha molto a che fare con il particolare punto di vista che ci offre l’autrice.
Sin dal titolo, è infatti manifesta la volontà di Paola Di Nicola Travaglini di non descrivere la professione di giudice in generale, ma quella di “una” giudice, portando all’attenzione del lettore il tema di cosa vuol dire appartenere all’ordine giudiziario per una donna.
Il libro inanella in un ideale percorso ogni aspetto del procedimento penale, dall’interrogatorio di un indagato detenuto – che rappresenta spesso per un GIP quale lei è stata per tanti anni il primo contatto del giudice con il fascicolo di cui si dovrà occupare – alla fase del dibattimento, sino alla sua conclusione con la lettura del dispositivo e la scrittura della motivazione della sentenza ed infine il deposito che segna il distacco del magistrato dalla sua “creatura”.
Ma lo fa da un punto di vista dichiaratamente partigiano, dal quale non si può prescindere in nessun momento del suo scritto: il punto di vista di chi svolge questo compito come donna, quindi partendo da un retaggio di pregiudizi, fastidio, malcelato senso di superiorità di buona parte dell’altra metà della razza umana, quella maschile.
Si parte con la descrizione di un dato storico che non va mai dimenticato, e cioè che fino ad epoca assai recente le donne non erano ammesse al concorso in magistratura perché ritenute non degne di esercitare la funzione di magistrati, e sono prese in rassegna tutte le attuali forme di discriminazione, spesso involontarie, gli stereotipi, le trappole cognitive ancora oggi ben presenti e radicate a tutti i livelli nei Tribunali e nelle Corti del nostro paese e provenienti da imputati, avvocati, colleghi.
Si tratta di fenomeni e scivolosi e particolari, ci avverte l’autrice: sei convinto che non esistano anche se vivi circondato dagli stessi, ogni giorno. Finché tu (se sei donna) o una persona a te cara (se sei uomo) non ci fate dolorosamente i conti. Allora cominci a riconoscerle. Ma spesso la reazione allora è di dire: c’erano prima, ma ora non ci sono più. Purtroppo, ammonisce Paola dalle pagine della sua vita-saggio, non è così.
È indubitabile che molto sia cambiato, in meglio, negli ultimi decenni, in tutti i settori (qualche giorno fa ho letto su un giornale un articolo su Tina Abselmi in cui si descrivono i gesti di ostilità di cui la grande esponente politica è stata oggetto da parte dei suoi colleghi uomini, che non si rassegnavano al fatto di avere accanto un’onorevole e poi una ministra di sesso femminile: comportamenti tragicamente simili all’atmosfera descritta in molti punti del libro di Paola Di Nicola Travaglini).
Contro tutti questi ragionamenti, non solo le discriminazioni in sé ma anche le minimizzazioni, le autoassoluzioni, gli sviamenti da reazione delle coscienze, punta il dito Paola Di Nicola.
E lo fa coraggiosamente partendo proprio da se stessa e dal lavoro che ha fatto sulla sua coscienza prima per rendersi conto delle trappole e auto-trappole che si era inflitta e poi del percorso per liberarsene.
Parla del rifiuto che incontra ogni donna di essere considerata come istituzione, del rifiuto della parte intellettuale, della sensazione di essere considerata e accettata solo come corpo. E lo fa, paradossalmente, mettendo il suo corpo e la sua persona, tutta intera, al centro della scena.
Perché in fondo è proprio in questo portare in ogni aspetto della sua vita, senza infingimenti e cesure, tutta intera la sua sensibilità e il suo essere che si sostanzia l’essere giudice al femminile.
Il contrasto con il modello maschile, basato tradizionalmente sul processo come “stare in scena”, sulla astrazione del giudice dalle sue pulsioni corporee nell’utopistico tentativo di farsi “bocca della legge” (ed in un passato non molto lontano, di Dio), sulla cancellazione dell’uomo dietro il paramento della toga, non potrebbe essere più evidente.
Il libro porta al lettore un modo diverso, altrettanto ricco e prezioso di quello maschile che siamo abituati a riconoscere come unico modello da millenni, e dopo aver enfatizzato contrasti e stereotipi di genere si conclude con il riconoscimento che negli ultimi anni moltissimo è stato fatto in termini culturali e organizzativi.
Siamo forse pronti, dopo il tempo lunghissimo della negazione e quello, recente, del contrasto e dello svilimento, al tempo della simbiosi e del completamento dei modelli.

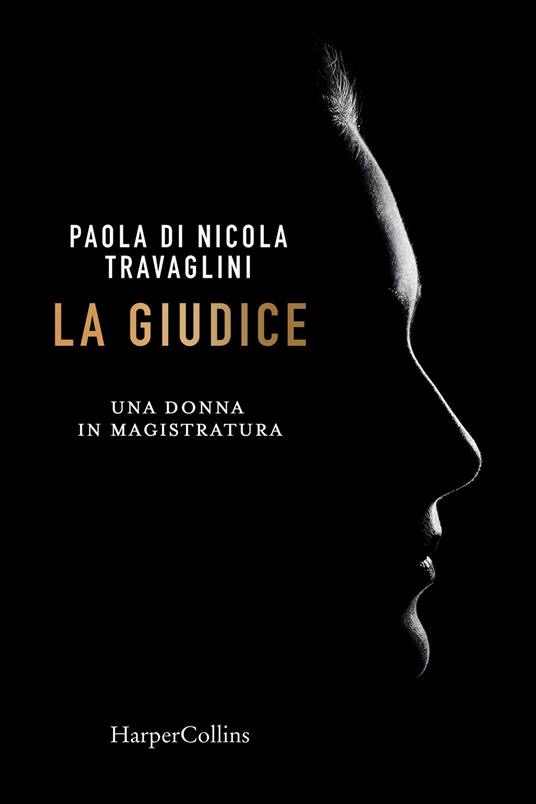

 And then Add to Home Screen.
And then Add to Home Screen.