1. Mentre prosegue indisturbata l’ormai ultra-triennale aggressione russa all’Ucraina e una tregua precaria sopisce il conflitto medio-orientale, una giurista esperta e uno storico della contemporaneità ci regalano un volume che ha lo scopo di fare chiarezza sulla storia, le finalità e la crisi della giustizia penale internazionale.
Caos – La giustizia internazionale sotto attacco (Laterza, 2025) è uno strumento prezioso per chiunque, giurista o laico curioso, intenda farsi un’idea e prendere una posizione consapevole nel dibattito, rovente e talvolta ideologico: sull’utilità della giustizia penale internazionale, sull’appropriata qualificazione dei crimini attribuiti alle parti in conflitto, sul rapporto tra pace e giustizia in quadro che impone di aggiornare l’ormai sessantennale motto di Luther King “No Peace without Justice, No Justice without Peace”.
Il volume ripercorre agilmente l’iter del diritto penale internazionale dai processi di Norimberga, Tokyo e Gerusalemme (il processo Eichmann, cui Hanna Arendt dedicò il noto reportage su La banalità del male, un tòpos ineludibile per gli studiosi del male incommensurabile e delle ragioni della sua affermazione su larga scala), ai Tribunali ad hoc costituiti per i crimini commessi nella ex-Yugoslavia e nel Ruanda, fino alla istituzione, con lo Statuto di Roma, della Corte Penale Internazionale.
La traiettoria, agilmente illustrata nel volume, in estrema sintesi, è scandita dalle seguenti tappe: giustizia dei vincitori sui vinti, attuata da Tribunali militari che applicano, talvolta retroattivamente, un diritto di guerra a conflitto finito; definizione convenzionale del genocidio nella Risoluzione Onu del 1946 e nella Convenzione del 1948; giustizia amministrata dagli Stati in applicazione dei crimini definiti in sede convenzionale o interna; Tribunali internazionali e Tribunali misti (composti cioè da giudici interni e internazionali) istituiti ad hoc al termine di sanguinosi conflitti; fino ad arrivare allo Statuto di Roma che definisce e sanziona con apposite disposizioni il genocidio, i crimini di guerra e i crimini contro l’umanità e, attraverso dettagliate previsioni processuali, istituisce la Corte penale internazionale come Corte permanente, fondata sul consenso degli Stati e indipendente dalle Nazioni Unite, che interviene in funzione complementare quando gli Stati non siano capaci o non siano disponibili a reprimere il male smisurato, superando lo schema della giustizia dei vincitori e le deroghe ai principi di irretroattività della norma penale sostanziale e della naturalità e precostituzione del giudice.
La ricostruzione di Emanuela Fronza e Marcello Flores non manca di segnalare alcune criticità insite nel meccanismo di funzionamento della Corte che ne hanno condizionato politicamente l’operato, restituendo nei primi anni del suo funzionamento l’immagine di un organismo sostanzialmente concentrato sulle questioni africane.
Tra questi limiti rilevano innanzitutto la mancata adesione o la mancata ratifica di Stati importanti sullo scenario internazionale, come la Russia, gli Stati Uniti, la Cina, Israele, alcuni dei quali compongono il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e sono perciò in grado di impedire, esercitando il diritto di veto, il referral che costituisce l’unico meccanismo di investitura della Corte nei confronti di Paesi che non aderiscono alla convenzione istitutiva.
Si tratta di un limite, per così dire, istituzionale, in forza del quale può procedersi nei confronti di Putin e della commissaria per l’Infanzia Lvova Belova per la sottrazione dei bambini ucraini (parte del piano di deportazione della popolazione delle zone occupate) ma non anche per il crimine di aggressione perché questo richiederebbe l’adesione della Russia allo Statuto di Roma: ragione per la quale il Comitato dei Ministri degli esteri del Consiglio d’Europa, sollecitati dalla cd. dichiarazione di Leopoli del 9 maggio 2025, ha avviato un percorso che dovrebbe condurre all’istituzione di un Tribunale speciale che se ne occupi.
Un altro limite è segnato dalla sostanziale discrezionalità delle policies di scelta dei casi da parte del Procuratore presso la Corte penale internazionale che ha fatto sì, per esempio, che le indagini sul caso afghano si concentrassero sui crimini dei talebani, trascurando gli abusi dei militari statunitensi.
2. Il libro fornisce informazioni importanti che possono aiutare il lettore ad orientarsi nell’acceso dibattito sull’esatta qualificazione delle condotte di Israele a Gaza, sottraendolo al furore delle contrapposte ideologie.
Gli autori ci fanno comprendere, anzitutto, le ragioni di questo furore, segnalando come convivano nella nozione di genocidio una dimensione strettamente giuridica, una dimensione storica ed una forte risonanza emotiva. Di qui il valore aggiunto di un volume curato da una giurista colta e da uno storico.
In questo quadro Fronza e Flores ci ricordano che:
a) il delitto di genocidio non era annoverato dallo Statuto di Norimberga e non fu perciò applicato alla Shoah che pure rappresenta, nella dimensione storica ed emotiva, l’archetipo del male assoluto;
b) quella carenza ci rimanda ad un dibattito della dottrina internazionalistica novecentesca, vividamente ricostruito da Philip Sands, nel bellissimo La strada verso est (Guanda, 2024), che vide quali protagonisti Rahael Lemkin, sostenitore della categoria del genocidio quale crimine contro i gruppi (nazionali, etnici, religiosi) e Hersch Lauterpacht, fiero avversario di quella categoria che riteneva sbilanciata in favore della tutela dei gruppi, anziché degli individui, e foriera di difficoltà probatorie e che perciò sosteneva, piuttosto, la categoria dei crimini contro l’umanità: un dibattito che vide prevalere le teorie di quest’ultimo, nonostante gli intensi sforzi di persuasione profusi da Lemkin (autore del fondamentale saggio nel collegio del procuratore Jackson;
c) il mandato di cattura emesso dalla Corte penale internazionale nei confronti di Netanyahu, Gallant e dei leader di Hamas non contempla il crimine di genocidio (si contestano crimini di guerra e contro l’umanità), mentre la Corte Internazionale di Giustizia (che, come precisano gli Autori, si occupa della responsabilità degli Stati e non degli individui), su impulso del Sud Africa, ha ritenuto “plausibile” una deriva genocidiaria delle condotte israeliane, ammonendo il governo di quel Paese.
Soprattutto però Fronza e Flores ci ricordano che il dibattito sulla qualificazione dei crimini di Israele è, nella prospettiva del diritto, meno rilevante di quanto suggeriscano i toni accesi del dibattito pubblico perché lo Statuto della Corte penale internazionale non sancisce gerarchie tra il genocidio e gli altri crimini di guerra o contro l’umanità e stabilisce una cornice edittale unica, nell’ambito della quale a fare la differenza sono le concrete modalità della condotta e la gravità delle sue conseguenze; e perché i crimini contro l’umanità annoverano figure come la starvation, lo sterminio, l’apartheid, le sparizioni forzate che, anche sul piano evocativo, possono qualificare adeguatamente certi fatti senza banalizzarli.
Nel contempo, il libro dissolve alcune delle principali obiezioni mosse dai sostenitori della natura non genocidiaria delle condotte israeliane, a partire da quella che fa leva sulla quantità (migliaia e non milioni) dei civili uccisi e sulla circostanza che, nel tempo della reazione, considerata la sua superiorità militare, Israele avrebbe potuto sterminare un numero ben maggiore di palestinesi se davvero avesse inteso distruggere quella entità (laddove la nozione convenzionale si accontenta dell’intenzione di distruzione parziale di «un gruppo nazionale, etnico, razziale religioso»).
In breve, gli autori ci ricordano che l’archetipo della Shoah non corrisponde alla fattispecie giuridica del genocidio che, infatti, è stata riconosciuta in casi (quantitativamente) meno gravi dello sterminio nazifascista degli ebrei, come il massacro dei tutsi in Ruanda, quello delle minoranze musulmane bosniache a Srebrenica (circa 8mila civili), e delle minoranze vietnamite, cinesi e cham in Cambogia; mentre l’elemento intenzionale genocidiario – escluso dai commentatori più vicini alle ragioni del governo di Israele – è seriamente indiziato da alcune dichiarazioni delle autorità israeliane riportate in un bel saggio di Didier Fassin (Une étrange défaite, La Découverte, 2024), nel quale si sottolinea anche la forte rilevanza sintomatica di alcune condotte come l’ostacolo ai soccorsi umanitari e all’operatività delle agenzie internazionali a ciò preposte.
Come dire che, sottratta agli stereotipi ideologici, agli slogan e alle semplificazioni dei social media, la questione definitoria si fa complessa, non consente prese di posizione emotive e svela come sia prematura e, forse, non immediatamente necessaria una presa di posizione critica nei confronti di esponenti del mondo ebraico - prime fra tutte, due sopravvissute alla Shoah come la senatrice a vita Segre e la scrittrice Edith Bruck - che, pur rifiutando l’etichetta genocidiaria, si sono già pronunciate, così come molti intellettuali israeliani, in termini inequivocabili sulla gravità e la sproporzione della reazione israeliana ai fatti del 7 ottobre.
3. Rifuggendo da ingenui entusiasmi, il libro esalta il valore irrinunciabile della giustizia penale internazionale come garanzia della soggezione degli Stati e dei governanti ai principi supremi del diritto umanitario, garanzia di eguaglianza tra occidente e oriente, tra nord e sud del mondo, tra Stati forti e Stati deboli, tra vincitori e vinti, una conquista che – insieme alla preminenza delle Costituzioni e alla necessità di presidiare il rischio della legge ingiusta - costituisce il portato più rilevante e irrinunciabile delle tragedie umanitarie del novecento: un’utopia necessaria e concreta, dicono gli autori, rifuggendo, ad un tempo, dal cinismo della realpolitik (il diritto internazionale che vale fino ad un certo punto; la guerra che non può non produrre morti) e dalla cecità verso i diversi segnali della crisi.
La narrazione è attraversata da diversi paradossi.
Proprio quando si emancipa dalla dimensione della giustizia dei vincitori la giustizia penale internazionale è sabotata: dalle sanzioni statunitensi contro il procuratore e i suoi collaboratori impegnati nelle indagini su Israele e sui crimini dei soldati americani in Afghanistan, dalla dichiarata indisponibilità di alcuni Paesi occidentali (Italia, Germania, Polonia, Francia) ad eseguire l’arresto di Netanyahu; dall’analoga indisponibilità di Paesi tradizionalmente o politicamente vicini alla Russia (Ungheria e Mongolia) di eseguire l’arresto di Putin; dai mandati di arresto emessi dalla Federazione russa nei confronti del Procuratore e di alcuni giudici della Corte.
Proprio nei confronti del male smisurato il diritto penale sembra incapace di esprimere quella funzione preventiva che sa esprimere, a livello domestico, nei riguardi di condotte assai meno gravi.
4. Attualizzando la massima di Luther King dalla quale abbiamo preso le mosse, gli autori non mancano di segnalare, alla luce dell’esperienza, la problematicità del rapporto tra giustizia e pace: se da un lato il rito della giustizia è condizione essenziale perché la soluzione dei conflitti sia in qualche modo accettata e condivisa dalle comunità, emarginando la vendetta (lo scempio di piazzale Loreto, le esecuzioni sommarie, il dileggio del cadavere di Gheddafi); dall’altro, le istanze della punizione possono ostacolare i processi di pace, che spesso esigono il coinvolgimento dei protagonisti del conflitto autori dei crimini, come avvenuto nel contesto del conflitto tra il governo ugandese e il Lord’s Resistance Army di Joseph Kony, dove il processo di pace fu interrotto dal mandato emesso dalla Corte penale internazionale nei confronti di Kony.
Il libro apre così scorci sulle esperienze di giustizia transizionale e riparativa del Sud Africa e della Colombia, come tentativi, più o meno fortunati, di conciliare la messa al bando delle blanket amnesty per i crimini internazionali con le esigenze di pacificazione e di ripresa della convivenza nelle comunità attraversate da cruente guerre civili.
5. Condivisibile è, infine, l’argomentata analisi dei fattori politici e culturali che permeano uno spirito del tempo ostile al funzionamento della giustizia penale internazionale.
Le tendenze autoritarie e i rigurgiti sovranisti muovono gli Stati, anche appartenenti al novero delle democrazie occidentali, a recuperare gli spazi della politica e della ragion di Stato, pure a discapito dei vincoli illo tempore liberamente accettati[1].
L’approssimazione culturale indotta dai social e dalla disintermediazione delle espressioni politiche dei cittadini favorisce il rifiuto della complessità delle logiche del diritto e del processo che è chiamato a ricostruire verità affidabili, un rifiuto che ha talvolta derive giustizialiste, talaltra produce esiti di cinico lassismo.
A questo Zeitgeist non sembrano sottrarsi alcuni intellettuali, pur muniti di conoscenze storiche, per i quali «Leggi, trattati e tribunali possono stabilire quanto gli aggrada, tutto quanto sembra loro “giusto”, ma se il mondo ha deciso di andare da un’altra parte si può essere certi che ci andrà. Ora, da più di un secolo (in verità direi da sempre) la guerra colpisce in maniera più o meno indiscriminata le popolazioni civili. Non ne ricordo neppure una, e sfido chiunque a farlo, in cui ciò non sia accaduto»[2].
Forse nobilitandola, gli autori riconducono questa affermazione ad una logica hegeliana secondo la quale “tutto il reale è razionale”.
Può darsi sia così, ma allora si potrebbe dire lo stesso dei crimini domestici, anche più efferati, la cui repressione produce raramente risultati di stabile eradicazione.
È questa una prospettiva troppo cupa per essere supinamente accettata. Ed allora Fronza e Flores ci invitano, senza velleitarismo, a reagire coltivando l’utopia necessaria di una giustizia, anche internazionale, uguale per tutti.
[1] A tale proposito (p. 95), gli autori richiamano, riproducendola, la lettera aperta inviata il 22 maggio 2025 dai governi italiano e danese (con l’adesione dei governi austriaco, belga, ceco. Estone, lettone, lituano e polacco) alla Corte europea dei diritti dell’uomo, accusata di aver fornito interpretazioni dei diritti umani eccessivamente penalizzanti per la capacità dei leader di «prendere decisioni politiche nelle nostre democrazie…di proteggere le nostre società democratiche e le nostre popolazioni dalle sfide che il mondo di oggi ci pone», con riferimenti esemplificativi alla materia dell’espulsione dei cittadini stranieri criminali «in cui l’interpretazione della Convenzione ha portato alla protezione delle persone sbagliate e ha posto troppe limitazioni alla capacità degli Stati di decidere chi espellere dai propri territori».
[2] Ernesto Galli della Loggia, La guerra e i crimini di guerra, in «Corriere della Sera», 11 dicembre 2024.
Il volume di Marcello Flores ed Emanuela Fronza, Caos. La giustizia internazionale sotto attacco, Laterza, 2025 verrà presentato a Roma nel pomeriggio del 3 dicembre 2025 nell'ambito dell'incontro
IL DIRITTO INTERNAZIONALE NEL CAOS: L’IMPATTO DELLA CRISI DELL’OCCIDENTE SULLA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI
L'incontro è a cura dei Magistrati di Area Democratica per la Giustizia, Corte di cassazione.
Segreteria organizzativa: antonio.scalera@giustizia.it
Mercoledì 3 dicembre 2025, h. 15.00
Aula Magna – Facoltà Teologica Valdese Via Pietro Cossa n. 40 – ROMA oppure da remoto su piattaforma ZOOM https://us06web.zoom.us/j/.86426268125?pwd=9qRXcUb3aNCGff2INQJQYrQNrLENOa.1 ID riunione: 86423238125 codice accesso: 016651
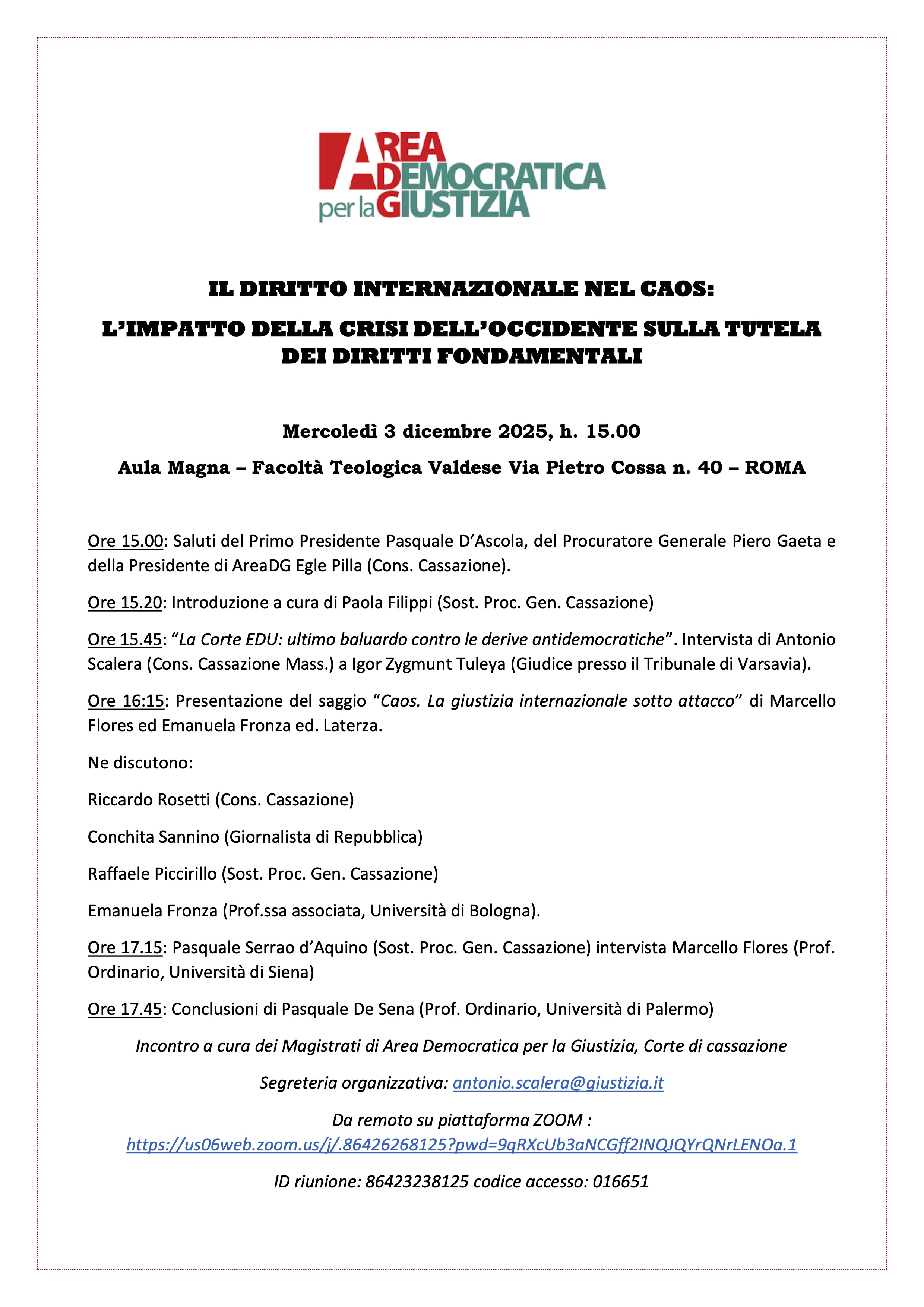
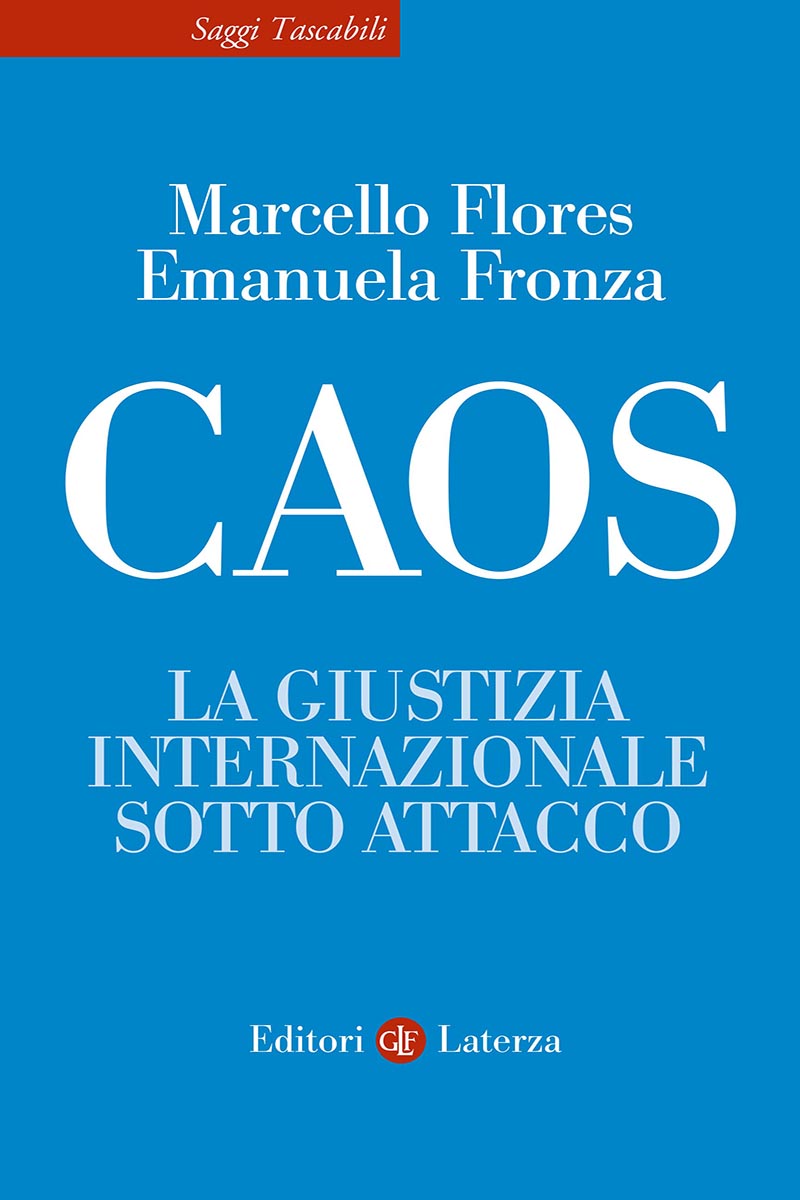
Marcello Flores - Emanuela Fronza, Caos. La giustizia internazionale sotto attacco, Laterza, 2025.

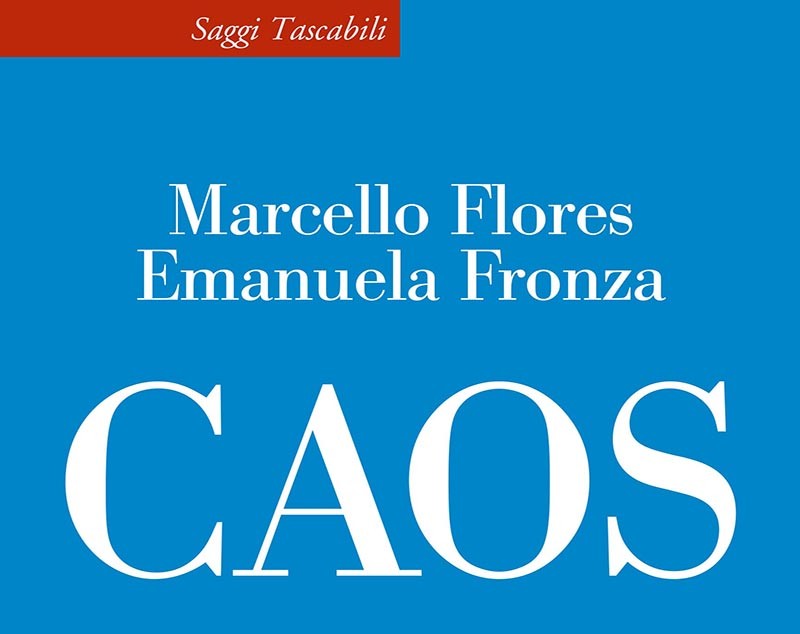

 And then Add to Home Screen.
And then Add to Home Screen.