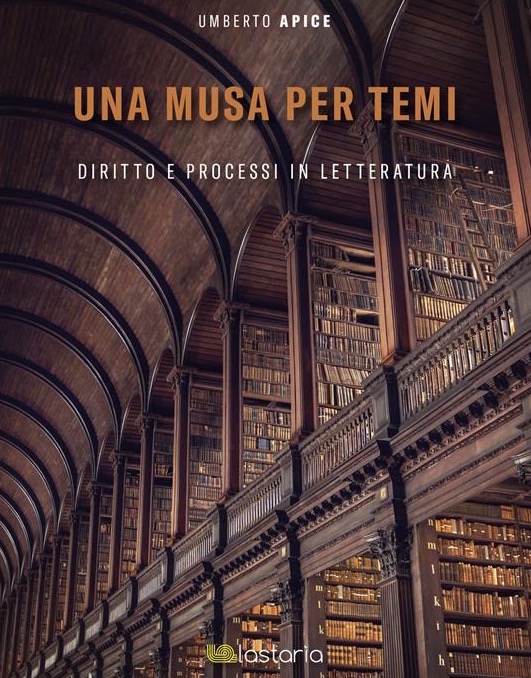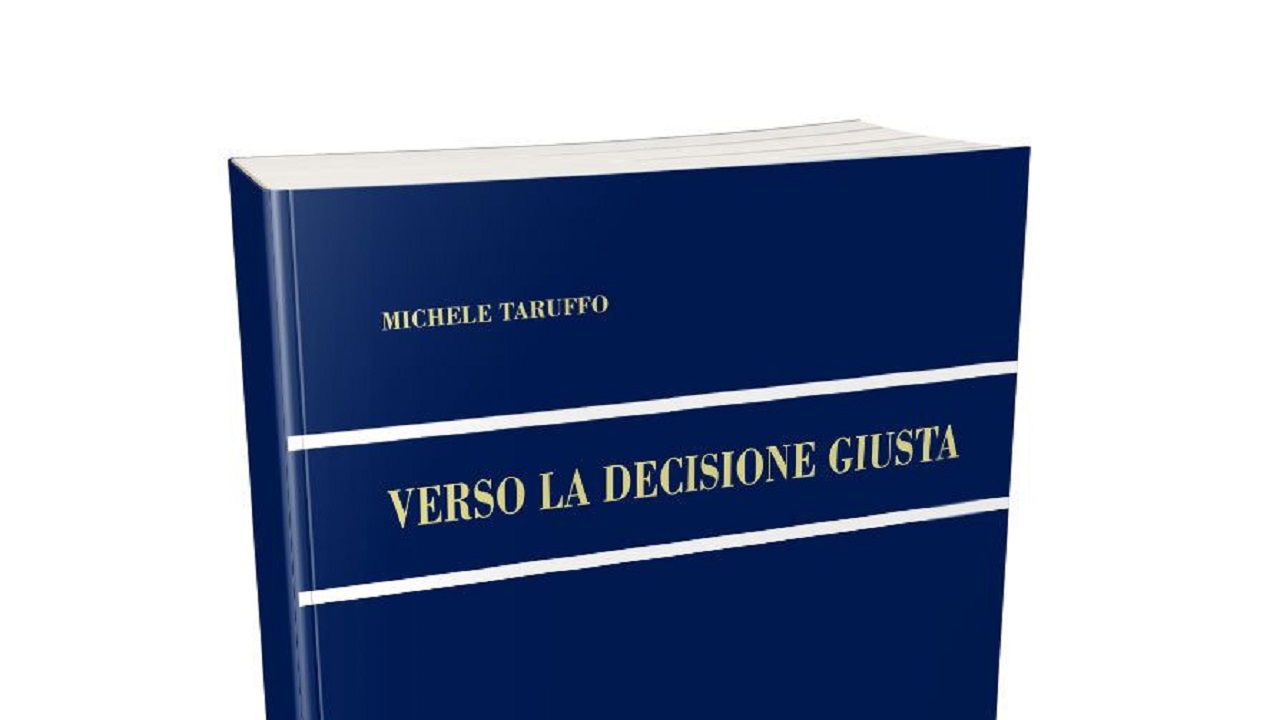
Michele Taruffo, Verso la decisione giusta, Torino, Giappichelli, 2020, 447
di Bruno Capponi
L’ultima opera di Michele Taruffo, scomparso lo scorso dicembre, è una raccolta di saggi, taluni molto brevi, che l’a. ha evidentemente immaginato come un percorso “culturale” verso la ricerca della decisione “giusta” (già la scelta dell’aggettivo è sintomatica del contesto in cui l’opera va collocata). Manca una introduzione che illustri al lettore le ragioni della silloge, mancano i riferimenti della eventualmente già avvenuta pubblicazione dei saggi in qualche rivista, italiana o straniera (l’impressione che se trae è che, a fronte di scritti già noti, altri sono il frutto inedito dell’allineamento lungo quel percorso che lo Studioso aveva deciso di intraprendere, o di far intraprendere al lettore, quasi a conclusione della sua parabola). Assenti anche le notizie sull’autore che pubblicazioni di questo tipo, riassuntive di un lungo cammino di riflessioni e di studi, in genere presentano (anche quando gli autori sono ben noti, com’è certamente il caso di Michele Taruffo). Come avviene per gli scritti dei giuristi maturi, il corredo di note è sempre ridotto all’essenziale, ovvero manca del tutto.
Il lettore si trova così di fronte a una raccolta piuttosto estesa (quasi 450 pagg.) che presenta 32 saggi divisi in quattro parti: Aspetti della giustizia civile (6), che segna l’inizio del cammino e che rimanda a temi generali come l’accesso alla giustizia, la giurisdizione come attività di “creazione” del diritto, il multiculturalismo processuale; Sulla verità (6), tema caro all’a. e anche indagato in forma monografica (La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti, Laterza, Bari, 2009); Sulla prova (13), parte che riflette i forse più consistenti interessi scientifici di Taruffo, o almeno quelli per i quali lo Studioso è maggiormente noto anche all’estero, e che infatti raccoglie il maggior numero di saggi; Sulla decisione (7), argomento la cui analisi l’a. non ha mai più abbandonato dopo la pubblicazione della sua prima monografia (1975) su La motivazione della sentenza civile e che, ovviamente, è strettamente connesso col tema del giudizio di fatto che lo aveva portato a indagare in modo inedito e di fatto insuperato, già nei primi anni Settanta, il tema scivoloso delle prove atipiche.
Il tratto caratteristico di tutti i saggi – perché questo era il tratto dell’a. – è la linearità e, diremmo, l’ineluttabilità degli argomenti grazie ai quali vengono contestate, e spesso ribaltate, quelle opinioni comuni che il neofita tenderebbe ad accettare come fossero declinazioni della legge. Taruffo dubita di tutto, e dimostra con abilità che qualsiasi argomentazione del giurista è reversibile, qualsiasi opinione per quanto consolidata può essere ridiscussa sin dalle premesse, qualsiasi conclusione può rivelarsi fallace quando assoggettata a verifica serrata con autonomia e indipendenza di giudizio. Ciò non soltanto allorché oggetto dell’esame sia un tema sfuggente e “filosofico” come quello della “verità” (gustose le tre divagazioni ispirate dalla lettura del saggio di U. Eco, Sulle spalle dei giganti, La Nave di Teseo, Milano, 2017), ma anche quando viene presa di petto l’interpretazione, comunemente accettata da intere generazioni di processualisti, di una norma centrale dell’istruzione probatoria qual è l’art. 115 c.p.c.; dopo gli studi di Carnacini, Cappelletti e Liebman e dopo i tentativi, un po’ meno riusciti, di studiosi successivi che avevano provato a ravvisare nella norma una garanzia del diritto alla prova (mi riferisco a E.F. Ricci), poteva darsi per scontato che il brocardo sui probata partium fosse giustificato a garanzia dell’imparzialità anche psicologica del giudice, che non può porsi alla ricerca della prova, che è quanto dire indagare sul fatto, senza rischiare di perdere, anche inconsapevolmente, la sua posizione di terzietà rispetto alle parti in contesa. Taruffo, in un saggio breve (neppure venti pagine) ma densissimo, giunge a dimostrare non soltanto che il brocardo, generalmente tramandato come «aforisma dell’antica sapienza», è frutto di una manipolazione letterale relativamente recente – con l’aggiunta di partium – che sembra aver ingannato lo stesso Calamandrei, ma soprattutto che la tesi di Liebman, che per molto tempo è parsa la sintesi vincente di tutti i precedenti studi, risulta essere del tutto ingiustificata proprio alla luce della Relazione al Re (§ 14), che lascia l’asserto – «la mancanza di autonomi poteri istruttori del giudice è condizione necessaria per assicurare la sua imparzialità e neutralità di giudizio» – privo di qualsiasi conferma empirica. La conclusione attinta – «nel momento presente non si può far altro che constatare che nel nostro ordinamento [il principio dispositivo in materia di prove] non trova adeguata giustificazione né come principio tecnico né come principio categorico, oltre a non essere chiaramente enunciato nel tenore letterale di alcuna norma» (pag. 344) – suona, oltre che come conclusione critica di un saggio che abbatte una sorta di idolum, come un programma di ricerca per il futuro studioso che voglia indagare – mutuando le parole di Liebman – il vero Fondamento del principio dispositivo.
Ne emerge la figura di uno studioso rigoroso, privo di preconcetti, disposto a qualsiasi indagine anche (o forse soprattutto) fuori del diritto e dei confini nazionali alla perenne ricerca dei principi fondamentali presenti e ricorrenti in ordinamenti anche tra loro lontani, che vengono vagliati senza preconcetti e soprattutto senza la pretesa di ricavarne ricette e pratiche soluzioni da esportare sic et simpliciter nel nostro sistema, eternamente in crisi e così alla continua ricerca di “soluzioni”; con una chiara tendenza a sorridere di talune opinioni, quando riconosciute prive di qualsiasi fondamento scientifico (ciò che avviene sovente). Di certo, al nostro a. non difetta una buona dose di umorismo: qualità che si affaccia prepotente, ad esempio, quando afferma, a proposito dell’assonanza tra “disponibilità” del diritto e “principio dispositivo”, che «l’art. 12 delle Preleggi invita l’interprete a tener conto del “significato proprio” delle parole usate dal legislatore, non del loro suono» (pag. 328); o quando accenna ai terrapiattisti come portatori «di una certezza che a quanto pare continua ad essere largamente condivisa» (pag. 373); o quando, parlando della motivazione giustificativa, conclude che «tutto sommato, la dimostrazione del teorema di Pitagora non ha nulla di retorico ma il teorema vale perché è logicamente giustificato» (pag. 395); o ancora quando ci informa che l’espressione italiana equivalente di bullshit – “stronzata” – «non è elegante … anche se allude efficacemente al fenomeno» (pag. 131, in nota).
Ogni recensione non è neutra, riflettendo i gusti e le preferenze del redattore. Dico questo per giustificare che, dell’intero e vario materiale raccolto nella ricca e ariosa pubblicazione, a me sembra di dover prediligere gli aspetti che rimandano ai due grandi “fari” del lungo impegno di studio dell’a.: la motivazione della sentenza anche in funzione del suo controllo e – tema strettamente connesso – la Corte di cassazione vertice delle giurisdizioni (la sua definizione “vertice ambiguo” è ormai entrata nell’uso comune: cfr. Il vertice ambiguo. Saggi sulla Cassazione civile, Il Mulino, Bologna, 1991). Nella quarta parte dell’opera, Taruffo torna sul modello del vertice tra common e civil law, definendolo stavolta “astratto” e ciò «nella misura in cui la decisione della singola corte – che pure riguarda sempre questioni di diritto – prende o non prende in considerazione i fatti che hanno determinato la controversia nel caso concreto» (pag. 421); prosegue comparando il precedente con efficacia persuasiva, proprio del nostro sistema, con le pronunce di altre Corti supreme recanti “direttive interpretative” (in uso in Russia come a Cuba) che hanno carattere vincolante per tutti i giudici, le amministrazioni, i soggetti pubblici e privati e dunque risultano frutto di un’attività «sostanzialmente analoga a quella di produzione di norme, anche perché non deriva dalla decisione di casi concreti».
Secondo Taruffo, il modello italiano produce un elevato grado di astrattezza specie nella formulazione delle massime, rivolte dal passato (il caso deciso) al futuro ma con l’utilizzo di espressioni sintetiche e stereotipate che non sempre enunciano la vera ratio decidendi della questione di diritto affrontata; sottolinea l’a. che «il punto essenziale è che comunque il precedente di civil law viene concepito come una regola, formulata in termini generali e astratti, e non come l’applicazione di una norma a una fattispecie concreta» (pag. 424); una mitigazione di questa “astrattezza” può venire dal fatto che il nostro precedente è tutt’altro che uno stare decisis, non esistendo da noi – ovvero esistendo in modo assai flebile, soprattutto nell’interpretazione giurisprudenziale, tra sezione semplice e sezioni unite – un vincolo che deriva dal precedente, vincolo che del resto, ove ritenuto sussistente, si mostrerebbe in conflitto con la norma costituzionale – davvero abusata nelle sue applicazioni – che vuole qualsiasi giudice soggetto soltanto alla legge.
Eppure, proprio nel nostro sistema – nel quale peraltro la Corte di cassazione svolge una pluralità di funzioni anche tra loro in conflitto: vedi il caso della cassazione c.d. sostitutiva – sta sempre più prendendo piede la decisione di ricorsi “nell’interesse della legge”, in casi, cioè, in cui non c’è o non c’è più una controversia da risolvere (ciò che quasi spregiativamente viene indicato come jus litigatoris) e resta un principio, ossia una regola rivolta al futuro, da affermare (lo jus constitutionis). Si tratta, a mio avviso, di una chiara anomalia del nostro sistema, sebbene non da tutti percepita, che rischia di alterare la funzione della Corte: la quale, sebbene suprema, è pur sempre un giudice, che deve giudicare un caso concreto e proprio giudicando quel caso concreto può affermare una regola astratta (o suscettibile di essere astrattizzata); non anche, da giudice, affermare una regola in pura “astrattezza” per i soli casi futuri, prendendo magari spunto da un caso che, quanto alla sua concreta risoluzione, più non interessa. Nel contesto attuale, citare le parole di Calamandrei che parlano di coordinazione tra funzione legislativa e funzione giudiziaria rischia di essere fuorviante. L’evoluzione in atto della nostra Corte suprema mostra che forse, ora come ora, non risponde del tutto al vero l’idea che essa «rimane vincolata a decidere nel merito, in un modo o nell’altro, tutte le specifiche questioni di diritto su cui vertono tutti i ricorsi che ad essa vengono proposti» (pag. 428), anche perché la selezione dei ricorsi, che la Corte non riesce a realizzare con lo strumento a ciò deputato (art. 360 bis c.p.c., norma di incertissima interpretazione e, perciò, di occasionale applicazione) viene poi eseguita in modo piuttosto indiscriminato – nonostante il self-restraint che a volte è dato cogliere all’interno della stessa Corte – con gli strumenti dell’autosufficienza del ricorso e della specificità del motivo, grazie ai quali l’organo di legittimità riesce spessissimo ad affrancarsi dalla decisione del “merito” dei ricorsi. Ma, fatta in questo modo, la selezione ha un intollerabile tasso di casualità, e risulta addirittura odiosa allorché sanziona la più o meno esercitata perizia del difensore tecnico nel redigere il ricorso che la Corte si dichiarerà poi in condizioni di poter scrutinare.
Un discorso molto chiaro l’a. dedica al tema della motivazione e del suo controllo, e in particolare al controllo che avviene, o dovrebbe avvenire, in sede di legittimità (pag. 409 ss.). Con una lucida analisi, e resistendo al mantra del “nulla è cambiato” col quale molta dottrina ha tentato di esorcizzare l’improvvisata riforma del 2012, Taruffo prende atto che il nostro sistema sta affrontando una vera e propria crisi della motivazione: che nasce da interventi normativi, realizzati e tentati (chi non ricorda quelli del ministro Orlando, con gli avvocati chiamati a motivare i verdetti dei giudici?), da discorsi ambigui su diritto ed economia e anche da orientamenti giurisprudenziali (non esclusi quelli della stessa Cassazione – specie la sezioni unite del 2015 sulla mancata copertura offerta dalla legge sul diritto d’autore quanto alle attività processuali, ciò che legittimerebbe la riproduzione in sentenza di qualsiasi atto di parte o degli ausiliari). Una crisi che viene da lontano, come ben testimoniano, nella IX Legislatura, le pagine della Risoluzione del CSM sul d.d.l. Vassalli recante Provvedimenti urgenti per il processo civile, redatta da G. Borrè, specie nei passaggi sul “collo di bottiglia” delle decisioni e sulla conseguente necessità di “sdrammatizzare” il problema della stesura delle motivazioni.
Quando Taruffo parla del “minimo costituzionale” delle sentenze gemelle del 2014 (che ribattezza come “massimo” costituzionale, perché la norma del comma 6 dell’art. 111 Cost. non può essere intesa se non in termini di effettiva motivazione: pag. 412), avverte chiaramente il carattere posticcio e autoreferenziale delle massime ripetute, anche a fronte della garanzia imposta da quel comma 6; gli sembra infatti impossibile che il controllo – pur “evoluto” dalla logicità alla legittimità – non debba ricomprendere la “sufficienza” e la “contraddittorietà”, salvo che quest’ultima non si presenti nella ennesima forma patologica della «manifesta e irriducibile contraddittorietà» (qui la massima consolidata, dice Taruffo, è «in poche righe intrinsecamente contraddittoria o, nel migliore dei casi, irrimediabilmente vaga» perché la corte non affronta mai il problema di stabilire «quando una contraddizione non è né “manifesta” né irriducibile” e quindi potrebbe essere considerata irrilevante»: pagg. 413-414). L’a. sottolinea che il recupero della formula originaria del n. 5) dell’art. 360, realizzato nel 2012, non ha avuto l’obiettivo di selezionare un vizio nuovo, fino ad allora inedito, sulla ricostruzione del fatto (come la giurisprudenza della corte, a partire dalle sentenze gemelle, ha ripetuto allo scopo di regolare i confini col vecchio motivo), bensì ha perseguito il risultato di escludere del tutto il controllo sulla motivazione, che poi la corte stessa ha “recuperato” lavorando sul n. 4) e anche sul n. 3) dello stesso art. 360 ma imponendo comunque il limite del “minimo costituzionale”; d’altra parte, non può non convenirsi sulla considerazione secondo cui un recupero pieno del controllo dovrebbe passare attraverso un mutamento di giurisprudenza sulle violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c., che un consolidato orientamento tende a non ammettere (o, meglio, tendeva, vigente il n. 5) nella lezione che abbiamo conosciuto tra il 1950 e il 2012).
Le pagine su precedente e nomofilachia (pag. 442 ss.) mostrano gli equivoci alla base della riforma del 2016, nota per aver realizzato la “cameralizzazione” del giudizio di legittimità. Chi abbia esperienza pratica di tale giudizio sa bene che spesso restano del tutto imperscrutabili le ragioni per le quali un ricorso complesso viene avviato per la camera di consiglio mentre altro ricorso, in apparenza più lineare o modesto, è ammesso ai fasti della pubblica udienza; d’altra parte, si leggono spesso ordinanze ampiamente motivate (a volte anche della sezione VI, che dovrebbe realizzare una selezione preliminare) che vengono poi richiamate quale “precedente” alla stessa stregua di una sentenza delle sezioni unite. Per l’osservatore, infatti, spesso non è dato distinguere le sentenze dalle ordinanze, anche perché le raccomandazioni dei primi presidenti sulla relativa tecnica di redazione raramente vengono seguite; e del resto nessuna raccomandazione tecnica potrebbe suggerire all’estensore di una sentenza, fosse anche delle sezioni unite, di scrivere un trattatello in cui esibire la propria cultura o le proprie preferenze scientifiche senza collegamenti o ricadute espliciti rispetto al caso deciso.
Troppo spesso si perde di vista che nelle sentenze (o nelle ordinanze) a parlare è la Suprema Corte di cassazione e non questo o quell’estensore: i quali hanno molte altre sedi (dalle Accademie alle Scuole) in cui poter liberamente dibattere, smessa la toga, i problemi giuridici che sono o saranno chiamati ad affrontare da giudici.
D’altra parte, come possiamo continuare a parlare di nomofilachia quando – scegliamo un argomento a caso – la sezione III è in grado di pubblicare, nonostante un importante precedente “nomofilattico” delle sezioni unite (sent. 27 novembre 2007, n. 24627), due decisioni che, a soli tre mesi di distanza l’una dall’altra e senza che la successiva tenga conto della precedente, affermano da un lato che sono sempre ammissibili anche le impugnazioni incidentali tardive che riguardano un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale o che investono lo stesso capo ma per motivi diversi da quelli già fatti valere con l’impugnazione principale (ord. 11 novembre 2020, n. 25285) e, dall’altro lato, che «ai sensi dell’art. 334 c.p.c. e del combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., sono inammissibili le impugnazioni incidentali tardive che hanno contenuto adesivo al ricorso principale, quelle che investono un capo della sentenza non impugnato ed inoltre quelle che investono lo stesso capo impugnato ma per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale: in tali casi, infatti, essendo l’interesse ad impugnare già sorto in conseguenza dell’emanazione della sentenza di appello, l’impugnazione deve essere proposta nei termini di cui all’art. 325 c.p.c.» (ord. 24 agosto 2020, n. 17614)? E non si tratta certo di un caso isolato, perché chi si dedichi a studiare la giurisprudenza della nostra Cassazione scopre facilmente, in relazione alla stessa questione, l’esistenza di più filoni perfettamente autoreferenziali e “a comparti stagni”, nei quali l’ultima sentenza della serie richiama i soli precedenti conformi ignorando l’esistenza di quelli dell’altro o degli altri filoni, destinati così a marciare paralleli per anni, radicando l’incertezza dei risultati. Due esempi a caso: il tema delle restituzioni in appello di quanto versato in esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado, che a volte è materia di pronuncia d’ufficio e a volte richiede la domanda di parte, ammessa senza preclusioni nonostante l’art. 345 c.p.c.; il tema dell’interpretazione dell’art. 2929 c.c., se la norma riguardi le sole nullità relative o anche a quelle assolute; e gli esempi potrebbero continuare ad libitum. Vengono a proposito le parole dell’a.: «se si parla della funzione nomofilattica che la Cassazione dovrebbe svolgere attraverso i suoi precedenti comunque vincolanti, si giunge a dimenticare l’antico detto, attribuito tra gli altri a Seneca, per cui errare humanum est, ma perseverare diabolicum» (pag. 444).
Non sorprende che dello stesso fenomeno – la nomofilachia – all’interno della Cassazione si abbiano idee molto diverse: per taluni, l’attività muove dal basso, mediante la definizione dei giudizi e l’affermazione della regola che sempre parte dall’esame del caso; per altri, la funzione rileva direttamente dinanzi alla legge e può anche prescindere dall’analisi del caso concreto. Per taluni, il diritto è quello oggettivo (di cui parla l’art. 65 ord. giud.); per altri, il diritto è quello che viene vagliato e ricostruito, a volte “inventato” nel senso latino del termine, secondo canoni di rilevanza costituzionale o eurounitaria, divenendo di necessità opinione, autorevolissima ma pur sempre discutibile, dell’organo di legittimità (il “diritto giudiziario”).
Una nota finale. Il libro è dedicato non alla decisione “legittima”, bensì alla decisione “giusta”; l’a. sembra indicare i passaggi per il raggiungimento di tale obiettivo attraverso la verità (pag. 99 ss.), il corretto utilizzo delle norme sulla prova (pag. 187 ss.), la presentazione di una teoria della decisione giusta (pag. 357 ss.), che sia certa e coerente (pag. 369 ss.) ancorché complessa (pag. 383 ss.) per poi tornare al problema di base (“quel che muove”…), ossia il rapporto tra prova e motivazione (pag. 297 ss.) e il suo controllo specie in sede di legittimità (pag. 409 ss.) e così da parte di un “vertice” che sembra alla ricerca perenne di una sua precisa identità (pag. 417 ss.) anche e soprattutto nella cultura del precedente e della nomofilachia (pag. 433 ss.).
Se il percorso è chiaramente tracciato, possiamo dire che la strada davanti a noi verso la decisione “giusta” è ancora molto lunga.