Fiandaca o Giostra
di Andrea Apollonio
Qualche giorno fa è morto il grande George Steiner,il cui primo libro è al tempo stesso un caposaldo della critica letteraria: "Tolstoj o Dostoevskij". Steiner metteva a confronto quelle che per lui (e non solo per lui) erano due concezioni fondanti e antitetiche della letteratura russa e dunque occidentale, mettendo in risalto nel primo la connotazione epica del racconto, nel secondo il dato verista e talvolta tragico.
Ricordare il più grande critico letterario del Novecento è anche uno stimolo per mettere a confronto due grandi maestri del pensiero penalistico, che a distanza di un paio d'anni o poco più l'uno dall'altro hanno pubblicato, nell'oramai nota collana "Prime lezioni" di Laterza, due libretti apparentemente - apparentemente - speculari: "Prima lezione di diritto penale", di Giovanni Fiandaca (giugno 2017), e "Prima lezione sulla giustizia penale", di Glauco Giostra (gennaio 2020).
L'intento dei due giuristi prestati alla saggistica divulgativa è lo stesso, esplicitato in particolare da Fiandaca nella sua Premessa: puntare ad una cerchia di non specialisti vuol dire "adottare uno stile espositivo non appesantito da termini tecnici" e "prescindere da quei profili della materia che, se appassionano (e persino oltre misura!) gli studiosi accademici, rischiano di apparire ad occhi esterni astrattamente concettualistici o addirittura irritanti". Per un giurista scollarsi dal profilo tecnico, formale e volutamente - o necessariamente - affettato è spesso un'operazione (ahimé) impossibile, ma l'accademico palermitano è conosciuto anche per essere un ottimo divulgatore - tra i suoi pregevoli e multidisciplinari scritti sulle mafie, ricordiamo giusto "La mafia non ha vinto" (con Salvatore Lupo).
Il volume di Fiandaca nel suo primo quarto affronta il dibattito - annoso - sulla pena, ripercorre le concezioni di prevenzione generale e speciale, con molti riferimenti a filosofi e giuristi ottocenteschi senza omettere i grandi classici del pensiero tedesco contemporaneo, Roxin e Jacobs. Una dissertazione dall'alto tasso di astrazione ma pur sempre magistrale, impregnata di autorevole tradizione accademica, in cui si produce un grande maestro della scienza penalistica.
L'ampio respiro del Fiandaca divulgatore comincia ad emergere nel secondo capitolo ove si affronta il tema del diritto penale ipertrofico, che riguarda ogni aspetto della vita sociale. Un tema molto sentito e ben comprensibile dal comune cittadino, che ha per le mani questo testo perché "offre un quadro dei temi e dei problemi di fondo del diritto penale contemporaneo" (dalla quarta di copertina). Proseguendo nel filo tessuto da Fiandaca, ci si imbatte poi in una dissertazione sul bene giuridico avviata dal pensiero di Franco Bricola: questione imprescindibile per ogni studioso di diritto penale, un po' meno per quel lettore che vorrebbe trovare risposte alle domande che sorgono spontanee seguendo l'attualità, la cronaca, il dibattito pubblico.
Rimangono quindi per lui - superando anche il terzo capitolo, che verte su elemento oggettivo e soggettivo del reato - gli ultimi due capitoli, in cui Fiandaca affronta due temi corali e, potremmo dire, universali: il rapporto tra la legge e il giudice e quello tra il diritto penale e le scienze. "Un modello di giudice servo passivo (se non proprio sciocco!) del legislatore sarebbe improponibile nella realtà contemporanea": partendo da questa considerazione l'accademico siciliano prende per mano il lettore mostrandogli la vera natura della legalità contemporanea, che passa attraverso l'applicazione della legge al caso concreto previo vaglio critico del giudice; una legalità sempre più giurisprudenziale che è anche una forma di garanzia di coerenza interna del sistema penale, considerata la "mancanza di una organica visione d'insieme" del legislatore. E' una risposta concreta ed esaustiva quella che Fiandaca fornisce al lettore che, almeno dai tempi di Tangentopoli, si chiede quale sia il vero punto di frizione tra potere politico e potere giudiziario sul piano dell'applicazione della legge, se è vero che persino in Costituzione è detto che il secondo si deve limitare a dare mera esecuzione a quanto deciso dal primo nelle sedi parlamentari che occupa. Nè è scevro di spunti di riflessione l'ultimo capitolo (che mostra per intero l'indole multidisciplinare dell'autore), che espone in maniera scorrevole i temi certamente più accattivanti del diritto penale, tra i quali la capacità di intendere e di volere ed il collegato aspetto psicologico e criminologico del crimine.
Con questo volume, insomma, Fiandaca non sconfessa nessuna delle proprie qualità, ponendosi allo stesso tempo da professore e da divulgatore; essendo costui, peraltro, uno dei pochissimi maestri della scienza penalistica a saperle esercitare entrambe, ottimamente.
Un altro autore dalla duplice natura è Glauco Giostra, processualista di qualche anno in meno ma ugualmente, come Fiandaca nel suo campo, vertice del diritto processuale penale (e sarà un caso che entrambi sono stati membri del Consiglio Superiore della Magistratura?): la sua è una prima lezione sulla "giustizia penale", da intendersi come una prima lezione sul processo penale, quello "stretto ponte tibetano che consente di passare dalla res iudicanda alla res iudicata". Come detto, anche Giostra vuole prestarsi ad una saggistica divulgativa, immaginando di "avviare un'ideale conversazione tra chi da molto tempo sta cercando di orientarsi nel complesso universo della giustizia penale e chi per curiosità, interesse o studio intende avvicinarsi ad esso per la prima volta. Ho cercato di intuire cosa valesse la pena trasmettere in un'unica, pur lunga lezione" - così, nell'Introduzione. Giostra si propone quindi di effettuare una selezione rigorosa e, al tempo stesso, semplificatoria, con risultati sorprendenti.
Ai risultati arriviamo, non prima di avere evidenziato come Giostra voglia mettere a suo agio il lettore, confortandone l'impreparazione con un Glossario dei termini tecnici o comunque di non facile comprensione, "da usare a mo' di pronto soccorso terminologico, per evitare che la mancata conoscenza di un vocabolo o di una locuzione pregiudichi la comprensione del discorso". L'accademico marchigiano si appresta così ad affrontare la sfida della procedura penale somministrata al grande pubblico.
Le forme e i riti, le direzioni e i metodi ("le regole processuali sono un guardrail metodologico") del diritto punitivo per eccellenza sono mostrati nella loro imperfezione, non di rado privi di esatta coincidenza con i principi di garanzia a cui dovrebbero conformarsi; ma spesso si rivelano una scusa appena plausibile per affrontare le questioni di cui, da anni, è intriso il dibattito pubblico: il rapporto della giurisdizione con i media, i condizionamenti mediatici sulla - e della - giustizia; la prescrizione, che copre quattro paginette fitte di spunti utili a formare - o a raffinare - una propria opinione su di una questione politica attuale di primaria importanza.
Certo non mancano, sopratutto nel terzo capitolo riguardanti "Le strutture portanti del processo penale", le dissertazioni teoriche (a tratti appesantite dall'immancabile filiera dei principi del rito penale: è il caso della formazione della prova in contraddittorio), ma anche gli istituti processuali più complessi vengono trattati sulla superficie di un linguaggio semplificato e gradevole, che utilizza formule efficaci ed esempi concreti: sono a questo fine richiamati i principali cold case degli ultimi anni: dal delitto di Meredith Kercher a quello di Chiara Poggi, con qualche implicito riferimento - anche qui - ai fatti di Tangentopoli.
Giostra sembra intendersi con il suo pubblico sopratutto quando sconfina in ambiti meta-giuridici:
ad esempio, fin dalle prime pagine è posto il problema del giudicare, che è un problema umano, esistenziale: "ogni persona investita del titanico compito di giudicare ha un vissuto, un patrimonio culturale e un assetto emotivo che fatalmente ne influenzano la capacità di percepire, di valutare e di decidere". Il lettore comprende che si parla anche di lui, o comunque si parla per lui. Una sensazione che trova conferma nell'ultimo capitolo del volume, sulla "narrazione della giustizia penale": necessaria, in ultima analisi, per il necessario "controllo della collettività sulla giustizia amministrata in suo nome". Il lettore è ormai certo che quando si parla di giustizia penale, si parla per lui.
Nel suo libro di critica letteraria, Steiner cerca di non stabilire supremazie, ma fa intendere che preferisce Dostoevskij, il suo realismo tragico, quasi shakesperiano, più aderente alla realtà; pur riconoscendo nelle opere di entrambi la massima espressione del romanzo ottocentesco. Sempre giocando su questo impossibile parallelismo tra i due grandi romanzieri russi da un lato, i due grandi giuristi dall'altro, allo stesso modo potrebbe dirsi che entrambi rappresentano due massimi vertici del pensiero giuridico - alzi la mano chi non ha studiato sui loro manuali o commentari - e queste "prime lezioni" confermano (se pure ce ne fosse bisogno) la loro profonda capacità di elaborazione, che riesce ad affiorare in spiegazioni semplici di questioni vertiginose. Eppure, un giudizio di maggiore aderenza ai propositi divulgativi che sorreggono i due volumetti (che non sono né compendi, ne saggi né, tantomeno, monografie: il cui senso principale, per questo, è proprio la divulgazione) premierebbe il bell'affresco di Giostra sulla giustizia penale nel suo insieme: il cui autore, facendosi davvero prossimo al lettore, di fatto non si occupa di distinguere tra diritto sostanziale e processuale, quanto piuttosto di veicolare verso il cittadino domande - e risposte - sull'aspetto più rilevante della contemporaneità (di ogni contemporaneità): quello del diritto e della sua narrazione pubblica. Narrazione tanto necessaria da far pensare che nessuno studioso possa tirarsi indietro, proclamandosi innocente.
P.S. E' da quando sono ragazzo che preferisco Dostoevskij a Tolstoj, ma fin da subito ho compreso che il vero padre della letteratura occidentale è lui. E' il gioco dei contrari, a cui nessuna percezione soggettiva può sottrarsi: e allora, che questa mia preferenza sia intesa a contrario, come un omaggio alla statura scientifica e umana di Fiandaca.

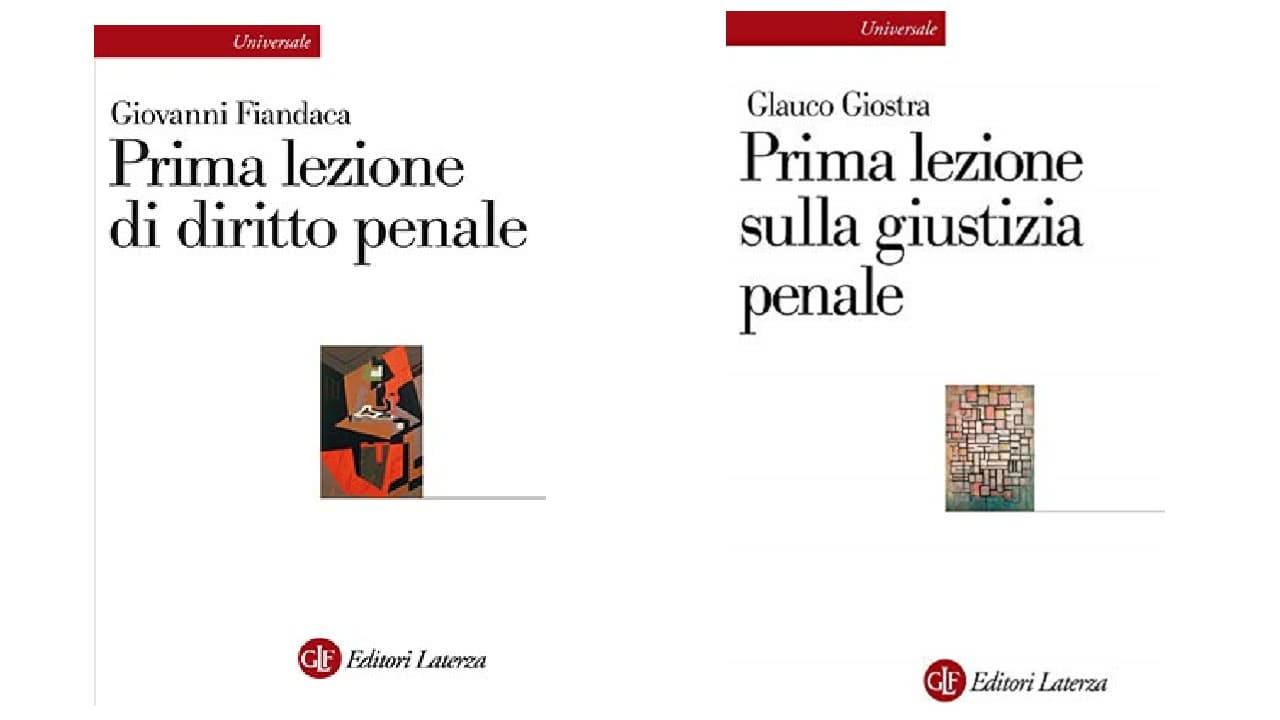

 And then Add to Home Screen.
And then Add to Home Screen.