Laicità innominata. La giurisprudenza sui rapporti tra nullità e divorzio
di Nicola Colaianni
Sommario: 1. La separazione tra le giurisdizioni ecclesiastica e civile sul matrimonio - 2. La separazione tra atto e rapporto matrimoniale - 3. La separazione come laicità.
1. La separazione tra le giurisdizioni ecclesiastica e civile sul matrimonio
Le ripercussioni della giurisdizione ecclesiastica in materia di nullità matrimoniali sulla giurisdizione civile si vanno sempre più attutendo e ormai sono prossime ai minimi termini. Erano state massime, e devastanti, per oltre cinquant’anni dal concordato del 1929 quando secondo l’interpretazione datane dalla giurisprudenza, così sintetizzata con la solita brillantezza da Jemolo, “ciò che fa la Chiesa è ben fatto; i vincoli ch’essa riconosce valgono per lo Stato, quelli ch’essa dichiara venuti meno, vengono meno per lo Stato”[1] . Ma erano entrate in crisi irreversibile con la legge n. 898/1970 istitutiva del divorzio, che all’art. 2 prevede la cessazione degli effetti civili del matrimonio canonico trascritto. Alla Chiesa sembrò, e lo denunciò anche per le vie diplomatiche[2], un vulnus all’art. 34 del Concordato, con cui secondo la sua interpretazione lo Stato avrebbe inteso recepire nel proprio ordinamento il matrimonio canonico, comprensivo di tutte le sue componenti essenziali, fra cui l'indissolubilità. Ma a questa tesi della riconduzione ad unità del regime matrimoniale, il canonico recepito tal quale dallo Stato, la Corte costituzionale oppose quella della “separazione dei due ordinamenti”, da cui “deriva che nell'ordinamento statale il vincolo matrimoniale, con le sue caratteristiche di dissolubilità od indissolubilità, nasce dalla legge civile ed é da questa regolato”[3]. Ne consegue il diritto di ottenere, ricorrendo le condizioni previste nella legge, la cessazione ex nunc degli effetti civili del matrimonio concordatario con apposita “azione per farlo valere”[4] , avente petitum e causa petendi diversi rispetto a quella canonistica.
L’affermata separazione dei due ordinamenti, tuttavia, pur sancendo l’autonomia della nuova disciplina civilistica, lasciava sul piano dommatico una primazia all’ordinamento canonico, in quanto unico legittimato, grazie alla riserva di giurisdizione attribuitagli, a pronunciarsi in punto di validità o nullità dell’atto di matrimonio: che, operando ex tunc, è questione assorbente quella dell’efficacia civile di competenza dell’ordinamento statale. Questa primazia del giudizio canonico neppure risentì particolarmente della rivisitazione dell’efficacia civile della iurisdictio nullitatum operata dalla Corte costituzionale nel 1982, che impose alla delibazione i limiti del rispetto del diritto di difesa, sia pure nel nucleo ristretto, nel processo canonico e dell’inefficacia di statuizioni contrarie all’ordine pubblico interno[5]. Infatti, la Cassazione a sezioni unite limitò l’impedimento alla delibazione alle sole differenze tra le cause di nullità previste dai due ordinamenti che superino “quel livello di maggiore disponibilità tipico dei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica”[6].
Un cambio di registro avverrà solo con la fondamentale sentenza con cui – dopo aver glissato sulla questione in varie pronunce confermative dell’orientamento assunto prima della revisione concordataria - la Cassazione diede atto che l’art. 8 dell’accordo di revisione non riproduceva più il comma dell’art. 34 del concordato lateranense relativo alla riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici: e, poiché “le disposizioni del Concordato stesso non riprodotte nel presente testo sono abrogate” (art. 13, n. 1, l. 121/1985), la riserva di giurisdizione era da ritenersi caducata con il conseguente concorso di giurisdizioni addirittura sulla nullità dell’atto di matrimonio canonico[7]. Nonostante uno strumentale obiter dictum inserito dalla Corte costituzionale in una sentenza d’inammissibilità della questione di costituzionalità[8], sulla caduta della riserva e sul conseguente concorso di giurisdizioni la Cassazione ha tenuto la barra dritta nelle successive decisioni[9] costituenti ormai –come noteranno le sentenze “gemelle” del 2014[10] - "diritto vivente".
Il concorso di giurisdizioni è di grande rilievo sul piano sistematico in quanto rovescia l’assetto dei rapporti precedente la legge sul divorzio e attribuisce allo Stato l’intera giurisdizione sul matrimonio, inteso come atto e come rapporto. Il che presuppone l’autonomia della giurisdizione statale e quindi fa venir meno la primazia della giurisdizione canonica. La primazia diventa fattuale e dipende dal criterio estrinseco della prevenzione cronologica: più forte è la giurisdizione adita per prima. Ciò vale innanzitutto nel caso che si tratti di giudizi con identico petitum di nullità, che era il caso risolto dalle Sezioni unite ma verosimilmente di infrequente ricorrenza, stante il breve termine di un anno previsto dagli artt. 120 cpv., 121 co. 3 e 123 cpv. c.c. per proporre l’azione di nullità. Ma soprattutto il concorso di giurisdizioni rafforza, se conclusosi prima, il giudizio di cessazione degli effetti civili, ovvero di divorzio, del matrimonio canonico trascritto, rendendolo meno permeabile agli effetti della giurisdizione canonica sulle nullità. Invero, il procedimento di divorzio ha, come s’è detto, petitum e causa petendi diversi rispetto al procedimento di nullità del matrimonio-atto, riguardando infatti il matrimonio-rapporto e cioè l'impossibilità di mantenere o ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Di conseguenza, il giudicato civile sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio e sulle connesse questioni economiche non è ostativo alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, ma questa – capace ordinariamente di far cessare la materia del contendere che abbia come presupposto l’esistenza e la validità del vincolo matrimoniale, ormai invece venuto meno[11] - non potrà travolgere le statuizioni economiche passate in giudicato in virtù degli effetti sostanziali stabiliti dall'art. 2909 c.c.[12].
L’inidoneità della delibazione ad impedire che la causa prosegua dovrebbe valere anche nel caso in cui si sia formato il giudicato sulla cessazione degli effetti civili ma la causa stia proseguendo sulle statuizioni economiche: il giudizio civile dovrebbe continuare nonostante il riconoscimento civile della nullità del matrimonio canonico trascritto, intervenuto però dopo la sentenza di divorzio. Questa conclusione è sembrata, tuttavia, revocabile in dubbio riproponendosi anche in questo caso la cessazione della materia del contendere in quanto il giudizio sull’assegno divorzile presuppone la validità dell'atto matrimoniale, nella specie riconosciuta inesistente.
Questa la divergenza di interpretazione manifestatasi all’interno della prima sezione[13] e risolta dalle Sezioni unite nel primo senso[14] con ragionamento assolutamente persuasivo. Risponde, invero, solo apparentemente ai canoni della logica formale che la cessazione degli effetti civili del matrimonio canonico ne presupponga la validità, di tal che la successiva pronuncia di nullità – inidonea, beninteso, ad incidere sul giudizio divorzile passato in giudicato - provochi la cessazione della materia del contendere almeno nel caso in cui esso sia ancora pendente pur se sotto un profilo particolare come la spettanza e la determinazione dell’assegno. Ma tale logica relativizza e minimizza il presupposto dell’autonomia dei due giudizi, che consiste nella ricordata separazione dei due ordinamenti per cui essi hanno natura ed effetti differenti. Precisamente, il giudizio divorzile implica (non la validità dell’atto, certamente presupposta ma estranea al giudizio, bensì) la “constatazione dell’intervenuta dissoluzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi e dell’impossibilità di ricostituirla, nonché della necessità di un riequilibrio tra le condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, da realizzarsi attraverso il riconoscimento di un contributo a favore di uno di essi”. È questo presupposto, una volta accertato e passato in giudicato, che giustifica la continuazione del procedimento per la spettanza e la quantificazione dell’assegno divorzile ancorchè medio tempore sia intervenuta l’efficacia civile della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio canonico a suo tempo trascritto. Infatti, l’accertamento dell’impossibilità di mantenimento o ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi è oggetto diverso, separato da quello della validità del matrimonio–atto e perciò, se definitivo, resta insensibile al riconoscimento della nullità di quell’atto, che quindi non preclude la continuazione del giudizio per la determinazione dell’assegno.
Viene così esplicata un’ulteriore limitazione degli effetti della delibazione, che non è in contrasto con gli impegni concordatari. Questi, infatti, erano stati già ridotti dalla Cassazione a quelli rivenienti in senso stretto dall’art. 8 dell’accordo di revisione, che rimette ogni statuizione sul venir meno degli effetti civili “esplicitamente alla giurisdizione e implicitamente alla normativa dello Stato italiano”[15]. Il giudizio sulla determinazione dell’assegno attiene al venir meno di questi effetti e, invero, trova titolo proprio nell’accertamento di quell’impossibilità, ormai incontestabile. Rievocare il diverso presupposto della nullità dell’atto significherebbe riproporre la tesi dell’unità della giurisdizione, in capo al diritto canonico, e negare la separazione dei due ordinamenti.
2. La separazione tra atto e rapporto matrimoniale
Il principio di diritto posto dalle Sezioni unite costituisce in fondo un semplice corollario del già riconosciuto principio di autonomia dei due giudizi canonico e civile, rispettivamente di nullità e di divorzio. Ma, al di là della sua incidenza pratica, limitata ai non molti casi simili a quelli esaminati nelle sentenze citate, esso, limitando ulteriormente la portata della delibazione della sentenza ecclesiastica, segna al momento la massima presa di distanza o di indifferenza dell’ordinamento dall’atto del matrimonio, da cui nasce il rapporto coniugale, per far posto alla sua preoccupazione per le conseguenze della fine della “comunione spirituale e materiale tra i coniugi”, quale che sia l’atto matrimoniale, civile o religioso (rispettivamente art. 1 e 2 l. 898/1970), dal quale essa tragga origine.
Può sembrare paradossale che questa definizione del matrimonio sia stata introdotta dal legislatore civile nella legge sul divorzio. In precedenza, infatti, non esisteva una definizione del matrimonio non solo nel codice civile ma nella stessa Costituzione, che pure lo evoca come fondamento della famiglia e, a sua volta, ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. D'altro canto, una definizione di simile pregnanza era stata accolta dalla stessa Chiesa solo cinque anni prima, quando il Concilio scrisse della “intima communitas vitae et amoris coniugalis”, che “conducit totamque vitam eorum pervadit” [16], ma, espressa com’era in una costituzione pastorale sia pure del livello più alto, non ha riscosso grande fortuna sul piano giuridico. Invero, nel nuovo codice di diritto canonico, riformato nel 1983, se ne avverte un’eco nel sintagma “matrimoniale foedus”, che al can. 1055 §1 c.i.c. sostituisce nella definizione quello “matrimonialis contractus” del vecchio codice: dunque, un patto, un’alleanza, non un qualsiasi contratto. Ma con esso i coniugi costituiscono una comunità di tutta la vita (totius vitae consortium”) e non anche, come nella riportata definizione conciliare, di amore. Un’amputazione voluta della nuova definizione in favore dell’antico “matrimonialis contractus”, che ricompare infatti già al § 2 dello stesso canone, seguito nei canoni successivi dalle tradizionali conseguenze in termini di validità e di nullità, solo rivisitate dalla giurisprudenza.
Per vero, nella recente riforma del processo matrimoniale canonico realizzata dall’attuale pontefice si coglie un’apertura al (fallimento del) rapporto nel rilievo dato ad alcuni cosiddetti “casi di nullità notoria” già introdotti dalla giurisprudenza, come la “brevità della convivenza” o la “ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo delle nozze o in tempo immediatamente successivo”, che, pur evidentemente non attenendo all’atto, sono assunti come presumptions of fact o indici sintomatici di vizi di nullità dello stesso[17] . Ma l’apertura non è tale, ovviamente, da condurre a superare il difetto di tutela del coniuge più debole in caso di nullità dell’atto, limitandosi il can. 1691 c.i.c. a stabilire che nella sentenza di nullità sia contenuto un ammonimento alle parti sulle obbligazioni morali di sostentamento reciproco e verso i loro figli e anche su quelle civili, cui eventualmente siano tenute (nel nostro ordinamento, l’assegno per un periodo non superiore a tre anni, previsto dall’art. 129 c.c.). Dal punto di vista della Chiesa, cioè, il sostentamento è un’obbligazione naturale, di adempimento spontaneo, senza alcuna coazione da parte del creditore naturale o di terzi (tra i quali si annovera proprio l’autorità ecclesiastica, che magari nel frattempo avrà assistito con un suo ministro alla celebrazione delle nuove nozze dell’obbligato naturale) [18].
Tutt’altra la posizione dello Stato, per cui nel caso si tratta, conformemente alla Costituzione, di un “dovere inderogabile di solidarietà” e anzi il contributo da versare all’ex coniuge economicamente pù debole per effetto dell’art. 5, co. 6, della legge 898/1970, secondo la più recente giurisprudenza, ha funzione non meramente assistenziale ma anche perequativo-compensativa rispetto alla vita coniugale svolta ed alle aspettative eventualmente sacrificate e non più compensate, come in costanza di matrimonio, dal disgregarsi della comunione morale e spirituale[19].
Al momento della stipulazione dell’accordo di revisione del concordato nel 1984 era, comunque, evidente questa posizione statale, causa ed effetto della separazione dei due ordinamenti sul matrimonio, avvenuta per effetto di una legge, che anche per il suo spiccato orientamento costituzionale, è idonea a contribuire alla formazione dell’ordine pubblico dello Stato in materia. Non sorprende, quindi, che nel procedimento di delibazione assumesse particolare importanza, per il contrasto con l’ordinamento italiano, la esclusiva rilevanza attribuita dall’ordinamento canonico all’atto del matrimonio, in quanto sacramento costitutivo del vincolo matrimoniale, con totale disinteresse per l’effettività del rapporto coniugale che ne seguiva, di modo che la prima sezione della Cassazione cominciò a sostenere coerentemente l’ostatività della prolungata convivenza [20] alla delibazione delle sentenze di nullità. Ma a rimettere le cose a posto, pur in mancanza di un contrasto sincronico, intervennero di nuovo le sezioni unite stabilendo che "la convivenza tra coniugi successiva alla celebrazione del matrimonio non è espressiva delle norme fondamentali che disciplinano l'istituto" data la “inesistenza nelle norme costituzionali di un principio chiaramente evincibile circa la prevalenza del matrimonio-rapporto sul matrimonio-atto, anche se viziato”, sicchè “la stabilità del vincolo comunque realizzatasi e quindi anche attraverso la convivenza dopo la celebrazione” non rappresenta “la dimensione normativa dell’effettività dell’unione che impedisce di dare rilievo al difetto genetico dell’atto costitutivo”[21].
Non solo, anzi, secondo la Cassazione non era ricavabile espressamente un principio di ordine pubblico del genere ma addirittura un atteggiamento dell’ordinamento civile benevolentior verso le sentenze ecclesiastiche al confronto di quelle straniere era positivamente deducibile dall’obbligo concordatario del giudice della delibazione di tener conto della “specificità dell’ordinamento canonico” e, quindi, della rilevanza esclusiva da esso attribuita al matrimonio-atto rispetto al rapporto. Che questo fosse il significato da attribuire al richiamo della specificità era piuttosto dubbio ed in effetti, come fu precisato qualche anno dopo da Cass. 1824/1993, cit., la clausola grazie alla sua elasticità “ha il solo scopo di attenuare la equiparazione, ai fini della delibazione, della sentenza ecclesiastica alla sentenza straniera”. Ma non rispondeva al criterio di ragionevolezza dell’interpretazione, salvo che in una interpretazione confermativa dello status quo ante[22], spingere l’attenuazione fino al punto di continuare ad accogliere nell’ordinamento civile in tutta la sua portata una peculiarità dell’ordinamento canonico tale da integrarne quel proprium irriducibile, nel suo nucleo forte, alla dimensione del diritto statale e, quindi, da risultare incompatibile con l’area di tutela dell’affidamento e, in generale, con l’ordine pubblico: è questo il caso, in cui tocca alle parti “pagare” la specificità dell’ordinamento canonico, rimanendo private dell’efficacia civile della sentenza ecclesiastica di nullità.
Cionondimeno, il principio dell’irrilevanza della effettiva convivenza rispetto al difetto genetico dell’atto matrimonio frenò la presa d’atto dell’avvenuta separazione dei due ordinamenti per oltre un quarto di secolo fino alle citate “sentenze gemelle” del 2014, che diedero rilievo come motivo ostativo alla convivenza prolungatasi oltre (non l’anno, ma) il triennio[23]. A dissodare il terreno erano intervenute qualche anno prima le stesse sezioni unite quando avevano esteso l’ostatività alle incompatibilità assolute, in nessun modo conformabili ai “valori o principi essenziali della coscienza sociale, desunti dalle fonti normative costituzionali e dalle norme inderogabili, anche ordinarie, nella materia matrimoniale”: quali appunto le “pronunce di annullamento canonico intervenute dopo molti anni di convivenza o coabitazione dei coniugi, dato il rilievo del matrimonio rapporto, “riconosciuto in precedenza ma assunto ora a valore cogente, per lo stretto nesso tra esso e il matrimonio atto, sancito nella Costituzione (art. 29)” [24].
Alla Costituzione (non solo l’art. 29 ma anche gli artt. 2, 3, 30 e 31) le citate sentenze del 2014 aggiungeranno le Carte europee dei diritti (art. 8, par. 1, e 12 CEDU, art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, l'art. 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, espressamente richiamata nel Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, il codice civile. E, anche dall’esame della convergente giurisprudenza formatasi su tali disposizioni, stabiliranno che la convivenza dei coniugi o "come coniugi" — cioè, la consuetudine di vita comune, il ”vivere insieme” stabilmente e con continuità nel corso del tempo o per un tempo significativo tale da costituire ”legami familiari” — integra in questa “complessità fattuale” un aspetto essenziale e costitutivo del ”matrimonio-rapporto”, caratterizzandosi al pari di questo, secondo il paradigma dell'art. 2 Cost., come il "contenitore", per così dire, di una pluralità di “diritti inviolabili”, di ”doveri inderogabili”, di ”responsabilità” anche genitoriali in presenza di figli, di "aspettative legittime" e di "legittimi affidamenti" degli stessi coniugi e dei figli, sia come singoli sia nelle reciproche relazioni familiari”.
3. La separazione come laicità
La laicità è il filo rosso che ha reso possibile separare l’uno dall’altro i due ordinamenti aggrovigliati sul matrimonio. La separazione viene riconosciuta così non solo sotto l’aspetto processuale ma anche su quello sostanziale della tutela attribuita in ciascuno di essi al rapporto di convivenza al fine di impedire che si possa porre nel nulla, con relativa rapidità un rapporto durato anche decenni, con la nascita, il mantenimento, l’istruzione e l’educazione dei figli (art. 30 cost.) e l’instaurazione di rapporti familiari anche con i parenti dei genitori, che almeno sotto l’aspetto successorio verrebbero travolti dalla dichiarazione di nullità. Si tratta di rapporti che l'ordinamento non può non garantire a tutti, senza distinzione di religione: e nell’escluderne chi, avendo a suo tempo scelto il matrimonio canonico trascritto, si trovi a subire anche la trascrizione della sentenza di nullità di quell’atto con la conseguenza di vederli travolti formalmente fin dall’origine si potrebbero cogliere elementi di una discriminazione per motivi di religione, vietata dall’art. 3 Cost.[25].
È il principio di laicità, a monte, che determina una separazione sempre più marcata tra matrimonio-atto e matrimonio-rapporto, per cui non c’è più necessariamente connessione e per lo Stato, in definitiva, ciò che più rileva, ed è meritevole di tutela, è l’instaurazione o il venir meno della convivenza. Un’espressione flessibile, questa, capace di designare ogni forma di effettiva comunione spirituale e materiale, indipendentemente non solo da un atto, civile o religioso trascritto, da cui sia originata, ma dalla stessa esistenza di un atto matrimoniale come si può dedurre dall’osservazione ai “legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale” di cui all’art. 1, co. 36, l. 20 maggio 2016, n. 769 (che ricalca l’art. 143 c.c. estendendolo così alla disciplina delle convivenze, come la legge è intitolata a sottolinearne la grande varietà).
Il pendolo della tutela statuale si è andato così gradualmente spostando dalla varietà degli atti giuridici pubblicamente certificati alla medesimezza del fatto risultante dalla relazione concretamente instaurata tra due soggetti, da ciò che è formale a ciò che è sostanziale, dalla condotta obbligatoria per le parti a quella discrezionale da esse tenuta. Questo risultato unificante è stato ottenuto, come s’è visto, attraverso la separazione: anzi, “l’arte della separazione”, com’è stato definito[26] questo tratto del liberalismo politico di cui il jeffersoniano “muro” che separa la Chiesa dallo Stato è la narrazione retorica più celebre ma che in realtà ha una storia più complessa, risalente all’antica distinzione evangelica tra “quel che è di Cesare e quel che è di Dio” ed espressa da quella moderna tra peccato e reato[27]. Nello stato costituzionale di diritto questo dualismo è alla base del principio supremo di laicità, che infatti si declina come “distinzione degli ordini distinti” in modo da tematizzarne la finitezza ed evitarne sconfinamenti e strumentalizzazioni reciproche[28].
Questo intimo nesso, quasi una sinonimia, tra separazione e laicità consente di gettare uno sguardo più comprensivo sulla effettiva ricezione del principio di laicità, che altrimenti potrebbe sembrare minimale e dare l’impressione che la viva vox Constitutionis sia poco percepita. La giurisprudenza di legittimità sta cominciando a fare più frequentemente applicazioni espresse del principio di laicità: solo nell’ultimo anno si possono ricordare le due importanti sentenze sul diritto alla propaganda ateistica per non incorrere nel divieto di discriminazioni e sul diritto all'autodeterminazione in materia di rifiuto (del testimone di Geova) del trattamento sanitario e libertà di professione della fede[29]. E in precedenza anche al principio di laicità la Cassazione fece ricorso nel sollevare la questione di costituzionalità sull’obbligo governativo di avviare trattative d’intesa, salva la discrezionalità di stipularle, con le confessioni religiose diverse dalla cattolica[30].
Ma la ricezione del principio di laicità nella giurisprudenza va valutata anche con riguardo ai casi in cui, pur la laicità non essendo espressamente nominata, viene applicato il principio di separazione degli ordini, di cui la laicità è fonte e culmine. Della separazione la giurisprudenza della Cassazione ha fatto uso ovviamente nelle controversie in cui assumeva rilievo principale l’interpretazione dell’art. 7 Cost. rispetto ai patti lateranensi - come per esempio quella sui limiti del divieto di “non ingerenza” dello Stato sui rapporti degli “enti centrali” della Chiesa cattolica - ma anche in “materie miste” tra etiche e diritto, caratterizzate da “eccessi di culture”[31] specie confessionali, come quella del diritto alla cura e dalla cura[32]. Ma la separazione ha trovato, come s’è visto, terreno fecondo anche nella delicata materia della delibazione delle sentenze ecclesiastiche, e quindi della distinzione tra atto e rapporto matrimoniale, consentendo al giudice di districarsi tra le intersecazioni di discipline canoniche e statali: dalle sentenze del 2014 (preparate da quella sulle incompatibilità assolute e relative del 2008) a questa del 2021. La presa d’atto della coesistenza tra la pronuncia di cessazione degli effetti civili e quella di nullità del matrimonio, con la possibilità di un contrasto di giudicati (quanto meno, in quest’ultimo caso, sotto il profilo pratico della potenziale sovrapposizione tra gli effetti economici del divorzio e della pronuncia di nullità), muove dalla raggiunta consapevolezza di una separazione dei due ordinamenti, con cui si è superata, sia pur lentamente, una giurisprudenza a lungo impastata di concezioni mutuate dal matrimonio-atto proprie del diritto canonico.
Si tratta di una laicità innominata, cioè di una interpretazione costituzionalmente (nel caso, per la precisione, laicamente) orientata di norme di collegamento, che ha consentito di tener conto della realtà della vita comune condotta dagli ex coniugi prima del disgregarsi della loro comunione materiale e spirituale e almeno delle conseguenze economiche di tale disgregazione per ciascuno di essi. E proprio il principio, non solo direttivo ma anche regolativo, di laicità consente che quest’attenzione alle conseguenze dell’efficacia civile della dichiarazione di nullità non si traduca in un “utilitarismo dell’atto” giurisdizionale[33], incompatibile con un sistema di giustizia legale.
Certo, ci si può, e anzi sul piano della politica del diritto ci si dovrebbe, chiedere se la tutela della vita familiare rivolta esclusivamente alla convivenza non renda ormai priva di valore, un orpello retorico da cerimoniale, l’impegno matrimoniale – nella celebrazione canonica così solenne e basata su una Parola al massimo grado eteronoma – a sostenersi nella “buona o cattiva sorte” [34]; e se, quindi, nell’ormai acquisito relativismo delle forme non si dia più spazio per norme stimolanti la scelta dell’atto formale del matrimonio, una sua resilienza costituzionale di fronte al declino di fatto. Domande non facili, meritevoli di una risposta meditata e non disinvolta, che difficilmente può dare un agire politico privo di una causa finale e improntato, come l’attuale, piuttosto al presentismo quando non proprio all’emergenzialismo. L’attuale stato legislativo e giurisprudenziale mostra, tuttavia, che la tendenza alla privatizzazione del matrimonio ha portato, comunque, a tutelare non un individualismo incurante dei doveri di solidarietà ma, all’opposto e in applicazione proprio dell’art. 2 Cost., la relazione con l’altro, cioè il rapporto anziché l’atto, anche quando il rapporto nasca dall’atto.
[1] A.C. Jemolo, Chiesa e Stato negli ultimi cento anni, Einaudi, Torino, 1971, p. 513.
[2] Cfr. Dieci documenti diplomatici sulla interpretazione dell’art. 34 del Concordato tra l’Italia e la Santa Sede, in Rivista di Studi Politici Internazionali, Vol. 37, 1970, III, pp. 461 ss.
[3] Corte cost. 8 luglio 1971, n. 169.
[4] Corte cost. 11 dicembre 1973, n. 176.
[5] Corte cost. 2 febbraio1982, n. 18.
[6] Cass. sez. un. 1 ottobre 1982, n. 5026.
[7] Cass. sez. un. 13 febbraio 1993, n. 1824.
[8] Corte cost. 29 novembre 1993, n. 421.
[9] Conf. ad es. Cass. sez. un. 6 luglio 2011, n. 14839.
[10] Cass. 17 luglio 2014, n. 16379 e 16380.
[11] Cass. 7 ottobre 2019, n. 24933, e altre precedenti ivi citt.
[12] Cass. 18 settembre 2013, 21331, ed altre precedenti ivi citt.
[13] Rispettivamente Cass. 23 gennaio 2019, n. 1882, e Cass. 25 febbraio 2020, n. 5078.
[14] Cass. sez. un. 31 marzo 2021, n. 9004: "In tema di divorzio, il riconoscimento dell'efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso, intervenuto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili ma prima che sia divenuta definitiva la decisione in ordine alle relative conseguenze economiche, non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio civile avente ad oggetto lo scioglimento del vincolo coniugale, il quale può dunque proseguire ai fini dell'accertamento della spettanza e della liquidazione dell'assegno divorzile". Prime note alla sentenza di J. Pasquali Cerioli, Le Sezioni unite e l''indifferenza' del giudizio sull'assegno divorzile al riconoscimento delle nullità canoniche: la tutela del "coniuge debole" nell'ordine matrimoniale dello Stato, in Statoechiese.it, 2021, n. 7; A. Cesarini, Libertà e responsabilità nella convivenza coniugale: la stabilità dell’assegno divorzile a seguito di ‘delibazione’ della nullità canonica, ibid., n. 11.
[15] Cass. 23 marzo 2001, n. 4202.
[16] Concilio Vaticano II, cost. Gaudium et spes, 1965, n. 48 s. Un’apertura sul piano pastorale, priva di conseguenze su quello giuridico, alla positività del rapporto coniugale si rinviene ora in papa Francesco (J.M. Bergoglio), esortazione Amoris laetitia, 2016, n. 293, secondo cui anche “una semplice convivenza, quando l’unione raggiunge una notevole stabilità attraverso un vincolo pubblico, è connotata da affetto profondo, da responsabilità nei confronti della prole, da capacità di superare le prove, può essere vista come un’occasione da accompagnare nello sviluppo verso il sacramento del matrimonio”.
[17] Di “sconfinamento della nullità verso lo scioglimento” aveva scritto P. Moneta, Nullità e scioglimento del matrimonio, in Id., Communitas vitae et amoris. Scritti di diritto matrimoniale canonico, Pisa University Press, Pisa, 2013, p. 412. Sulla dubbia delibabilità della sentenza contenente simili statuizioni e/o emanata all’esito del processus brevior, introdotto dal motu proprio di papa Francesco Mitis iudex dominus Jesus del 15 agosto 2015, si può vedere il mio Il giusto processo di delibazione delle sentenze ecclesiastiche, in Rivista di diritto privato, 2016, n. 1, p. 131 ss., ora anche in N. Colaianni, La lotta per la laicità. Stato e Chiesa nell’età dei diritti, Cacucci, Bari, 2017, pp. 275 ss. Per un’ampia critica del motu proprio, anche in direzione dell’efficacia civile delle sentenze, v. invece G. Boni, L’efficacia civile in Italia delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale dopo il Motu Proprio Mitis iudex (parte seconda) , in Statoechiese.it, 2017, pp. 61 ss.
[18] Questo esito normativo è scaturito – come magistralmente osservò G. Dossetti, La famiglia, in Rivista internazionale di scienze sociali, 1943, ripubblicato in Id., “Grandezza e miseria” del diritto della Chiesa, a cura di F. Margiotta Broglio, Il Mulino, Bologna, 1996, pp. 197 e 202. – da un “isolamento sistematico dei problemi relativi al matrimonio, studiato (… ancor più dopo il XIII secolo, in conseguenza dell’esplicito inquadramento nel numero settenario dei sacramenti) sempre avulso dal restante complesso dei problemi familiari: quindi mancata costruzione di una dottrina, non solo sostanzialmente ma anche formalmente unitaria, della società coniugale e parentale, (…) mancanza di una determinazione in tutto precisa ed esauriente dei rapporti di solidarietà e dei doveri vicendevoli tra persona società coniugale e parentale e società superiori”.
[19] Cass. sez. un. 11 luglio 2018, n. 18287, e Cass., I, 28 febbraio 2020, richiamate da Cass. 9004/2021, cit.
[20] Cass, 18 giugno 1987, nn. 5354 e 5358; 3 luglio 1987, n. 5823.
[21] Cass. sez. un. 20 luglio 1988, n. 4700.
[22] V. per tutti in questo senso G. Dalla Torre, “Specificità dell’ordinamento canonico” e delibazione delle sentenze matrimoniali ecclesiastiche, in Statoechiese.it, 2013, e in senso contrario G. Casuscelli, Delibazione e ordine pubblico: le violazioni dell’Accordo “che apporta modificazioni al Concordato lateranense”, ibid., 2014.
[23] Questo, insieme alla privatizzazione dell’ordine pubblico a motivo della rilevabilità della convivenza solo su eccezione dell’opponente alla delibazione, il punto criticabile delle sentenze: si può vedere al riguardo il mio Convivenza 'come coniugi' e ordine pubblico: incontro ravvicinato ma non troppo, in Giurisprudenza italiana, 2014, n. 10, pp. 2119 ss., ora anche in Colaianni, La lotta per la laicità, cit., pp. 260 ss. Per la critica, invece, della restrizione dei margini della delibazione “da regola a eccezione, in evidente contrasto con gli impegni concordatari a suo tempo assunti dallo Stato italiano” v., anche per altre citazioni di letteratura, P. Cavana, L’evoluzione del concetto di ordine pubblico nel giudizio di delibazione, in Statoechiese.it, 2020, n.10, p. 44.
[24] Cass. 18 luglio 2008, n. 19809, che ha “negato il riconoscimento della efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio nel caso, nel quale la rilevanza della ignoranza di uno dei nubendi sull’infedeltà dell’altro prima del matrimonio è certa in attuazione delle istanze etiche che sottostanno al matrimonio religioso e alla specificità del diritto canonico, ma non è assolutamente compatibile con l’ordine pubblico italiano”. F. Alicino, L’altra “faccia” della specificità del matrimonio canonico (A proposito di Cassazione, Sez. Un., 18 luglio 2008, n. 19809), in Statoechiese.it, 2009, vi rileva “il maggior risalto attribuito agli elementi che separano lo Stato – laico – italiano da un contesto ordinamentale esterno e, comprensibilmente ossia legittimamente, pervaso da una visione sacramentale del diritto”.
[25] Cfr. V. Carbone, Ombre e luci della giurisprudenza sui rapporti tra giurisdizione ecclesiastica e quella italiana in ordine alla rilevanza del matrimonio-rapporto, in Corriere giuridico, 2012, p. 1044.
[26] M. Walzer, Il liberalismo e l’arte della separazione, in Id., Pensare politicamente. Saggi teorici, Laterza, Roma-Bari, 2009, p. 38.
[27] P. Prodi, Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto, Il Mulino, Bologna, 2000, specialmente pp. 480 ss.
[28] La distinzione degli ordini distinti, interpretati nella dimensione della , significa, infatti, che «la religione e gli obblighi morali che ne derivano non possono essere imposti come mezzo al fine dello Stato” e comporta “il divieto di ricorrere a obbligazioni di ordine religioso per rafforzare l’efficacia dei propri precetti” (Corte cost. 334/96, cit.). Comporta reciprocamente il divieto per le confessioni religiose di ricorrere ad obbligazioni di ordine civile per rafforzare l’efficacia di precetti essenzialmente religiosi.
[29] Rispettivamente Cass. 17 aprile 2020, n. 7893, e Cass. 23 dicembre 2020, n. 29469.
[30] Cass. 28 giugno 2013, n. 16305. La questione fu rigettata dalla Corte costituzionale con sentenza 10 marzo 2016, n. 52, molto discussa (v. almeno i contributi raccolti nel volume Bilateralità pattizia e diritto comune dei culti. A proposito della sentenza n. 52/2016, a cura di M. Parisi, Editoriale scientifica, Napoli, 2017).
[31] Espressione di M. Aime, Eccessi di culture, Einaudi, Torino, 2004.
[32] Rispettivamente Cass. 18 settembre 2017, n. 21541, e Cass. 16 ottobre 2007, n. 21748.
[33] Per riprendere l’espressione di L. Mengoni, L’argomentazione orientata alle conseguenze, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1994, pp. 1 ss.
[34] Pur con occhio disincantato sul futuro, M. Tamponi, Del convivere. La società postfamiliare, La nave di Teseo, Milano, 2019, p. 256, vede, tuttavia, oltre al declino “anche rinnovata emersione della forza e della necessità dell’istituzione”.

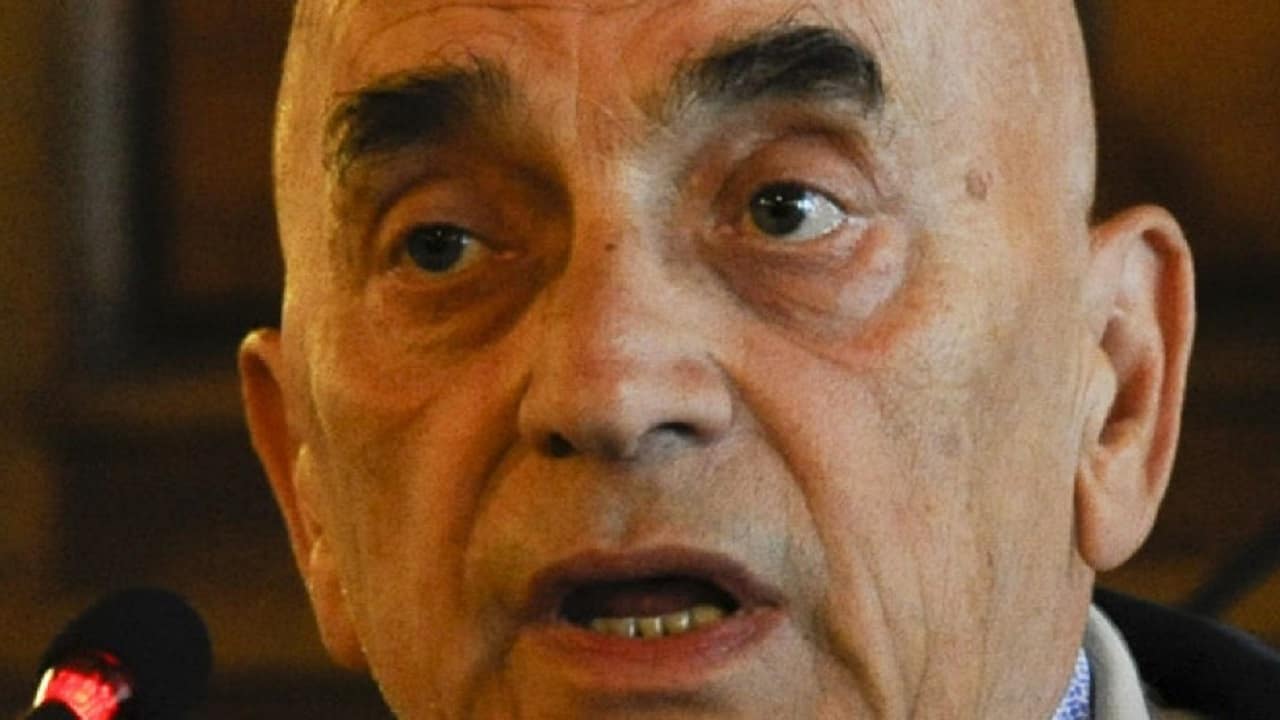

 And then Add to Home Screen.
And then Add to Home Screen.